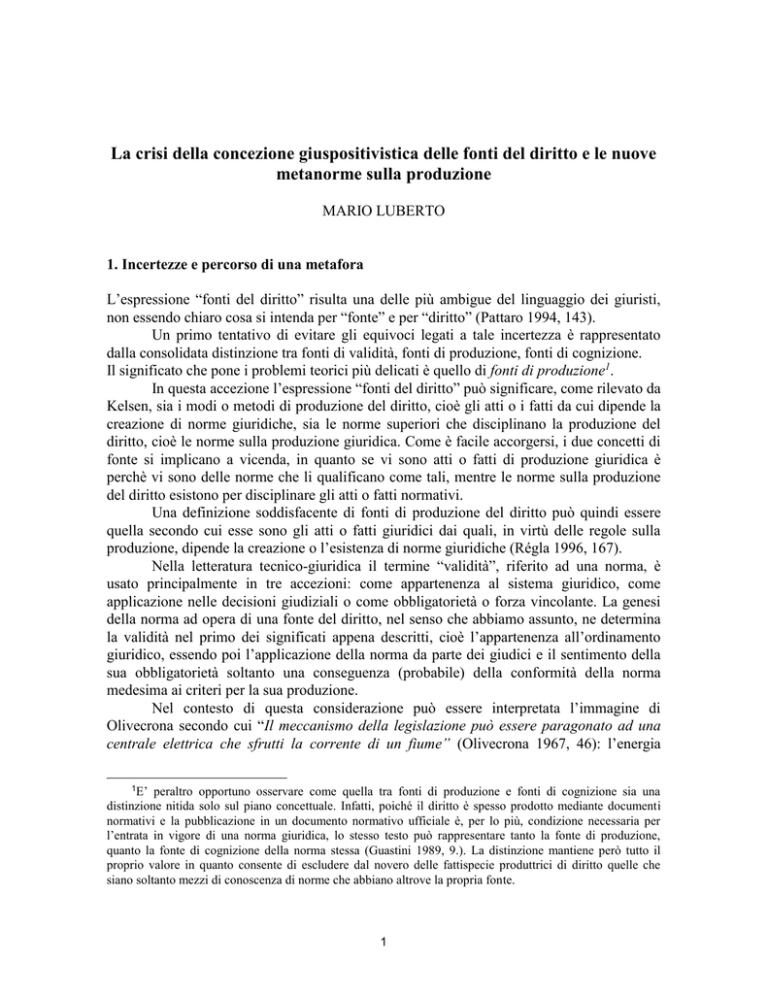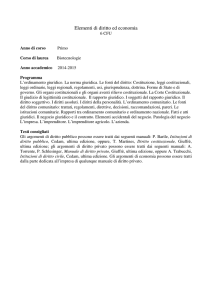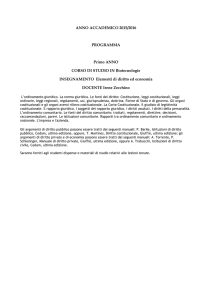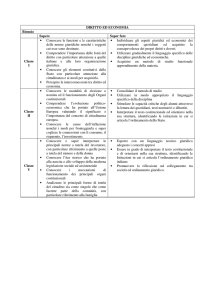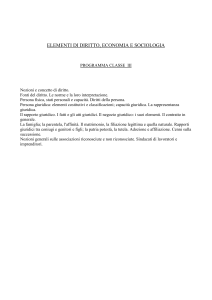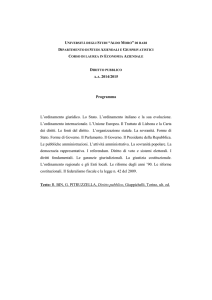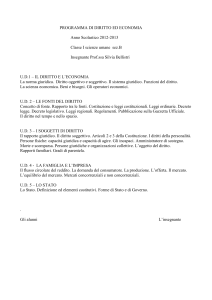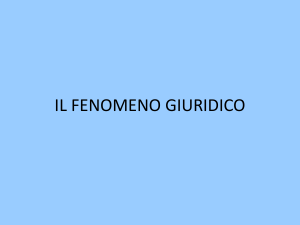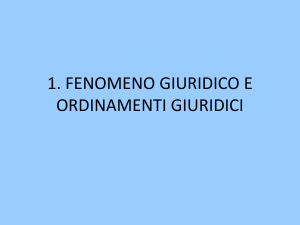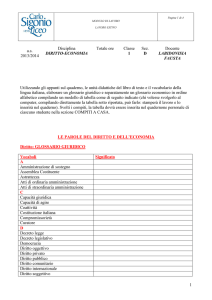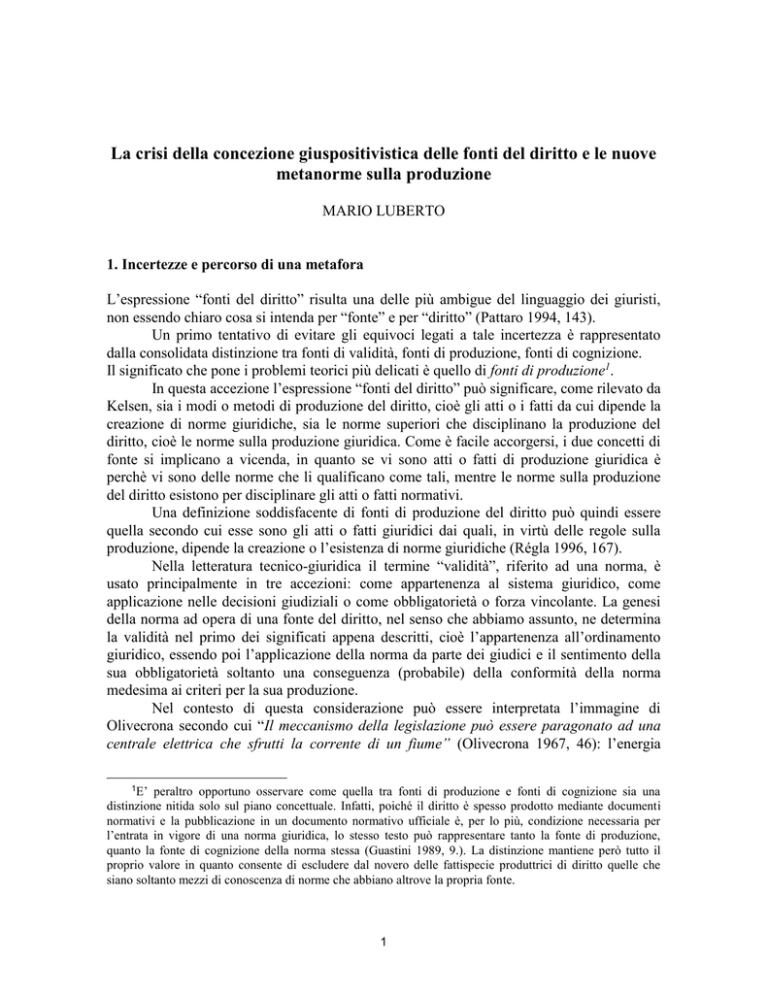
La crisi della concezione giuspositivistica delle fonti del diritto e le nuove
metanorme sulla produzione
MARIO LUBERTO
1. Incertezze e percorso di una metafora
L’espressione “fonti del diritto” risulta una delle più ambigue del linguaggio dei giuristi,
non essendo chiaro cosa si intenda per “fonte” e per “diritto” (Pattaro 1994, 143).
Un primo tentativo di evitare gli equivoci legati a tale incertezza è rappresentato
dalla consolidata distinzione tra fonti di validità, fonti di produzione, fonti di cognizione.
Il significato che pone i problemi teorici più delicati è quello di fonti di produzione1.
In questa accezione l’espressione “fonti del diritto” può significare, come rilevato da
Kelsen, sia i modi o metodi di produzione del diritto, cioè gli atti o i fatti da cui dipende la
creazione di norme giuridiche, sia le norme superiori che disciplinano la produzione del
diritto, cioè le norme sulla produzione giuridica. Come è facile accorgersi, i due concetti di
fonte si implicano a vicenda, in quanto se vi sono atti o fatti di produzione giuridica è
perchè vi sono delle norme che li qualificano come tali, mentre le norme sulla produzione
del diritto esistono per disciplinare gli atti o fatti normativi.
Una definizione soddisfacente di fonti di produzione del diritto può quindi essere
quella secondo cui esse sono gli atti o fatti giuridici dai quali, in virtù delle regole sulla
produzione, dipende la creazione o l’esistenza di norme giuridiche (Régla 1996, 167).
Nella letteratura tecnico-giuridica il termine “validità”, riferito ad una norma, è
usato principalmente in tre accezioni: come appartenenza al sistema giuridico, come
applicazione nelle decisioni giudiziali o come obbligatorietà o forza vincolante. La genesi
della norma ad opera di una fonte del diritto, nel senso che abbiamo assunto, ne determina
la validità nel primo dei significati appena descritti, cioè l’appartenenza all’ordinamento
giuridico, essendo poi l’applicazione della norma da parte dei giudici e il sentimento della
sua obbligatorietà soltanto una conseguenza (probabile) della conformità della norma
medesima ai criteri per la sua produzione.
Nel contesto di questa considerazione può essere interpretata l’immagine di
Olivecrona secondo cui “Il meccanismo della legislazione può essere paragonato ad una
centrale elettrica che sfrutti la corrente di un fiume” (Olivecrona 1967, 46): l’energia
1E’
peraltro opportuno osservare come quella tra fonti di produzione e fonti di cognizione sia una
distinzione nitida solo sul piano concettuale. Infatti, poiché il diritto è spesso prodotto mediante documenti
normativi e la pubblicazione in un documento normativo ufficiale è, per lo più, condizione necessaria per
l’entrata in vigore di una norma giuridica, lo stesso testo può rappresentare tanto la fonte di produzione,
quanto la fonte di cognizione della norma stessa (Guastini 1989, 9.). La distinzione mantiene però tutto il
proprio valore in quanto consente di escludere dal novero delle fattispecie produttrici di diritto quelle che
siano soltanto mezzi di conoscenza di norme che abbiano altrove la propria fonte.
1
elettrica (il diritto considerato obbligatorio e applicato dai tribunali) è prodotta grazie al
rispetto dei criteri procedurali e materiali previsti dalla costituzione (intesa quest’ultima in
un senso atecnico, come “norma di riconoscimento” à la Hart), da cui deriva il carattere di
fonte del diritto ad un atto o fatto.
Un altro modo per limitare gli equivoci che possono sorgere dall’uso della metafora
di “fonti del diritto” è quello di mettere in evidenza come ogni concezione delle fonti del
diritto abbia una valenza ideologica. Secondo Pattaro (1994, 149-50), ad esempio,
l’ambiguità del termine in esame è da ricondurre principalmente a tre fattori. Innanzi tutto,
alla convinzione che diritto sia solo quello emanato secondo determinate procedure, poi
all’intenzione di stabilire una gerarchia tra le norme dell’ordinamento e, infine, all’opinione
che la concezione del diritto che ne risulta corrisponda alla descrizione oggettiva della
realtà di fatto. Queste asserzioni, che esprimono il postulato del primato della legge sulle
altre fonti, dimostrerebbero come ogni teoria delle fonti del diritto, pur pretendendo di
presentarsi sotto veste scientifica, rappresenti in realtà il tentativo di fare accettare come
diritto valido certe prescrizioni invece di altre.
Per il suo carattere ideologico la definizione tradizionale di fonti di produzione è
stata radicalmente contestata dal giurista russo Leone Petrazycki, il quale ha negato che
legge, consuetudine, regolamenti, ecc., siano fonti del diritto nel senso suddetto, affermando
che esse sono in realtà “tipi di diritto”. L’uso della metafora da parte dei giuristi non è
ammissibile da un punto di vista scientifico, ritiene il Petrazycki, come non sarebbe
ammissibile che gli zoologi chiamassero cani e gatti “fonti degli animali”. “..Egualmente afferma l’autore- le “fonti del diritto” (consuetudini, leggi, ecc.) non sono fonti, ma esse
stesse diritto. Non è perciò esatto parlare di “fonti del diritto”, e discutere delle loro
relazioni con la legge. Questa locuzione va abolita con l’altra “dottrina del diritto positivo
e delle sue specie e varietà” (Paresce 1968, 893-94).
Tale soluzione non è condivisa dal Crisafulli (1968, 925), per il quale i dubbi
relativi all’impiego della metafora non rappresentano una ragione sufficiente a rinunciare a
valersene, interrompendo una consolidata tradizione scientifica. L’autore riduce il problema
a quello di stabilire preliminarmente che cosa si intenda per “fonte” e che cosa per “diritto”.
Altri autori (Monateri 1992, 382) preferiscono definire le fonti come “meccanismi
istituzionali” seguiti dagli interpreti per raggiungere decisioni giuridiche2.
La causa della molteplicità di significati e dell’incertezza sull’uso dell’espressione,
ed in particolare della confusione tra fonti di validità e fonti di produzione, va individuata
principalmente nella sovrapposizione tra l’originario significato fisico di “origine” del
termine fonte ed il suo significato figurato di “fondamento”. La fonte è infatti il punto in cui
diviene visibile alla luce una vena d’acqua ma in senso figurato essa , identificata in una
2L’uso
incostante del termine fonte è osservato anche da Guastini 1989, 9. che precisa come per fonte si
possa intendere un’autorità normativa, ossia un soggetto investito del potere di creare diritto (ad esempio
l’organo legislativo); un atto normativo, cioè un atto di linguaggio umano di contenuto prescrittivo (ad es.
l’atto del legiferare); un documento normativo, cioè il prodotto o il risultato di un atto normativo (ad es. il
testo scritto di una legge); il contenuto di significato di un documento normativo, quale risulta
dall’interpretazione (ad es. le norme di una legge).
2
divinità e personificata (così come è avvenuto nella mitologia), finisce per significare il
“fondamento” della natura e di tutta la realtà (e, dunque, anche del diritto) (Paresce 1968,
893).
Tutte le metafore quali quella in esame sono costruite sulla base di un’analogia, una
somiglianza di relazioni, per cui il problema delle fonti del diritto può essere introdotto
affermando che le fonti stanno al fiume come x sta al diritto (Regla 1996, 165).
Posto che l’uso ed il significato della locuzione “fonti del diritto” sono alquanto
problematici e che, in particolare, questa espressione non ha un riferimento semantico
verificabile con certezza, appare però opportuno sottolineare come essa svolga una funzione
difficilmente sostituibile nel linguaggio giuridico. Si tratta infatti di un concetto che, alla
stregua di altri concetti normativi come “diritto”, “obbligo”, “pretesa”, “dovere”,
“aspettativa”, “status” serve ad esporre in maniera ordinata e sistematica il rapporto tra un
fatto assunto come condizionante e gli effetti giuridici ad esso connessi3.
Se si pretendesse di rinunciare alla metafora si sarebbe costretti a dire che, ad
esempio, un documento sottoposto al Parlamento secondo procedure prestabilite ed
approvato da entrambe le Camere in modo identico è una legge; che la legge deve essere
applicata dai tribunali, tenuti a conoscerla dopo la sua pubblicazione e la vacatio legis; che
in caso di mancata applicazione della disposizione contenuta in una legge in un processo la
parte che si assume lesa può chiedere il riesame della decisione al giudice di grado
superiore, fino alla Corte di Cassazione; che se la legge è sospettata di incompatibilità con
qualche disposizione della Costituzione occorrerà sospendere il processo e sollevare la
questione di fronte alla Corte Costituzionale, la quale ha il potere di annullarla con effetto
ex tunc, ecc.
Risulta pertanto evidente la “comodità” dell’impiego dell’ immagine di “fonti del
diritto”, volta a rappresentare il veicolo intermediario tra un fatto giuridico (atto del
Parlamento, decisione del giudice, comportamento dei consociati, ecc.) e la catena causale
di conseguenze che ne derivano.
Il problema dell’utilizzazione della metafora potrebbe quindi risolversi in quello
della consapevolezza che essa non rappresenta alcunchè di reale ed oggettivo, non indica
entità esistenti in un ipotetico mondo normativo, parallelo alla dimensione empirica, ma
serve, da una parte, a descrivere il funzionamento di determinati meccanismi (funzione
assertiva), dall’altra ad influenzare il comportamento di determinati soggetti (i giudici e gli
operatori del diritto in generale) esercitando una funzione precettiva che implica scelte
ideologiche: la questione delle fonti è un problema di ideologia normativa (Regla 1996,
170).
Un concetto di fonte in senso moderno si trova soltanto nel Digesto dove troviamo
l’affermazione che “Ius autem civile est, quod ex legibus, plebiscitis, senatus consultis,
decretis principum, auctoritate prudentium venit”, (Mossini 1962, 191) dove l’uso del
verbo “venit” rivela un’ importante prospettiva. Tale verbo ha infatti il significato di origine
e derivazione: quello che è elencato nel passo citato del Digesto è dunque fonte, origine,
3Cfr
la nota tesi elaborata da Alf Ross in Scarpelli 1996, 119-34.
3
sorgente di ciò che ne deriva4. Nei testi dei giuristi romani precedenti, l’elenco delle fonti
era legato al verbo “constat”, che non ha alcun significato di derivazione, ma che serviva ad
indicare solo le parti di cui è costituito il diritto.
Una vera e propria teoria delle fonti, già presente “in nuce”, come osservato, nella
codificazione giustinianea, iniziò a precisarsi presso gli autori del diritto canonico.
Graziano sistemò il diritto naturale tra quello divino e quello umano, sostenendo che le
leggi positive non possono contrastare con la lex naturae, che le constitutiones dei principi
non possono violare il diritto ecclesiastico e che le consuetudines sono subordinate tanto al
diritto emanato dall’autorità civile quanto a quello della Chiesa.
I Glossatori rivolsero la propria attenzione allo studio della consuetudine,
considerandola una fonte giustificatrice di regole non riconducibili ai testi scritti ed un utile
strumento di elaborazione di quei rami del diritto, come il diritto feudale, che si ponevano
come alternativi e non di rado antitetici al diritto romano.
La preoccupazione dei giuristi medievali è stata dunque quella di realizzare,
attraverso l’elaborazione di una teoria delle fonti, un compromesso tra diversi modi di
produzione ed diversi sistemi di norme compresenti quali il diritto comune, il diritto
canonico, il diritto feudale, il diritto naturale e quello divino (Monateri 1992, .583).
La nascita dello stato di diritto conduce ad una consapevole svolta nella teoria delle
fonti, forgiata dal positivismo giuridico secondo le concezioni teoriche e politiche
dominanti. L’ideale illuministico della certezza del diritto esige che il governo della società
avvenga ad opera della legge, cioè del diritto emanato dallo stato attraverso i suoi organi ed
alla legge è affidata la tutela dei diritti soggettivi, la disciplina dell’attività della pubblica
amministrazione e il controllo delle decisioni dei giudici, che devono applicarla secondo lo
schema del sillogismo.
Il legislatore italiano del 1942 ha voluto fissare, in maniera perentoria, quali siano le
fonti di produzione del diritto, affrontando il problema in una serie di disposizioni che
hanno il valore di criteri supremi, almeno sul piano logico, dell’intero ordinamento, le
cosiddette Preleggi.
Nel capo primo (artt. 1-9) il legislatore indica le fonti di produzione
dell’ordinamento giuridico italiano, disponendole in ordine gerarchico e configurando un
sistema chiuso, nel capo secondo (artt. 10-15) detta disposizioni relative all’obbligatorietà,
agli effetti nel tempo e alla interpretazione delle norme giuridiche.
La loro collocazione nel codice civile corrisponde all’ideologia, nata dalle
codificazioni moderne e dominante al tempo dell’emanazione del codice, secondo cui il
diritto privato rappresenta il nucleo essenziale dell’esperienza giuridica.
4Questo
primo effettivo tentativo di costruire un teoria delle fonti del diritto va posto in relazione con
l’importante mutamento costituzionale dello stato romano, in cui la volontà del sovrano era divenuta la fonte
preminente, come testimoniato dal noto passo di Ulpiano, interpretato a sostegno delle pretese assolutistiche
degli imperatori, in cui si afferma che “Quod principi placuit legis habet vigorem”.
4
Con il termine pancivilismo si indica tale preminenza del diritto privato sulle altre
branche del diritto, preminenza che si concreta nella utilizzazione dei concetti civilistici per
la spiegazione e la rappresentazione del diritto dell’intero ordinamento.
Detta preminenza è da ricondurre principalmente a ragioni di carattere storico,
poichè la branca del diritto civile è quella che per prima e per più lungo tempo è stata
oggetto dello studio dei giuristi in Europa.
Non stupisce quindi che le nozioni civilistiche abbiano raggiunto un grado di
perfezione tale, da indurre i cultori della materia a ritenere che esse fossero utilizzabili per
la comprensione del fenomeno giuridico in generale.
Il fatto di essere inserite prima del codice civile ha conferito inoltre alle preleggi il
valore di leges legum e costituzionale. Esse contengono infatti principi che, fatti propri
dall’Illuminismo giuridico, sono stati accolti dalle codificazioni della Restaurazione: il
primato della legge, con esclusione delle altre fonti concorrenti; il valore garantistico del
codice civile, la cui funzione era quella di tutelare i diritti, soprattutto economici, dei
cittadini; la subordinazione del giudice, considerato secondo il modello affermatosi in
Francia, un funzionario dell’amministrazione, alla legge.
L’importanza delle regole logiche messe in luce dalla dottrina delle leges legum
rimane nel sec.XVII presso i giusnaturalisti moderni, che le considerano vincolanti per il
giudice ed il legislatore, in misura tale da non considerare legge obbligatoria quella che sia
in contrasto con esse.
Nel tardo giusnaturalismo poi questi principi svolgono la funzione dei principi della
scienza e la dottrina delle leges legum trova la propria collocazione nella parte generale
delle trattazioni sistematiche del diritto privato. In questo periodo infatti il diritto naturale è
utilizzato, da autori come Christian Wolff, per costruire un sistema giuridico naturalerazionale5, nel quale gli istituti del diritto vigente si possano collocare come deduzione da
superiori principi della ragione, secondo un ideale già perseguito da Leibniz, che aveva
considerato la giurisprudenza alla stregua di una scienza matematico-deduttiva (Barberis
1993, 15).
I principi del diritto perdono parte della loro importanza in seguito alle codificazioni
e al sorgere della dottrina giuspositivistica. Nel codice la razionalizzazione del sistema è
affidata al disegno tracciato dal legislatore, la conformità al quale assurge a criterio
esclusivo di individuazione delle norme giuridiche vincolanti. Molti principi razionali
vengono accolti, in quanto servono a garantire la certezza del diritto, ma non sono più
essenziali al fine di stabilire la natura legis.
Un rinnovato interesse per le leges legum si riscontra nella dottrina giuspositivistica
che intese reagire alle critiche antiformalistiche della seconda metà dell’800.
5E’
opportuno distinguere, in seno al giusnaturalismo moderno (sec.XVII e XVIII), un uso “politico” del
diritto naturale da uno “scientifico”. Il primo consiste nel richiamo al diritto naturale come diritto soggettivo
preesistente al sorgere della società e dello stato, con lo scopo di limitare il potere statuale. Chi pratica il
secondo invece considera il diritto naturale come un sistema razionale di norme, sulla base del quale conferire
coerenza, completezza e logicità al diritto vigente.
5
Come noto, uno dei caratteri della norma giuridica che gli antiformalisti
contestarono con vigore è quello della imperatività, del diritto come comando. La polemica,
se da una parte suscitò la reazione degli imperativisti (Bobbio 1993, 79), dall’altra indusse
molti teorici ad osservare che, accanto a prescrizioni rivolte ai consociati, vi sono
nell’ordinamento norme che si riferiscono ad altre norme, la cui funzione è quella di
razionalizzare il sistema.
Zitelmann, sulla base della sua esperienza di diritto internazionale privato, individuò
tre tipi di tali norme: le norme sulle fonti; le norme sull’interpretazione; le norme sul vigore
della legge nello spazio e nel tempo.
Betti ha definito queste regole, tra le quali si collocano le norme sull’interpretazione
della legge e sull’interpretazione dei contratti, “norme di secondo grado”, caratterizzate dal
fatto di concorrere a determinare la massima alla quale il giudice deve conformarsi nella
decisione del caso concreto (Giuliani 1982, 194).
Questa discussione ha messo in luce come le norme sulle fonti, ascritte alla
categoria delle “norme su norme”, si presentino sia come norme strumentali rispetto alle
altre, in quanto consentono all’operatore del diritto, in particolare al giudice, di individuare
il materiale normativo cui ricorrere, sia come regole procedurali sulla base delle quali
svolgere un controllo di legittimità della norma giuridica.
Nella letteratura italiana questo tipo di norme è indicato con i concetti di “norme per la
produzione giuridica”, “norme di struttura”, “norme di organizzazione”, mentre negli autori
di lingua inglese ci si riferisce ad esse definendole “power conferring rules” o “competence
norms” (Mazzarese 1996, 127).
La coscienza della peculiarità delle metanorme è da ricondurre soprattutto alla teoria
di Hart, secondo cui in tutti gli ordinamenti giuridici evoluti, caratterizzati dalla dinamicità,
non vi sono soltanto norme che regolano la condotta dei consociati, ma anche delle
secondary rules che regolano il modo in cui si producono altre norme.
Il carattere che accomuna le metanorme è quello di essere intrasistemiche (ad
eccezione della kelseniana Grundnorm), nel senso che, all’interno dell’ordinamento,
individuano nell’ordinamento dato i criteri di validità delle norme e delle fonti che le
producono. Esse si pongono quali “regole di chiusura”, cioè quali norme rivolte a garantire
la completezza e l’autosufficienza dell’ordinamento giuridico (Jori-Pintore 1995, 285).
Le metanorme di un ordinamento si possono raggruppare in due tipi: norme che
definiscono i criteri di validità di attività concernenti norme (produzione, applicazione,
revisione, abrogazione, interpretazione) e norme che attengono ai criteri di validità di altre
norme, diverse dall’essere il risultato di atti giuridici (Mazzarese 1996, 131).
Tra le metanorme del primo tipo si possono annoverare l’art.12 Prel.:
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore”; l’art. 15 Prel: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”
6
e l’art.139 Cost. “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale”.
Sono invece metanorme vertenti su norme quelle che ne limitano l’ambito di
validità sotto il profilo spaziale, personale, temporale, materiale, come l’art. 1 Prel.: “Sono
fonti del diritto:1) le leggi; 2) i regolamenti;3) le norme corporative; 4) gli usi” e l’ art.8
Prel.: “Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in
quanto da essi richiamati”.
Infine, è una metanorma vertente su norme quella che, in un ordinamento, è il
criterio ultimo di validità delle norme di questo. Si tratta del tipo di metanorma più
controverso perchè è extrasistemica. Essa può essere considerata, kelsenianamente, come
condizione logica trascendentale di possibilità di individuazione di un ordinamento, oppure,
hartianamente, in termini sociologici o in termini strettamente giuridici, come la norma che
individua i criteri di validità delle norme di revisione della Costituzione (Mazzarese 1996,
139).
In conclusione a queste brevi annotazioni sulla natura delle preleggi, si può
constatare come esse rappresentino un punto di incontro tra l’ideologia razionalisticagiusnaturalistica, che coltiva una visione del diritto come sistema di regole e principi
razionali indipendenti dall’arbitrio del legislatore, e quella giuspositivistica, connotata dalla
preoccupazione di garantire la certezza del diritto e volta ad escludere la libertà
dell’interprete nella soluzione dei problemi che l’applicazione della norma giuridica
inevitabilmente pone.
Codificando in apposite norme i principi che la tradizione gli ha consegnato, il
legislatore ne ha rivendicato la paternità, salvaguardando il primato della legge.
La formulazione di un elenco delle fonti di produzione deve essere posto in
relazione ad un’esigenza che non è soltanto ideologica ma anche, e soprattutto, di carattere
logico e razionale: quella di garantire l’unità dell’ordinamento.
L’unità di un sistema di norme, ha osservato Bobbio (1993, 176), sarebbe
massimamente garantito dalla loro provenienza ad opera di un’unica fonte di produzione.
Tuttavia, questa situazione non appare storicamente realizzabile.
Infatti, anche riconoscendo l’esistenza di un potere originario su cui si fonda
l’ordinamento, le norme da questo potere emanate non possono, da sole, esaurire
direttamente il bisogno di produzione giuridica. E ciò per due ragioni: innanzi tutto, perché
la società su cui sorge un ordinamento ha proprie regole sociali, morali e religiose, che
debbono essere recepite, tacitamente o espressamente, pena l’ineffettività dell’ordinamento
stesso; in secondo luogo, perché la necessità di una normazione continuamente aggiornata
impone la delegazione della produzione giuridica a centri subordinati al potere originario,
affinché specifichino le norme da questo emanate, come gli enti locali autonomi, in grado di
affrontare i problemi delle singole comunità ed i privati, cui viene riconosciuto uno spazio
entro il quale perseguire i propri interessi.
7
Di qui la necessità di porre ordine nella complessità del sistema delle norme,
stabilendo a quali condizioni e secondo quale ordine gerarchico esse appartengano
all’ordinamento giuridico.
La normativa sulle fonti contenuta innanzi al codice del 1942 è però esposta ad
un’importante critica, cioè quella di essere incompleta.
Il carattere di non esaustività dell’elenco delle fonti si è rivelato in tutta la sua
portata in seguito all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che, oltre ad avere
una forza ed un valore superiori alla disciplina precedente, ha previsto altri tipi di fonte.
Il sistema vigente deve dunque essere ricostruito coordinando il testo delle preleggi
con la Costituzione o, per essere più precisi, coordinando le prime, antecedenti al regime
costituzionale attuale e dotate (soltanto) di forza di legge ordinaria, con la seconda.
La rassegna delle fonti deve essere conclusa con l’aggiunta delle fonti comunitarie,
cioè con gli atti normativi emanati dalla Comunità Economica Europea, cui lo stato italiano
riconosce efficacia nel proprio ordinamento, direttamente o indirettamente.
Come è stato opportunamente sottolineato, neppure la disciplina costituzionale delle
fonti è completa, poichè esse risultano trattate non autonomamente, per il fatto di essere
fonti, ma sotto il profilo dei soggetti od organi titolari del potere normativo e dei loro
reciproci rapporti (Crisafulli 1968, 942). Ad esempio, la formazione delle leggi ordinarie è
prevista e disciplinata dalla Costituzione (artt. 70-82) in sede di trattazione dell’organo del
Parlamento; le disposizioni riguardanti le leggi costituzionali (artt.138 e 139 Cost.) sono
dettate in riferimento al problema delle garanzie costituzionali.
Di fronte a tale osservazione, ci si è chiesti se non sia possibile istituire, mediante
legge ordinaria, nuove fonti non stabilite in sede costituzionale.
Secondo il Crisafulli (1968, 940), l’incompiutezza del dettato costituzionale in
materia di fonti è intenzionale. Da una parte infatti, si è voluto garantire un sistema di fonti
“chiuso” a livello primario, nel senso che la legge non può creare fonti “concorrenziali”,
dotate della sua medesima forza o tali da escludere la competenza della legge. Dall’altra
viene concesso alla legge di conferire attribuzioni normative di grado subordinato e di
riconoscere fonti-fatto che non siano in concorrenza con essa.
La visione che risulta dalla lettura delle disposizioni sulle fonti del diritto esprime il
primato della legge ed è improntata al formalismo, dalla tendenza a considerare diritto
valido solo quello conforme a parametri predeterminati.
La dottrina tradizionale qualifica un fatto od atto come fonte di produzione del
diritto sulla base del “nomen iuris”, del contenuto tipico (indicato con “prevedere”,
“indicare”, “stabilire”, “prescrivere”) e delle forme di esternazione, cioè dei particolari
procedimenti attraverso i quali l’atto è emanato.
Dalla qualifica di fonte derivano poi conseguenze ben precise, le quali consentono
di affermare che la nozione non ha un rilievo soltanto teorico-dogmatico, ma anche tecnicogiuridico.
Innanzi tutto, soltanto la violazione, mediata o immediata, delle norme contenute in
una fonte riconosciuta può costituire un atto illecito per l’ordinamento; soltanto a queste
8
norme si applica il principio iura novit curia; solo a norme derivanti da una fonte del diritto
può farsi ricorso per stabilire i principi generali dell’ordinamento ai sensi dell’art.12, 2°
comma, delle Preleggi (analogia iuris); solo la violazione di una norma giuridica può essere
oggetto di ricorso per Cassazione, se compiuta da autorità giurisdizionali nell’esercizio
della funzione giurisdizionale. Infine, per le fonti legali sono dettate apposite regole di
interpretazione, diverse da quelle previste per gli altri atti giuridici, come il contratto
(Crisafulli, 935-36).
L’opinione del rilievo normativo della categoria delle fonti del diritto non è
condivisa dallo Zagrebelsky, secondo cui il regime giuridico di ciascun atto è determinato
dall’ordinamento attraverso specifiche disposizioni e non dipende dall’inclusione od
esclusione nel genus delle fonti del diritto. Non varrebbe a confutare questa tesi la
menzione del concetto nell’art. 1 delle Preleggi, non solo perchè esso è incompleto, ma
soprattutto perché la disciplina di ciascuno degli atti ivi indicati come “fonti” è fissata in
norme specifiche e non è mai riferibile ad una nozione ampia di “fonte del diritto”
(Zagrebelsky 1984, 7.).
La teoria delle fonti che si cela dietro alla formulazione di disposizioni sulla
produzione giuridica intende, non inconsapevolmente, prescrivere al giudice di attenersi
principalmente alle fonti legali, agli avvocati di ricercare solo in esse le norme giuridiche di
cui chiedere l’applicazione, ai funzionari di svolgere i rispettivi compiti attraverso
l’osservanza scrupolosa delle norme dettate dal legislatore, giudicando possibile stabilire,
mediante il ricorso a schemi precostituiti, che cosa sia il diritto in una società.
La stessa dottrina di ispirazione formalistica, di fronte ad alcuni atti di incerta
classificazione, ha avvertito l’insufficienza dei criteri elaborati.
Ad esempio, l’atto risultante da referendum abrogativo ex art.75 Cost. non può
essere qualificato o meno come fonte legale sulla base dei tradizionali criteri formalistici, in
quanto produce effetti di innovazione del diritto preesistente, ma segue un procedimento ed
ha forme di esternazione del tutto peculiari.
Dubbi analoghi si pongono per le sentenze della Corte Costituzionale, incluse da
alcuni autori tra le fonti del diritto per il loro effetto di eliminazione di leggi e norme di
legge.
Il sistema formale delle fonti di produzione rivela la propria fragilità già
dall’interno, se si esaminano due particolari categorie di fonte: la consuetudine e le fonti
extra ordinem.
La consuetudine è riconosciuta dallo stesso art.1 delle disposizioni preliminari, ma
relegato dal legislatore ai margini dell’ordinamento, quale fonte meramente sussidiaria: la
consuetudine.
L’art. 8 prel. afferma infatti che gli usi o consuetudini hanno efficacia nelle materie
già disciplinate da leggi o regolamenti e solo qualora espressamente richiamati da tali fonti;
l’art. 15 Prel. comporta che una disposizione contenuta in una legge non possa essere
abrogata o modificata da una consuetudine.
9
Da una stretta interpretazione di queste disposizioni deriva l’ammissibilità della
consuetudine c.d. secundum legem, integratrice di regole legislative o regolamentari, non
invece quella della consuetudine praeter legem, la quale intervenga in materia non regolata
da altre fonti sovraordinate, e della consuetudine contra legem, da cui si ricavino norme
contrastanti con quelle legislative.
La legge, per il suo carattere di ius scriptum, appariva meglio garantire la certezza
del diritto, in quanto rendeva più agevole individuare le norme giuridiche esistenti ed il loro
significato. A questo motivo si affiancava la più rapida produzione giuridica per mezzo
della legge, che consente di adeguare più facilmente il diritto ai mutamenti che
intervengono nella società, a differenza della consuetudine la cui formazione richiede la
ripetizione di un comportamento per un lungo periodo.
La dottrina tende invece a riconoscere efficacia anche alla norma consuetudinaria
nelle materie in cui nessuna altra fonte di rango superiore detti una disciplina, senza
peraltro produrre l’effetto di mutare la fisionomia del sistema , dal momento che le materie
di maggior rilievo sociale sono quasi sempre regolate legislativamente.
La constatazione della circostanza che la consuetudine abbia una forza propria,
indipendente dalla voluntas legis, induce il Modugno a negare che ad essa sia applicabile il
concetto dogmatico di fonte del diritto.
Di fonti del diritto si dovrebbe parlare solo in riferimento a quelle fonti costruite ad
hoc dall’ordinamento (le c.d. fonti-atto), non invece alle fonti- fatto, che contengono in sé il
proprio principio di qualificazione: “ E’ l’efficacia reale di queste ultime che rende
possibile qualificare come normativo il fatto dal quale derivano e nel quale è pure
immanente la norma di legittimazione. E’ il criterio di effettività-verificabile a posterioriche caratterizza e condiziona la legittimità del fatto normativo” (Modugno 1989, 23).
Quanto alla categoria delle fonti extra ordinem, si tratta di fonti non disciplinate da
disposizioni sulla produzione giuridica, ma operanti sulla base del principio di effettività,
che funziona come norma sulla produzione (Pizzorusso 1977, 540).
Quella delle fonti extra ordinem è una categoria eterogenea di fatti normativi, che si
pongono in alternativa a quelli legali e possono, caso per caso, prevalere su di essi in
ragione di fattori extragiuridici. Esse costituiscono un caso in cui la dissociazione tra
modelli seguiti dalle fonti formali e modelli messi in atto è approvata dalla comunità
giuridica (Monateri 1992, 392).
Sono da annoverare tra queste fonti fattuali, innanzi tutto, l’instaurazione e
l’estinzione dell’ordinamento giuridico.
Da annoverare nella categoria in esame anche la consuetudine contra legem, la
quale come abbiamo sottolineato, non è considerata ammissibile nell’ordinamento giuridico
italiano. Essa è un fatto normativo che presenta la stessa struttura della consuetudine
secundum e praeter legem ma che ottiene osservanza pur essendo in contrasto con una
norma scritta. Più precisamente, è una fonte extra ordinem poichè deroga alle norme sulla
produzione giuridica sulla base del solo principio di effettività, non potendo tale deroga
fondarsi sulla opinio iuris.
10
Si fondano sul principio di effettività anche le convenzioni tra organi costituzionali,
qualora riescano a produrre efficacia erga omnes, oltre la sfera dei rapporti interni tra gli
organi partecipanti alla convenzione.
Vi sono poi gli atti dell’esecutivo che, pur previsti e disciplinati dalla legge, producono
effetti oltre il proprio ambito legale.
Ciò avviene, ad esempio, per le circolari, atti con cui un organo della Pubblica
Amministrazione informa gli uffici subordinati od anche terzi estranei dell’avvenuta
emanazione di un atto e ne fornisce l’interpretazione. Quando la circolare è solo
apparentemente interpretativa, ma in realtà produttiva di norme, assume nella gerarchia
delle fonti il livello degli atti che l’organo da cui proviene può legittimamente emanare (di
solito un regolamento).
Normalmente la circolare contrastante con norme superiori può essere impugnata ed
annullata. Quando tuttavia questo non avviene (perchè gli uffici dipendenti credono di
ottemperare ad un ordine legittimo o insindacabile, oppure gli estranei non impugnino
tempestivamente o non venga loro riconosciuto l’interesse processuale a farlo), le circolari
invalide operano come fonte del diritto extra ordinem (Pizzorusso 1977, 554).
La categoria delle fonti extra ordinem pone in discussione molti dei dogmi
tradizionalmente sostenuti dalla teoria del diritto formalistica. In particolare, la
constatazione della esistenza di fonti non previste né esplicitamente né implicitamente dalla
legge, ma fondate sul principio di effettività, confligge con il carattere della completezza
dell’ordinamento giuridico e comporta la rinuncia a reperire in quest’ultimo tutto il diritto
(Meneghelli 1992, 255).
2. L’ideologia tradizionale delle fonti e l’autocritica giuspositivistica
L’ideologia che si pone a fondamento del sistema delle fonti del diritto fino ad ora esposto è
quella del positivismo giuridico, che in questo contesto può essere definito come una
concezione secondo la quale il diritto è atto di volontà dell’uomo. Le origini di tale visione
sono relativamente recenti e vanno individuate nel fenomeno delle codificazioni
ottocentesche, che offrirono agli studiosi del diritto un corpo di disposizioni coerente,
unitario e sistematico.
Tra le correnti filosofiche che contribuirono al movimento delle codificazioni,
quella che maggiormente influenzò la concezione del sistema delle fonti del diritto fu
proprio il volontarismo (Tarello 1988, 2)6.
6E’
da notare come il rilievo attribuito da Tarello al volontarismo nella formazione delle codificazioni
ottocentesche non appaia condiviso, nella sua portata, dal Fassò il quale sottolinea invece come sia stata
soprattutto l’idea di un modello di diritto razionale ed immutabile, il diritto naturale, a influenzare, sul piano
filosofico, i codici. Il volontarismo avrebbe finito per prevalere su questa genesi giusnaturalistica soprattutto
per l’interesse dei sovrani a riservarsi il monopolio della produzione del diritto. “(...)A lungo andare
l’elemento giusnaturalistico-razionalistico verrà dimenticato, e i giuristi, nella loro grandissima
maggioranza, riterranno che motivo sufficiente e necessario della validità della norma -ossia della sua
11
Si tratta di un modo di intendere il diritto che deriva dal pensiero di Hobbes, ma che
affonda le proprie radici nell’opera di Pufendorf, per il quale il diritto è volontà dell’autorità
suprema. Il volontarismo presentava alcune implicazioni destinate a produrre ripercussioni
profonde e durature nella teoria del diritto contemporanea: l’immagine del diritto non come
un insieme di asserzioni ma come un insieme di comandi (imperativismo) e la
considerazione della conoscenza del diritto come conoscenza della volontà del legislatore,
con il conseguente rilievo attribuito ai lavori preparatori e all’occasione della legge quali
criteri guida per l’interprete.
Una volta penetrato nei codici, il volontarismo rappresentò il seme da cui germogliò
il positivismo giuridico ottocentesco, per il quale è diritto valido solo quello posto dallo
stato attraverso i suoi organi.
Le più importanti scuole di diritto sviluppatesi in questo periodo in Europa, cioè la
Scuola dell’Esegesi in Francia, la Pandettistica e la Allgemeine Rechtslehre in Germania,
fecero propri il volontarismo che il positivismo giuridico statualistico comportava, anche
perché la riduzione del diritto a posizione dell’autorità sovrana semplificava l’oggetto del
loro studio, offrendo l’illusione di poter costruire una scienza giuridica rigorosa. La visione
delle fonti del diritto che si delineò, e che nonostante la reazione antiformalistica
manifestatasi nella seconda metà dell’800 ha improntato di sé gli studi giuridici fino a
tempi recenti, è caratterizzata dalla considerazione delle fonti stesse come fatti normativi,
cioè atti o fatti cui l’ordinamento riconosce la possibilità di creare diritto, tra i quali assume
una indiscussa posizione di supremazia la legge statuale, fulcro del sistema copernicano
delle fonti a discapito del diritto consuetudinario, giudiziario, giurisprudenziale ed
internazionale.
La visione delle fonti e del diritto sta subendo però un processo di revisione che,
stimolato inizialmente dal nuovo vigore delle critiche di matrice giusnaturalistica del
dopoguerra, nonché dallo sviluppo di orientamenti di tipo istituzionalistico e realistico,
viene ora condotto all’interno dello stesso giuspositivismo il quale, accolte le premesse
epistemologiche della filosofia analitica, ha intrapreso una nuova riflessione sul proprio
oggetto e sul proprio metodo.
In Italia il processo di autocritica svoltosi all’interno del giuspositivismo, iniziato
con Bobbio e Scarpelli, ha condotto a respingere o modificare profondamente le sue tesi
fondamentali, tanto da indurre ad affermare che non sia più lecito parlare di un
giuspositivismo italiano, in quanto si è verificato il passaggio ad un “post-positivismo”
giuridico ed analitico (Jori 1987, 2).
Nel corso di questa discussione si sono registrati diversi modi di intendere il
giuspositivismo.
giuridicità- sia la posizione di essa da parte del legislatore, ma a ciò si arriverà gradatamente, con un
processo che ha il suo inizio nella convinzione che la volontà del legislatore sia razionale (...).” (Fassò 1994,
27).
12
Per i suoi sostenitori il termine indica un approccio avalutativo al diritto (Bobbio),
oppure la separazione tra diritto e morale e, infine, la necessità di mantenere distinti i
giudizi di fatto da quelli di valore.
Da parte dei suoi critici, il giuspositivismo è stato rappresentato come ideologia per
cui il diritto è intrinsecamente giusto, con il conseguente obbligo di obbedienza alla legge
indipendentemente da considerazioni di ordine morale.
Altri autori ne hanno invece messo in luce alcuni caratteri “intermedi”: la sua
configurazione come teoria del diritto legalistica e come metodo di analisi dei concetti
giuridici. Mentre alcuni tra questi scrittori ritengono che in questa accezione il
giuspositivismo possa far conquistare alla giurisprudenza la tanto ambita avalutatività, altri
(ad esempio Scarpelli) hanno sostenuto che il legalismo e l’analisi dei concetti siano mezzi
attraverso i quali i giuristi, credendo di ottenere l’avalutatività, cadono in realtà
nell’ideologia della valutazione favorevole del diritto positivo, con la conseguenza che la
scelta politica iniziale sarebbe soltanto “occultata”(Jori 1987, 5).
Posta questa premessa, la linea evolutiva del giuspositivismo, in particolare italiano,
negli ultimi decenni può essere descritta analizzando i diversi modi di intendere la norma
giuridica (dal momento che il positivismo giuridico è anzitutto riduzione del diritto a
norma) al fine di evidenziare come anche la teoria delle fonti abbia subito un notevole
mutamento. E’ possibile così osservare che al primo giuspositivismo, per il quale la norma
giuridica è comando, ne è seguito un altro per il quale la norma è invece un oggetto
impersonale, un discorso, una realtà sociale.
La principale critica rivolta all’imperativismo tradizionale è stata quella di essere
“ingenuo”, in quanto la relazione giuridica normativa non è una relazione personale, anche
se le situazioni della norma e del comando presentano alcune analogie7.
La seconda fase del giuspositivismo è quella inaugurata da Kelsen per il quale il
diritto è norma, ovvero regola di condotta che esprime, nella forma logica del giudizio
ipotetico, un “dover essere”.
Anche se la sua teoria normativistica rappresenta un determinante passo verso il
superamento della concezione del diritto come comando, sono ancora presenti in questo
Gli aspetti comuni alla norma ed al comando, come è stato indicato Pattaro 1994, 583-88 sono i
seguenti: in entrambe i casi al soggetto avverte un impulso ad agire immotivato (cioè non determinato da suoi
desideri, interessi, valutazioni) associato alla reppresentazione di un comportamento da tenere; in tutte e due le
situazioni l’impulso ad agire è provocato da una’espressione imperativa; tanto nella situazione normativa
quanto in quella del comando chi sperimenta l’impulso volitivo avverte un senso di costrizione interiore.
Rispetto a queste affinità prevalgono però le differenze. Occorre sottolineare innanzi tutto come il
comando, per essere efficace, richieda un appropriato rapporto tra chi lo emette ed il suo destinatario
(possibilità di esercitare una suggestione diretta mediante la minaccia di una sanzione) mentre nella norma
l’espressione imperativa agisce di forza propria, è interiorizzata dal soggetto che sperimenta i comportamenti
prescritti come intrinsecamente doverosi. In secondo luogo, il comportamento prescritto nella norma è
“universalizzabile”, è considerato da chi lo deve osservare come doveroso per qualsiasi altro soggetto che, nel
gruppo sociale, si trovi nella medesima situazione. Infine, la prescrizione normativa suscita un senso del
dovere associato al comportamento da tenere, mentre di fronte al comando il destinatario osserva la condotta
soltanto per sottrarsi alle conseguenze di fatto (la sanzione) previste per l’inosservanza.
13
autore residui di volontarismo. Questo può essere affermato sia in riferimento al noto
concetto di imputazione, che implica un atto di volontà umano il quale, assunto un fatto
come condizione, vi attribuisca la conseguenza della sanzione, sia tenendo conto della
evoluzione del suo pensiero negli anni “americani”.
Il contatto con gli orientamenti presenti nella cultura di Common Law a partire dal
1941 -il realismo giuridico e l’analytical jurisprudence- inducono Kelsen a distinguere tra
le asserzioni sulle norme e le norme, con la conseguenza che il carattere di giudizio
ipotetico viene ora considerato proprio solo delle prime, mentre vengono enfatizzati i tratti
imperativistici della norma giuridica e della stessa Grundnorm8.
Resta lecito ritenere che il sistema delle fonti del diritto configurato nella dottrina pura del
diritto kelseniana si differenzi sostanzialmente dalla tradizione giuspositivistica a lui
precedente.
Innanzi tutto, perché l’intero ordinamento viene fondato su una norma fondamentale
che non è positivamente emanata, ma “presupposta”: è la costituzione in senso materiale e
rappresenta un sostrato preesistente all’opera del legislatore, dal quale questi deve partire e
che non può modificare arbitrariamente.
Inoltre, nello Stufenbau kelseniano il sistema normativo appare non più legato
all’idea della legge come atto normativo per eccellenza ma ha un carattere “dinamico”: la
maggior parte delle norme sono sia applicazione (di una norma superiore), che creazione
(potenziale) di una norma inferiore, in modo che non solo la Costituzione e la legge si
configurano come fonti, ma anche la sentenza del giudice, il negozio giuridico, l’atto
amministrativo. La pura creazione e la pura applicazione si trovano, rispettivamente,
soltanto agli estremi superiore ed inferiore dell’ordinamento giuridico.
Il sistema delle fonti configurato nella dottrina di Kelsen, secondo lo Zagrebelsky
(1984, 35) presta però il fianco ad un’obiezione rilevante.
Esso postula una coincidenza tra effettività e legittimità dell’ordinamento, cioè un
ordinamento fisso. La sua dottrina perciò consente di prendere atto solo di una
trasformazione, quella radicale che consiste nel passaggio da una norma fondamentale
all’altra attraverso la rivoluzione. Vengono trascurate invece le trasformazioni graduali e
quotidiane del sistema costituzionale, almeno fino a quando il vecchio ordinamento non si
possa considerare sostituito, attraverso graduali trasformazioni, da un ordinamento nuovo.
La dottrina di Kelsen non si accorda per questo con l’instabilità permanente delle
forme di vita collettiva del nostro tempo, la quale conduce a sviluppi graduali, non a
trasformazioni radicali quali l’alternanza monarchia-repubblica, autocrazia-democrazia,
democrazia liberale-democrazia socialista.
Il grande seguito della dottrina pura del diritto tra i giuristi positivisti, ottenuto
nonostante l’allontanamento dalle tradizionali concezioni strettamente imperativistiche e
8La
iniziale indistinzione in Kelsen tra norme ed asserzioni della dottrina su di esse può essere attribuita
alla tradizione tedesca del Juristenrecht, secondo la quale le norme non sono formulate dal legislatore ma
dalla dottrina giuridica. Tale tradizione ha indotto l’autore ad attribuire alle norme quella forma ipotetica
conveniente piuttosto alle asserzioni dottrinali. (Barberis. 1993, 157).
14
statualistiche, è da attribuire al fatto che la teoria della Grundnorm si presta ad essere
interpretata come “metodologia immunizzante” che consente alla giurisprudenza di studiare
il diritto senza ricorrere a considerazioni, morali o sociologiche, distruttive delle pratiche
giurisprudenziali diffuse (Jori 1987, 19). La sua “nomodinamica”, ovvero lo spostamento
dell’attenzione dalla singola norma al complesso delle norme (impostazione seguita, tra gli
altri, da Hart e Bobbio) , consente di ridurre l’elemento ideologico dell’imperativismo senza
cadere nella ricerca di norme alternative a quelle positive, quali quelle del diritto naturale, e
senza ridurre la giurisprudenza a sociologia giuridica.
Gli ultimi rilevanti sviluppi del giuspositivismo kelseniano, che conducono
l’imperativismo classico ad un ulteriore grado di dissoluzione, sono dati dal suo incontro
con il positivismo logico, secondo cui la norma è un’entità linguistica, un significato
portato dal linguaggio e più precisamente un significato prescrittivo. Lo stesso diritto è un
discorso o linguaggio, con la conseguenza che la conoscenza del diritto è conoscenza del
linguaggio delle norme giuridiche da parte della giurisprudenza (il cui discorso è un metadiscorso), che la teoria generale del diritto è concepita come un tentativo di rendere
sistematico il linguaggio della giurisprudenza e che non è accettabile la pretesa
giusnaturalistica di conoscenza obiettiva dei valori di giustizia, data la inderivabilità logica
di giudizi di valore o normativi da premesse fattuali.
Per quanto riguarda questa fase del kelsenismo, si può osservare come l’incontro tra
normativismo e filosofia analitica e la susseguente configurazione della norma in termini di
linguaggio prescrittivo si ponga in tensione con l’esigenza di concepire il diritto come
realtà9.
Questa tensione consente di spiegare il passaggio del giuspositivismo, in particolare
quello italiano, ad una fase successiva che si compie con l’opera di Herbert Hart, per il
quale il diritto positivo è costituito, come per Kelsen, da norme che sono innanzi tutto una
pratica sociale, anche se gli aspetti linguistici, ovvero le reazioni verbali a situazioni sociali
nelle quali si dice che esista una norma, sono essenziali nella spiegazione del diritto (Jori
1987, 30).
9Una critica radicale alla convinzione che l’incontro tra il kelsenismo e l’empirismo logico abbia
conferito al giuspositivismo il titolo ad essere considerata l’unica forma di conoscenza scientifica del diritto è
stata formulata dal Pattaro. L’autore osserva come la pretesa di avalutatività del positivismo giuridico
analitico sia stata messa in discussione, in Italia, dai suoi stessi sostenitori. Lo Scarpelli, come è noto, pur
esprimendo la propria scelta a favore del metodo giuspositivistico ne ammette la scelta ideologica di partenza
(consistente nell’accettazione del diritto positivo come unico criterio-guida delle azioni) e finisce per
annoverarlo tra le attività politiche; Bobbio invece distingue tra la ideologia e la teoria del diritto
giuspositivistica ritenendo erroneamente, secondo Pattaro, che la scelta ideologica possa non influenzare il
metodo di studio del diritto. In realtà, conclude Pattaro, l’applicazione dei presupposti epistemologici della
filosofia analitica (avalutatività della scienza e metodo della ricerca positiva) al diritto non può che condurre
allo studio del diritto come fatto, al modo dei giusrealisti della scuola di Uppsala, cioè all’accertamento del
significato semantico dei concetti giuridici e della loro funzione pragmatica nei diversi contesti (discorso del
legislatore, del giudice, del giurista e del teorico generale del diritto) (Scarpelli 1976, 451ss.)
15
La validità delle norme deriva dalla rule of recognition, una norma a sua volta creata
dalla pratica sociale: essa è quella che si manifesta (“is shown”) dal modo in cui i
consociati, ed in particolare i giudici, individuano il diritto valido.
Nella maggior parte dei casi la norma di riconoscimento non viene dichiarata,
ma la sua esistenza si manifesta nel modo in cui vengono individuate le norme
particolari, da parte dei tribunali o di altri funzionari o dei privati o dei loro
consiglieri (Hart 1991, 120)
La validità non è più esistenza specifica della norma, ma appartenenza della
medesima all’ordinamento secondo i criteri della norma di riconoscimento.
Questo concetto di validità comporta che la descrizione del diritto sia anche descrizione
sociologica e questa convinzione è espressa da Hart attraverso la celebre distinzione tra
aspetto esterno ed interno.
Il primo è quello messo in luce dalla descrizione, da parte del giurista, del fatto che
esistono norme giuridiche effettive nella società; il secondo nella descrizione delle norme
effettive osservate e nella qualificazione dei fatti e degli atti sociali attraverso quelle norme,
considerate ora come criteri accettati ed utilizzati dai consociati nell’individuare le regole
obbligatorie (le norme primarie). Nello studio del diritto il giurista deve occuparsi di
entrambe gli aspetti.
Il sistema delle fonti del diritto che risulta da questa teoria si caratterizza per la sua
varietà e duttilità. Per Hart infatti la norma di riconoscimento può individuare il diritto
valido “(...)In riferimento a un testo dotato di autorità, a un provvedimento legislativo, alla
pratica consuetudinaria, a dichiarazioni generali di persone specificate, o a decisioni
giudiziarie pronunciate in casi particolari (Hart 1991, 119).”
Da questo punto di vista sembra tutt’altro che casuale la mancanza in The Concept
of Law di un capitolo dedicato espressamente al sistema delle fonti (la trattazione del quale
è assorbita nel Cap. VI riguardante la rule of recognition), in quanto la norma di
riconoscimento implica un ordinamento “aperto” alle pratiche sociali di reperimento del
diritto, che non si presta ad una descrizione “statica”.
Un ordine gerarchico tra le fonti del diritto si ha anche nell’ordinamento di Hart e
tuttavia non si tratta della stessa gerarchia configurata da Kelsen come derivazione da una
norma superiore, ma di una gerarchia determinata da criteri che sono stabiliti nella stessa
norma di riconoscimento. Se infatti ogni ordinamento contiene criteri in base ai quali una
norma deve essere considerata, in caso di conflitto, subordinata ad un altra, ciò non
significa che la medesima derivi da quella sovraordinata.
(...)E tuttavia esse (le norme subordinate ad altre) devono la loro natura
giuridica, per quanto precaria, non ad un esercizio “tacito” di potere legislativo
ma all’accettazione di una norma di riconoscimento che attribuisce loro questa
posizione indipendente per quanto subordinata. (Hart 1991, 119)
16
La varietà di fonti del diritto non dipende in questo modo dalla circostanza che tra la
costituzione e gli atti di mera applicazione sia individuabile una costruzione a gradini ma,
ancora una volta, dai criteri accettati ed utilizzati nella società ai fini della qualificazione
normativa dei fatti.
Gli sviluppi del giuspositivismo di tipo analitico dopo Hart hanno condotto ad una
crisi della c.d. “terza via” kelseniana, che permetteva di configurare una scienza normativa
intermedia tra lo studio etico-politico e la sociologia giuridica empirica. Le direzioni
assunte dagli studi analitici del diritto sono state, in Italia, quella dell’approccio sociologico
empirico, per cui le norme sono espressioni linguistiche parte della realtà sociale, e quella
degli studi logici, nei quali le norme sono considerate espressioni linguistiche pure, astratte
dalla realtà sociale.
Per quanto la prospettiva giuspositivistica di stampo ottocentesco appaia ormai
superata, la concezione delle fonti del diritto non può, a nostro avviso, giungere a ripudiare
interamente un approccio di tipo formalistico10.
Nel contesto di questa affermazione per formalismo intendiamo l’esistenza di un
metodo di scelta seguito dal giurista (giudice, studioso, avvocato, funzionario) al fine di
selezionare le norme che deve assumere nel ragionamento pratico, cioè nella decisione del
caso concreto (Jori 1980, 13). Questo formalismo pratico consiste nella scelta delle norme
di decisione sulla base di altre norme, ovvero metanorme, norme superiori, norme di
riconoscimento.
In particolare il diritto non può fare a meno di utilizzare criteri formali di selezione
delle norme, cioè criteri consistenti nell’uso di formule linguistiche o in altre tecniche: la
richiesta di un certo contenuto prescrittivo, il rispetto di procedure o competenze (ad
esempio il procedimento legislativo), il compimento di certe formalità materiali collegate al
testo, scritto od orale, della norma.
L’obiezione, che sorge immediata, secondo la quale tale formalismo finisce per
sacrificare le esigenze del caso concreto in favore di esigenze astratte di uguaglianza e
certezza del trattamento giuridico, configurando un sistema delle fonti impermeabile al
fluire della vita sociale, non coglie nel segno da due punti di vista.
In primo luogo, la decisione dei casi singoli in base a norme logicamente precedenti, in altri
termini la tensione tra giustizia ed equità, non è propria soltanto del diritto ma anche di altri
sistemi normativi (ad esempio quello della morale).
10Sull’uso
del termine “formalismo” nel diritto, ci sembra, ancora una volta, utile richiamare uno studio
di Bobbio. L’autore individua tre tipi di formalismo: un formalismo etico, che consiste nella convinzione che
sia giusto ciò che è conforme alla legge (Hobbes); un formalismo giuridico, secondo cui la caratteristica del
diritto non è quella di prescrivere ciò che un individuo deve o non deve fare, ma semplicemente il modo in cui
ciascuno deve agire per raggiungere i propri scopi. Esso non riguarda il contenuto, ma la forma che il rapporto
intersoggettivo deve assumere per produrre conseguenze giuridiche (Kant); un formalismo scientifico, che
riguarda la concezione della scienza giuridica, il cui compito sarebbe quello di costruire un sistema di concetti
del diritto ricavabili dal diritto positivo, in modo da dedurne la soluzione di tutti i possibili casi controversi.
17
In secondo luogo, il formalismo inteso quale individuazione delle norme in base a
metanorme non comporta, di per sè, un sistema delle fonti completamente formalizzato, una
struttura gerarchica delle fonti, il ricorso a norme scritte o con un testo standard (Jori 1981,
35). Infatti, le norme possono essere individuate mediante diverse tecniche, non
necessariamente con la stessa (ad es. l’inclusione in appositi elenchi da parte della legge),
inoltre non è necessario che nell’ordinamento vi siano norme protette formalmente, in
maniera da risultare gerarchicamente superiori alle altre (si pensi all’ordinamento inglese,
nel quale le norme della legislazione ordinaria non sono sovraordinate al precedente
giudiziario, nè vi è un testo scritto avente rilievo costituzionale), ed infine non è necessario
che le norme rivestano una forma linguistica fissa (si pensi ancora alle regole di diritto che
si formano negli ordinamenti di Common Law per effetto dello stare decisis).
Se una pur approssimativa conclusione si vuole azzardare a trarre sullo stato del
dibattito teorico attuale circa le fonti del diritto, si possono constatare la rinuncia a fornirne
un quadro esaustivo e definitivo e la consapevolezza circa la rapidità con cui i criteri di
individuazione delle norme valide in un ordinamento possono variare, atteggiamento che
sembra ben rappresentato dalla definizione di Alf Ross:
Per “fonti del diritto”, allora, s’intende l’insieme dei fattori che influiscono sulla
formulazione della norma che sta a fondamento della decisione del giudice, con
la precisazione che questa influenza può variare: da quelle fonti che forniscono
al giudice immediatamente una norma che egli non deve far altro che
riconoscere valida, a quelle fonti che gli offrono soltanto idee ed ispirazioni,
dalle quali egli stesso deve trarre la norma di cui ha bisogno. (Ross 1990, 74)
Questo approccio problematico è legato non solo alla riflessione teorica che
abbiamo tentato di illustrare, ma anche a fenomeni da tempo in atto quali il processo di
perdita di centralità della legge e quello, strettamente connesso, del declino dello stato
nazionale sovrano.
3. La crisi della legge parlamentare
Gli ordinamenti giuridici contemporanei presentano una profonda trasformazione dei
rispettivi sistemi delle fonti di produzione del diritto.
Il fenomeno si manifesta soprattutto nella perdita del proprio ruolo privilegiato da
parte della legge, sommersa da una produzione normativa caotica e sempre meno
controllabile, che assai poco si presta a teorizzazioni volte a conferire al sistema delle fonti
limpidezza e definitività.
Questo decadimento della legge del Parlamento, concepita nello stato di diritto
ottocentesco quale strumento principale di governo, risulta icto oculi dalla stessa lettura
18
delle disposizioni emanate dal legislatore, affette da difetti tecnici di formulazione anche
molto gravi, denunciate con la complessiva espressione di “sciatteria legislativa”.
Nello svolgimento della trattazione l’analisi sarà rivolta al sistema normativo dello
stato italiano, che rappresenta però il paradigma di una situazione diffusa in gran parte degli
ordinamenti di Civil Law.
Innanzi tutto, occorre rilevare l’amplissimo numero di leggi vigenti
nell’ordinamento giuridico, stratificatesi nel tempo e non periodicamente sfoltito. La forte
incertezza determinatasi ha condotto la Corte Costituzionale a relativizzare il noto
principio, sancito dall’art.5 del Codice Penale, secondo il quale error vel ignorantia iuris
non excusant, ammettendo la possibilità di configurare un’ignoranza scusabile che esenta
l’autore della condotta illecita da responsabilità11.
Assai deleterio, in quanto attribuisce una delega in bianco all’interprete, è il
frequente uso della c.d. clausola di abrogazione innominata, con la quale il legislatore, nel
momento in cui emana una nuova disposizione, dichiara abrogate tutte le altre disposizioni
con questa incompatibili, senza ulteriori specificazioni.
Molto diffuso è altresì il fenomeno dell’“intreccio di leggi”, che consiste
nell’inserimento, in una legge con un determinato titolo o dedicata ad un determinato
argomento, di articoli che disciplinano materie completamente diverse, con la conseguenza
di vanificare ogni tentativo di interpretazione sistematica.
Ai difetti sopra elencati se ne aggiunge un altro, forse il più gravido di conseguenze ed il
più noto, cioè quello dell’imperfetta stesura delle leggi. Le leggi sono scritte con un
linguaggio impreciso ed atecnico, non di rado mutuato da quello politico e risultano di
difficile lettura sia per la loro estenuante lunghezza che per il richiamo a leggi o decreti di
cui si indicano solo la data ed il numero, il cui contenuto sfugge ad una prima lettura del
testo.
E’ stato sostenuto (Ainis 1997, 124-26) che le leggi oscure sono incostituzionali.
Anche se manca infatti nella Costituzione una disposizione che richieda espressamente la
chiarezza della legge, tale requisito è dato per presupposto da numerosi articoli. Ad
esempio, da quelli che sanciscono il principio di legalità (artt. 97, 101, 13 e 25) e
dall’art.73, che subordina l’entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, intesa come
formalità strumentale alla conoscenza del diritto da parte dei consociati, conoscenza che
presuppone innanzi tutto la chiarezza del testo normativo.
L’armonia del sistema è fortemente incrinata anche dall’eccesso della legislazione
di dettaglio, che consiste nella produzione delle c.d. “leggine” e delle “leggiprovvedimento”, destinate a soggetti e situazioni individuali e concrete (Italia 1990, 9-18).
Si è poi enormemente diffusa la decretazione di urgenza, degenerata ad ordinario strumento
di amministrazione, alla quale si ricorre anche in assenza dei rigorosi presupposti di
11La
storica sentenza di cui trattasi è la n.364 del 1988 (pubblicata sulla Rivista Italiana del 1988, 686)
che configura l’ignoranza incolpevole nei casi di forza maggiore (ad es. la mancata diffusione della Gazzetta
Ufficiale a causa di uno sciopero) e di errore determinato da fonte qualificata (ad es., parere autorevole ma
ingannatorio di un giurista).
19
necessità ed urgenza con i quali il costituente ha delimitato l’istituto (art.77 Cost.). Soltanto
recentemente la Corte Costituzionale, con sentenza dell’ottobre 1996, n.360, è intervenuta
riguardo a questo problema, preoccupandosi in particolare di arginare la nota prassi della
reiterazione dei decreti-legge non convertiti, la quale consentiva di fatto al potere esecutivo
di appropriarsi di una funzione legislativa non riconosciutagli dal costituente12.
La perdita di centralità della legge è resa palese dal forte ridimensionamento dello
strumento che può essere considerato l’emblema della pretesa del legislatore di avocare a sé
la disciplina della vita sociale: il codice. Con espressione divenuta celebre tra gli studiosi
della metamorfosi contemporanea del sistema delle fonti, Natalino Irti (1979, 27) ha
affermato che l’epoca attuale può essere definita l'“età della decodificazione”.
I fattori di questo importante processo, tuttora in atto, sono stati presi in esame da
Irti in relazione al codice civile del 1942, ma appaiono riferibili anche agli altri codici.
La decodificazione, cioè la perdita di centralità del codice nel sistema delle fonti,
affonda le proprie radici nel primo dopoguerra, quando la crisi economica ha condotto ad
un mutamento del ruolo dello stato il quale, da semplice garante dei diritti degli individui
ed arbitro del rispetto delle regole del gioco del mercato, quale era concepito dal pensiero
liberale, è intervenuto nell’economia anche limitando l’autonomia privata (Irti 1979, 14).
Sul piano giuridico questo mutamento si è tradotto in un incremento della
produzione di leggi speciali, volte a soddisfare le nuove esigenze sociali ed economiche13.
La “specialità” di queste leggi ne connota tre caratteristiche: la collocazione al di
fuori del corpo del codice, la previsione di una disciplina nuova e diversa da quella
codicistica e l’applicabilità ad un settore specifico collocato all’interno della materia
regolata dal codice. Nell’ambito della categoria è fondamentale distinguere tra leggi speciali
“specializzanti”, che svolgono una disciplina contenuta nel codice, le quali potrebbero
essere considerate le leggi speciali in senso proprio, conformi al concetto stesso di
specialità; leggi speciali che invece esprimono principi diversi da quelli del codice. Le
prime sono applicabili mediante analogia legis, mentre per l’analogia iuris occorre fare
riferimento al codice, le seconde possono costituire oggetto anche di analogia iuris: i loro
principi devono essere annoverati tra quelli dell’“ordinamento giuridico dello stato”.
E’ a queste ultime che può essere attribuita la conseguenza della decodificazione,
poiché non solo sono portatrici di una disciplina che è quantitativamente prevalente sul
codice, ma tendono a creare micro-sistemi (nell’ambito della materia disciplinata dal
codice) ispirati a principi sconosciuti se non contrapposti a quelli codicistici.
12La
sentenza di cui trattasi (pubblicata sul Corriere Giuridico n.12 del 1996, 1355ss.) ha dichiarato
incostituzionale la reiterazione dei decreti non convertiti nel caso in cui la nuova disciplina non sia
sostanzialmente diversa dalla precedente ed in quello in cui manchino nuovi presupposti di necessità ed
urgenza.
13Si è volutamente utilizzato il concetto di incremento e non di creazione della legislazione speciale, per
indicare che lo svolgimento di discipline extracodicistiche non rappresenta un novita assoluta. Leggi speciali
si riscontrano anche nell’800 e nel primo ‘900, ma si tratta di leggi speciali assai più curate tecnicamente di
quelle attuali e che, soprattutto, si pongono come mero svolgimento della regolamentazione contenuta nel
codice (Schlesinger 1981, 75).
20
Il diritto dei codici è scaduto da diritto generale, applicabile salvo deroghe, a diritto
comune, applicabile solo alle fattispecie più generali, non caratterizzate da quegli elementi
particolari che ne hanno determinato la sussunzione sotto la legislazione speciale.
La marginalizzazione del codice si è notevolmente accentuata dopo l’entrata in
vigore della Carta Costituzionale.
Innanzi tutto, la Costituzione si pone ad un livello normativo gerarchicamente
superiore alla legislazione ordinaria, di cui il codice è espressione, sancendo diritti
fondamentali e regole cui la legge non può derogare.
In secondo luogo, essa ha rappresentato un forte incentivo alla produzione di leggi
speciali. La Costituzione della Repubblica non contiene soltanto norme volte a proteggere
le posizioni individuali di fronte ai poteri pubblici, ma anche norme di scopo ed
enunciazioni di principio, volte ad indirizzare l’attività dei privati e dello stato verso
determinati fini, la cui attuazione ha richiesto la emanazione di leggi speciali e leggi di
incentivo (Irti 1979, 14).
Infine, la Costituzione ha previsto nuove tipologie di fonti, quali il decreto-legge
(art.77), il decreto legislativo (art.76), la legislazione regionale (artt.117 e 118), il
regolamento parlamentare (art.64) e quello governativo (art.85) ed ha riconosciuto la
legittimità degli atti normativi comunitari (art.11) e del diritto internazionale
consuetudinario e pattizio (art.10). Nel sistema che risulta configurato la legge appare
irrimediabilmente “accerchiata” da altre fonti (Modugno-Nocilla 1990, 424).
I fattori che hanno determinato l’attuale instabilità normativa, e che legittimano il
pessimismo di alcuni autori circa la possibiltà di ripristinare l’unitarietà del sistema, sono
molteplici e profondi14.
Il passaggio dallo stato liberale allo stato democratico, in cui vige il principio di
uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, ha determinato il pluralismo istituzionale,
per cui tutti i gruppi sociali sono ammessi a partecipare alla vita politica, economica e
sociale e, segnatamente, alla produzione del diritto. Questa legittimazione ha condotto ad
una legislazione fortemente legata alle richieste provenienti dagli strati sociali, con un
sostanziale ritorno a quel particolarismo giuridico, cioè a trattamenti normativi
differenziati, che aveva rappresentato il principale bersaglio dei promotori delle
codificazioni ottocentesche.
Ne consegue una legge che, essendo rivolta agli appartenenti ad un gruppo
determinato, ha perso il carattere della generalità.
L’inadeguatezza della legislazione è legata anche allo scadimento del procedimento
di formazione della legge, alla cui lentezza non corrisponde un’attenta ponderazione delle
problematiche sottese alle norme. Di fronte a trasformazioni sociali e tecnologiche sempre
più rapide e profonde, la legge non può che apparire tardiva ed obsoleta. Queste stesse
trasformazioni hanno costretto il legislatore ad emanare disposizioni ad hoc, formulate in
14“Le
condizioni della vita costituzionale contemporanea costringono a rassegnarsi alla relativa mancanza
di unità del sistema delle fonti del diritto, in conseguenza della mancanza di un unico principio informatore
della vita collettiva.” (Zagrebelsky 1984, 35-6)
21
un linguaggio tecnico ed altamente specializzato, con l’inevitabile compromissione di un
altro carattere tradizionalmente ascritto alle norme giuridiche: l’astrattezza (Zagrebelsky
1992, 44).
Strettamente connesso ai fenomeni appena indicati è quello della
“contrattualizzazione della legge”, espressione con la quale si rappresenta la degradazione
della legge a sanzione di accordi intervenuti tra le parti sociali, ammesse a partecipare al
processo politico. La necessità del legislatore di ricercare il consenso dei destinatari per
garantire l’efficacia delle proprie norme, ha condotto ad un notevole ridimensionamento
dell’aspirazione della legge a divenire fattore di ordine, con l’ulteriore difetto
dell’occasionalità assunta dalla medesima e con la perdita dell’imperatività delle norme.
Nel quadro così tracciato si colloca l’imponente produzione di “leggiprovvedimento”, carenti della generalità e dell’astrattezza e dotate invece della concretezza
ed individualità proprie dei provvedimenti amministrativi; di “leggi-incentivo”, volte ad
indirizzare l’attività dei privati attraverso la promessa di finanziamenti od agevolazioni
fiscali; delle “leggine”, atti dal contenuto fortemente compromissorio che, in relazione a
settori specifici, adottano soluzioni volte a compiacere determinati gruppi di pressione.
Posto in luce il contesto in cui nascono la crisi della legge e del codice, che hanno
provocato una sostanziale crisi di legittimazione del Parlamento ed il trasferimento dei
relativi poteri decisionali a favore di altri soggetti (Labriola 1983, 733), non possono che
apparire palliativi le proposte di risolvere la grave incertezza determinatasi attraverso
espedienti di carattere tecnico.
Ci riferiamo in particolare alla proposta di istituire uffici investiti del compito di
sfoltire periodicamente la legislazione vigente e, soprattutto, agli sforzi rivolti ad ottenere
una maggiore perfezione nella formulazione delle norme attraverso la messa a punto di
regole rivolte al legislatore e costituenti la “nomografia” , ovvero l’arte del legiferare15.
Lo Scarpelli ha sottolineato come l’ideale illuministico di una legislazione chiara,
precisa ed univoca, tale da non dare adito ad interpretazioni contraddittorie sia, nell’attuale
stato di frattura tra costituzione formale e costituzione materiale, irrealizzabile. Sia perché è
la stessa complessità dei problemi emergenti nella società attuale a richiedere un linguaggio
specialistico, ed a delineare più linguaggi giuridici, sia perché la diffusione dell’informatica
ha determinato una “crisi della scrittura” e la “rivincita della parola”, con la conseguente
prevalenza, nella comunicazione, di strutture logiche diverse da quelle del testo scritto
(Scarpelli 1995, 28).
Questa conclusione non implica l’inutilità degli sforzi diretti a porre rimedio alle
imperfezioni della legislazione16, ma richiede che tali sforzi siano condotti nella
15L’insufficienza
di accorgimenti tecnico-legislativi riguarda anche la proposta di emanare leggi a tempo
determinato. Questa soluzione consentirebbe l’eliminazione della legislazione vecchia e superata, ma avrebbe
l’effetto di intensificare l’attività di produzione normativa (legislativa, regolamentare, giurisprudenziale) volta
a riempire tempestivamente le lacune createsi (Corsale 1979, 232).
16Alcuni ipotesi di lavoro in tal senso sono attualmente allo studio del Parlamento Italiano e si svolgono
in tre direzioni. A livello costituzionale si prospetta la formulazione di una riserva di regolamento, volta ad
attribuire al Governo la disciplina di alcune materie (ad es. l’organizzazione della P.A.). A livello di legge
22
consapevolezza che il problema ha radici molto profonde, in quanto la società attuale rende
assai difficile la regolamentazione legislativa in sé. A differenza di quanto avvenuto nell’età
giacobina (il cui legicentrismo rappresentava una garanzia dei diritti contro l’assolutismo),
la società attuale pare reclamare una “libertà dalla legge”, sia a favore dell’autonomia dei
privati e degli enti locali (Violante 1997, 4-5) sia, soprattutto, verso un diritto
giurisprudenziale.
La crisi del sistema delle fonti, composto da norme oscure, contraddittorie e volte ad
attuare i fini costituzionali, ha prodotto significativi cambiamenti nella teoria del diritto, in
particolare in tema di interpretazione, di antinomie, di sanzione.
La frammentazione del linguaggio giuridico in una serie di linguaggi specialistici e
tecnici e, in altra direzione, la sua contaminazione con il linguaggio comune e quello
politico hanno condotto i teorici del diritto negli ultimi decenni a esprimere scetticismo
sull’esistenza di un “significato proprio delle parole”, dal quale, a norma dell’art.12 delle
Preleggi, l’interprete dovrebbe farsi guidare nella propria attività.
Si è determinata la consapevolezza che l’interprete non si limita a dichiarare il
contenuto di un documento normativo preesistente, ma decide quale sia il senso da
attribuire all’espressione letterale da cui procede.
Di qui la ormai nota distinzione tra “disposizione” e “norma”: la prima intesa come
enunciato del legislatore, la seconda come il significato che alla disposizione viene
attribuito dall’interprete. Tale significato è dunque il risultato, non il punto di partenza
dell’attività interpretativa17.
E’ rifiutata, sulla base di queste premesse, anche una posizione equilibrata come
quella di Hart, il quale in The concept of law propone una teoria dell’interpretazione
distante tanto dall’ingenuità illuministico-giuspositivistica, secondo cui l’interprete deve
dichiarare il significato preesistente della norma giuridica, quanto dal pessimismo dei rules
sceptics, per i quali nessun vincolo esiste nei confronti di chi si pone di fronte ad un testo
normativo.
L’enunciato normativo presenta infatti, secondo Hart (1991, cap. 8) una “trama
aperta”, tale da consentire di individuare una serie di casi cui la disposizione è applicabile
ed altri che ne sono sottratti, mentre tra queste due aree di certezza positiva e negativa
residua una “zona di penombra” nella quale trova spazio il potere decisionale
dell’interprete.
ordinaria, la l. 15/3/97 ha sancito espressamente il principio di sussidiarietà, in base al quale agli enti locali
spettano tutti i compiti non incompatibili con la loro dimensione territoriale. A livello di regolamenti
parlamentari, non solo si sta valutando l’istituzione di una “giunta per la legislazione”, col compito di
esprimere pareri sulla correttezza formale della legge, ma anche la possibiltà di formulare su ogni legge un
giudizio di effettiva necessità, utile ad accertare che il progetto o disegno di legge da approvare non disciplini
una questione risolvibile attraverso norme già esistenti. (Violante L. 1997. Possibilità di riordino della
legislazione italiana vigente, 9-12 (Relazione presentata al convegno Applicazione e tecnica legislativa,
svoltoso a Bologna il 9-10 maggio 1997).
17Questa tesi è stata formulata da Tarello nella sua fondamentale opera L’interpretazione della legge del
1980.
23
“(...)Chiarezza ed oscurità, a ben vedere, non sono qualità intrinseche di un testo,
precedenti l’interpretazione: sono, esse stesse, frutto di interpretazione, intesa in senso lato
come ascrizione di significato ad un testo”: così Guastini (1990, 86) motiva la propria presa
di distanze dalla concezione hartiana, considerata troppo “ottimistica”.
Non è però soltanto l’interpretazione letterale ad essere messa in discussione di
fronte all’instabilità del sistema normativo, ma anche quella sistematica. La
frammentazione del diritto vigente in una serie di microsistemi di leggi speciali, portatori di
logiche autonome, impedisce di ricondurre le norme di ciascuna branca dell’ordinamento
giuridico agli stessi principi codicistici, ormai inidonei a garantire la coerenza e l’unità del
sistema. Questa constatazione ha condotto Irti ad affermare che il giurista si trova costretto
a rinunciare all’ambizione di costruire un teoria generale, per divenire invece un esperto
nella lettura delle leggi speciali: viene prospettato il ritorno ad un nuova Scuola
dell’Esegesi (Irti 1979, 99).
Pur accogliendo questa conclusione di Irti come, almeno in parte, provocatoria non
si può non considerare come la teoria generale del diritto costituisca un approccio sempre
meno adatto allo studio degli ordinamenti contemporanei. Uno dei possibili esiti di questa
inadeguatezza è la progressiva affermazione di uno studio del diritto di tipo casistico,
conforme alla cultura dei paesi di common law, fondato prevalentemente
sull’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale degli istituti.
Altro possibile percorso della teoria del diritto è quello di una sua
“internazionalizzazione”: lo sviluppo del diritto internazionale e delle istituzioni
comunitarie può proporre una prospettiva secondo cui i caratteri dell’unità, coerenza,
completezza vengano ricercati nell’ordinamento internazionale e non in quelli nazionali.
La proliferazione di leggi speciali ha stimolato anche una rivisitazione dei criteri di
risoluzione delle ipotesi di conflitto tra norme, le antinomie.
Il fenomeno della legislazione speciale, inizialmente occasionale ed episodico, in
ossequio alla tradizione del primato della legge generale ed astratta, ha assunto proporzioni
imponenti, divenendo (oltre che quantitativamente preponderante) dinamico, cioè aperto ed
incessante, differenziato, perché rivolto a cerchie di soggetti, a classi di beni ed a particolari
rapporti, e disorganico, in quanto non corrispondente ad una logica unitaria e rigorosa.
I principi che essa esprime non sono più divergenti e circoscritti rispetto al codice
ma finiscono, nella maggior parte dei casi, per “consolidarsi” ed assumere carattere di
generalità: esprimono, nei rispettivi settori, una propria ratio, rendendo incerta
l’applicazione dei tradizionali criteri di interpretazione e di abrogazione (Italia 1990, 40).
L’antinomia tra il codice e le leggi speciali non può essere risolta (soltanto)
attraverso il ricorso alla prevalenza della lex specialis, poiché in molti casi è in discussione
la stessa relazione di specialità. L’unico strumento applicabile è quello della deroga da parte
della norma di principio gerarchicamente superiore: così, ad esempio, l’art 28 Cost.
(responsabilità di dipendenti e funzionari dello Stato o di altri enti pubblici) prevale sull’art.
2043 c.c. (responsabilità civile).
24
Anche il rapporto tra specialità e gerarchia si è però modificato, in quanto la legge
speciale è in grado di integrare o modificare la disposizione superiore, non soltanto
disciplinando in modo diverso fattispecie diverse, ma modificando la stessa
regolamentazione dettata. La legislazione sull’affitto dei fondi rustici ha di fatto modificato,
in materia, l’art. 42 Cost. che assegna una funzione sociale alla proprietà (Italia 1990, 71).
Sui criteri di specialità e gerarchia prevale, al fine di garantire un minimum di unità
del sistema delle fonti, il criterio della “ragionevolezza”.
Poiché l’art. 3 della Costituzione non si limita a garantire un’ uguaglianza di tipo
formale, ma impegna il legislatore a realizzare anche la parità sostanziale tra i cittadini, non
possono essere considerate illegittime, di per sè, le leggi speciali o quelle non astratte né
generali, purché rispettino la suddetta disposizione. Le leggi speciali devono essere
“ragionevoli”, nel senso di soddisfare tanto le esigenze del caso concreto, quanto quelle del
sistema normativo (costituzionale), senza creare privilegi o svantaggi ingiustificati (Ruggeri
1994, 154).
Infine, la varietà dei tipi di norme ha condotto a modificare l’immagine tradizionale,
elaborata dai teorici di ispirazione liberale, del diritto come sistema che svolge una funzione
protettiva dei diritti soggettivi e repressiva degli atti illeciti.
Le Costituzioni post-liberali non si limitano a garantire la conservazione di un tipo
di società esistente, ma prospettano un modello di società da realizzare.
Il legislatore, cui spetta il compito di attuare tale modello, può decidere di
perseguire gli scopi indicati (uguaglianza sostanziale, funzione sociale della proprietà
privata, solidarietà sociale) intervenendo direttamente nella società e nell’economia, oppure
cercando di guidare nella direzione desiderata i comportamenti dei consociati.
Quest’ultimo tipo di intervento ha dato luogo ad una copiosa legislazione di
incentivazione, già sopra segnalata, che non contiene sanzioni negative in caso di
inosservanza, ma sanzioni positive, ovvero benefici e vantaggi, a favore di chi pone in
essere i comportamenti voluti. L’uso di questa tecnica mette in luce un’ulteriore funzione
attribuita dal diritto, quella promozionale.
Essa risulta espressamente assegnata al diritto dalla Costituzione italiana, che in
numerose sue norme ricorre all’uso del verbo “promuovere”, ad es. negli artt. 4/1, 5, 9, 31,
47/ 1-2 (Bobbio 1977, 25).
Il periodo che stiamo vivendo si caratterizza per un ridimensionamento della
funzione promozionale del diritto. La crisi del Welfare State riduce drasticamente la
possibilità dello Stato di concedere benefici economici; il progetto dell’Europa comune
richiede la rinuncia ad ogni politica nazionale protezionistica nei confronti delle imprese; la
discussione in atto sullo stesso modello delineato dalla Costituzione priva di legittimazione
l’azione positiva dello stato in molti settori della vita sociale.
Questi mutamenti hanno posto le premesse per un progressivo ritiro dall’economia e
dalla società dello Stato legislatore (si pensi al fenomeno delle “privatizzazioni”), al quale
viene richiesto di garantire il corretto svolgimento del mercato (controllando le condizioni
di svolgimento della concorrenza tra i soggetti e la distribuzione tra privati dei mezzi di
25
comunicazione di massa; tutelando il consumatore che entri in rapporto con l’imprenditore
nell’ambito della c.d. “contrattazione di massa”; assicurando che l’attività economica non si
svolga con danno per l’ambiente o con pregiudizio per diritti fondamentali dell’individuo),
senza che possa essere però prospettato uno stato “neutrale” di tipo ottocentesco.
La perdita di un centro di riferimento quale era la legge, ha posto, drammaticamente,
la questione di come recuperare un grado di certezza accettabile nel sistema delle fonti18.
La prima risposta formulata dalla dottrina è stata quella del ruolo da attribuire alla
Costituzione e, correlativamente, al controllo di costituzionalità delle leggi. In quanto posta
al vertice dello Stufenbau la Carta Costituzionale, che pure ha determinato la crisi della
normazione legislativa, consente di ricostruire l’unità del sistema, le cui norme devono
costituire attuazione o almeno una non violazione di essa (Irti 1979, 69).
La soluzione del controllo di conformità alla costituzione, quale metodo per
conseguire una reductio ad unum delle norme giuridiche è però discutibile da due punti di
vista.
In primo luogo, la Corte Costituzionale decide in base a tecniche ed argomenti che
solo parzialmente sono giuridiche, ma sono sostanzialmente di politica (quantomeno di
politica costituzionale). Ogni decisione della Corte suscita dibattiti, spesso accesi, sulle
conseguenze non solo giuridiche ma anche politiche che produce19.
Inoltre, le norme costituzionali sono, per la loro ampiezza e compromissorietà,
ambigue e non rappresentano un criterio adeguato per il controllo dell’attività interpretativa,
la quale può pervenire sulla loro base a decisioni anche divergenti, tutte giustificabili
attraverso la disposizione interpretata.
Infine, ed è questo uno dei nodi più difficili da sciogliere, la Costituzione non
appare più esprimere un’immagine dello stato e della società unanimemente condivisi (Irti
1995, 11). La caduta delle ideologie ha rimesso in discussione il presupposto su cui la Carta
del 1948 è stata redatta, ovvero la necessità di conciliazione del marxismo, del liberalismo e
18L’interrogativo
non può porsi sul come restaurare il primato della legge e dei codici, poiché le
condizioni storiche attuali non legittimano un tentativo di questo tipo. Le codificazioni dell’800 sono sorte in
una società relativamente omogenea e statica. Non nel senso che non si siano verificati eventi storici rilevanti,
ma in quello di una società facilmente identificabile in una classe dirigente (la borghesia) ed in determinati
valori (la protezione dell’individuo e delle sue libertà personali e di iniziativa economica), tanto che Marx
potè definire i codici come la forma che il diritto assume nelle società borghesi capitalistiche (non è un caso
che i primi movimenti antiformalistici si siano sviluppati quando, con la rivoluzione industriale, il tessuto
sociale ha subito forti modificazioni). In una società pluralistica come quella contemporanea ci si può
domandare, più in generale, come ripristinare un grado accettabile di certezza del diritto, intesa come
possibiltà di controllare oggettivamente la decisione dell’interprete.
19Di queste conseguenze i giudici della Corte sono perfettamente consapevoli, come risulta dalla lettura
di un breve passo della motivazione della sentenza 360/1996, citata, che vieta la reiterazione dei decreti legge:
“Questa Corte, nell’adottare la presente pronuncia, è consapevole delle difficoltà di ordine pratico che dalla
stessa, nei tempi brevi, potranno derivare sul piano dell’assetto delle fonti normative, stante l’ampiezza
assunta dal fenomeno della reiterazione nel corso delle ultime legislature. Tali difficoltà, ancorchè ben
presenti, non sono, peraltro tali da poter giustificare il protrarsi di una prassi che è andata sempre più
degenerando e che ha condotto ad oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria quali quelli enunciati
nell’art.77 della Costituzione.”.
26
del cattolicesimo, conducendo alla formulazione di proposte volte a mutare in maniera
profonda la fisionomia dello stato (in senso presidenzialistico, federalistico, ecc.).
L’esito dell’incertezza del sistema viene da altri autori individuato in una
legislazione di principi, unico strumento di coordinamento in grado di ricostruire l’unità
dell’ordinamento.
Tali principi non sono unicamente quelli presenti nel codice, ma sono in generale i principi
del diritto.
Non si tratta di evocare termini giusnaturalistici, ma di riferirsi a pensatori come
Dworkin (per il quale i principi sono quelli propri di una comunità, individuati ed enunciati
dalla cultura giuridica, rispetto ai quali è sempre possibile compiere un’attività
interpretativa e costruttiva) e soprattutto alle carte costituzionali. Attraverso il ricorso a tali
fonti sarebbe possibile ai giudici, specialmente a quelli costituzionali, il reperimento di
principi “aperti” che consentano da un lato di adeguare il sistema alle nuove esigenze
sociali, dall’altro di garantire la costanza, relativa, delle interpretazioni.
Secondo Scarpelli (1987, 3-15) sarebbe per questa via praticabile un’operazione di
razionalizzazione del sistema da parte dei giudici, e soprattutto della Corte Costituzionale.
Questo percorso presenta indubbiamente degli inconvenienti dovuti alla molteplicità delle
istanze giurisdizionali (vari gradi di giurisdizione; giurisdizioni di merito e di diritto) che
portano ad un anarchismo giudiziario individualistico, impedendo la formazione di un
sistema coerente di precedenti. Inoltre, la separazione tra il giudizio sulla legge, spettante
alla Corte Costituzionale, e quello sul caso rende la Corte meno sensibile alle istanze sociali
e rende difficoltosa la creazione di nuovo diritto anche a causa del potere puramente
negativo, di annullamento, dell’organo.
L’impossibilità del Parlamento di erogare tutte le norme di cui la società necessita
ha comportato l’ampliamento della potestà normativa del governo (mediante decreti legge e
decreti legislativi), il ricorso alla “delegificazione”, cioè al trasferimento di determinate
materie dalla competenza legislativa a quella regolamentare ed ha infine fatto sorgere
problemi di coordinamento con la legislazione regionale nelle materie di competenza
esclusiva delle regioni (individuate dall’art.117 Cost.).
In altre parole, la legge può riacquistare un ruolo di perno del sistema recuperando
le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza. Questi caratteri assumono però un
significato nuovo rispetto a quello che possedevano nel contesto in cui sono stati concepiti
(quello dell’ideologia statualistica) e non indicano una pretesa della legge di esclusività ed
esaustività del diritto ma, al contrario, la consapevolezza che in una società i cui rapporti
non si prestano ad essere ordinati medianti strumenti rigidi, deve essere concesso ampio
potere di decisione ed adattamento all’interprete.
27
4. Il declino della sovranità dello stato di fronte allo sviluppo del diritto
sovranazionale
Le codificazioni, fenomeno che abbiamo posto all’origine dell’ideologia giuspositivistica
delle fonti, sono scaturite oltre che da ragioni di ordine pratico e filosofico anche, e innanzi
tutto, dalla pretesa degli stati nazionali di conquistare il monopolio della produzione del
diritto nei rispettivi ambiti, per affermare senza mediazioni il proprio potere sui sudditi.
Tale potere è una delle manifestazioni della sovranità statuale, attributo dello stato
teorizzato dalla giuspubblicistica dell’ottocento.
Nella sua accezione tradizionale il concetto di sovranità presenta un lato interno ed
uno esterno. Secondo il primo punto di vista, indica la incommensurabilità dello stato al
proprio interno con ogni altro soggetto: lo stato non può entrare in rapporto giuridico con
altri soggetti, poiché questo presupporrebbe un terzo superiore alle parti che ponga la norma
qualificante il rapporto, per cui di fronte allo stato si possono configurare soltanto posizioni
di soggezione. Verso l’esterno la sovranità si attua attraverso il principio di non ingerenza
da parte di soggetti estranei all’ordinamento giuridico (Zagrebelsky 1992, 5).
Il concetto di sovranità ha origini giusnaturalistiche e precisamente si trova
formulato da Francisco de Vitoria il quale, nella ricerca di un fondamento giuridico alla
conquista del nuovo mondo, elaborò l’immagine di un ordine mondiale come società di
stati sovrani liberi ed indipendenti, soggetti allo ius gentium ed al diritto costituzionale
interno. Nelle controversie tra stati, la violazione del diritto internazionale può essere punita
soltanto con la guerra, non esistendo un giudice superiore agli stati (Ferrajoli 1995, 12).
La configurazione di una comunità mondiale degli stati entra in crisi alle soglie
dell’età moderna, quando la dissoluzione dell’impero porta ad un nuovo assetto
internazionale caratterizzato da unità politiche territoriali indipendenti, sancito dalla pace di
Westfalia del 1648 e rappresentato dal motto rex imperator in regno suo, col quale viene
decretata la fine della concezione universalistica della reductio ad unum che aveva
connotato il pensiero medievale sia in campo politico-giuridico che in campo filosofico e
teologico.
La relativizzazione del potere statuale ed il suo svincolamento da limiti interni ed
esterni è stata precisata, come noto, da autori “assolutisti” quali Bodin ed Hobbes. Il primo
ha posto al potere statuale, connotato formalmente (per Bodin, la semplice inosservanza del
comando del sovrano è un atto criminoso e non è ammesso alcun sindacato sul suo
contenuto), vincoli di ordine soltanto morale (il rispetto del diritto naturale e delle leggi di
Dio), il secondo vi ha aggiunto un limite di carattere logico (la conservazione della vita dei
sudditi, per la quale il sovrano è stato istituito), ma ha portato a compimento il processo di
personificazione dello stato sovrano (Silvestri 1996, 13) attraverso la concentrazione di tutti
i poteri giuridici esistenti sul territorio in una totalità personificata (il Leviatano).
Da questa immagine della sovranità, volta a giustificare l’esercizio effettivo di un
potere su un dato territorio, si svilupparono i principi del positivismo giuridico quali la
convenzionalità del diritto, il fondamento volontaristico e formalistico della volontà delle
28
norme, il monopolio statale della produzione del diritto, l’unità dell’ordinamento e
l’autonomia da fonti extra e sovrastatuali.
La sovranità dello stato è stata solo apparentemente limitata dalle dottrine della
sovranità popolare e della sovranità nazionale.
Il richiamo al popolo quale soggetto titolare della sovranità è stato utilizzato per
contrastare regimi tirannici, ma ha risolto anche due importanti problemi teorici del potere
sovrano. Individuando un fondamento al potere, ha bloccato il regresso all’infinito cui
erano costretti i sostenitori della sovranità dello stato ed ha inoltre offerto una fonte di
legittimazione all’esercizio del potere stesso. Si pensi, ad esempio, a Rosseau, la cui volonté
genérale, vera volontà di ciascuno e punto di incontro tra la volontà dei singoli e la volontà
del corpo sociale, si presenta come strumento per teorizzare una forma di democrazia
diretta, ma contiene il germe dello stato etico in quanto la volontà generale è interpretata ed
espressa dallo stato.
Analoghe considerazioni possono essere formulate in relazione alla dottrina della
sovranità nazionale, attraverso la quale sono state conciliate la teoria tradizionale della
sovranità e le istanze democratiche di abbattimento dell’Anciéne Regíme. La nazione
infatti, entità ideale che trascende il popolo, rappresenta un astratto titolo di legittimazione e
non si presta a rivendicazioni concrete. Le costituzioni contemporanee hanno superato
questa visione della sovranità popolare e quando menzionano il popolo (come nell’art. 1
della Costituzione italiana), non lo intendono quale soggetto ideale ed astratto, ma si
riferiscono ai singoli individui od ai gruppi sociali da essi composti (Silvestri 1996, 26).
L’idea di sovranità ha subito importanti cambiamenti, che possono essere descritti
adeguatamente solo seguendo gli opposti percorsi seguiti dalla sovranità interna e quella
esterna.
La sovranità interna ha sofferto fondamentali limitazioni in seguito allo sviluppo
dello stato di diritto e, successivamente, dello stato costituzionale che hanno condotto
all’affermazione del principio di legalità, della divisione dei poteri, dei diritti fondamentali.
Sul piano del sistema delle fonti ciò ha portato al superamento del residuo assolutistico del
primato della legge, in quanto le costituzioni configurano la validità della norma in
relazione a regole non soltanto procedurali, ma anche contenutistiche.
Alla limitazione della sovranità interna si è contrapposta l’assolutizzazione della
sovranità verso l’esterno: legittimato all’interno dai propri limiti, lo stato si è proiettato,
rafforzato, verso gli altri stati giungendo all’identificazione tra stato e diritto e negando,
nella propria vocazione espansionistica e distruttiva (manifestatasi nelle guerre coloniali e
nelle guerre mondiali), la giuridicità del diritto internazionale (Ferrajoli 1995, 35). Al
superamento della condizione del bellum omnium contra omnes all’interno dello stato si
oppone una comunità di stati superiorem non recognoscentes, in cui si riproducono tutte le
incertezze dello stato di natura, con la differenza che i soggetti di questa realtà pregiuridica
non sono gli individui, ma gli stati.
Negli ultimi decenni, anche la sovranità esterna sembra attraversare una crisi tale da
provocarne un forte ridimensionamento ed una limitazione.
29
L’esperienza dei conflitti mondiali ha fatto sorgere la necessità di porre le basi di un
pacifico assetto internazionale e di sancire solennemente i fondamentali diritti dell’uomo, al
fine di rendere unanimamente condannabile di fronte alla comunità degli stati i governi
responsabili delle loro violazioni. I documenti redatti, la Carta dell’ONU del 1945 e la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, si pongono perciò quali basi di un
nuovo diritto internazionale, ius cogens superiore alla potestà dei parlamenti nazionali. Essi
appaiono un tentativo di superare lo status naturae tra le nazioni e presentano il valore di
pactum unionis, ma anche di pactum subiectionis ad un nuovo ordine internazionale, nel
quale allo ius ad bellum si contrappone l’obbligo di mantenere la pace.
Il progetto così delineato non è stato tuttora attuato, come mostrano le tragiche
esperienze delle guerre civili e internazionali recenti, per difficoltà sul piano effettivo
(restando la politica degli stati determinata dai rispettivi interessi economici, politici e
religiosi), ma anche per un’antinomia presente negli stessi documenti sopra menzionati.
La Carta ONU infatti, sancisce all’art. 2 l’uguaglianza tra gli stati e all’art. 7 il
divieto di ingerenza interna, riconoscendo così implicitamente che vi è incompatibilità tra
sovranità e diritto, poiché la comunità internazionale rinuncia ad imporre i propri principi
giuridici nell’ambito dei confini statali.
Se la “positivizzazione” di un diritto naturale a livello internazionale non ha ancora
compiutamente esplicato la propria potenzialità erosiva della sovranità statale, ben più
penetrante si è manifestata l’incidenza in tal senso di quelle istituzioni internazionali, in
particolare della Comunità Economica Europea, rivolte alla collaborazione ed integrazione
sul piano economico e commerciale tra stati. Lo sviluppo di tali organismi ha condotto,
come osserveremo tra breve, a modificare in maniera assai rilevante i sistemi delle fonti
all’interno degli stati membri, con effetti di non poco conto nei confronti dei giudici e degli
stessi cittadini.
Il fenomeno della internazionalizzazione del diritto, consistente nella crescita di un
diritto comunitario prodotto da appositi organi comunitari, rivela il tramonto della pretesa
di esclusività-impenetrabilità, secondo la quale solo le norme statuali sono idonee a
disciplinare le fattispecie produttive di norme efficaci nel territorio nazionale, ultimo
baluardo eretto a protezione della sovranità dell’ordinamento giuridico (Pinelli 1995, 361).
Una prima forma di demolizione del privilegio statuale in materia di diritto è
rappresentato da quella interpretazione attraverso la quale le diverse Corti Costituzionali
europee hanno individuato un diritto internazionale comune, fondato sulle costituzioni, di
cui ogni individuo è titolare, a prescindere dal requisito della cittadinanza. Il concetto di
popolo, comunità stanziata su un determinato territorio, non configura più un limite
all’estensione dei diritti fondamentali agli stranieri.
In questo senso devono essere lette alcune recenti pronunce giurisprudenziali
italiane, che hanno rivisitato l’art. 16 delle Preleggi, a norma del quale lo straniero è
ammesso a godere dei diritti civili riconosciuti al cittadino a condizione di reciprocità, cioè
soltanto se a propria volta lo stato straniero li garantisca al cittadino italiano.
30
Corte di cassazione e Corte Costituzionale hanno stabilito che non siano
condizionati dalla reciprocità il diritto alla tutela giurisdizionale, riconosciuto dall’art. 24
Cost., il diritto alla libertà personale, quelli all’inviolabilità del domicilio, alla libertà e
segretezza della corrispondenza, alla libertà religiosa, alla libertà di manifestazione di
pensiero, alla personalità della responsabilità penale. Infine è stato specificato che l’art. 3
della Costituzione, nonostante il testuale riferimento ai cittadini, garantisce l’uguaglianza di
fronte alla legge anche agli stranieri, qualora si tratti di assicurare la tutela dei diritti
inviolabili dell’uomo (Cian-Trabucchi 1996, 43).
Questo processo si inserisce peraltro nel dibattito contemporaneo sulla cittadinanza.
Questa categoria, sorta per determinare l’appartenenza dell’individuo alla comunità statale,
tende ad essere superata in relazione al godimento dei diritti, riconosciuti ad ognuno a
prescindere dal suo status di cittadino, in una prospettiva secondo cui ciascun uomo è
“cittadino del mondo” (Belvisi 1997, 118).
Gli ordinamenti nazionali delle fonti di produzione del diritto sono stati ancora più
profondamente mutati dagli atti normativi comunitari, con ripercussioni di carattere pratico
e teorico degne di menzione.
Nell’ordinamento italiano, l’efficacia delle fonti della Comunità Europea è
ricondicibile alle due norme contenute negli artt. 11 e 10 della Costituzione.
L’art. 11 consente “limitazioni di sovranità”, circoscritte entro confini ben precisi.
In particolare, le limitazioni devono essere previste a favore di un ordinamento che
garantisca la pace e la libertà tra le nazioni (un’interpretazione uniforme vi fa rientrare la
Comunità Europea), debbono attuarsi in condizioni di parità con gli altri stati, non possono
violare i valori supremi dell’ordinamento giuridico e si richiede che siano “necessarie”, cioè
congrue in vista del raggiungimento dei fini di pace e giustizia.
Si può osservare come la disposizione in esame non comporti alcuna rinuncia alla
sovranità ed ammetta soltanto le limitazioni necessarie.
Poiché per “sovranità” si intende la potestà normativa dello stato, si configura la
possibilità di un’antinomia tra la normazione nazionale e quella comunitaria. Questo
conflitto deve essere risolto, secondo una recente opinione, sulla base del potere
dell’ordinamento comunitario, scaturito dall’art. 11, di disporre l’inefficacia del diritto
interno confliggente con quello della comunità. Questa interpretazione considera che la
norma in esame abbia intaccato il monopolio statale di dettare la normazione sull’efficacia
del diritto interno (Pinelli 1995, 374).
L’art. 10 Cost. prevede invece che lo stato italiano si “conformi” alle regole pattizie
e consuetudinarie internazionali generalmente riconosciute, ammettendo l’esistenza di un
nucleo di norme di produzione non statuale, idoneo a limitare, nel rispetto dei suoi valori
fondamentali, l’ordinamento giuridico italiano.
La prevalenza del diritto di fonte comunitaria su quello interno è stata sostenuta
anche dalla Corte Costituzionale, che in diverse pronunce ha affermato la capacità dei
trattati comunitari di derogare, grazie al citato art. 11, al sistema costituzionale delle fonti
ed ha sottolinato il potere-dovere dei giudici nazionali e degli organi della Pubblica
31
Amministrazione di disapplicare, cioè considerare non efficaci, le norme interne
contrastanti con il diritto comunitario direttamente applicabile.
La stessa Corte ha inoltre chiarito che il rapporto tra regolamenti CEE e leggi
nazionali non si pone in termini gerarchici, ma di competenza: la violazione della
competenza comunitaria da parte del legislatore rende la legge incostituzionale, per
violazione dell’art.11.
Queste decisioni comportano due conseguenze di estrema importanza. Innanzi tutto,
poiché la relazione tra fonti interne e comunitarie non è di gerarchia, ma di competenza, le
eventuali antinomie sono risolte dall’art.189 del trattato CEE (che attribuisce efficacia ai
regolamenti ed alle direttive) in connessione con l’art. 11 Cost. per cui l’art. 189 diviene,
sia pure mediatamente, norma costituzionale italiana sulla produzione del diritto.
In secondo luogo, attraverso il potere dei giudici comuni di disapplicare le leggi
interne contrastanti col diritto comunitario, è stato creato un sindacato diffuso di
costituzionalità sulle prime nei confronti del secondo.
Ulteriori fattori di aggiramento dall’esterno della legge statuale sono il diritto
internazionale privato, ovvero l’insieme delle norme che servono ad individuare le regole
applicabili ai rapporti tra italiani e stranieri (le quali assumono efficacia dal nostro
ordinamento) e la c.d. lex mercatoria.
Con quest’ultima espressione si designa un diritto derivante dagli usi, dai contratti e
dai regolamenti degli ordini professionali nel campo del commercio internazionale,
applicato dagli arbitri, scelti dalle parti in alternativa ai giudici nazionali, nella decisione
delle controversie tra operatori commerciali di paesi diversi.
L’accettazione di questo diritto da parte degli stati, attraverso i propri giudici, è
riconducibile all’enorme difficoltà di formulare, di comune accordo, norme sul diritto
internazionale. Lo sforzo volto a codificare e sistematizzare le regole ed i principi di questa
lex mercatoria rivela come essa non consista in pratiche e principi generalmente
riconosciuti, classificabili tra gli “usi” di cui all’art. 1 n.4 Prel., ma rappresenti un
importante caso di prevalenza di fonti autonome su fonti eteronome (statali) (Pinelli 1995,
389).
Autorevole dottrina (Galgano) ha visto nel processo sopra descritto una rivincita
dell’effettività sul formalismo ed ha sostenuto che il contratto è destinato a divenire il
principale strumento di innovazione giuridica, a discapito delle fonti statali di produzione.
A questa osservazione è stato replicato che il diritto transnazionale della lex
mercatoria incontra limiti di vario ordine, la cui presenza indurrebbe a concludere sulla
incapacità del mercato internazionale di autogovernarsi. Questi limiti sono quelli del diritto
pubblico dell’economia, volto al controllo pubblico di settori economici, della protezione
dei diritti di libertà, che smentisce la tesi del superamento delle costituzioni nazionali, ed
infine quello delle difficoltà che il processo di integrazione comunitaria sta incontrando, le
quali rappresentano un ulteriore elemento di sfiducia sulla capacità spontanea del mercato
di guidarla (Pinelli 1995, 365).
32
Il privilegio statuale nelle fonti del diritto è stato ridimensionato anche dalla
costante ed attenta giurisprudenza della Corte di Giustizia, le cui decisioni completano
l’opera di affermazione del primato del diritto della comunità sul diritto interno, già iniziata
dalla Corte Costituzionale.
Già nel 1963 la Corte di giustizia ha sancito il principio per cui in tutti i casi nei
quali la norma comunitaria imponga agli stati obblighi precisi, cioè sufficientemente
dettagliati, ed incondizionati, non rimessi alla loro discrezionalità, da essa scaturisca un
diritto soggettivo direttamente applicabile nel diritto interno ed azionabile da parte del
cittadino di fronte al giudice nazionale (Sorrentino 1996, 84). La garanzia di questi diritti è
stata successivamente rafforzata dall’affermazione della responsabilità patrimoniale dello
stato inadempiente nei confronti del cittadino che abbia sofferto un danno dalla mancata
attuazione della norma.
Queste pronunce appaiono configurare una nuova categoria di diritti soggettivi, i
diritti soggettivi comunitari, collocabile tra le dichiarazioni dei diritti contenute nelle carte
internazionali e le costituzioni nazionali, idonea ad emarginare ulteriormente il potere
legislativo nazionale, in quanto limite invalicabile nei suoi confronti.
La stessa Corte ha poi inciso sui sistemi normativi dei paesi membri attraverso
l’ampliamento dell’efficacia delle direttive, atti normativi che, nella disciplina risultante dal
trattato CEE, richiedono la recezione da parte dei legislatori.
L’organo interpretativo comunitario ha ritenuto che anche le direttive possano
produrre effetti diretti negli ordinamenti degli stati membri in due casi: quando siano
“dettagliate”, ovvero contengano, oltre all’indicazione di fini e di obiettivi, una disciplina
dei mezzi e delle forme dell’azione statale; oppure prevedano obblighi determinati a carico
degli stati e sia scaduto il termine per l’adempimento (Sorrentino 1996, 93).
Ne risulta una soggezione del giudice nazionale non soltanto alla legge, ma anche
alla norma comunitaria, accentuata, in Italia, dalla tendenza della Corte Costituzionale a
dichiarare non ammissibili al proprio giudizio le questioni che si riferiscono a norme
comunitarie direttamente applicabili ed a rimettersi in questi casi alle decisioni della Corte
di Giustizia.
La forte influenza esercitata sul diritto degli stati dagli atti degli organi comunitari
sta ponendo in discussione, come già avvenuto con l’avvento del costituzionalismo, la
configurazione data tradizionalmente al concetto di sovranità.
L’inadeguatezza della sovranità, quale si era affermata nelle sue origini, a spiegare il
potere dello stato, è dimostrata dalle difficoltà che sorgono nel momento in cui si cerchi di
ricostruire teoricamente il rapporto tra stati e Comunità Europea. Essa corrisponde ad una
tradizione giuridica sviluppatasi in un contesto di pluralità di ordinamenti autonomi aventi
la pretesa dell’originarietà, in cui il diritto internazionale era soltanto strumento di
coordinamento dell’attività di soggetti non riconoscenti un’autorità superiore.
Questo modello teorico non è applicabile a quei soggetti internazionali, quali gli
organi della CEE, che non si limitano ad agire quali organi degli stati, ma sono dotati di
33
poteri di autodeterminazione del proprio indirizzo politico, anche se in materie circoscritte
(Cannizzaro 1996, 79).
Poiché il trasferimento di sovranità ne comporta la perdita da parte del soggetto che
lo ha operato (Bodin), è stato negato che gli organi comunitari siano sovrani, costituendo
solo strumenti, la cui azione non è priva di discrezionalità, per l’esercizio indiretto della
sovranità statale.
Questa tesi si presta a varie obiezioni. Innanzi tutto, se è vero che l’ordinamento
comunitario ha la funzione di produrre norme ma manca di un apparato di coercizione, è
altrettanto vero che l’esercizio della coercizione non è un carattere indefettibile della
sovranità, poiché l’elemento della coercizione è stato elaborato, storicamente, al fine di
escludere che la sola normazione dei singoli stati in relazione a fattispecie poste al di fuori
del territorio potesse costituire illecito internazionale. Peraltro, alla mancanza di strumenti
diretti di coercizione la comunità può sopperire sia ricorrendo agli organi degli stati membri
sia favorendo, con appositi meccanismi, l’attuazione delle proprie norme senza la
cooperazione degli stati (Cannizzaro 1996, 93).
In secondo luogo, è artificioso ritenere che la Comunità non sia libera nella scelta
dei propri fini. Il Trattato CEE indica, accanto a fini necessari, fini non necessari che spetta
agli organi comunitari decidere di perseguire. Tali organi sono poi liberi in sede di
interpretazione dei fini assegnati, in modo che la loro situazione non risulti sostanzialmente
differente da quella degli organi statali, che reperiscono i propri fini nelle Costituzioni.
Infine, mentre in passato l’adozione del sistema a votazione unanime in ambito
comunitario rendeva palese la preminenza degli stati membri, l’attuale sistema di voto, di
tipo maggioritario, accanto al significativo ruolo attribuito al Parlamento Europeo in
numerosi procedimenti, consente di pensare all’esercizio di competenze comunitarie come
ad una espressione di volontà autonoma rispetto a quella degli stati (Cannizzaro 1996, 97).
Lo schema classico della sovranità, non utile a spiegare la ripartizione di
competenze tra Comunità e stati, non consente di risolvere neppure un altro rilevante
problema, quello della responsabilità in caso di illecito commesso dagli organi comunitari.
Nulla quaestio qualora l’illecito sia commesso in violazione di norme internazionali
che vincolino la Comunità: i suoi organi ne rispondono.
Cosa avviene invece se l’atto comunitario viola norme interne statali che tutelino
diritti soggettivi? Se si decidesse per la responsabilità dello stato, in quanto il trasferimento
di competenze non costituirebbe un motivo valido per sottrarsi agli obblighi internazionali,
ne risulterebbe una responsabilità per fatto altrui (cioè dello stato verso il cittadino, per
l’attuazione della norma emanata dall’organo comunitario), difficilmente accettabile.
D’altra parte, la difficoltà di configurare una responsabilità a carico della comunità,
non tenuta al rispetto delle norme nazionali interne, finisce per riconoscere agli stati la
possibilità di sfuggire ai propri obblighi attraverso l’azione comunitaria (Cannizzaro 1996,
117).
L’inquadramento dei rapporti tra Stato e diritto comunitario esige la messa a punto
di modelli teorici che si distaccano da quelli finora utilizzati, quali quello della sovranità
34
“ripartita”, in base al quale ciascun ente è sovrano nel rispettivo ambito di competenza, e
che comporta il superamento del dogma dell’indivisibilità della sovranità; oppure quello
della sovranità “solidale”, secondo cui Comunità e stati sono soggetti indipendenti i cui
poteri confluiscono in una sfera giuridica unica, in cui ciascuno realizza le proprie
prerogative sovrane. Quest’ultima costruzione porta all’abbandono del carattere
dell’esclusività del potere sovrano (Cannizzaro 1996, 123).
Sul piano delle fonti del diritto, la metamorfosi della sovranità non deve essere
rappresentata in termini di irruzione del diritto comunitario negli ordinamenti interni, ma
nei termini di un più mite riconoscimento ed adattamento, che esprime uno dei due modi,
accanto a quello della produzione diretta, attraverso i quali lo stato può creare diritto
efficace nel proprio territorio (Pinelli 1995, 381).
Ciò appare confermato dalla circostanza che non è tuttora emerso un organico
ordinamento comunitario delle fonti e dall’assenza di una fonte legislativa “comunitaria”,
sostitutiva di quella nazionale.
Il rapporto tra diritto prodotto da fonti esterne ed ordinamenti interni si realizza in
termini di adattamento dello stato al diritto internazionale di origine pattizia e di
riconoscimento sia del diritto comunitario, del diritto internazionale privato e di quello
internazionale generale, richiamato da norme costituzionali, sia, attraverso i giudici
nazionali, di un diritto estraneo, privo di fondamento costituzionale (la lex mercatoria).
In ultima analisi, se non è più accettabile l’immagine della comunità internazionale
come insieme di ordinamenti chiusi verso l’esterno ed autonomi, poiché la produzione di
norme sovra e transnazionali è destinata ad incidere sempre più profondamente sul
comportamento dei legislatori, dei giudici nazionali, degli operatori del diritto e dei
consociati, è altrettanto vero che i soggetti del diritto internazionale sono gli stati, la cui
esistenza non può che tradursi in meccanismi di mediazione tra il proprio diritto e quello
prodotto altrove.
Alla rinuncia dello stato alla sovranità rispetto alla prerogativa di battere moneta,
concretizzatasi con l’entrata in vigore dell’EURO il 1°gennaio 1999, farà presumibilmente
seguito un allineamento, in Europa, degli stati anche nella politica estera, sociale ed
economica a favore delle istituzioni comunitarie. Meno prossima appare la possibilità che
gli stati ammettano una progressiva sostituzione dell’Unione Europea per quanto attiene
alla potestà di legiferare.
Insomma, “La comunità è in cammino, ma finché a formarla restano gli stati, è
anche giusto che questi regolino la vita nel loro interno con i propri codici, sempre entro i
limiti e con gli sviluppi consentiti dalla norma comune, alla quale va riconosciuta una
prevalente efficacia (Trabucchi 1993, 719).”
35
5. Il negozio giuridico
L’esito dell’evoluzione tracciata (verso un superamento del modello giuspositivistico
tradizionale) è che criteri con cui il teorico e l’operatore del diritto devono reperire le fonti
normative non coincidono più con quelli contenuti nelle metanorme legislative, ma sono
divenuti criteri aperti ad una osservazione di tipo sociologico, basato su ciò che avviene
effettivamente nella società e, anzitutto, nei tribunali.
Un rilievo del tutto nuovo ha assunto, sotto questo profilo, il negozio giuridico.
Nella tradizione dottrinale il negozio è collocato, come noto, tra gli eventi idonei a creare,
modificare o estinguere rapporti giuridici tra soggetti.
La species più importante appartenente al genus del negozio è il contratto, connotato
dalla bilateralità o plurilateralità soggettiva e dalla natura patrimoniale del rapporto posto in
essere, modificato od estinto.
Le origini della categoria si collocano nel momento in cui è sorta nell’Europa
continentale la scienza giuridica moderna, ad opera dei Pandettisti.
Il procedimento seguito dai giuristi tedeschi è stato quello di costruire per astrazione
e generalizzazione un concetto in grado di abbracciare tutti quei comportamenti (il
testamento, il matrimonio, i singoli atti di scambio) ai quali il diritto romano conferiva
rilievo giuridico. Il tratto comune di tali comportamenti è stato individuato nella presenza di
una volontà rivolta alla produzione di effetti specifici.
Così, Savigny definiva il negozio giuridico come una dichiarazione di volontà
finalizzata alla costituzione o allo scioglimento di un rapporto giuridico.
Un’analisi di tipo storico-comparatistico mostra che nelle società primitive gli atti
volti allo scambio di beni o servizi in natura sono caratterizzati da forme solenni e da rigide
strutture. Con l’evoluzione della società il formalismo è destinato ad attenuarsi, in favore di
strumenti di scambio più agili e duttili. In questa linea evolutiva si colloca la Pandettistica
la quale, in un’epoca in cui si stava sviluppando l’economia capitalistica e nella quale il
valore primario era quello dell’individualismo, ha individuato l’essenza del negozio nella
capacità della volontà del privato di produrre effetti giuridici.
I mutamenti che caratterizzano lo sviluppo attuale della società rendono legittimo
chiedersi se sia corretto continuare ad impostare i problemi dell’autonomia negoziale in
termini di autodeterminazione o autoregolamentazione delle parti contraenti.
Si pensi al consolidato fenomeno della c.d. contrattazione di massa, seguita alla
diffusione in ampi strati sociali del bisogno e della possibilità di conseguire i beni ed i
servizi offerti dal mercato.
Nei contratti di massa l’autonomia dispositiva è ridotta alla richiesta del bene o
servizio da parte dell’utente, in presenza della quale l’imprenditore non ha ragione (e,
talvolta, ad esempio nei casi di attività svolta in condizione di monopolio legale, neppure la
possibilità) di rifiutare. Inoltre, l’imprenditore inserisce nei contratti destinati a regolare una
serie uniforme di rapporti, condizioni generali che gli consentono di assumere un ruolo
preponderante nel regolamento contrattuale, anche se le legislazioni di ormai tutti gli stati
36
europei hanno apprestato una tutela sostanziale del consumatore di fronte alle clausole c.d.
vessatorie.
La volontà o la dichiarazione non appaiono determinanti per la produzione degli
effetti giuridici neppure in quei rapporti (ad es. di lavoro subordinato) in cui sono coinvolti
interessi superiori a quelli individuali, nei quali la libertà dei privati è limitata dalla legge e
dai contratti collettivi20.
L’immagine teorica usuale del negozio e del contratto risulta in questo quadro
alquanto turbata, soprattutto perchè tali figure, tracciate per ricondurre ad unità le posizioni
dei contraenti nel contesto della loro uguaglianza di fronte alla legge, sono a tal fine
insufficienti.
Secondo Galgano (1977, 947), poiché gli interessi a confronto nella contrattazione
di massa e in altri rapporti della società contemporanea non si dimostrano suscettibili di una
reductio ad unum, il contratto è divenuto soltanto una mascheratura degli interessi coinvolti
nell’operazione negoziale.
Alla crisi in atto del negozio giuridico nel diritto privato si contrappone una sua
affermazione nell’ambito pubblicistico.
Questo importante processo, profeticamente colto dal Galgano nella sua voce
Negozio giuridico del 1977, dipende dal fatto che “L’esercizio dei pubblici poteri sta
perdendo carattere autoritario, per evolversi verso una gestione negoziata e consensuale”
(Galgano 1977 947). Ne consegue l’impossibilità di sostenere con nitidezza la distinzione
tra diritto privato e diritto pubblico, tra diritto autonomo ed eteronomo, in quanto il primo è
destinato a rilevare oltre la cerchia dei rapporti tra privati, mentre il secondo viene prodotto
sempre più frequentemente in una rivoluzionaria prospettiva di accordo con i destinatari.
La dottrina si dimostra in verità ancora refrattaria a modificare gli schemi finora
utilizzati.
Non mancano opinioni che configurano il negozio come una norma giuridica,
definendolo o come lex privata o come norma sugli effetti negoziali, subordinata alla legge
che autorizza, a suo mezzo, la produzione degli effetti (Scognamiglio 1981, 18). Tuttavia, a
questo potenziale riconoscimento del ruolo del negozio viene opposta una decisa obiezione:
"Attraverso il riconoscimento dell’autonomia privata, la legge non ha inteso elevare il
negozio a fonte del diritto. Essa si impegna soltanto a fare seguire alle regole poste dai
privati corrispondenti modificazioni della realtà giuridica” (ibid., 18).
Queste affermazioni dottrinali non colgono con sufficiente consapevolezza il ruolo
che il negozio giuridico ha assunto tra le fonti di produzione.
L’autore che per primo ha collocato il negozio giuridico tra le fonti del diritto è stato
Hans Kelsen.
20Circa
i rapporti nei quali la legge interviene autoritativamente a conciliare i diversi interessi sociali in
gioco, è prevedibile un ridimensionamento del fenomeno. La crisi del Welfare State comporta una prevedibile
riduzione dell’impegno diretto dello Stato legislatore nella società, in particolare la prospettata «flessibilità»
del mercato del lavoro non potrà che condurre ad una riduzione dei vincoli posti alla contrattazione tra
lavoratore e datore di lavoro.
37
Nei Lineamenti di dottrina pura del diritto viene sottolineata la funzione
individualizzatrice del negozio, cioè la sua capacità di creare, nell’ambito del diritto civile,
le norme giuridiche applicabili al singolo rapporto.
Nell’ordinamento giuridico, secondo Kelsen, l’autonomia dei privati si porrebbe tra
la legge, le cui disposizioni generali ed astratte sono inidonee ad incidere direttamente sul
rapporto giuridico, e la sentenza, il cui intervento, solo eventuale, è condizionato dalla
violazione delle norme del comportamento reciproco, che il giudice deve accertare (Kelsen
1976, 110-11).
Anche se queste osservazioni appaiono innovative rispetto al rilevo attribuito al
negozio dalla dottrina di matrice giuspositivistica, è ancora presente in Kelsen, preoccupato
di non contaminare la sua “dottrina pura”, l’idea della dipendenza dell’atto privato di
normazione dalla legge.
Si trova infatti affermato nei Lineamenti che “(...)Delegate dalla legge, le parti
pongono delle norme concrete per il comportamento reciproco” (Kelsen 1976, 111). Non si
perviene al riconoscimento che mediante lo strumento del negozio i privati creino diritto in
maniera autonoma, a prescindere da qualsiasi preesistente norma generale ed astratta.
Sulla linea di Kelsen si pone anche uno dei maggiori studiosi italiani del negozio
giuridico, Emilio Betti. Nella Teoria generale del negozio giuridico (Betti 1994, 44) si
trova un’affermazione che sembra un riconoscimento della libera produzione negoziale del
diritto da parte dei privati: “Gli interessi che il diritto privato disciplina, esistono nella vita
sociale indipendentemente dalla tutela giuridica,” e più avanti (ibid., 45) “Già nella vita
sociale, prima ancora di qualsiasi intervento dell’ordine giuridico, i privati provvedono da
sé a foggiarsi i mezzi adatti. Ora mezzi di tal natura sono per eccellenza i negozi
giuridici.(...)I negozi giuridici hanno la loro genesi nella vita di relazione(...)”.
Tuttavia, questa apertura alla dimensione sociale del diritto privato è solo apparente,
ha un valore soltanto sociologico e non giuridico, dal momento che la produzione degli
effetti giuridici dipende sempre dall’intervento dello stato.
Infatti, prosegue il Betti, la libertà dei privati di porre norme può essere riconosciuta
dall’ordinamento dello stato in due modi: come fonte di norme giuridiche destinate a far
parte dell’ordinamento giuridico stesso, oppure come semplice presupposto per la nascita di
rapporti giuridici già disciplinati dalla legge con norme generali ed astratte. “Questa
autonomia (l’autonomia privata) viene riconosciuta dall’ordine giuridico, nel campo del
diritto privato, esclusivamente nella seconda delle funzioni anzidette. Viene riconosciuta
cioè dall’ordine giuridico quale attività e potestà creativa, modificativa, estintiva di rapporti
giuridici fra privato e privato: rapporti, la vita e le vicende dei quali sono disciplinate in
anticipo da preesistenti norme giuridiche. La manifestazione precipua di codesta autonomia
è il negozio giuridico.” (ibid., 49-50).
In definitiva, senza l’intervento di riconoscimento del legislatore, il negozio resta un
fatto sociale giuridicamente irrilevante o addirittura illecito (ibid., 54).
La teoria del diritto ha pertanto sempre negato la natura di vere e proprie fonti del
diritto ai negozi giuridici, accogliendo invece una concezione secondo cui sono fonti solo
38
gli atti che producono norme generali, volte a disciplinare i comportamenti di intere
categorie di consociati, e astratte, cioè suscettibili di applicazione ad un numero indefinito
di casi. Seguendo questo approccio la dottrina italiana ha escluso che il contratto sia fonte,
anche se esso, secondo l’art.1372 c.c., una volta concluso “Ha forza di legge tra le parti”.
L’approccio della dottrina pura del diritto al problema delle fonti può essere
proficuamente integrato. Infatti, la crisi della concezione giuspositivistica delle fonti di
produzione rende assai ardua la costruzione sia di una teoria della norma giuridica, sia di
una teoria dell’ ordinamento, ormai privo dei caratteri della completezza, della coerenza e
dell’unità. Ci sembra che si prestino ad un’analisi maggiormente aderente al rilievo assunto
dal negozio giuridico gli studi di Axel Hagerström. Questi infatti ha applicato all’esame del
negozio la sua nota concezione del diritto quale insieme di norme sentite come vincolanti
dai consociati e, soprattutto, applicate dai tribunali.
In particolare, interessa la distinzione da questi compiuta tra gli effetti giuridici e
quelli psicologici del negozio.
Gli effetti giuridici non consistono nella creazione di diritti ed obblighi, poichè nella
realtà empirica nulla viene ad esistenza in seguito alla pronuncia od alla sottoscrizione delle
formule contrattuali, ma nel fatto che, a determinate condizioni, l’apparato statuale
interviene a far rispettare l’accordo.
La persuasione di aver creato, estinto, modificato diritti ed obblighi rientra negli
effetti psicologici dell’atto e dipende dalla circostanza che la rappresentazione di diritti e
doveri associata all’uso di enunciati imperativi fa sorgere nel promittente la convinzione di
essere tenuto ad un determinato comportamento, nel promissario quella di poter esigere
quel comportamento.
Naturalmente questi due ordini di effetti, giuridici e psicologici, non sono privi di
collegamento, poiché la consapevolezza dell’intervento dell’apparato statuale rafforza
l’influsso psicologico del negozio. In quanto fruito dal giudice nelle sue decisioni del caso
concreto, alla stessa stregua della legge o del regolamento, il negozio è da annoverare tra le
fonti di produzione del diritto.
Sulla base di queste premesse, osserviamo come per l’ordinamento giuridico
italiano esista già, de iure condito, una figura di contratto annoverata tra le fonti del diritto.
Ci riferiamo ai contratti collettivi di diritto comune, conclusi dalle rappresentanze di
categorie di lavoratori e datori di lavoro. Formalmente si tratta di atti di autonomia privata
privi di efficacia erga omnes, il cui fondamento è in prevalenza individuato nell’art. 1322
c.c., che riconosce la possibilità di stipulare contratti atipici, non previsti dalla legge, purchè
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
In seguito a successivi interventi giurisprudenziali, la portata di questi contratti è stata
estesa oltre il rapporto tra le parti contraenti.
Questo orientamento è culminato, come è noto, nella decisione della Corte
Costituzionale, secondo cui le clausole del contratto collettivo rappresentano il parametro in
base al quale stabilire se la retribuzione del lavoratore sia “giusta” ex. art. 36 Cost.
(Pizzorusso 1977, 557).
39
Tale evoluzione consente di considerare decisamente ridotte le differenze tra i
contratti collettivi di diritto comune e quelli previsti dall’art. 39 della Costituzione, che
avrebbero dovuto, nell’intenzione del costituente, sostituire i contratti corporativi tra le
fonti del diritto.
Le norme collettive che scaturiscono dalla contrattazione collettiva sono di fatto
osservate per ragioni che prescindono dallo scambio del consenso e dal riconoscimento da
parte di fonti legali ed occupano nella gerarchia delle fonti la posizione assegnata alle
norme corporative dall’art. 1 Prel. : sono subordinate alla legge ed al regolamento, ma
prevalgono sulla consuetudine.
La dottrina più recente ha preso atto di questo cambiamento e considera il contratto
collettivo quale fonte del diritto, per la sua capacità di incidere sui passaggi logicoargomentativi seguiti dal giudice nella valutazione del comportamento delle parti. Dal
contratto infatti sorgono categorie volte a definire situazioni concrete, relative ad un
rapporto di lavoro in atto o che potrebbe sorgere (Nogler 1997, 110).
L’importanza del contratto collettivo appare definitivamente sancita dal d.lgs.
29/1993 e successive modifiche, sulla c.d privatizzazione del pubblico impiego. Con esso il
contratto collettivo è divenuto la fonte di disciplina anche dei rapporti di lavoro con la
Pubblica Amministrazione, con esclusione soltanto di alcune categorie professionali.
L’efficacia normativa del contratto collettivo è stata spiegata da Olivecrona, che lo
ha organicamente inserito nel sistema delle fonti. Nel corso della sua analisi
dell’ordinamento giuridico, in sede di descrizione della produzione extrastatuale del diritto,
afferma infatti che “Dopo quella delle associazioni, la più importante forma di attività
legislativa esterna all’organizzazione dello stato è data dai contratti. (...) Il raggio di
influenza della legislazione contrattuale si amplia quando il contratto viene concluso tra
associazioni che rappresentano gruppi opposti, con lo scopo di vincolare i loro membri”, ed
individua nel contratto collettivo di lavoro l’esempio più significativo (Olivecrona 1972,
151-52).
Negli ultimi anni, la consapevolezza che l’accordo delle parti può produrre diritto
oggettivo si è estesa, fino a trovare riconoscimento legislativo, nell’ambito del diritto
amministrativo, maggiormente legato al dogma della produzione statualistica del diritto.
Nella concezione tradizionale ottocentesca infatti, l’attività amministrativa dello
stato è incentrata sul provvedimento amministrativo, atto unilaterale di esercizio del potere
pubblico, considerato un’attuazione del comando generale ed astratto contenuto nella legge.
L’azione dei pubblici poteri è infallibile, perchè limitata e legittimata dalla legge (Di
Benedetto 1996, 419).
Questa immagine è divenuta inadeguata negli ordinamenti democratici
contemporanei, nei quali l’attività della pubblica amministrazione deve essere fondata sul
consenso.
Nell’ordinamento giuridico italiano, la stessa Costituzione prevede il diritto-dovere
di partecipazione dei cittadini, inteso quale loro diretto coinvolgimento nella vita pubblica.
In questa luce possono essere lette disposizioni come l’art. 1 Cost. : “La sovranità
40
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (2°
comma) e l’art 3, secondo comma, Cost.: “E’ compito della repubblica rimuovere gli
ostacoli(...), che, (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
paese”.
Di fronte alla nuova visione del rapporto dello stato con i cittadini, caratterizzata
non soltanto dal riconoscimento di diritti soggettivi che lo stato non può violare, come nel
pensiero liberale ottocentesco, ma anche dall’attribuzione ai cittadini del diritto di
determinare la struttura e gli indirizzi dell’azione statale, il legislatore ha previsto istituti
partecipativi.
Le nuove e rivoluzionarie disposizioni sono quelle contenute nella legge 241 del
1990, che detta una disciplina organica del procedimento amministrativo, cioè della
sequenza di atti che la Pubblica Amministrazione deve seguire quando emana i propri
provvedimenti, e nella legge 142 del 1990, la cosiddetta legge sulle autonomie locali, che
prevede concreti istituti partecipativi nell’ambito dei principi enunciati dalla legge n. 241.
Con queste norme, che hanno determinato il superamento del diritto amministrativo
“classico”, estrinsecantesi in atti autoritativi, si è affermata la categoria del contratto di
diritto pubblico, relativo sia ad accordi tra privati e P.A. che a quelli tra soggetti pubblici.
Per quanto riguarda i primi, la dottrina aveva, già prima dell’intervento legislativo,
definito contratti di diritto pubblico gli accordi intercorsi secondo la prassi tra la P.A. ed i
privati, per ragioni di speditezza procedimentale e di più efficace contemperamento degli
interessi coinvolti negli effetti del provvedimento. Questi contratti si distinguono da quelli
di diritto privato poichè, anche se le norme scaturiscono da un accordo, i soggetti del patto
non si trovano su un piano di parità, residuando all’organo amministrativo il potere di
revocare l’atto per motivi di opportunità di tutela dell’interesse pubblico (Di Benedetto
1996, 420).
La categoria del contratto di diritto pubblico, di creazione dottrinale e
giurisprudenziale, è stata sostanzialmente accolta nell’art. 11 della l. 241/1990 che ha
previsto la possibilità per la pubblica amministrazione di perseguire gli interessi pubblici
mediante accordi.
In dettaglio, la citata legge prevede sia accordi integrativi, che servono a
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento e che debbono essere in esso
inseriti, sia accordi sostitutivi, ammessi solo nei casi previsti dalla legge, i quali dettano la
disciplina di una fattispecie in luogo dello stesso atto dell’amministrazione.
La natura contrattuale dei provvedimenti emanati sulla base di accordi è confermata
dalla circostanza che essi sono, per espresso richiamo legislativo, soggetti alle norme del
codice civile in materia di contratti ed obbligazioni, e che la P.A. deve corrispondere un
indennizzo al privato, qualora receda dall’accordo per motivi di interesse pubblico.
La rilevanza di figure contrattuali nel diritto amministrativo non si limita ai rapporti
tra privato e soggetto pubblico, ma coinvolge anche le relazioni tra enti pubblici
nell’esercizio delle rispettive attribuzioni. L’art. 15 della l. 241/1990 istituzionalizza gli
41
accordi tra enti pubblici e li sottopone, salvo specifica incompatibilità, alle regole del
codice civile. La stessa legge prevede poi la possibilità che più amministrazioni pubbliche,
in presenza di interessi convergenti, possano concludere accordi di programma, nei quali
fissare obiettivi e modalità di azione comuni.
La prevalente dottrina ha attribuito natura contrattuale a queste convenzioni, anche
in considerazione del fatto che gli stipulanti sono, a differenza degli accordi conclusi con i
privati, su un piano di parità. La conseguenza della natura contrattuale è che, pur dovendo
essere inclusi in un provvedimento amministrativo, vincolano le parti (pubbliche) fino dal
momento della loro stipulazione (Di Benedetto 1996, 432).
Mentre la dottrina del negozio di diritto pubblico è diffusa da diversi anni nel diritto
amministrativo, del tutto nuova appare l’efficacia della produzione contrattuale del diritto
manifestatasi in un’altra branca dell’ordinamento, storicamente riservata alla
regolamentazione legislativa: quella della procedura penale.
Fin dalla sua nascita il processo penale, per la capacità incidere sulla libertà
personale dei cittadini, è stato circondato da varie garanzie, prima fra tutte la possibilità di
disciplinarne le diverse fasi solo ad opera di norme di rango legislativo. Conformemente a
tale tradizione degli ordinamenti continentali, l’art. 112 della Costituzione attribuisce
l’esercizio, obbligatorio, dell’azione penale ad un organo pubblico, il magistrato del
Pubblico Ministero.
La rilevanza di una sorta di contratto “processuale” tra le parti del processo penale è
da stata resa possibile dalla riforma del codice nel 1988, che ha introdotto il rito speciale,
proprio della tradizione dei sistemi anglosassoni, del c.d. patteggiamento (artt. 444 e ss.
c.p.p.).
Tale rito consiste, come è noto, in un procedimento che le parti del processo
(pubblico ministero ed imputato) possono attivare volontariamente al fine di definire
rapidamente il procedimento penale, con il “premio” della riduzione della pena per
l’imputato che vi acconsenta.
Accanto all’applicazione della pena su richiesta delle parti, si collocava il giudizio
abbreviato, altra forma di definizione del procedimento riconducibile ad un’accordo inter
partes.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva infatti riconosciuto che “In tema
di giudizio abbreviato, quando sulla richiesta dell’imputato sia intervenuto il consenso del
p.m., deve ritenersi perfezionato un negozio giuridico di diritto pubblico, per sua natura
irrevocabile (...)”21
La Suprema Corte non si era limitata a definire lo scambio dei consensi del giudizio
abbreviato un negozio giuridico, ma aveva aggiunto come le volontà in esso manifestate
non fossero più revocabili dagli interessati22, estendendo al giudizio abbreviato la regola di
cui all’art. 1328 del Codice Civile, in base al quale la proposta di un contraente può essere
21Cass.
Pen. -Sezione III- 8 giugno 1993. Pubblicata su Cassazione Penale, 1995, p 99-108.
il giudice potrebbe disporre la non applicabilità del rito speciale, qualora giudicasse insufficienti
per la sua decisione le prove raccolte.
22Solo
42
revocata solo fino al momento in cui il contratto sia concluso. Una volta raggiunto
l’accordo, i dichiaranti sarebbero rimasti ad esso definitivamente vincolati.
La riforma “del giudice unico” (L.479/99) ha modificato i presupposti del giudizio
abbreviato, tra i quali non è più annoverato il consenso del Pubblico ministero. Viene meno,
per esigenze di economia processuale (l’instaurazione del rito è, in questo modo, agevolata)
una fonte negoziale del diritto processuale penale.
La giurisprudenza citata in proposito resta un documento della tendenza ad applicare
categorie privatistiche anche a branche del diritto originariamente incompatibili con esse.
Quanto all’applicazione della pena su richiesta delle parti, ne è stata esclusa la qualifica di
negozio giuridico bilaterale, di diritto privato o di diritto pubblico, dal momento che in
questo istituto vi sarebbero due manifestazioni di volontà unilaterali, convergenti,
provenienti dall’imputato e dal pubblico ministero, ma rivolte ad un terzo, il giudice
(Lattanzi 1997, 132).
Resta possibile l’ascrizione di questo procedimento speciale nel più ampio genus dei
negozi di natura processuale poichè, una volta perfezionato con l’adesione dell’altra parte e
la ratifica del giudice, non è revocabile unilateralmente e neppure modificabile per
evenienze sopravvenute (Id., 133).
Tutti i mutamenti sopra esaminati mostrano, inconfutabilmente, come nella società
contemporanea il diritto di origine negoziale e immediatamente sociale stia prevalendo sul
diritto dettato dallo stato attraverso i suoi organi, sia permeando di sè le fonti del diritto
tradizionalmente statuali (così nei casi delle leggi-provvedimento e degli accordi tra
pubblica amministrazione e amministrati), sia estendendo la propria efficacia oltre i limiti
che la legge pretenderebbe di tracciare (come avvenuto per la contrattazione collettiva).
Come osservato da Lombardi Vallauri, la negoziazione del diritto, ovvero lo
spostamento della produzione normativa dagli antichi centri logici del sistema verso
centrali private, si può iscrivere in un più ampio processo di de-pubblicizzazione e disufficializzazione, che coinvolge anche campi diversi da quello del diritto (Lombardi
Vallauri 1985, 355). Così è, ad esempio, per il campo economico e dei servizi, sempre più
orientato verso il neo-liberismo e le privatizzazioni, e per il campo religioso, dove le chiese
ufficiali subiscono la forte concorrenza di forme nuove di spiritualità, organizzate in sette o
chiese alternative, e di teologie private e personali non più controllabili attraverso le
gerarchie tradizionali.
Da un punto di vista filosofico, tale fenomeno può essere descritto in termini di
prevalenza di centri di produzione autonomi rispetto a quelli eteronomi. I concetti di
"sovranità" e di "stato", forgiati dalla teoria politica e giuridica dell’età moderna, appaiono
inadeguati a spiegare e rappresentare il diritto odierno, sottratto al monopolio di un solo
soggetto e prodotto da un’ ampia e diversificata pluralità di fonti.
Sotto questo profilo ci pare più che convincente la tesi di chi sottolinea analogie tra
la società contemporanea e quella medievale. In essa, il potere politico non alimentava la
pretesa di regolare compiutamente ogni comportamento sociale e la giuridificazione era
limitata a quelle parti del diritto immediatamente connesse all’attività di governo. Nella
43
costituzione medievale inoltre convivevano vari ordinamenti, come quello del diritto
romano, quello canonico, quello degli statuti e delle corporazioni, quello feudale. La
funzione fondamentale del principe medievale non era quella di legiferare, ma di rendere
giustizia ai sudditi: egli era più un gran giustiziere del suo popolo che un legislatore (Grossi
1996, 277).
Questa considerazione consente di capire la ragione per cui abbia assunto
un’eccezionale importanza un’altra forma di diritto assai diffusa nella società medievale,
creata dal ceto dei mercanti e sottratta al controllo di tipo statale, e che proprio con
riferimento a quel diritto spontaneo è stata indicata come lex mercatoria.
Con l’espressione lex mercatoria si designa un particolare tipo di diritto formatosi
nell’età comunale. Si trattava di un diritto creato dal ceto dei mercanti, senza alcuna
mediazione dell’ autorità politica, costituito dagli usi dei mercanti, dai loro statuti e dalla
giurisprudenza mercantile (la curia mercatorum), amministrata da giudici-mercanti.
La lex mercatoria si caratterizzava per la sua applicazione ai rapporti mercantili,
cioè a tutti i rapporti in cui almeno una delle due parti fosse un mercante: anche i non
mercanti dunque finivano per esservi assoggettati sulla base della presunzione, non
superabile con prova contraria, che chi contratta con un mercante sia anch’esso un
mercante.
Il mancato rispetto delle regole mercantili non provocava conseguenze giuridiche
poiché tali regole erano applicate da organi interni al ceto e non da organi statali, ma
determinava l’impossibilità per l’autore della violazione di invocare a proprio favore la lex
mercatoria (Galgano 1993, 41).
La legge dei mercanti si caratterizzava quindi non solo per il fatto di essere regola
dell’attività commerciale, ma soprattutto perchè diritto creato dagli stessi mercanti. La sua
origine è da ricondurre ad un’esigenza del tutto analoga a quella che ne ha determinato la
rinascita negli ultimi decenni, cioè la dimensione extra-comunale del mercato e la
conseguente necessità per coloro che vi operavano di un diritto uniforme per i propri affari.
Questo spiega il motivo per cui, di fronte ad un’ operazione conclusa da un mercante, la lex
mercatoria prevalesse su ogni altro tipo di diritto di carattere universale (diritto romano,
canonico, naturale) o particolare.
Il declino di questo diritto medievale ha inizio col processo di formazione dello
stato moderno, ente territoriale e monopolizzatore del diritto, e con la sua evoluzione nello
stato di diritto liberale. Da questo momento infatti la borghesia mercantile si rende conto di
quanto possa essere vantaggioso l’uso del diritto a proprio favore, rivendica privilegi e
promuove il processo di codificazione. Il diritto commerciale, di conseguenza, si statalizza
e viene posta in discussione la stessa distinzione, volta a tracciare un limite tra lo stato e la
società civile, tra ius publicum, valido “ratione imperii”, e ius privatum, valido “imperio
rationis” (Galgano 1993, 92).
In epoca moderna il diritto del commercio ha ripreso ad espandersi in due direzioni:
quella della commercializzazione del diritto privato (attuatasi in Italia nel 1942, quando il
codice civile ha formalmente assorbito il codice del commercio, ma sostanzialmente
44
affermato la prevalenza di quest’ultimo) e quella della tendenza a rendersi diritto
internazionalmente uniforme, adottato in base a convenzioni tra gli stati, o addirittura
sopranazionale.
Questa circostanza consente di spiegare il rinnovato interesse degli studiosi per la
presunta nuova lex mercatoria.
Intorno agli anni ‘20, gli specialisti del diritto di vendita e dei rapporti di commercio
hanno evidenziato la formazione di un diritto extrastatuale in interi settori del commercio
internazionale, ad opera dei commercianti e delle loro categorie professionali. La loro
intenzione non era quella di indicare un ordinamento originario e sovrano ma un diritto
spontaneo, costituitosi da sè.
Il dibattito sull’argomento si è riacceso negli anni ‘50, stavolta ad opera degli
studiosi di diritto internazionale. La fine del colonialismo ha fatto sorgere dei rapporti tra
paesi del Terzo Mondo e imprese private, ai quali non era applicabile il diritto
internazionale per mancanza di soggettività pubblica in queste ultime. Gli internazionalisti
hanno ritenuto applicabile un «transnational law», costituito da alcuni principi, tra i quali
quello per cui pacta sunt servanda e tutti i principi generalmente riconosciuti (Bonell 1992,
317).
In questa discussione si colloca la nascita, nel 1926, dell’UNIDROIT, l’Istituto
Romano per l’unificazione del diritto, istituzione internazionale autonoma che si propone il
compito della unificazione del diritto nell’ambito del diritto privato, in relazione sia ai
contratti tipici più importanti (ad es. la vendita) sia ai modelli contrattuali innominati (ad es,
il factoring ed il franchising), creati dalla pratica commerciale internazionale (Siehere
1988, 86). L’ istituto si è riferito, più o meno esplicitamente, all’esperienza dell’ American
Law Institute, che all’inizio degli anni venti, di fronte all’incertezza determinata
dall’esistenza di quarantotto stati federali, ciascuno dei quali fonte indipendente di diritto,
ha proceduto ad una esposizione sistematica del diritto esistente (Bonell 1997, 9).
Lo sviluppo di un diritto commerciale internazionale non statuale e la sua crescente
importanza hanno condotto a proposte di una vera e propria codificazione. La sempre
maggiore specializzazione della giurisprudenza moderna infatti, renderebbe urgente
l’esigenza di una sistematizzazione anche in questo settore (Zimmermann 1999, 234).
A prescindere dalla realizzabilità di queste proposte, esse rivelano la dimensione
assunta della lex mercatoria la quale, nel contesto della società post-industriale in cui i beni
ed i concetti giuridici sono creati prevalentemente dalla tecnica contrattuale (Galgano 1993,
211), si configura come uno strumento di innovazione giuridica alternativa alla legge ed ai
codici23.
L’incapacità del diritto positivo a seguire i mutamenti della società dipende dal carattere metanazionale
assunto dall’economia, evidentemente insofferente di fronte alla discontinuità delle discipline nazionali, e
dalle rapide trasformazioni economiche e sociali, sfuggenti alla rigidità della disciplina legislativa.
In molti settori, quali quelli degli interessi collettivi, della tutela dell’ambiente, della tutela del
consumatore, della tutela del lavoratore, dei diritti del malato, del diritto d’autore, della comunicazione di
massa, della disciplina della concorrenza (Alpa 1993, 112), il principale strumento di produzione di nuovo
45
I fattori che hanno consentito la crescita di questo tipo di diritto sono stati principalmente
l’interpretazione dei giudici nazionali, quella della giurisprudenza arbitrale e l’elaborazione
di nuove regole e tipi contrattuali da parte degli uffici legali delle multinazionali e delle
associazioni internazionali di categoria.
La mediazione dell’interprete, sia esso il giudice nazionale o un arbitro scelto dalle
parti, è indispensabile nella produzione di un nuovo diritto. Essa si pone quale veicolo di
legittimazione dei comportamenti non tipizzati dalla legge, inseriti nella motivazione della
sentenza (Lipari 1988, 482), ed assume un ruolo fondamentale nell’ambito di un processo
evolutivo, quale quello proprio delle società contemporanee, teso a privilegiare le fonti
extralegislative.
E’ determinante in questo senso l’intervento degli arbitri internazionali, designati
dalle parti in luogo dei rispettivi giudici nazionali, ai fini della creazione, della conoscenza
e della obbligatorietà delle regole del commercio internazionale.
La giurisprudenza arbitrale internazionale è in grado di conferire al tipo di diritto in
esame l’uniformità e la prevedibilità necessarie affinchè esso si possa delineare come un
sistema alternativo a quello statuale24, non soggetto alla frammentazione legata alle
interpretazioni dei giudici nazionali.
Vi sono tre modalità attraverso le quali l’arbitro internazionale utilizza la lex mercatoria per
la soluzione della controversia a lui sottoposta.
Il primo si riferisce alle ipotesi in cui vi sia un espresso richiamo delle parti in tal
senso. Questo esercizio del potere di autonomia delle parti prevale, riguardo alla disciplina
contrattuale, su ogni altra norma individuabile col meccanismo internazionalprivatistico.
In mancanza di un espresso richiamo delle parti, la lex mercatoria può essere
applicata dall’arbitro internazionale quando il sistema processuale in cui opera (come
avviene per quello svizzero o quello dei Paesi Bassi) lo autorizza a ricercare la “regola del
diritto appropriata” al rapporto, anche se appartenente ad un complesso normativo non
statuale.
Infine, la lex mercatoria è utilizzabile quando il contratto sia “delocalizzato”, cioè le
parti abbiano espresso la volontà di sottrarlo alla disciplina esclusiva di un ordinamento
giuridico nazionale. Intenzione che può essere palesata dalla clausola compromissoria che
richiami i principi generali di diritto comuni a più sistemi giuridici nazionali, o dal rinvio
dei contraenti a complessi normativi extrastatuali (quale, appunto, la lex mercatoria)
(Luzzatto 1997, 101).
diritto è costituito dal contratto, che esprime la volontà della società civile di autoorganizzarsi senza la
mediazione politica.
24La dipendenza della lex mercatoria dall’opera degli arbitri sarebbe legata al loro potere di individuare
ed applicare ai rapporti giuridici norme non statuali (Bernardini 1987, 502). Questo potere troverebbe anche
un fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1961, il cui art. VII afferma che l’abitro può applicare al
rapporto la regola più appropriata. Trattasi però di un fondamento discusso da altri autori, per i quali questa
disposizione si riferirebbe soltanto alla possibilità di scelta della regola di uno degli ordinamenti nazionali
coinvolti nell’atto.
46
Alla formazione di un diritto commerciale sovrastatuale hanno contribuito anche i giudici
nazionali. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha formulato affermazioni importanti, come
quella per cui la regola iura novit curia deve considerarsi estesa anche al diritto straniero25,
che il giudice nazionale deve applicare anche se non provato dalla parte interessata, e quella
secondo cui l’ordine pubblico, l’insieme delle norme fondamentali ed inderogabili
dell’ordinamento, non è determinato solo dal diritto interno, ma soprattutto dai principi di
civiltà giuridiche affini (Galgano 1993, 216).
La Cassazione è arrivata a considerare la societas mercatorum un vero e proprio
ordinamento giuridico (Galgano 1993, 219). Essa esprimerebbe un proprio diritto di natura
consuetudinaria, fondato sulla opinio necessitatis delle sue regole, fatto valere non da propri
organi, ma attraverso gli organi di coercizione dei singoli stati competenti per territorio. Gli
usi instaurati in sede di commercio internazionale non sarebbero usi contrattuali, validi solo
tra le parti, ma veri e propri usi ex art. 1 delle Preleggi, fonti di diritto oggettivo.
Più in generale, la giurisprudenza dei paesi europei conferisce il proprio apporto alla
produzione della lex mercatoria, riconoscendo l’esistenza e la legittimità dei contratti
atipici stipulati dagli operatori economici, accogliendoli in quanto conformi ai principi
diffusi tra i paesi appartenenti ad una stessa area culturale giuridica. E’ stato così
notevolmente allargato il criterio della "meritevolezza", in base al quale gli ordinamenti
effettuano il controllo degli atti di autonomia privata.
L’ulteriore fattore di crescita della lex mercatoria è rappresentato dalle norme
elaborate dalle stesse categorie professionali interessate. Gli uffici legali delle
multinazionali e le associazioni internazionali di categoria creano schemi contrattuali non
previsti dalla legge, dando vita a nuovi istituti o a discipline innovative rispetto a quella
legislativa.
I contenuti e gli effetti di molti atti di scambio sono reperibili in norme contrattuali
generali predisposte per regolare tipi di atti da concludere e valide per intere categorie di
operatori, norme che il Santini (1988, 281) definisce “codici collettivi”.
In quest’ultima categoria l’autore include varie fonti di disciplina di atti. Tra di essi i
regolamenti che, emanati da pubblici poteri, sono espressi nel loro contenuto dalle categorie
degli operatori interessati, quali i c.d. regolamenti di borsa, che disciplinano in modo
unitario le contrattazioni di borsa tra gli operatori aderenti, e sono fondati sul consenso
degli operatori stessi, interessati ad una preventiva determinazione delle modalità di
realizzazione dei relativi contratti26.
25Questa
tendenza è stata accolta anche dalla recente legge del 1995 n°218 in tema di diritto
internazionale privato. Essa infatti reca diverse disposizioni che autorizzano il giudice italiano a ricorrere non
solo al diritto legislativo, ma anche a quello giurisprudenziale e dottrinale degli stati esteri. Ad esempio, l’art.
15 così recita “La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione ed applicazione nel
tempo”.
26Tra i codici collettivi sono da annoverare anche i regolamenti d’affari, condizioni generali codificate da
associazioni professionali al fine di predisporre una disciplina uniforme per le contrattazioni del settore
merceologico interessato. Si tratta di norme che possono assumere sia la veste di regolamenti rivolti ai membri
di una data associazione professionale, sia quella di contratti tipo offerti anche agli operatori non soci: in
47
La formulazione di regole contrattuali generali ed astratte, tali da garantire prevedibilità ai
rapporti da concludere, comporta per le imprese notevoli vantaggi (Roppo 1977, 530):
accelera i procedimenti di conclusione degli affari e ne riduce i costi; rimuove motivi di
incertezza e controversia in relazione al contenuto del contratto; offre all’impresa la
possibilità di gestire, in modo più economico, le liti in un unico foro; configura un diritto
più flessibile ed adeguato di quello legale.
Infine, un ruolo analogo a quello dei codici collettivi è svolto dalle clausole che, nei
contratti individuali, le parti inseriscano negli accordi di integrazione. Si tratta di clausole
che regolano scambi successivi tra quelle stesse parti e che possono prevedere, ad esempio,
che il produttore sia esonerato da responsabilità in caso di ritardi nella consegna dovuti a
fatto di terzi o a forza maggiore, oppure può trattarsi di clausole arbitrali riferite anche ai
rapporti che verranno conclusi in futuro tra gli stipulanti (Santini 1988, 295).
In dottrina si discute sulla possibilità di qualificare la lex mercatoria come un vero e
proprio diritto, alternativo a quello positivo, il cui campo di efficacia coincida con i mercati
internazionali, creato dal ceto imprenditoriale per superare la discontinuità degli
ordinamenti nazionali.
Secondo David (1976, 587) vi sono due ostacoli che impediscono di conferire alla
lex mercatoria la coerenza e la prevedibilità necessarie ad un “diritto”, un ordinamento
giuridico autonomo. Tali ostacoli sono la frammentazione della giurisprudenza arbitrale,
che non rappresenta un sistema giurisdizionale organico, e la diffusa prassi di non motivare,
da parte degli arbitri, le proprie decisioni. Lo stesso David (1976, 588) ritiene peraltro che
vi sia una fondamentale differenze tra la moderna lex mercatoria e quella, senza dubbio
fonte autonoma del diritto, dell’età comunale. La seconda infatti si è formata e sviluppata in
un contesto di assenza di un diritto statuale, mentre la prima è potuta sorgere solo nella
misura in cui gli stati hanno autorizzato la produzione di diritto da parte dei privati.
Altri autori (Bernardini 1987, 504) evidenziano, oltre alla frammentarietà e
lacunosità del diritto mercatorio, la mancanza di fonti di cognizione e, soprattutto, la
carenza di organi propri dell’ordinamento mercantile in grado di sanzionarne
autonomamente le violazioni.
Riteniamo preferibile la soluzione proposta da Bonell (1992, 326-30) il quale, pur
negando l’autonomia della lex mercatoria, suggerisce di affrontare il problema tenendo
distinto l’atteggiamento delle corti statali da quelle arbitrali.
Di fronte alle prime, la lex mercatoria non può venire in rilievo come diritto
extrastatuale, in quanto le sue regole ed i suoi principi trovano efficacia solo se
entrambe i casi l’operatore sarà libero nei confronti della controparte, e sarà solo la volontà delle parti
medesime a recepire le norme regolamentari (Santini 1988, 283). I contratti-tipo rientrerebbero, secondo la
dottrina, nella più ampia categoria dei contratti normativi, caratterizzati dal fine di regolamentare i futuri
comportamenti dei soggetti e dunque rapporti ancora da concludere. Tra i c.d. codici collettivi rilevano i
codici di lealtà e correttezza, anch’essi elaborati da associazioni di operatori interessati. Normalmente queste
regole di carattere deontologico assumono rilievo giuridico tramite la volontà degli stipulanti, i quali adottino
impegni contrattuali di uniformare la propria condotta ad esse, con la conseguenza che la loro violazione
rappresenta la lesione di uno specifico obbligo contrattuale.
48
espressamente richiamati dalle parti o se si tratta di usi contrattuali propri della operazione
economica giudicata. La lex mercatoria può invece configurarsi come diritto transnazionale
ed extrastatuale di fronte alle corti arbitrali, per la ragione che gli arbitri possono decidere
ex aequo et bono, attingendo il diritto da fonti non statuali.
La riemersione di un diritto transtatuale e spontaneamente creato dai privati
rappresenta senza dubbio una manifestazione della crisi del potere legislativo, poiché
significa la rinuncia dello stesso a regolare completamente la sfera del giuridico e
l’accettazione delle condizioni poste dalla società civile.
La sistemazione diritto privato-diritto pubblico risulta da questo processo
profondamente mutata. Come è noto, il concetto di diritto privato ha sempre espresso
l’antitesi della società civile rispetto allo stato, e su tale antitesi sono state erette costruzioni
teoriche tra cui quella di Jean Domat è paradigmatica.
Domat ha infatti tracciato la separazione tra la società civile, che ha proprie fonti del
diritto, contrattuali e consuetudinarie, e produce il diritto dei privati, e lo stato, che ha
proprie fonti pubbliche (la legislazione ed i regolamenti) ed esprime un proprio diritto
(pubblico).
L’importanza fin qui studiata della lex mercatoria comporta, sotto un profilo teorico
generale, una ulteriore affermazione del contratto tra le fonti del diritto. Se infatti la sua
obbligatorietà dipende in gran parte dall’opera del giudice, non si può dimenticare che la
genesi di questa categoria di norme giuridiche è indissolubilmente legata alla negoziazione
dei privati nell’“espace international” (Bernardini 1987, 493), cioè nell’area sovranazionale
del mercato.
Il nuovo tipo di diritto che si sta affermando nel commercio internazionale
rappresenta un sistema di norme in cui è l’autonomia delle parti ad essere la più importante
fonte di produzione. Il potere normativo dei privati non soltanto non è ivi soggetto alle
limitazioni previste dagli ordinamenti giuridici nazionali (in quello italiano dall’art.1322
c.c., che vincola la libertà delle parti ai “limiti posti dalla legge” e alla circostanza di
realizzare “interessi meritevoli di tutela”), ma non è neppure ridimensionato dai principi del
sistema extrastatuale in esame, sempre derogabili dai contraenti del rapporto internazionale.
Gli ordinamenti contemporanei risultano, in definitiva, scossi da un impetuoso processo di
neogiuridicizzazione, intesa come espansione ed intensificazione del diritto prodotto da
organizzazioni non statali (Lombardi Vallauri 1985, 361), che costringe lo studioso a
riconoscere un rilievo ben più ampio di quello tradizionale al principio di effettività. Il
fenomeno esaminato fino ad ora non può, ad esempio, essere risolto inquadrando la lex
mercatoria tra le fonti extra ordinem, poichè ciò implicherebbe un giudizio di eccezionalità
sullo stesso non rispondente alla realtà, nella quale il diritto dei privati è in aperta e
continua concorrenza con le fonti statuali nella normazione.
Il negozio giuridico ha dunque assunto una collocazione tra le fonti del diritto,
sebbene nessuna metanorma sulla produzione normativa lo qualifichi in questo modo.
49
6. Le regole del ragionamento giuridico come metanorme sulla produzione del diritto
Di fronte alla prevalenza della realtà sugli schemi legislativi e dottrinali, attraverso un
ripensamento degli strumenti della scienza giuridica, il positivismo giuridico ha da tempo
abbandonato le sue posizioni originarie, accogliendo una concezione delle fonti aperta ai
modi di individuazione del diritto che si affermano nella società e nei tribunali (si pensi alla
rule of recognition di Hart).
Questa evoluzione ha portato la scienza giuridica a rinunciare ad alcuni dei postulati
che hanno connotato la concezione del diritto partire dall’800.
La resa del legislatore e degli stessi teorici a delineare un sistema delle fonti coerente e
completo, ha significato il tramonto dell’idea che forse più di tutte è stata le meta ambita
degli studiosi del diritto, quella della certezza.
L’ideale della certezza, elaborato e coltivato dal pensiero giusnaturalistico moderno
a garanzia dei diritti individuali, appare sempre più irraggiungibile, poichè la mancanza di
stabilità e coesione sociale ne rende irrealizzabili le condizioni che consistono nella
possibilità di conoscenza delle leggi da parte dei destinatari, nell’uniformità di
interpretazione da parte degli organi giudicanti, nell’efficacia dell’ordinamento giuridico
nel suo complesso (Faralli 1997, 89).
Appaiono illusori i tentativi di risolvere la grave incertezza determinatasi con
espedienti di carattere tecnico, volti ad assicurare il rispetto di determinati canoni nella
formulazione delle norme giuridiche da parte dell’autorità competente. E’ l’idea moderna
del diritto che, in questo scenario, risulta sconvolta, dal momento che non appare più
realizzabile il progetto rassicurante di un codice che accolga i fondamenti dell’ordinamento
giuridico, e che presenti i caratteri della sistematicità e della completezza.
Riteniamo però che di fronte alla constatazione dell’ inadeguatezza del diritto
legislativo non siano giustificate le opzioni a favore di una libera produzione
giurisprudenziale, e nemmeno la tentazione di disconoscere ogni funzione al diritto a favore
di strumenti alternativi di governo della società.
La storia ci insegna che le concezioni filosofiche esasperatamente antilegalistiche,
attraverso la svalutazione e la delegittimazione filosofica della legge, hanno condotto alla
teorizzazione dello stato etico (Platone, Hegel) o, all’opposto, dell’anarchia (Stirner) quali
uniche alternative al diritto.
Peraltro, la critica alla certezza del diritto formulata da alcuni filosofi richiede una
precisazione. Aristotele, ad esempio, constatata l’insufficienza della legge per i suoi
caratteri di generalità ed astrattezza, suggerisce il correttivo dell’ equità. Questa
osservazione è formulata nell’Etica Nicomachea, in un’opera di morale. Lo stesso autore
perviene a diverse conclusioni in una sede più propria, la Politica, dove, pur affermando
che la costituzione migliore non è quella scritta nelle leggi, auspica che in ogni stato le leggi
siano sovrane, perchè, proprio per il fatto di essere generali ed astratte, esse sono scevre
dall’elemento passionale ed irrazionale presente in ciascun uomo (Fassò 1982, 111). Se la
50
certezza non ha valore etico, non è un valore assoluto, non significa che non abbia
significato sul terreno giuridico e politico, su un terreno di valori relativi.
Di fronte alla crisi del diritto codificato sembra ineluttabile il fenomeno della
produzione normativa giudiziaria (quantomeno costituzionale), da giudicare anzi
positivamente perchè consente di adeguare il diritto alla società mediante una
interpretazione storica dei principi costituzionali. La posizione del diritto da parte delle
corti non deve però giungere a disconoscere la funzione della legislazione nell’ordinamento
giuridico, la legge infatti ha un proprio fondamento costituzionale ed al legislatore spetta il
compito di contribuire alla formazione del diritto (Zagrebelsy 1992, 112): la Costituzione si
preoccupa di tracciare le linee fondamentali dell’ordinamento mentre al legislatore sono
riservate le scelte politiche contingenti.
A questa considerazione si aggiunga quella per cui la legge mantiene un ruolo di
grande importanza tra le fonti di produzione del diritto (Pizzorusso 1977, 176). Oltre infatti
a costituire il modello per tutti gli atti normativi aventi la stessa denominazione (nel nostro
ordinamento, le leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano), è
il prototipo della categoria delle fonti caratterizzate dalla efficacia normativa primaria,
comprendente i decreti legislativi dell’esecutivo, le decisioni di accoglimento della Corte
Costituzionale ed i referendum abrogativi. Inoltre è l’unica fonte dotata di un’attitudine a
regolare tutte le materie assoggettabili a disciplina giuridica27.
Infine, è la stessa Costituzione a riconoscere il ruolo preminente dello strumento
legislativo, ponendo in alcune materie la c.d. “riserva di legge”, dalla quale scaturisce, da
una parte, il divieto a fonti diverse o subordinate alla legge di intervenire sulla materia,
dall’altra la prescrizione alla legge di disciplinare compiutamente la materia, senza
delegazione a fonti regolamentari.
Il legislatore deve rassegnarsi a vedere trattate le proprie leggi come “parte del
diritto” e non come “tutto il diritto”, ma può rivendicare la propria funzione come
essenziale di fronte alla Corte Costituzionale ed ai giudici in genere.
Il contributo del giudice alla formazione del sistema delle fonti pone in rilievo una
problematica che, a nostro avviso, rappresenta il fulcro del tema che abbiamo cercato di
esaminare. Intendiamo dire che nella teoria contemporanea la discussione sul mutamento
del sistema delle fonti e quella sulla interpretazione giuridica sono un tutt’uno.
Infatti, l’inadeguatezza del diritto positivo di fronte ai problemi politici, sociali ed
economici ha avuto come esito fatale la dissoluzione dell’immagine giusnaturalistica e
giuspositivistica dell’interprete quale mero esecutore degli ordini di un legislatore:
l’interprete non dichiara ma crea il diritto.
Giovanni Tarello (1980, 4) nella sua opera L’interpretazione della legge propone
un’ interessante distinzione tra l’uso moderno e l’uso antico del verbo “interpretare” nel
1989, 20 osserva come la competenza della legge sia “residuale”, cioè estesa a tutte le materie
non espressamente riservate ad altra fonte. Quando risulti una separazione di competenze tra diversi tipi di atti
normativi, le eventuali antinomie non sono risolvibili attraverso l’applicazione dei tradizionali criteri logici,
poichè prevale sempre la norma derivante dall’autorità titolare della competenza.
27Guastini
51
diritto. Nell’uso moderno esso indica l’attività di attribuzione di significato ad un
documento giuridico, in quello antico (interpretatio, ) invece significava l’attività
di mediazione tra il ius e coloro che vi erano assoggettati, ad opera di soggetti dotati di
particolari qualità (gli interpretes) e consisteva perciò in uno ius dicere. Negli ordinamenti
contemporanei, l’interpretazione ha assunto il più antico significato di produzione del
diritto.
Dunque, non è più accettabile la concezione statualistica per cui l’attività di
interpretazione avrebbe luogo solo nei casi dubbi. Per sostenere questa posizione i teorici
del diritto giuspositivisti si sono richiamati al brocardo “in claris non fit interpretatio”,
reso, come noto, come divieto all’interprete di compiere attività di definizione o
integrazione di fronte ad un testo giuridico dal senso letterale evidente. In realtà nel diritto
comune, poichè con interpretatio si designavano le decisioni dei giuristi e dei tribunali, cui
era attribuita efficacia di fonte del diritto in tutte le materie non regolate dalla lex (dal diritto
giustinianeo, da quello statutario o comunque posto da organi delegati), il brocardo suddetto
era soltanto un criterio gerarchico interpretativo, in base al quale era vietato il ricorso al
diritto dottrinale o giurisprudenziale in presenza della lex (Tarello 1980, 34).
Nella teoria giuridica contemporanea la questione si propone nei termini della
contrapposizione tra la teoria cognitivista e quella non cognitivista. Secondo la prima il
significato della disposizione interpretata è logos, è intrinseco al fatto, per cui esiste un
significato “vero”, precostituito28, mentre per i non cognitivisti il significato è un attributo
artificiale del fatto, è il prodotto di una decisione dell’interprete in un dato contesto storicosociale (Montanari 1996, 4-15).
Per una più recente tesi intermedia, è individuabile un significato “migliore”, in base
agli argomenti posti a sostegno della scelta (Jori 1996, 209).
E’ ormai diffusa la consapevolezza che l’interpretazione sia un’attività che
comporta sempre una decisione del significato della disposizione e quasi sempre una
proposta di significato e che non sia una mera attività cognitiva. Lo stesso Kelsen ha messo
in luce come l’interpretazione sia un’attività volitiva del giudice ed un momento
imprescindibile dell’applicazione.
Il problema che si pone al teorico (ma anche al pratico) del diritto non è quello di
optare per una delle tre concezioni accennate (cognitivista, non cognitivista, intermedia),
ma di individuare i criteri con cui controllare l’interprete.
Tale controllo richiede che siano tracciati i limiti dell’interpretazione, che sia
analizzato il ruolo della motivazione, che siano studiate le caratteristiche del ragionamento
giuridico.
Il primo problema, quello dei limiti all’interpretazione, può essere impostato
tenendo presente che secondo le regole del linguaggio tecnico-giuridico e di quello comune
28Questo
orientamento è stato criticato dall’empirismo radicale, che lo rimprovera di aver abbandonato la
metafisica teologica per accogliere una metafisica razionale, attraverso la costruzione di categorie causali
volte a mettere in relazione gli eventi osservati. Per gli empiristi la scienza non dovrebbe spingersi oltre la
descrizione puntuale degli eventi e dovrebbe rinunciare alla determinazione di un ordine tra i fatti.
52
allo stesso testo non può essere attribuito qualunque significato e che la decisone
dell’interprete è vincolata alle convinzioni proprie della società. Ne deriva una conclusione
di tipo “hartiano”, per la quale gli enunciati normativi giuridici hanno un nucleo di
significato relativamente costante.
Non ci pare una obiezione decisiva quella per cui l’interprete, in particolare il
giudice, è di fatto libero di attribuire qualsiasi senso all’enunciato.
Riteniamo infatti che lo svolgimento del processo interpretativo debba essere
valutato non in base a -possibili- singole decisioni arbitrarie, ma in rapporto alle decisioni
interpretative che finiscono per essere accettate nella comunità giuridica. Restando
all’esempio del giudice, figura privilegiata di interprete, non è corretto affermare che è
dotato di un potere illimitato, perchè se è vero che nulla gli impedisce di decidere qualsiasi
norma per il caso concreto, è altrettanto vero che la sua decisione è destinata ad essere
vanificata in seguito al vaglio degli organi dell’impugnazione, nella misura in cui si
allontani irragionevolmente dagli orientamenti dominanti. La decisione irragionevole
difficilmente assume il valore di precedente e ciò significa che non è conforme ai canoni
accolti dalla comunità dei giuristi.
Il controllo sociale sull’ opera dell’interprete è reso possibile dalla motivazione, cioè
da quella parte della decisione che indica i presupposti di fatto o di diritto in base ai quali si
è pervenuti a ricavare la norma per il caso concreto. Nell’ordinamento italiano in particolare
l’obbligo di motivazione per i giudici è previsto a livello costituzionale (art. 111 Cost.:
“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”).
Il ruolo svolto dalla motivazione è quello di illustrare i passaggi del ragionamento
giuridico, in maniera tale da giustificare la soluzione adottata ed in tanto la motivazione può
svolgere questo ruolo, in quanto sia conforme a schemi di ragionamento accolti nella
cultura giuridica di ciascuna società (Tarello 1980, 73).
Il nucleo della questione è rappresentato dalla domanda se il ragionamento dei
giuristi si articoli secondo le regole della logica formale, nel rispetto dei criteri di inferenza
e non contraddizione, oppure si svolga nelle forme della persuasione e della
ragionevolezza29.
Alcuni studiosi (von Wright, Scarpelli, Ross, Alchourrón, Bulygin) hanno, come è
noto, sostenuto che alle norme, così come alle asserzioni, è applicabile la logica, intesa
quale insieme di regole formali che collegano proposizioni. In questo contesto si colloca lo
sforzo di costruzione della logica c.d. deontica, ovvero la logica degli enunciati normativi.
29In
realtà, come notato da Bobbio con la consueta acutezza, il problema non dovrebbe essere impostato
in termini così generali, ma occorrerebbe distinguere i diversi tipi di ragionamento giuridico, a seconda della
posizione dell’interprete nella produzione o nella applicazione del diritto. Si possono individuare così il
ragionamento del legislatore, caratterizzato dal richiamo a principi o valori, quello del giudice, in cui sarà
prevalente il richiamo all’equità, e quello del giurista, in cui troveranno maggior spazio i richiami alle
esigenze di tipo sistematico (Bobbio 1989. 165).
53
Il ragionamento giuridico sarebbe un ragionamento, secondo la terminologia
aristotelica30, apodittico, in quanto partendo da proposizioni prime vere (le norme
giuridiche) perviene, attraverso un sillogismo o una catena di sillogismi, a proposizioni
necessariamente e formalmente vere ( la regola del caso concreto). Questa logica di tipo
formale ha rappresentato uno degli strumenti più importanti del positivismo giuridico come
teoria del diritto, perchè rispondente alla intenzione di disconoscere natura di fonti del
diritto agli organi dell’applicazione, la quale consisterebbe in una operazione automatica
secondo lo schema del sillogismo (disposizione di legge - descrizione della fattispecie
concreta - dichiarazione imperativa del diritto nel caso in esame).
A questa mentalità matematizzante, che vorrebbe fare della giurisprudenza una
scienza more geometrico demonstrata, si è opposto chi (come ad es. Viehweg, Toulmin,
Perelmann) ha ritenuto che il ragionamento giuridico segua non le regole della logica, ma
quelle della retorica, essendo un discorso volto a persuadere un uditorio, reale od ipotetico,
della ragionevolezza e della probabilità della soluzione proposta.
Il rinnovato interesse in questo ambito per gli studi retorici è nato in un clima di
reazione alla concezione neopositivistica, che negava empiricità e controllabilità al discorso
metafisico, a quello etico, a quello politico ed a quello giuridico, in quanto espressioni di
emozioni e di sentimenti (Tarello 1980, 86).
Il trattato di Perelmann sull’argomentazione giuridica (1958) è rivolto a dimostrare
che anche il discorso giuridico persuasivo è controllabile e limitato da proprie regole, che
non sono quelle della logica formale, ma nemmeno si esauriscono nell’appello a emozioni o
sentimenti. Le regole applicabili alla persuasione sono quelle della “ragionevolezza”. A
questo fine l’autore ricostruisce una fenomenologia dell’argomentazione giuridica, una
descrizione degli argomenti usati con successo nei diversi contesti storico-culturali e nelle
varie situazioni dialogiche, individuando alcune tecniche del ragionamento persuasivo.
Riteniamo che un’attenta osservazione di come si articolino i discorsi dei giuristi
(avvocati, studiosi, giudici) renda difficilmente sostenibile la tesi della applicabilità ad essi
di una logica deontica, che fissi i passaggi attraverso i quali da premesse giuridicamente
valide possono essere dedotte norme giuridiche valide.
Gli assertori della logica formale non sono riusciti a superare la decisiva obiezione
per cui essa è stata concepita per le asserzioni, di cui può dirsi che siano vere o false, e non
per le direttive, non qualificabili con tale parametro.
Il primo Kelsen tentò, salvo poi ritornare, come vedremo, sui suoi passi di sostenere
che se non è applicabile direttamente, la logica deontica si può applicare al diritto
indirettamente, tramite il controllo logico delle affermazioni sul diritto.
30Aristotele
ha individuato due tipi di collegamento tra proposizioni, quello analitico e quello dialettico.
A questa partizione corrispondono due tipi di ragionamento, quello apodittico, spiegato nel testo, e quello
dialettico, che, partendo da proposizioni fondate sull’opinione, le consolida mediante argomenti (con la
persuasione e la retorica) e giunge a conclusioni che non sono formalmente vere ma anch’esse opinabili
(Tarello 1980, 76).
54
Altri autori hanno sostenuto che effettivamente le direttive non presentano la
proprietà di essere vere o false, ma possono essere considerate valide o invalide e che su
queste proprietà è edificabile una logica appropriata, in grado di determinare a quali
condizioni le norme giuridiche siano portatrici di un significato direttivo (Jori 1996, 227).
Questi tentativi non appaiono convincenti. La validità della norma non dipende solo
dal fatto che essa sia correttamente dedotta da altre norme, ma soprattutto dal fatto che essa
sia stata prodotta da un’autorità competente ed in conformità delle procedure accettate
nell’ordinamento giuridico dato. La norma non è un atto di deduzione, ma un atto di
decisione.
In questo senso è estremamente chiara la affermazione del secondo Kelsen (1989,
67) che la logica classica sia applicabile solo ad asserzioni e non alle norme “(...) Le norme
statuiscono un dovere, e poichè dovere è un correlato di volere, esse sono il senso di atti di
volontà, e come tali non sono nè vere, nè false (...). Peraltro tra validità di una norma e
verità di un’asserzione non vi è alcuna analogia: verità e falsità sono qualità di
un’asserzione, mentre la validità non è qualità di una norma, ma la sua specifica esistenza
ideale”.
L’obiezione che potrebbe essere formulata a chi sostiene il carattere probabilistico e
persuasivo del ragionamento giuridico è quella secondo cui il giurista fa ampio uso di
strumenti logici quali l’analogia, l’argomentum a contrario ed a fortiori, l’argomento
sistematico.
La tesi che sosteniamo, confortati da autorevoli scrittori (Zagrebelsky 1996,186) è
che questi strumenti siano soltanto risorse argomentative per l’interprete, il quale perviene
indipendentemente dal metodo alla regola del caso, salvo richiamarsi in un secondo
momento ad essi al fine di fondare la propria decisione, di dimostrare che la norma estratta
dall’ordinamento è possibile, cioè giustificabile in un ordinamento dato.
Le regole dell’inferenza logica hanno un limitato campo di applicazione nel diritto,
poichè presuppongono operazioni, quali la scelta del documento giuridico rilevante e
l’attribuzione ad esso di un significato, frutto di decisioni dell’interprete. Ad esempio, il
ricorso all’analogia per colmare le lacune dell’ordinamento non è un’operazione
strettamente logica, ma dipende dall’attribuzione al diritto di determinate caratteristiche
(coerenza e completezza) non intrinseche, ma frutto di precise scelte politiche (Tarello
1980, 82). Ancora, di fronte ad una lacuna è l’interprete a decidere se debba essere
utilizzato il procedimento analogico o quello a contrario, con soluzioni opposte del caso
concreto.
Per quanto attiene all’interpretazione logica e a quella sistematica, pretese
applicazioni del metodo deduttivo, sono insufficienti, poichè di fronte a norme oscure o ad
un comportamento regolato da più norme, l’interprete dovrà ricorrere a tecniche di ricerca
che lo condurranno a soluzioni soltanto probabili (Bobbio 1989, 172).
L’interpretazione storica e quella teleologica, che rappresenterebbero due casi di
applicazione del metodo induttivo, avendo ad oggetto comportamenti umani
55
(rispettivamente, quello del legislatore e quello della generalità dei consociati) presentano
carattere anch’esso soltanto probabilistico (Bobbio 1989, 176).
In definitiva, nel ragionamento giuridico si trovano sia argomenti retorici che
argomenti logici, questi ultimi utilizzati non con metodo matematico ma al fine di
persuasione della ragionevolezza della soluzione accolta. Perchè questo fine possa dirsi
raggiunto non è sufficiente la consistency, l’assenza di autocontraddizione, ma occorre la
coherence, la congruenza, ovvero la capacità della decisione di “fare senso” come un tutto
(MacCormick 1995, 37).
Nell’ambito della coherence Mc Cormick distingue una congruenza normativa ed
una narrativa.
La congruenza normativa è riferita alle questioni di diritto, ed è rispettata in tutti i
casi in cui la regola decisa sia giustificata come applicazione conforme a determinati
principi o valori, scelti dall’interprete per conferire senso all’insieme delle norme rilevanti
per la questione. Quindi, secondo MacCormick, un insieme di norme è congruente se esse
sono correlate, in quanto funzionali al raggiungimento di fini o valori comuni.
La congruenza narrativa invece è quella riferita a questioni di fatto, di cui non vi sia
una prova diretta mediante percezione immediata e dunque alla maggior parte dei fatti
oggetto di processi. Essa consiste in una sorta di verosimiglianza, di buon senso secondo
l’id quod plerumque accidit, che rende la proposizione controllata spiegabile allo stesso
modo di quella formulata sulla base della percezione diretta (MacCormick, 51).
Tutto ciò che, nel rispetto dei criteri suddetti di coerenza narrativa e normativa,
venga accolto ed utilizzato dall’interprete per giustificare la propria decisione avrà dignità
di fonte del diritto. E’ questa considerazione che ci conduce a sostenere che il negozio
giuridico, la giurisprudenza, l’interpretazione dottrinale devono essere annoverati tra gli atti
normativi dell’ordinamento giuridico.
In ultima analisi, le regole del ragionamento giuridico sono destinate, nel contesto
attuale di profonda crisi del sistema delle fonti formali, a svolgere il ruolo di metanorme
sulla produzione del diritto. La determinazione di tali metanorme ed il perseguimento della
certezza nel diritto sono i gravosi compiti che spettano agli organi volti a garantire
l’uniformità interpretativa (la Cassazione, la Corte Costituzionale, La Corte di Giustizia
europea) ed agli studiosi del diritto.
Riferimenti bibliografici
Ainis, M. 1997. La legge oscura. Bari: Laterza.
Alpa, G. 1993. Note sulla costruzione del diritto privato europeo. Sociologia del diritto 1:
111-20.
Baratta, A. 1990. Le fonti del diritto ed il diritto giurisprudenziale. Materiali per una storia
della cultura giuridica 1: 189-210.
Barberis, M. 1993. Introduzione allo studio della filosofia del diritto. Bologna: Il Mulino.
56
Basciu, M. (Ed.) 1994. Crisi e metamorfosi della sovranità. Milano:Giuffré.
Bernardini, P. 1987. Contratti internazionali e diritto applicabile. Diritto del commercio
internazionale 2: 393-414.
Bessone, M., R. Guastini (eds.). 1995. La regola del caso. Materiali sul ragionamento
giuridico. Padova: Cedam.
Betti, E. 1994. Teoria generale del negozio giuridico. Ed. G. Crifò. Napoli:ESI.
Bobbio, N. 1965. Giusnaturalismo e Positivismo Giuridico. Milano: Edizioni di Comunità.
______. 1989. Sul ragionamento dei giuristi. L’analisi del ragionamento giuridico. Eds. P.
Comanducci e R. Guastini. Torino: Giappichelli.
______. 1993. Teoria Generale del diritto. Torino:Giappichelli.
Bonell, M. J. 1992. La moderna lex mercatoria tra mito e realtà. Diritto del commercio
internazionale 2: 315-32.
Bonell, M. J., F. Bonelli. 1997. Contratti commerciali internazionali e principi UNIDROIT.
Milano:Giuffré.
Cannizzaro, E. 1996. Esercizio di competenze e sovranità nell’esperienza giuridica
dell’integrazione europea. Rivista di diritto costituzionale 1: 75-123.
Carbone, M.S. 1997. Principi dei contratti internazionali e norme di origine internazionale
(con particolare riguardo al diritto uniforme) Contratti commerciali internazionali e
principi UNIDROIT. Milano:Giuffré.
Cian, G., A. Trabucchi,. 1996. Commentario breve al Codice Civile. (Con complemento
giurisprudenziale). Padova:Cedam.
Comanducci P., R. Guastini (eds.) 1989. L’analisi del ragionamento giuridico.
Torino:Giappichelli.
Corsale, M. 1979. Certezza del diritto e crisi di legittimità. Milano:Giuffré.
Crisafulli, V. 1968. Fonti del diritto(diritto costituzionale). Enciclopedia del diritto, XVII.
Milano:Giuffré.
David, R. 1976. Il diritto del commercio internazionale: un nuovo compito per i legislatori
nazionali o una nuova lex mercatoria? Rivista di diritto civile 1: 577-90.
Di Lucia, P. 1995. Nomografia. Milano:Giuffré.
Faralli, C. 1997. Certezza del diritto o diritto alla certezza? Materiali per una storia della
cultura giuridica 1: 89-104.
Fassò, G. 1966-1967. Storia della filosofia del diritto, voll. I-II. Roma: Laterza.
______. 1982 . Il giudice e la realtà sociale. In Scritti di Filosofia del diritto, II. Eds.
E.Pattaro,C.Faralli, G.Zucchini. Milano:Giuffré.
______.1994. Storia della filosofia del diritto, vol. III. Ed. C. Faralli e G. Zanetti. Bologna:
Il Mulino.
Ferrajoli, L. 1995. La sovranità nel mondo moderno. Milano:Anabasi.
Galgano, F. 1993. Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale. Bologna: Il Mulino.
Giuliani, A. 1982. Le “Disposizioni sulla legge in generale” nel codice civile del 1942. In
Trattato di diritto privato, vol.1, 197-209. Ed. P. Rescigno. Torino:Utet.
57
Grossi, P. 1996. Un diritto senza stato. (La nozione di autonomia come fondamento della
costituzione giuridica medioevale). Quaderni fiorentini 25: 267-84.
Guastini, R. 1989. Produzione ed applicazione del diritto: lezioni sulle “preleggi”.
Torino:Giappichelli.
______.1990. Dalle fonti alle norme. Torino:Giappichelli.
Jori, M. 1980. Il formalismo giuridico. Milano:Giuffrè.
______. 1987. Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi. Milano:Giuffré.
Jori, M., A. Pintore. 1995. Manuale di teoria generale del diritto. Torino:Giappichelli.
Kelsen, H. 1976. Lineamenti di dottrina pura del diritto.Torino:Einaudi.
Hart, H. 1991. Il concetto di diritto. Torino: Einaudi.
Irti, N. 1979. L’età della decodificazione. Milano: Giuffrè.
______. 1995. Codice Civile e società politica. Bari: Laterza.
Italia, V. 1990. La fabbrica delle leggi. Milano: Giuffré.
Labriola, S. 1983. Crisi della legge e principio di rappresentanza. Diritto e società 4: 72336.
Lipari, N. 1988. La formazione negoziale del diritto. In Nuovi moti per la formazione del
diritto. Atti Conv. Intern. Roma, 2-3 giugno 1987. Padova: Cedam.
Lombardi Vallauri, L. 1985. Delegalizzazione, neogiuridicizzazioni, secolarizzazione. Jus
1: 355-72.
Luzzatto, R. 1997. I principi UNIDROIT e l’arbitrato commerciale internazionale. In
Contratti commerciali internazionali e principi UNIDROIT. Milano:Giuffré.
MacCormick, N. 1995. La congruenza nella giustificazione giuridica. In La regola del caso.
Materiali sul ragionamento giuridico. Eds. R. Guastini e M. Bessone. Padova:
Cedam.
Mazzarese, T. 1995. Metanorme. Rilievi su un concetto scomodo della teoria del diritto. In
Struttura e dinamica dei sistemi giuridici. Ed. P. Comanducci: 125-58.
Meneghelli, R. 1990. Breve spunto di riflessione critica su un aspetto particolare
dell’attuale crisi della legge. Diritto e società 2: 217-23.
______.1992. Il dogma della completezza dell’ordinamento giuridico e le fonti extra
ordinem: spunto critico. Diritto e società 2: 249-55.
Modugno, F. 1989. Fonti del diritto. Enciclopedia giuridica, XIV. Roma: Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
Modugno F., D. Nocilla, 1990. Crisi della legge e sistema delle fonti. Diritto e Società 3:
411-34.
Monateri, P.G. 1992. Fonti del diritto. In Digesto delle discipline privatistiche. Sezione
civile, VIII. Torino:Utet.
Mossini, L. 1962. Fonti del diritto. Contributo alla storia di una metafora giuridica. Studi
Senesi 2: 139-96.
Olivecrona, K. 1967. Il diritto come fatto. Ed. S. Castignone. Milano:Giuffrè.
______. 1972. La struttura dell’ordinamento giuridico. Milano: Etas Kompass.
Paresce, E. 1968. Fonti del Diritto. In Enciclopedia del diritto, XVII. Milano: Giuffré.
58
Pattaro, E. 1994 . Temi e problemi di Filosofia del Diritto. Bologna:Clueb.
Pinelli, C. 1995. Le fonti del diritto nell’epoca dell’internazionalizzazione. In Diritto
pubblico 2: 359-92.
Pizzorusso, A. 1977. Delle fonti del diritto. In Commentario del Codice Civile, Eds. A.
Scialoja e G. Branca. Bologna: Zanichelli.
Roppo, E. 1977. Il contratto. Bologna:Il Mulino.
Ross, A. 1990. Diritto e giustizia. Torino: PBE.
______. 1996. Tû-Tû. In Il linguaggio del diritto. Ed. U. Scarpelli. Milano: Led.: 119-34.
Ruggeri, A. 1994. Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le “metamorfosi” dei criteri
ordinatori delle fonti. Torino: Giappichelli.
Santini, G. 1988. Commercio e servizi. Bologna:Il Mulino.
Scarpelli, U. 1976. Diritto e analisi del linguaggio. Milano:Comunità.
______. 1995. Relazione introduttiva. In Nomografia. Ed. P. Di Lucia. Milano:Giuffré.
______. 1996. Il linguaggio del diritto. Milano:Led.
Scognamiglio, R. 1990. Negozio giuridico. In Enciclopedia giuridica, XX. Roma: Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
Silvestri, G. 1996. La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un
concetto. Rivista di diritto costituzionale 1: 3-74.
Sorrentino, F. 1993. La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europea.
Quaderni costituzionali 1: 71-112. Trimestrale di diritto pubblico 4: 1041-93.
Tarello, G. 1980. L’interpretazione della legge. Milano: Giuffrè.
______. 1988a. Codice. I-Teoria generale. In Enciclopedia Giuridica, VI. Roma: Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
Trabucchi, A. 1994. Il codice civile di fronte alla normativa comunitaria. Rivista di Diritto
Civile 4: 703-20.
Zagrebelsky, G. 1984. Il sistema costituzionale delle fonti del diritto. Torino: EGES.
______. 1992. Il diritto mite. Torino:Einaudi.
59