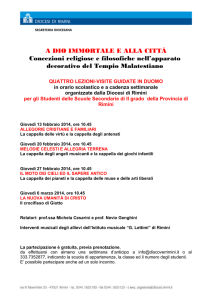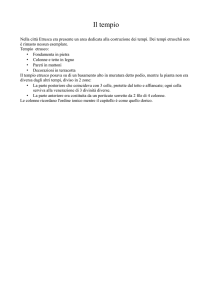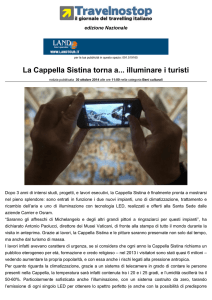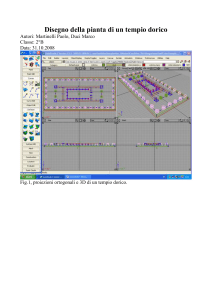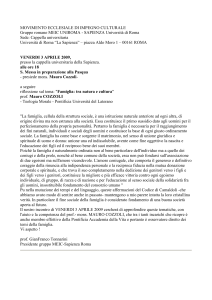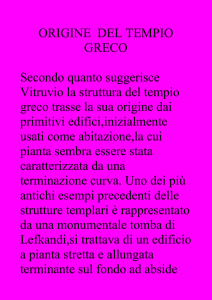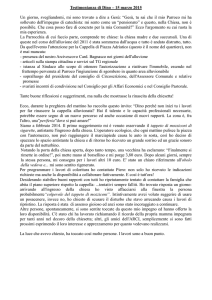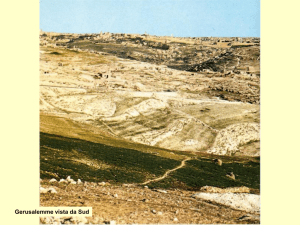Associazione culturale “La Fabbrica del Tempio”
Via IV Novembre, 35
47921 Rimini (RN)
Il Tempio Malatestiano di Rimini
Il progetto architettonico
Il Tempio Malatestiano, Basilica Cattedrale della Diocesi di Rimini, rappresenta una
delle testimonianze artistiche più significative del primo Rinascimento italiano, in cui
l'ampia e ricca tradizione dei saperi classici, attraverso la luce della Sapienza cristiana,
viene elavata a lode e sostegno della fede, in un percorso che ha, nell'articolazione
spaziale ed iconografica del Tempio, la sua più eclatante rappresentazione. Ma è anche
declinazione evidente di un "umanesimo cristiano" in cui l'uomo può riscoprirsi non quale
protagonista assoluto del proprio destino, ma quale centro ideale di quella ricca "attività
ordinatrice" che testimonia costantemente l'azione creatrice della Divina Sapienza, di
cui l'uomo, biblicamente, ne è l'immagine più fedele.
Proprio in questa duplice prospettiva va letto questo straordinario monumento,
edificato per volontà di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, trasformando
la preesistente e più modesta chiesa francescana (dedicata a San Francesco) per la quale
Giotto aveva realizzato il crocifisso attualmente collocato nell'abside (cfr. scheda
relativa).
A partire dal 1447, Sigismondo Pandolfo Malatesta dà avvio alla realizzazione di un
primo programma di trasformazione della preesistente chiesa, che consiste, di fatto,
nella realizzazione di due nuove cappella nella parte destra della navata, con interposta
sagrestia quale custodia di reliquie: la prima, dedicata a San Sigismondo, che di fatto
dovrebbe ospitare il suo monumento funerario; la seconda, dedicata a San Michele
Arcangelo, finalizzata ad ospitare le spoglie della futura moglie Isotta degli Atti. I lavori
di questo primo programma edificatorio si protraggono, a rilento, fino al 1452 (anno di
consacrazione della stessa cappella dedicata a San Sigismondo). Ma il rallentamento dei
lavori, alla cui direzione si trova il veronese Matteo de' Pasti, di fatto testimonia un più
ampio ripensamento dell'intero programma edificatorio, che sempre più risulta
interessare la riorganizzazione dell'intera chiesa. È proprio in questi anni che vengono
coinvolti artisti quali Agostino di Duccio e Piero della Francesca (cfr. scheda relativa) a
motivo della realizzazione sia di un nuovo apparato decorativo-scultoreo accompagnato
da affreschi parietali, mentre umanisti tra i quali Roberto Valturio e Basinio da Parma
partecipano alla definizione di un più accurato programma iconografico. Ma, sopratutto,
è con il coinvolgimento dell'architetto Leon Battista Alberti, in qualità di vero e proprio
"consulente umanistico", che l'ex chiesa francescana ritrova una più alta e rinnovata
connotazione identitaria, proprio a partire dal recupero di un linguaggio classico - quello
dell'architettura greco-romana - assunto quale espressione di una bellezza diversamente
declinata in "ordine", per una più ampia "significazione" teologico-spaziale. Un "ordine"
progettuale che investe la collocazione urbana del manufatto, caratterizzata
dall'evidenza piena del Tempio mediante sia l'antistante "vuoto" del sagrato, che la sua
relativa "sopraelevazione visiva" attuata attraverso la realizzazione di un solido
Pagina 1 di 4
Associazione culturale “La Fabbrica del Tempio”
Via IV Novembre, 35
47921 Rimini (RN)
basamento fondativo; un "ordine" che investe pienamente l'articolazione esterna
dell'edificio che, quale "involucro" architettonico, da una parte scandisce ritmicamente
la facciata (ora "trasfigurata" in Tempio dall'ampio portale, che, riferendosi
compositivamente all'esistente arco di Augusto, recupera il concetto teologico di Cristo
porta [Giovanni 10,9]), dall'altra configura i prospetti laterali quali sequenze di poderose
arcate, atte ad ospitare la memoria di uomini illustri, contraddistintisi per sapienza e
virtù; un "ordine" che investe l'architettura della navata e la distribuzione della luce al
suo interno, in cui la sequenza ritmica della diverse cappelle denota un forte asse
prospettico che doveva concludersi in una grande cupola (mai realizzata), catalizzatrice
proprio della luce quale metafora della presenza divina; un "ordine" di natura filosofica,
là dove la nuova chiesa, sempre nelle intenzioni dell'Alberti, avrebbe dovuto riportare
massime filosofiche e bibliche edificanti, e di cui il motto di Qoelet, "Tempus loquendi et
tempus tacendi", che a più riprese ricorre, ne rimane testimoninaza significativa; e,
ancora, per concludere, un "ordine" di natura liturgica, in cui - come sottolinea ancora
l'Alberti nel De re aedificatoria, il trattato di architettura che proprio in quegli stessi
anni va elaborando - la presenza dell'altare in fondo alla navata avrebbe accentuato
tutta l'importanza dell'unicità del sacrificio eucaristico quale evento di salvezza.
In questa articolato progetto di senso, in cui la bellezza si configura come
molteplicità di ordini ricomposti in armonica unità, prende forma quello che è un
percorso interno da leggersi quale vero e proprio itinerario dell'anima verso la luce, là
dove punto culminante doveva essere proprio la cupola albertiana, pensata sul modello
di quella del Pantheon a Roma.
Pagina 2 di 4
Associazione culturale “La Fabbrica del Tempio”
Via IV Novembre, 35
47921 Rimini (RN)
L'articolazione dell'interno
Caratterizzate da questa prospettiva iconografia, le sei cappelle rinascimentali,
che scandiscono lo spazio interno sin dall'ingresso, si presentano, come in un dialogo
complementare di corrispondenze frontali (a due a due), quali veri e propri gradini verso
una più ampia e completa visio Dei.
Così, all'interno della nuova identità architettonica, nella prima cappella di destra,
dedicata a san Sigismondo, connotata dalla presenza delle virtù cardinali e teologali, è
esaltata l'azione dell'uomo virtuoso, il cui operato non può non specchiarsi in quello
dell'uomo virtuso per eccelleza, il Cristo. Proprio al martirio di Cristo (o ai martiri) è
dedicata la cappela frontale (sul lato opposto della navata), sui cui pilastri le
rappresentazioni scultoree delle sibille e dei profeti (Michea ed Isaia) annunciano la
missione redentrice del Messia. Oltrepassate le due sagrestie, disposte simmetricamente
all'interno dell'articolazione spaziale della navata (la Cella delle Reliquie sulla destra e
la Cappella della Vergine Consolatrice e dei Caduti sulla sinistra), si configurano, da una
parte (a destra) la cappella dedicata a San Michele Arcangelo (comunemente indicata
come "cappella degli angeli musicanti" o "cappella di Isotta" in quanto vi è ospitato il
momumento funerario di Isotta degli Atti), i cui pilastri sono caratterizzati da formelle
con angeli musicanti, mentre frontalmente, dall'altra parte della navata, si trova la
cappella dedicata a San Raffaelle Arcangelo, connotata dal delicato gioco di putti
inquadrati su formelle rettangolari, così come gli "antistanti" angeli musicanti. È questo
lo spazio connotato dalla lode a Dio, là dove, da una parte gli angeli sembrano
inneggiare, con i loro variegati strumenti musicali, il salmo 150, mentre dall'altra, i
putti, ritratti in atteggiamento giocoso, appaiono rammemorare il salmo 8: "La tua
maestà voglio adorare nei cieli, con labbra di pargoli e di lattanti".
Ma quest'ultima cappella di San Raffaele Arcangelo è già un'anticipazione
"contemplativa" della bellezza dell'attività creatrice della Divina Sapienza, raffigurata
proprio nei libro dei Proverbi (8,27-30) come colei che durante la creazione del mondo
era "delizia" di Dio, atta a "giocare" con Lui in ogni istante. Ultima tappa di questo
Itinerario della mente verso Dio è infatti lo spazio della contemplazione della bellezza
del creato, testimoniato dalla cappella di San Gerolamo (la terza in sequenza a destra,
denominata più comunemente come "cappella dei pianeti") con una straordinaria
rappresentazione del cosmo celeste (così come indicata da Plinio e da Tolomeo), in cui
compaiono le raffigurazioni mitologico-antropomorfiche dei pianeti (da quello più vicino
alla terra, la Luna, per finire con Saturno), affiancati dalle rispettive case zodiacali, sia
notturne che diurne. Sulla chiave di volta dell'arco d'ingresso della cappella è scolpito un
sole, chiaro rimando alla luce come generatrice del cosmo, ma altrettando rimando alla
cappella frontale dedicata a Sant'Agostino (comunemente indicata come "cappella delle
arti liberali"), che con l'intensa rappresentazione delle arti liberali del trivio e del
quadrivio, e delle relative muse ispiratrici, celebra l'attività creatrice della Divina
Sapienza, qui ampiamente declinata, secondo la consuetudine del tempo, in un
linguaggio iconografico desunto dalla mitologia classica. Significativamente, all'apice dei
Pagina 3 di 4
Associazione culturale “La Fabbrica del Tempio”
Via IV Novembre, 35
47921 Rimini (RN)
pilastri di questa cappella, si trova la rappresentazione di Apollo (chiaro rimando alla
figura di Cristo sole, Cristo luce) che fronteggia Mnemosine, la madre di tutte le Muse,
identificata con l'Architettura (F.Canali e C.Muscolino). Qui, a conclusione del viaggio,
appare allora forte quel legame identitario di Cristo-luce, di Cristo-tempio, così caro
all'immagine della Gerusalemme celeste (Apocalisse 21,23).
E non a caso, tornando alla facciata esterna della chiesa, proprio l'adozione di un
linguaggio desunto dal modello del tempio classico appare non solo quale testimonianza
di un umanesimo attento al recupero filologico dell'eredità classica (che dal piano delle
humanae litterae si trasferisce all'ambito del linguaggio architettonico), ma quale
espressione, teologicamente coerente e pregnante, di quella identità di Cristo tempio,
così chiaramente esplicitata sia nel Vangelo di Giovanni (2,19), come in Apocalisse
(21,23).
D'atronde, la presenza di cherubini sulla sommità dei capitelli delle colonne
esterne, come su quella dei capitelli delle paraste che sandiscono lo spazio interno,
vuole essere non solo una citazione dotta nei confronti del tempio di Gerusalemme (1Re
6,29), ma, ancora una volta, un chiaro rimando a quella Divina Sapienza di cui, secondo
la Gerarchia Celeste di Dionigi Areopagita (VI sec.), gli stessi cherubini ne sono
"effusione": Divina Sapienza che, sin dall'inizio della creazione, è presente,
significativamente, "al fianco" di Dio come archittetto-ordinatrice (Proverbi 27,30), oltre
ad essere luce (Sapienza 7,26), che guida il "cammino" dell'uomo.
La costruzione del Tempio si protrae fino al 1460, anno in cui inizia il declino di
Sigismondo Pandolfo Malatesta, emarginato politicamente e sconfitto nel 1462 da
Federico da Montefeltro a capo delle truppe pontificie. Il Tempio rimane così incompiuto
ed il progetto albertiano per la facciata interrotto per sempre. Saranno poi gli stessi
francescani a provvedere alla copertura, a costruire una nuova abside e a sistemare gli
altari e gli arredi liturgici, innalzando anche l’attuale campanile.
Durante la seconda guerra mondiale, l’edificio è stato gravemente danneggiato
subendo tra il 1943 ed il 1944 diversi bombardamenti che ne hanno demolito la
copertura, l’abside e le due cappelle attigue (cioè le parti “più recenti” del Tempio).
Nei bombardamenti sono andati distrutti anche i due chiostri e gli edifici dell’attiguo
convento francescano. La ricostruzione, iniziata nel 1946, è terminata nel maggio 1947.
Nel 1950, è avvenuta la riconsacrazione della Chiesa.
L’aspetto odierno del Tempio Maltestiano è il frutto di un lungo restauro iniziato nel
1995 e terminato nel 2000. L’intervento non ha riguardato solo la parte monumentale,
ma si è esteso anche all’articolazione dei poli liturgici afferenti all’abside secondo le
indicazioni post conciliari.
Pagina 4 di 4