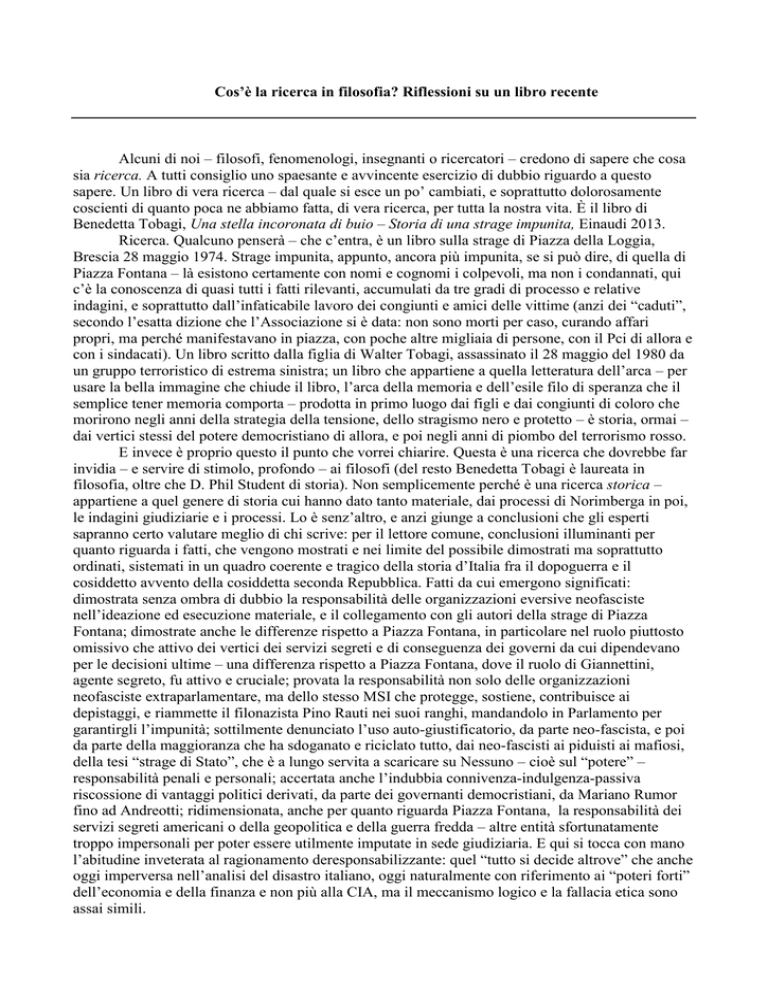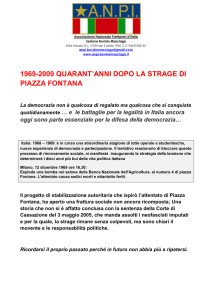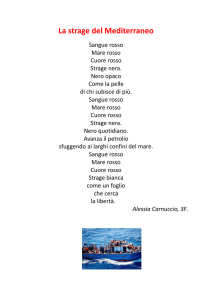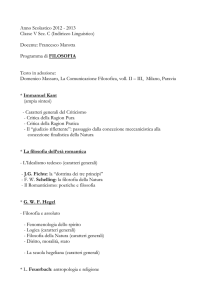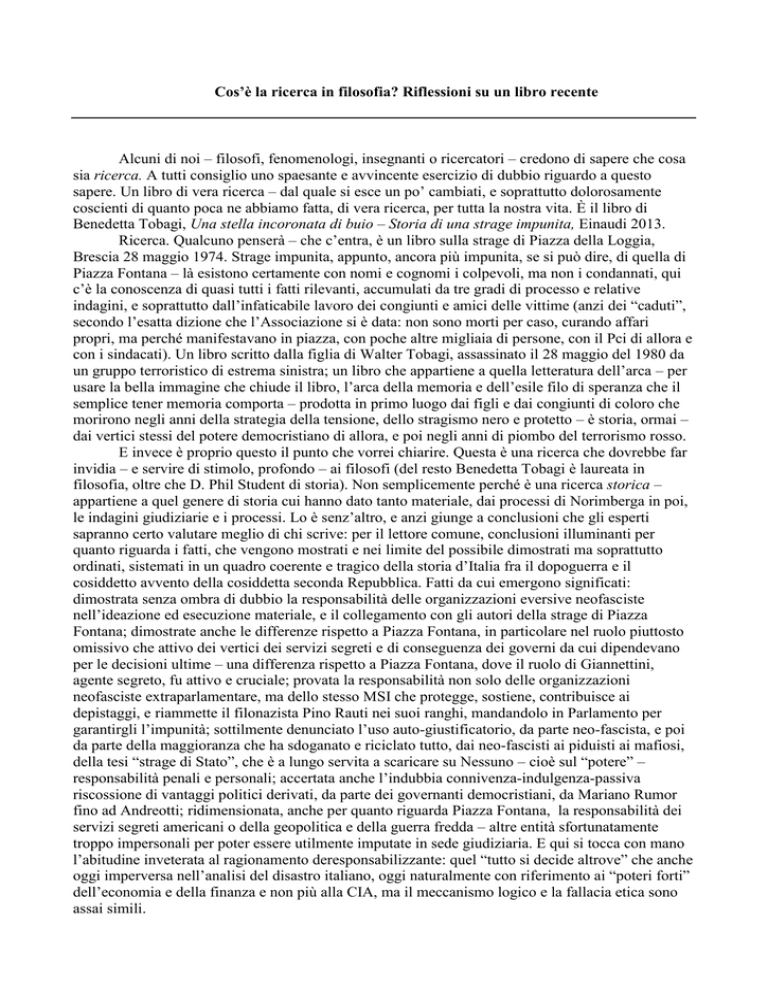
Cos’è la ricerca in filosofia? Riflessioni su un libro recente
Alcuni di noi – filosofi, fenomenologi, insegnanti o ricercatori – credono di sapere che cosa
sia ricerca. A tutti consiglio uno spaesante e avvincente esercizio di dubbio riguardo a questo
sapere. Un libro di vera ricerca – dal quale si esce un po’ cambiati, e soprattutto dolorosamente
coscienti di quanto poca ne abbiamo fatta, di vera ricerca, per tutta la nostra vita. È il libro di
Benedetta Tobagi, Una stella incoronata di buio – Storia di una strage impunita, Einaudi 2013.
Ricerca. Qualcuno penserà – che c’entra, è un libro sulla strage di Piazza della Loggia,
Brescia 28 maggio 1974. Strage impunita, appunto, ancora più impunita, se si può dire, di quella di
Piazza Fontana – là esistono certamente con nomi e cognomi i colpevoli, ma non i condannati, qui
c’è la conoscenza di quasi tutti i fatti rilevanti, accumulati da tre gradi di processo e relative
indagini, e soprattutto dall’infaticabile lavoro dei congiunti e amici delle vittime (anzi dei “caduti”,
secondo l’esatta dizione che l’Associazione si è data: non sono morti per caso, curando affari
propri, ma perché manifestavano in piazza, con poche altre migliaia di persone, con il Pci di allora e
con i sindacati). Un libro scritto dalla figlia di Walter Tobagi, assassinato il 28 maggio del 1980 da
un gruppo terroristico di estrema sinistra; un libro che appartiene a quella letteratura dell’arca – per
usare la bella immagine che chiude il libro, l’arca della memoria e dell’esile filo di speranza che il
semplice tener memoria comporta – prodotta in primo luogo dai figli e dai congiunti di coloro che
morirono negli anni della strategia della tensione, dello stragismo nero e protetto – è storia, ormai –
dai vertici stessi del potere democristiano di allora, e poi negli anni di piombo del terrorismo rosso.
E invece è proprio questo il punto che vorrei chiarire. Questa è una ricerca che dovrebbe far
invidia – e servire di stimolo, profondo – ai filosofi (del resto Benedetta Tobagi è laureata in
filosofia, oltre che D. Phil Student di storia). Non semplicemente perché è una ricerca storica –
appartiene a quel genere di storia cui hanno dato tanto materiale, dai processi di Norimberga in poi,
le indagini giudiziarie e i processi. Lo è senz’altro, e anzi giunge a conclusioni che gli esperti
sapranno certo valutare meglio di chi scrive: per il lettore comune, conclusioni illuminanti per
quanto riguarda i fatti, che vengono mostrati e nei limite del possibile dimostrati ma soprattutto
ordinati, sistemati in un quadro coerente e tragico della storia d’Italia fra il dopoguerra e il
cosiddetto avvento della cosiddetta seconda Repubblica. Fatti da cui emergono significati:
dimostrata senza ombra di dubbio la responsabilità delle organizzazioni eversive neofasciste
nell’ideazione ed esecuzione materiale, e il collegamento con gli autori della strage di Piazza
Fontana; dimostrate anche le differenze rispetto a Piazza Fontana, in particolare nel ruolo piuttosto
omissivo che attivo dei vertici dei servizi segreti e di conseguenza dei governi da cui dipendevano
per le decisioni ultime – una differenza rispetto a Piazza Fontana, dove il ruolo di Giannettini,
agente segreto, fu attivo e cruciale; provata la responsabilità non solo delle organizzazioni
neofasciste extraparlamentare, ma dello stesso MSI che protegge, sostiene, contribuisce ai
depistaggi, e riammette il filonazista Pino Rauti nei suoi ranghi, mandandolo in Parlamento per
garantirgli l’impunità; sottilmente denunciato l’uso auto-giustificatorio, da parte neo-fascista, e poi
da parte della maggioranza che ha sdoganato e riciclato tutto, dai neo-fascisti ai piduisti ai mafiosi,
della tesi “strage di Stato”, che è a lungo servita a scaricare su Nessuno – cioè sul “potere” –
responsabilità penali e personali; accertata anche l’indubbia connivenza-indulgenza-passiva
riscossione di vantaggi politici derivati, da parte dei governanti democristiani, da Mariano Rumor
fino ad Andreotti; ridimensionata, anche per quanto riguarda Piazza Fontana, la responsabilità dei
servizi segreti americani o della geopolitica e della guerra fredda – altre entità sfortunatamente
troppo impersonali per poter essere utilmente imputate in sede giudiziaria. E qui si tocca con mano
l’abitudine inveterata al ragionamento deresponsabilizzante: quel “tutto si decide altrove” che anche
oggi imperversa nell’analisi del disastro italiano, oggi naturalmente con riferimento ai “poteri forti”
dell’economia e della finanza e non più alla CIA, ma il meccanismo logico e la fallacia etica sono
assai simili.
C’è anche una scoperta ulteriore, una scoperta “normativa”: che, come sempre avviene
quando i fatti sono carichi di valori positivi e soprattutto negativi – trae dalla conoscenza dei fatti e
dei valori una “lezione” su quello che dovremmo fare. Dalla prima all’ultima pagina questo libro
indica la necessità inderogabile di una riflessione autocritica da parte di tutti noi, “discendenti” delle
forze ideologiche in gioco e in lotta in quegli anni, insieme più spietati, apparentemente più feroci, e
tuttavia meno disperati dei nostri anni, meno insensati o cinici (non un’ombra di rimpianto,
ciononostante) di quelli venuti dopo. Dopo Tangentopoli, dopo l’ultima fiammata di speranza che
una qualche catarsi, che un po’ di verità e un po’ di giustizia fossero possibili. Non purtroppo
rispetto ai fiumi di sangue versato prima, ma rispetto almeno alla corruzione profonda, non soltanto
economica ma di costume e di mente, in cui agonizzava la democrazia italiana. Che oggi è in coma
profondo, a quanto pare: un’immagine resterà di questa evidenza dell’oggi, particolarmente
didascalica nella sua crudezza. I maiali a Roma, che si aggirano nell’immondizia distesa a cielo
aperto.
Alcuni anzi vedranno il maggior merito di questo bel libro forse proprio in questo aspetto
della nostra storia (chi meglio di Benedetta Tobagi poteva illuminarlo): la dimostrata impossibilità
di ricostituire, con una memoria condivisa, una vita civile degna del nome, senza due condizioni. La
prima è la ricerca e l’accertamento definitivo – ma anche l’insegnamento, la divulgazione - della
verità storica dove non è più accertabile quella giudiziaria – e la verità storica non è più imprecisa,
non ha meno di quella giudiziaria le facce e le azioni, le scelte e i pensieri o le omissioni e le
rimozioni delle persone. Non è fatta di forze impersonali ma semmai di risposte personali a queste
forze che l’agire intrecciato degli uomini provoca, oltre le loro intenzioni. La seconda condizione
però è appunto, finalmente, la mai troppo tardiva disponibilità ad ascoltare le ragioni degli altri, di
quelli che furono i “nemici”, magari dei padri: a riconoscere, anche, la parte d’ombra che in ogni
appartenenza rinsaldata dall’opposizione a un “nemico” cresce, a mettere in questione la propria
identità morale e politica, dove si creda di averne ancora una. Anche il credere di non averne più
alcuna, del resto, è il risultato di rimozione e oblio, di ignoranza e menefreghismo, cioè di conti mai
fatti col proprio passato: perché anche proprio è il passato del paese in cui si vive, il passato degli
sconciati paesaggi, delle ingiuste città che abitiamo.
Avrà ragione, chi vedrà in questa lezione il contributo più importante di questo libro. Ma in
questi appunti io vorrei andare oltre questa lezione appresa – a quella ancora non appresa, che
ancora cerco di formulare: che cosa, in profondità, posso imparare da questa ricerca? Che cos’è
questo, che esemplifica in modo quasi lancinante (per un filosofo, per l’acuto sentimento delle
proprie omissioni e rimozioni di filosofo) l’Idea di ricerca? Sì, questa parola, quasi ossessiva,
continua a ritornarmi in mente, proprio come faceva durante la lettura di un libro uscito invece
ormai molti anni fa, ma altrettanto importante e coinvolgente anche oggi, Il vizio della memoria di
Gherardo Colombo: un uomo in ricerca, questo il pensiero che ad ogni pagina si levava in me, un
pensiero che accennava a qualcosa di cercato oltre (ma non senza) la verità dei fatti e quella dei
significati. Storia anche lì, la nostra storia. Ma oltre la nostra storia ancora qualcosa, qualcosa che
per il momento riesco a dire con lo strano verso di Mario Luzi, che mi torna alla mente
incongruamente: “e ancora/sopravanzano le cose i loro nomi”. Notate la perfetta ambiguità di
questo verso. C’è un’eccedenza di senso non formulato nelle parole intelligenti che descrivono i
fatti, i loro nessi, quando si tratta di azioni ed omissioni umane. Ma c’è anche un’eccedenza di
realtà, fattuale e valoriale, che le cose hanno rispetto a quello che siamo finora riusciti a saperne e a
dirne, e chiede di essere catturata in proposizioni, in immagini, in qualunque forma che ne faccia
senso. Qualcosa che tutti possono percepire, e che è probabilmente all’origine della filosofia: di
questa forse incongrua estrapolazione dell’interrogativo sull’umano, sulla sua essenza, da tutte le
frasi che contengono domande, di questa ricerca di senso che assurdamente viene separata dalla
ricerca sui fatti, ogni volta che la filosofia acquista, nelle diverse epoche, una sua tecnicità di lessico
e di problemi. Come è difficile allora mantenere l’equilibrio fra definitezza concettuale e
metodologica e contenuto vivo, come è difficile non scadere da un lato nel bizantinismo, e dall’altro
nella tuttologia. Oggi siamo in uno di questi periodi. Parliamo di filosofia in inglese, come un
tempo in latino, ma facciamo fatica a tenere insieme rigore e vita, capacità di dire qualcosa che
possa anche essere confutato e capacità di parlare a tutte le persone che hanno a cuore il senso della
vita propria e di quella associata, di incidere nella loro formazione, di tener viva la loro mente in
ogni occasione problematica dell’esistenza. Perché una filosofia che rinunci alla vocazione socratica
cos’è? A cosa serve?
Vorrei proporre un’ipotesi, che orienti il nostro pensiero in una direzione invece che in
un’altra. Saremo ormai forse d’accordo che un libro di storia contemporanea, e così immerso come
quello da cui siamo partiti nella questione tanto dolorosa e attuale della giustizia negata, dovrebbe
sconcertare e risvegliare ogni filosofo proprio ricordandogli che dei fatti della storia non può
disinteressarsi – anche se gli abusi della filosofia della storia, gli storicismi di ogni specie e i residui
relativismi e determinismi che ancora allignano nella filosofia postmoderna spiegano gran parte
della nostra diffidenza.
Ecco l’ipotesi: l’eccedenza di senso non formulato allo stato attuale della conoscenza e delle
domande, la filosofia la raccoglie in questioni che non cercano la spiegazione di ciò che è accaduto,
ma la giustificazione possibile delle azioni ed omissioni che stanno alla base dell’accaduto. Non
voglio dire che non si possa cercare anche la spiegazione. Ma nella prospettiva di prima persona in
cui il filosofo si colloca, questa ricerca non è molto diversa da un domandare agli altri le loro
ragioni. Perché? A quale scopo? In vista di quale valore? Come si può, ad esempio, rubare o
uccidere senza altro scopo che procurarsi denaro, come può ogni cosa che pareva mezzo – denaro,
potere, partiti, istituzioni, economia, politica – diventare fine a se stesso e alle persone cui doveva
semplicemente servire, in vista dei loro fini e valori?
Nel caso di Gherardo Colombo, mi fu subito chiaro su cosa verteva la ricerca – anche lì, con
la storia di tutti sapientemente intrecciata con la sua, dove gli squarci di memoria dell’infanzia,
dell’adolescenza, della giovinezza, ritmati dalla trasformazione dei paesaggi, dal tempo
misteriosamente altro delle “vacanze” – danno lo spessore del tempo vissuto, della realtà – non
quella del cronista o del giornalista, ma quella che i libri di vero respiro riescono a evocare, come
fanno i romanzi e i poemi. La domanda che attraversa quelle pagine è una sola: unde malum?
Troncata della sua premessa classica – si deus est – non è meno ardua, perché, Dio o no, la
caratteristica più spiccata del male morale, di quello solo bieco, ladro e truffaldino, come di quello
truculento e omicida, è l’inspiegabilità. Si usano di solito parole-mantra per spiegarlo, denaro e
potere – ma sono pseudo-spiegazioni, precisamente perché non c’è niente di più insensato dei mezzi
che diventano fini, e schiavizzano anche chi li persegue. L’agostiniano peccata enim quis intelligit?
- resta ancora la formulazione più chiara dello status quaestionis, quello che da sempre induce i
filosofi a rappresentarsi il male come non essere, niente, vuoto che divora.
Ma se la nostra ipotesi è corretta, ogni interrogazione essenzialmente filosofica, si trovi in
un libro di memoria, di storia o di filosofia, si trova necessariamente a fare i conti con l’enigma del
male, ogni volta che o nella misura in cui non riesce a trovare la giustificazione possibile di
un’azione o di un’omissione. Così facendo scopre. Scopre sempre nuovi aspetti dell’ingiustificabile,
e anche nuovi aspetti del giusto, che sono stati volati.
Anche Una stella incoronata di buio ha forse questa domanda – unde malum - come filo
conduttore. Ma questa domanda prende qui una forma più specifica. Perché questo male così
specifico di questo paese, la resistenza insormontabile alla scoperta e diffusione del vero – quando
si tratta di riconoscimento di responsabilità? Dai vertici del potere politico a quelli del potere
militare, alle organizzazioni politiche coinvolte agli uomini che hanno ideato e materialmente
eseguito una strage: anche quando non rischiano più (perché non più giudicabili, o perché espatriati,
o perché non personalmente ma solo indirettamente coinvolti): tutti coloro che potrebbero
contribuire a questa forma fondamentale di giustizia che è l’accertamento della verità e delle
responsabilità – non lo fanno, e al contrario contribuiscono tenacemente a rimuovere, occultare,
distruggere ogni traccia. Tre gradi di processo, quarant’anni di indagini, di scoperte, la situazione
internazionale e nazionale tanto cambiata – e infine, la sentenza definiva: assoluzione per tutti.
“L’amarezza è maggiore nel rendersi conto che né la caduta di un vincolo internazionale, né
l’ondata di rinnovamento innescata dalla stagione di Mani pulite sono bastate a creare le condizioni
perché si facesse piena luce sul passato. I vincoli resistono, caduto l’alibi dell’anticomunismo resta
la determinazione di alcuni centri di potere a proteggere se stessi e la propria reputazione…. La
percezione di un passato irredimibile che ritorna, senza possibilità di scampo, è soffocante” (378)
Una grande immagine improvvisamente apre uno squarcio di metafisica indifferenza quasi a
illuminare beffardamente questa angoscia: l’affresco che decora la sommità della Torre
dell’orologio in Piazza della Loggia, proprio al di sopra di una colonna scarnificata dalla bomba.
Scoperta, notata alla fine di questa lunga ricerca: Saturno divoratore, con falce e clessidra. Il
Tempo, che tutto cancella. Che tutto muta perché niente muti. Come fosse la sola risposta – già
racchiusa, scopre l’autrice, nella tesi di laurea di Livia, la giovane insegnante morta nella strage,
insieme agli amici del circolo politico e culturale cui apparteneva anche Manlio Milani, il marito
sopravvissuto, che ha speso il resto della sua vita a cercare la verità sulla strage. Era una tesi sul
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, una tesi dunque che racchiudeva misteriosamente il senso
desolato anche di questa storia, di tutta la nostra storia collettiva. Quando noi filosofi ne renderemo
ragione? Perché è questa, da sempre, la nostra storia?
E poi un’altra immagine, quella finale. Filosoficamente, tutta questa ricerca si svolge
all’ombra di una delle poche, grandi scoperte filosofiche del Novecento: il fenomeno del male
banale, del male senza radici di coscienza, di rivolta, di luciferina perversione, un male che non è
più quel “male radicale” la cui possibilità sembrava almeno condizione anche del bene, perché
esercizio di libero arbitrio. Ma il male banale, ottusamente inconsapevole di sé, sembra fatto da
mani di burattini, e tutto l’immenso sanguinoso teatro sembra un meccanismo di automi, senza
burattinai. Chi sono, allora, questi automi spirituali? Perché così Leibniz chiamava gli uomini, la cui
vita si svolge come girando sugli ingranaggi della loro oscura sostanza.
L’immagine viene dal Libro dei morti dell’antico Egitto, il manuale di istruzioni per l’anima
dopo la morte.
“Accederà alla salvezza della vita eterna colui il cui cuore sarà più leggero di una piuma. Il
cuore puro di un innocente, penso. Invece, mi sbaglio di grosso... L’orizzonte retributivo ebraico e
l’immagine del Dio giudice capace di penetrare i segreti dell’anima del peccatore, anche se questi
rifiuta ogni addebito di responsabilità, come fece per primo Caino nei confronti di suo fratello, sono
di là da venire. Il tribunale delle anime egizio esibisce nella sua feroce nudità un meccanismo
psicologico assai più realistico, e inquietante... Il cuore, infatti, leggo nei pannelli esplicativi,
potrebbe parlare, ma la formula rituale del Libro dei morti garantisce che esso si tratterrà dal
rivelare fatti che potrebbero compromettere il suo proprietario” (416).
Si tratterrà, dal rivelarli anche a se stesso. E qui intravedi un’ipotesi di ricerca che forse vede
solo il filosofo, eppure spiegherebbe perché questo libro sembra sempre lì sul punto di offrirti –
svoltate ancora poche pagine, una vera scoperta filosofica.
L’immagine del Dio giudice. O la rocca trascendentale della giustizia, l’inferno dantesco. La
millenaria efficacia di questi Novissimi non dipende dalla loro realtà – ma dalla loro idealità. Sono
l’Idea stessa della giustizia morale come verità finalmente rivelata e piena, e a tutti resa nota.
“Universale”, il giudizio: di tutti i tempi, per ogni tempo, per ogni e qualunque coscienza. Ci
eravamo abituati a credere che non ci sia bisogno di religione per vivere sotto la norma di questa
idea – come facciamo anche solo per constatare quanto poco trovi applicazione, questa idea, perfino
ai suoi livelli più basilari, quelli della giustizia penale. Ma un residuo di religione lo conserviamo
ancora tutti, se crediamo che l’eredità ebraica o quella cristiana o quella kantiana, solo perché sono
confluiti nella nostra storia, siano delle acquisizioni garantite anche per l’avvenire. Che le grandi
scoperte di valore restino con noi, siano conservate nell’essenziale anche quando “superate”, è una
forma di fede nella provvidenza, anche se in una provvidenza hegeliana più che cattolica.
Non c’è bisogno di aspettarsi il Giudizio Universale per credere che nessuna riconciliazione
e ricostruzione di una memoria condivisa sarà mai possibile senza una forma di catarsi. Questo è
vero, io credo, della storia italiana, ma dev’essere vero della storia delle comunità umane tutte, se
l’immagine del Giudizio Universale serba ancora un senso. E io credo che oggi ne serbi uno,
profondo, soprattutto in quanti di noi non credono affatto né che un Dio provveda nell’al di là né
che un momento storico verrà in cui tutto sarà chiaro e giustizia sarà fatta.
Questa idea ha come corrispettivo quella della coscienza morale, cioè del giudice in noi –
giudice non in quanto punisca, ma in quanto giudichi il vero, non lo ignori. Il cuore “non può”
ignorare ciò che uno ha fatto – perfino Hannah Arendt pensa alla coscienza morale come
all’impossibilità di convivere con un assassino – o con un ladro.
Hannah Arendt aveva riscoperto questo modo dell’ignorare che già Caino opponeva
all’accusa di Dio, e ne aveva descritto la fenomenologia, riaprendo il dibattito sulla questione
morale e sulla sua unità profonda con la questione politica, oltre la loro ovvia distinzione, su cui si
reggono le democrazie. Il fatto è che le democrazie si reggono tanto su quell’ovvia distinzione, per
la quale nessun legislatore può ergersi a giudice morale di un altro uomo, quanto su quella profonda
unità – per la quale ogni democrazia degenera in qualcos’altro se le virtù della cittadinanza, che
sono aspetti di moralità delle persone, non sono di continuo alimentate dall’interno, dall’anima di
ciascuno dei “sovrani” – soprattutto di quello che don Milani chiamava “i sovrani di domani”.
Ma l’immagine del Tribunale dei morti dell’antico Egitto scuote l’ultimo residuo di fede
nella provvidenza della storia. Credo che a tal punto sia indovinata, quell’immagine, perché dà
forma a un dubbio muto: l’antico Egitto, siamo noi. Non c’è storia e memoria che tengano, non c’è
progresso morale – se non c’è qui ed ora chi rinnovi, con l’esperienza del male subito, la cognizione
del dolore, da cui quella del valore è inseparabile. L’idea di catarsi, e con essa l’idea del giudice in
noi stessi, sono queste persone a tenerle in vita – non certo l’esserne culturalmente eredi. Dunque
abbiamo una sola risorsa: l’ingiustizia sofferta o veduta infliggere, in quanto sappiamo trarne una
più profonda conoscenza di cosa sia giustizia. Ogni lavoro, ogni pensiero, ogni ricerca in questa
direzione è parte di una battaglia che si svolge in ogni presente. L’antico Egitto non è all’origine, è
il fondo immobile dell’incoscienza sempre presente, con la quale in realtà ciascuno di noi può
convivere. Forse il prossimo passo è capire che la parola “valori” è stata la maggiore vittima degli
storicismi. Valore non è convinzione che si tramanda ma dato d’esperienza viva che chiede parola
nuova, pensiero chiaro. La ricetta egizia non rivela soltanto “un meccanismo psicologico assai più
realistico e inquietante” (415) degli imperativi kantiani. Indurre il proprio cuore all’omertà del
silenzio è la vera formula dell’indifferenza. È il nome del fondo pre-umano al quale, con tutta la
nostra scienza e la nostra tecnologia, rischiamo ogni giorno di tornare.