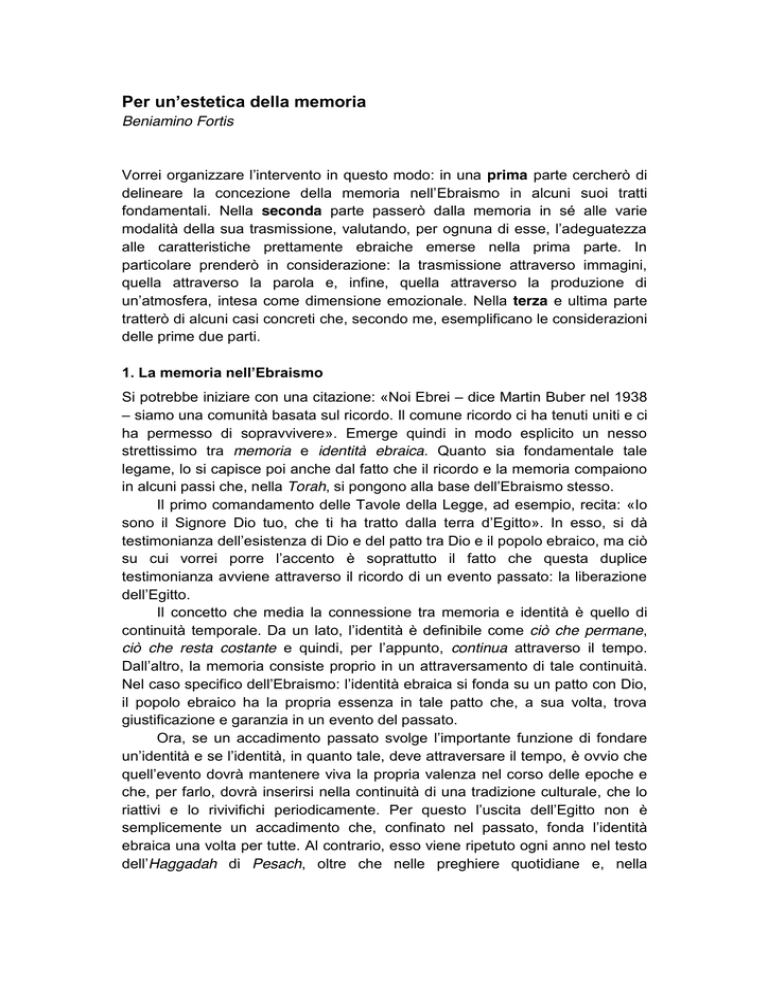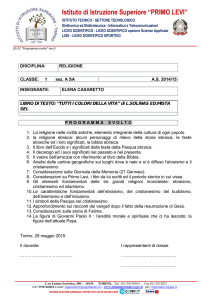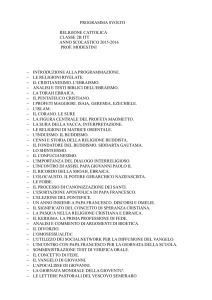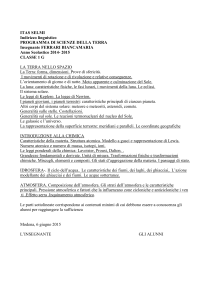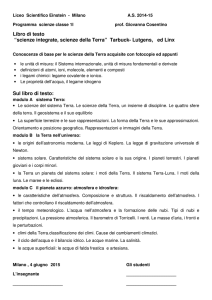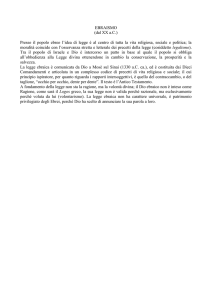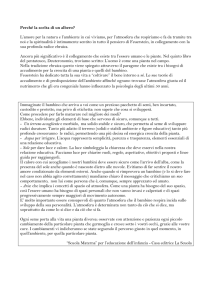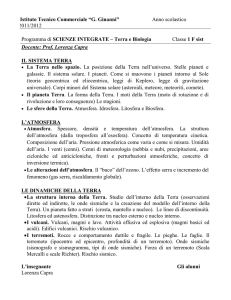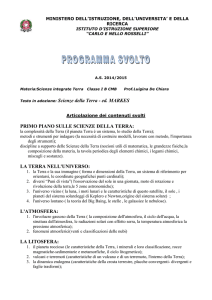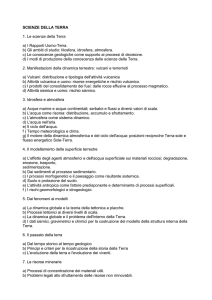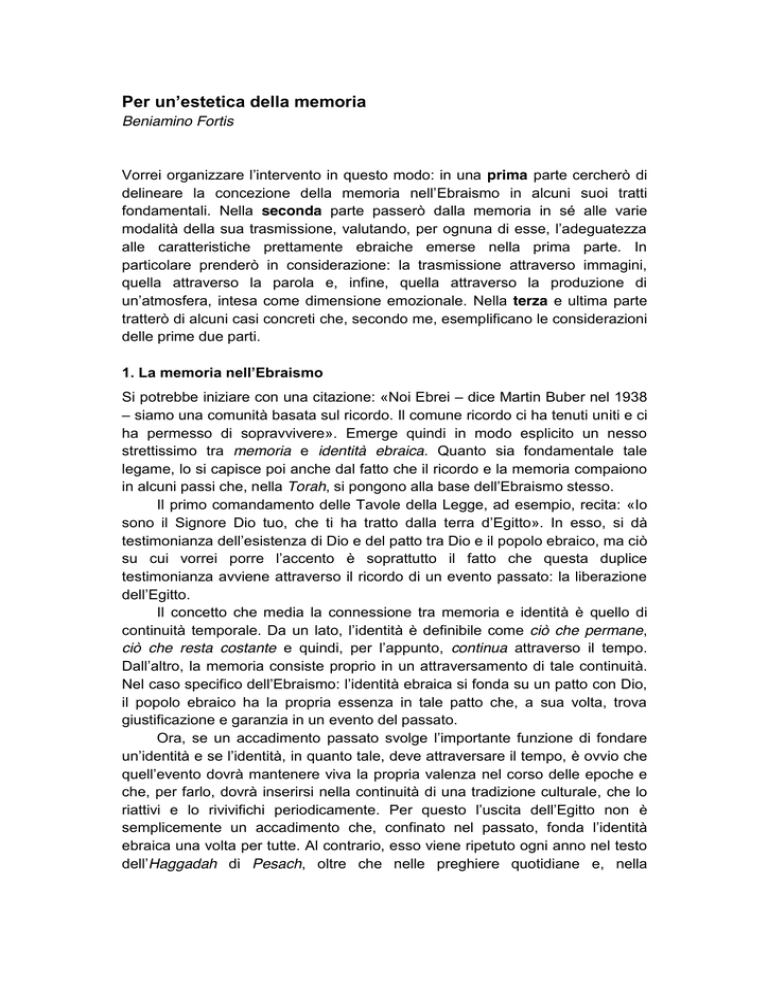
Per un’estetica della memoria
Beniamino Fortis
Vorrei organizzare l’intervento in questo modo: in una prima parte cercherò di
delineare la concezione della memoria nell’Ebraismo in alcuni suoi tratti
fondamentali. Nella seconda parte passerò dalla memoria in sé alle varie
modalità della sua trasmissione, valutando, per ognuna di esse, l’adeguatezza alle caratteristiche prettamente ebraiche emerse nella prima parte. In
particolare prenderò in considerazione: la trasmissione attraverso immagini,
quella attraverso la parola e, infine, quella attraverso la produzione di
un’atmosfera, intesa come dimensione emozionale. Nella terza e ultima parte
tratterò di alcuni casi concreti che, secondo me, esemplificano le considerazioni
delle prime due parti.
1. La memoria nell’Ebraismo
Si potrebbe iniziare con una citazione: «Noi Ebrei – dice Martin Buber nel 1938
– siamo una comunità basata sul ricordo. Il comune ricordo ci ha tenuti uniti e ci
ha permesso di sopravvivere». Emerge quindi in modo esplicito un nesso
strettissimo tra memoria e identità ebraica. Quanto sia fondamentale tale
legame, lo si capisce poi anche dal fatto che il ricordo e la memoria compaiono
in alcuni passi che, nella Torah, si pongono alla base dell’Ebraismo stesso.
Il primo comandamento delle Tavole della Legge, ad esempio, recita: «Io
sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d’Egitto». In esso, si dà
testimonianza dell’esistenza di Dio e del patto tra Dio e il popolo ebraico, ma ciò
su cui vorrei porre l’accento è soprattutto il fatto che questa duplice
testimonianza avviene attraverso il ricordo di un evento passato: la liberazione
dell’Egitto.
Il concetto che media la connessione tra memoria e identità è quello di
continuità temporale. Da un lato, l’identità è definibile come ciò che permane,
ciò che resta costante e quindi, per l’appunto, continua attraverso il tempo.
Dall’altro, la memoria consiste proprio in un attraversamento di tale continuità.
Nel caso specifico dell’Ebraismo: l’identità ebraica si fonda su un patto con Dio,
il popolo ebraico ha la propria essenza in tale patto che, a sua volta, trova
giustificazione e garanzia in un evento del passato.
Ora, se un accadimento passato svolge l’importante funzione di fondare un’identità e se l’identità, in quanto tale, deve attraversare il tempo, è ovvio che
quell’evento dovrà mantenere viva la propria valenza nel corso delle epoche e
che, per farlo, dovrà inserirsi nella continuità di una tradizione culturale, che lo
riattivi e lo rivivifichi periodicamente. Per questo l’uscita dell’Egitto non è
semplicemente un accadimento che, confinato nel passato, fonda l’identità
ebraica una volta per tutte. Al contrario, esso viene ripetuto ogni anno nel testo
dell’Haggadah di Pesach, oltre che nelle preghiere quotidiane e, nella
Per un’estetica della memoria Beniamino Fortis
ripetizione, riceve rinnovata attualità, viene trasformato in memoria viva, sentita,
e riaffermata quindi nel presente.
Un secondo esempio della centralità della memoria per l’Ebraismo si ha nella parte iniziale della preghiera principale, lo Shemà Israel, che ogni ebreo
osservante dovrebbe recitare tre volte al giorno. Il testo dice: «Ascolta, Israele,
il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno. […]. E queste parole che Io ti
comando oggi saranno nel tuo cuore. Le ripeterai ai tuoi figli e ne parlerai». In
questo caso non è un evento del passato a essere oggetto di memoria, ma il
principio stesso del monoteismo ebraico: l’unicità di Dio.
Due elementi in particolare mi sembrano degni di nota per il discorso che
voglio sviluppare. In primo luogo, il riferimento al cuore. Il ricordo, qui, non è
l’oggetto di uno sforzo puramente intellettivo. Non è il semplice richiamare alla
mente un principio teologico e quindi teorico. Al contrario, le parole devono
essere sentite, fatte proprie, interiorizzate a livello emozionale. Il secondo punto
riguarda invece la trasmissione della memoria alle generazioni a venire 1. Le
parole devono essere insegnate ai figli, in modo che il loro significato si possa
prolungare anche al futuro.
I due esempi – il primo dei dieci comandamenti e lo Shemà – pongono
l’accento su aspetti diversi, ma entrambi presuppongono la stessa concezione
della memoria, tipicamente ebraica. Nel primo esempio, la relazione originaria
tra Dio e il popolo ebraico si manifesta attraverso l’evento della liberazione dall’Egitto. L’evento può fondare l’identità, intesa come permanenza nel tempo,
perché esso stesso acquisisce tale permanenza, attraverso la continuità di una
memoria periodicamente riaffermata. Il secondo esempio, invece, mette in
risalto il particolare modo in cui la memoria viene riaffermata nel presente: non
semplice ripetizione, ma riproposizione emotivamente sentita (con il cuore),
poiché solo con un autentico coinvolgimento è possibile adempiere all’obbligo della prosecuzione, tramandare cioè il ricordo e prolungare la memoria nel
futuro.
Per riassumere, si possono identificare due punti cardine sui quali si fonda
la concezione ebraica della memoria, due parole d’ordine, per così dire:
sentimento e prosecuzione.
La prima parola – sentimento – concerne soprattutto la trasposizione del
passato nel presente. Una trasposizione che, per rendere nuovamente vivo il
passato, deve accompagnarsi a trasporto emotivo, a coinvolgimento ed
emozione. La memoria non può essere oggetto di un neutrale atteggiamento
storiografico. Yosef Hayim Yerushalmi, professore di storia dell’Ebraismo alla Columbia University di New York, nel suo libro Zakhor 2 , ad esempio,
1
Quest’aspetto, a dire il vero, è presente anche nel primo esempio, riguardante l’uscita dell’Egitto. Si consideri, infatti, che molti elementi della ritualità simbolica del seder di Pesach
sono finalizzati proprio a suscitare la curiosità dei bambini, facendo così delle generazioni future
i principali destinatari del ricordo.
2
Y. H. Yerushalmi, Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica, Giuntina, Firenze 2011.
2
Per un’estetica della memoria Beniamino Fortis
contrappone nettamente la memoria ebraicamente intesa alla storiografia, e
una delle differenze principali sta proprio nella presenza o meno del
sentimento: mentre la storiografia impone la neutralità di uno sguardo scientifico
e distaccato sul passato, la memoria nell’Ebraismo e sempre esperienza
vissuta e ri-vissuta.
La seconda parola d’ordine – prosecuzione – si riferisce al fatto che la
memoria non deve accontentarsi di una riproposizione nel presente, non deve
fermarsi. Il primo tratto, che dal passato conduce al presente, deve prolungarsi
poi in un secondo tratto, che dal presente si estende al futuro.
Sentimento e prosecuzione – la memoria nell’Ebraismo ha dunque queste
due caratteristiche portanti. La questione, a questo punto, è: quali modalità di
trasmissione della memoria sono in grado di svolgere la propria funzione,
preservando tali caratteristiche?
Questa domanda ci porta alla seconda parte della relazione, nella quale
prenderò in considerazione le due principali forme di comunicazione del ricordo:
l’immagine e la parola. Ognuna di esse presenta pregi e difetti. Quello che poi
vorrei suggerire è che un terzo mezzo di trasmissione, l’atmosfera, potrebbe
dimostrarsi in grado di coniugare i pregi di immagine e parola, evitandone al
contempo i difetti.
2. Trasmissione della memoria
Le varie forme di rappresentazione sono modi diversi di rapportarsi all’alterità
che si intende rappresentare. Occupandoci della memoria, l’alterità che nel
nostro caso specifico viene portata alla rappresentazione è ovviamente un
ricordo del passato. Si tratta quindi di verificare quanto il mezzo rappresentativo
incide su ciò che rappresenta; quanto riesce a renderlo fedelmente e quanto
invece lo modifica.
a. Immagine
Riguardo all’immagine, il punto di partenza obbligato nell’Ebraismo è il divieto
contenuto nel secondo comandamento: «Non ti farai alcun idolo né immagine
alcuna di tutto quanto è nel cielo al di sopra, né di quanto è quaggiù sulla terra,
né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti ad essi e non
li servirai».
Qui è subito necessaria una precisazione: bisogna distinguere cioè tra
raffigurazione e idolatria. Il vero oggetto del divieto è la seconda. Ma che cos’è
l’idolatria? Beh, l’idolatria è un’attitudine. Un atteggiamento reverenziale che si
può assumere nei confronti dell’immagine. Perché allora proibire tutte le
immagini, quando basterebbe mettere in guardia contro quel particolare
atteggiamento che nei loro confronti si può adottare? La risposta è nella natura
delle immagini.
In primo luogo, ogni immagine è potenzialmente un idolo: non tutte le
immagini sono idoli, ma tutte possono diventarlo. Inoltre, il potenziale idolatrico
3
Per un’estetica della memoria Beniamino Fortis
nelle immagini può essere attivato in virtù di qualcosa che è costitutivamente
presente in ognuna di esse, magari allo stato latente. E questo qualcosa è ciò
che Lévinas, in un saggio del 19483, chiama ombra.
Ogni immagine, rapportandosi a ciò che intende rappresentare, non
riesce, secondo Lévinas, a renderlo in modo neutrale e trasparente, ma
produce sempre una sorta di opacità – l’ombra, appunto – che ostacola il
pensiero nel suo rivolgersi all’oggetto rappresentato e lo blocca sull’immagine stessa. Questo arresto del pensiero descrive perfettamente l’atteggiamento idolatrico, cioè un atteggiamento di passiva accettazione nei confronti di ciò
che, in qualche modo, si impone come completo, concluso: un dato di cui si può
semplicemente prendere atto.
Applicato al caso specifico della memoria, un ricordo passato tramandato
attraverso immagini risulterà bloccato in un istante sottratto allo scorrere del
tempo. Quella che si può avere attraverso l’immagine è cioè un’esperienza non riproduttiva del passato, che viene riproposto, ma non integrato nel presente, e
che vi appare quindi come una sorta di “corpo estraneo”.
Le parole-chiave che potrebbero descrivere l’esperienza dell’immagine in relazione alla memoria sono quindi esteriorità e arresto.
Con esteriorità intendo il fatto che il ricordo espresso in immagine si pone
come qualcosa di estraneo nei confronti dell’osservatore, qualcosa che si presenta di fronte ad esso e gli si impone, appunto, dall’esterno.
Arresto, invece allude al fatto che l’immagine inibisce ogni possibile prosecuzione da parte del pensiero. Essa, in quanto conclusa, chiede tutt’al più
di essere accettata, passivamente accettata, non criticamente valutata,
interpretata e prolungata nel futuro.
Le due parole-chiave che definiscono l’immagine sono opposte a quelle che avevo utilizzato per determinare la concezione ebraica della memoria.
L’esteriorità è il contrario del sentimento, poiché implica sempre freddezza e
distacco. E ovviamente l’arresto è il contrario della prosecuzione. Si può quindi
concludere che l’immagine, come mezzo di trasmissione del ricordo, si rivela del tutto inadeguata a rendere la concezione ebraica della memoria.
b. Parola
Le cose sono molto diverse per quanto riguarda la parola. Quest’ultima, nell’Ebraismo, ha sempre una struttura dialogica che, in quanto tale, non corre il
rischio di cadere nell’esteriorità dell’immagine. La parola del dialogo è sempre
parola che interpella, che chiama in causa e che, nel farlo, non si accontenta di
una passiva accettazione, ma al contrario esige una risposta attiva – e questa
implica anche quel trasporto che avevo riconosciuto come essenziale per la
memoria ebraicamente intesa.
3
E. Lévinas, La realtà e la sua ombra, in Nomi propri, a cura di F. P. Ciglia, Marietti,
Casale Monferrato 1984.
4
Per un’estetica della memoria Beniamino Fortis
In questo, poi, emerge anche un secondo tratto caratteristico, che pone la
parola in sintonia con la concezione ebraica della memoria, e cioè il fatto che il
rispondere è già prosecuzione. La risposta è già un prolungamento oltre il primo
appello che ha dato il via al dialogo.
Torniamo per un attimo all’esempio dello Shemà Israel. Nel passo in cui si
dice: «E queste parole che Io ti comando oggi saranno nel tuo cuore. Le
ripeterai ai tuoi figli e ne parlerai», il testo si presenta costitutivamente aperto,
esorta alla propria prosecuzione. Per sua stessa natura aspira a prolungarsi
attraverso l’insegnamento alle generazioni future e attraverso il commento.
In questo senso, si può anche rispondere a una possibile obiezione,
secondo la quale la dinamica del dialogo non si applicherebbe alla parola in
generale, ma solo a quella orale, escludendo quindi quella scritta. In realtà,
nell’ottica ebraica, nemmeno la parola scritta può mai definirsi definitiva. La
prosecuzione, che nell’oralità avviene tramite la risposta in un dialogo, nella
scrittura assume la forma del commento, dell’esegesi e del dibattito sulle diverse possibili interpretazioni – Talmud e Mishnà ne sono la prova.
Riportando queste considerazioni nel contesto della memoria e della
temporalità, l’espressione attraverso immagini è schematizzabile attraverso un
movimento che porta dal passato al presente. Quella attraverso la parola,
invece, sollecita, in aggiunta, un secondo movimento che, dal presente, si
prolunga, poi, anche verso il futuro. La differenza tra i due modelli è da
ricercare nella dimensione del presente. A seconda di come il passato viene
accolto nel presente, si può determinare un arresto su di esso o una
prosecuzione verso il futuro. Più precisamente: nel caso dell’immagine, il passato viene accolto nel presente nel segno di un’essenziale esteriorità. Ed è
questa a implicare anche il secondo termine-chiave, cioè l’arresto. Se il passato
giunge al presente con esteriorità e distacco, verrà indotto un atteggiamento
fondamentalmente statico, incapace di prolungarsi nel futuro. Solo se il passato
viene riattualizzato nel presente, con trasporto e partecipazione, come avviene
nel caso della parola interpellante, esso potrà invece ricevere l’impulso necessario a proseguire nel futuro.
Nell’immagine l’esteriorità implica l’arresto – segnando così una radicale
incompatibilità con la memoria ebraicamente intesa.
La parola – scritta o orale – invece, presenta tutti i requisiti necessari per
farsi veicolo di trasmissione della memoria, così come questa viene concepita
nel mondo ebraico.
Gli schieramenti, quindi, sembrano ormai nettamente stabiliti: da un lato
l’immagine, classificata come incompatibile con la memoria ebraica;; dall’altro la parola, classificabile invece come perfettamente adeguata alla concezione
dell’Ebraismo.
Il pensiero ebraico, però, diffida delle classificazioni troppo nette. Vale
quindi la pena mettere ebraicamente in discussione quella a cui siamo appena
giunti.
5
Per un’estetica della memoria Beniamino Fortis
Il giudizio sull’immagine, allora, potrebbe non essere così negativo come
l’ho presentato finora. L’immagine, in fondo, ha dalla sua parte almeno un
pregio: l’immediatezza, l’accessibilità. Si pensi, solo a titolo di esempio, alla
biblia pauperum. Al contrario, alla parola si potrebbe rimproverare un certo
elitarismo intellettualistico. Il rapporto con la parola non è immediato come
quello con l’immagine, ma, al contrario, richiede una mediazione intellettuale che ne limita inevitabilmente la diffusione. Queste considerazioni fanno quindi
sorgere una domanda: È pensabile una terza forma di trasmissione della
memoria che assommi in sé i pregi dell’immagine – cioè soprattutto la sua
immediata comunicabilità – e quelli della parola – cioè quel coinvolgimento
partecipativo che è conditio sine qua non di un’eventuale prosecuzione?
Secondo me sì. E questa terza forma è l’atmosfera.
c. Atmosfera
Non esiste – e non può esistere – una definizione precisa di atmosfere, perché
è la precisione stessa, intesa in termini di chiarezza e distinzione cartesiane, a
mostrarsi in questo contesto inadeguata. In prima approssimazione si potrebbe
dire allora che un’atmosfera è una situazione caratterizzata in senso
emozionale.
Essendo legata a una situazione, l’atmosfera ha ovviamente a che fare
con gli oggetti che la situazione ricomprende, ma non è la proprietà di un
oggetto. Spesso si sviluppa a partire da un oggetto, che però è, per così dire,
solo uno spunto, un pretesto per lo sviluppo di un’atmosfera. Questa non sta all’oggetto, come, ad esempio, un attributo sta alla propria sostanza. Più che
altro, l’atmosfera si serve di un oggetto come di un punto d’appoggio per irradiarsi – e irradiare è proprio il verbo che ricorre più spesso negli studi sulle
atmosfere.
Questo, per quanto concerne il polo dell’oggetto. Sull’altro versante invece, quello soggettivo: l’atmosfera consiste in una connotazione emozionale, ma non per questo può definirsi il moto interiore di un soggetto. Non è un
sentimento che il soggetto possiede, ma semmai, un sentimento in cui il
soggetto entra, s’immerge.
Gernot Böhme4 – che ha riaperto il discorso sulle atmosfere nel dibattito
estetologico contemporaneo – dice che le atmosfere sono sentimenti
spazializzati, diffusi in una dimensione imprecisata e vincolati a una situazione.
Non sono né caratteristiche dell’oggetto, né moti interiori del soggetto,
nonostante vengano generate grazie a determinate proprietà di alcuni oggetti e
vengano percepite da un soggetto. Sono contesti emozionali nei quali soggetto
e oggetto entrano in relazione.
Le atmosfere non nascono solo e necessariamente in modo spontaneo,
come avviene, ad esempio, per situazioni naturali come un tramonto, una
4
G. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena. L'estetica come teoria generale della
percezione, a cura di T. Griffero, Marinotti, Milano 2010.
6
Per un’estetica della memoria Beniamino Fortis
tempesta o un paesaggio. Le atmosfere – e questo è il punto – possono anche
essere prodotte artificialmente, attraverso la creazione di determinate situazioni,
attraverso la disposizione mirata degli oggetti o la configurazione dello spazio,
in modo tale che poi, l’intervento di un soggetto nella situazione predisposta faccia sviluppare quella dimensione emotivamente intonata che è, per
l’appunto, l’atmosfera.
Nell’ambito della tematica della memoria, la nozione di atmosfera si presta a nuove modalità di trasmissione. Meglio: la creazione mirata di atmosfere, allo
scopo di trasmettere la memoria di determinati eventi del passato è il principio
base su cui si fondano vari progetti artistici e architettonici contemporanei.
Prima di passare a esempi concreti, però, vorrei dire due parole sulla
compatibilità tra la concezione ebraica della memoria e la sua trasmissione
mediante atmosfere.
Quella atmosferica è un’esperienza immersiva. Questo significa che, di
norma, si è immersi in un’atmosfera. E in tale immersione, il coinvolgimento emotivo non è solo inevitabile, ma è la condizione stessa del prodursi
dell’atmosfera, che – ricordo – necessita sempre del concorso di un soggetto.
A differenza dell’immagine, l’atmosfera non è di fronte, ma attorno a noi.
E, con il trasporto emotivo che questo avvolgimento comporta, risulta
soddisfatta quella che avevo identificato come prima condizione della memoria
ebraica. Questo, poi, conduce al soddisfacimento anche della seconda
condizione, cioè della prosecuzione di tale esperienza. Il coinvolgimento
emotivo in un’esperienza atmosferica richiede infatti di essere elaborato,
metabolizzato e assimilato, oltre la durata dell’esperienza stessa. Induce un
proseguimento attraverso la riflessione e, eventualmente, attraverso la
condivisione successiva con altri. Insomma: l’atmosfera dà da pensare. E con
essa, quindi, il rischio di indifferenza è molto meno presente di quanto non lo
sia invece dinanzi a un’immagine – con il distacco e l’esteriorità che questa
suggerisce.
Anche rispetto alla parola, però, l’atmosfera presenta dei vantaggi: principalmente l’immediatezza e l’accessibilità. Comunicando a livello percettivo
ed emotivo, l’atmosfera è immediata, accessibile a tutti. Non richiede, cioè,
quelle competenze intellettuali che, nel caso della parola, attuano
inevitabilmente una selezione tra i possibili fruitori.
Tirando le somme, si può concludere dicendo che l’atmosfera, come mezzo di trasmissione della memoria, sembra incontrare le esigenze della
concezione ebraica, meglio di quanto non sappia fare l’immagine e – almeno
per il particolare aspetto dell’accessibilità – anche meglio della parola. Forse
per questo la creazione di atmosfere viene scelta oggi sempre più spesso come
canale privilegiato di trasmissione della memoria ebraica – che in epoca
contemporanea è inevitabilmente legata anche alla Shoah.
A questo proposito vorrei concludere con alcuni esempi. Se ne potrebbero
fare molti, ma qualche parola sul museo ebraico mi sembra d’obbligo.
7
Per un’estetica della memoria Beniamino Fortis
3. Esempi
a. Il museo ebraico di Berlino
L’architetto è Daniel Libeskind, un ebreo americano di origine polacca che, con
il progetto di Berlino, stravolge l’idea stessa di museo: da semplice contenitore
di documenti, esso diventa fonte di esperienze estetiche ispiratrici ed evocative.
L’intera struttura, nella composizione architettonica esterna, nell’organizzazione interna dello spazio e in alcune delle installazioni che contiene, può essere
considerata un grande apparato per la produzione di atmosfere.
Tipicamente atmosferica, ad esempio, è un’indistinguibilità di fondo tra
forma e contenuto, cioè tra il modo di rappresentare e l’oggetto della
rappresentazione. Mi spiego meglio: la struttura del museo – cioè la sua forma
– rispecchia le caratteristiche dell’evento che intende commemorare – cioè il
suo contenuto. Entrambi, forma e contenuto, sono coinvolti in un’irrisolvibile
dialettica tra ordine e disordine o, detto altrimenti, tra razionalità e irrazionalità.
L’organizzazione dello spazio non si lascia cogliere in una visione d’insieme,
così come sfugge alla comprensione l’evento che il museo si propone di evocare. L’inafferrabilità della Shoah si riflette sull’inafferrabilità della logica
spaziale del museo: non vi sono, in esso, ambienti regolari fondati su una
ripartizione omogenea dei volumi, ma piuttosto spazi chiusi e aperti allo stesso
tempo, inutili dal punto di vista del vivere umano – come alcuni vani privi di
funzione specifica – inservibili e quasi grotteschi – come ad esempio una rampa
di scale che termina su una parete.
L’effetto atmosferico complessivo è di disorientamento, spaesamento e, al
limite, di inquietudine – che sono appunto le sensazioni che si vogliono
suscitare nel fruitore, nel tramandargli la memoria della Shoah.
Già dalla facciata esterna, le pareti di metallo lucido trasmettono un senso
di freddezza, accentuata poi dalle finestre a zig-zag che squarciano in modo
irregolare le superfici, alludendo a delle ferite ancora aperte.
Uno dei punti più alti nella produzione di atmosfere si ha poi, secondo me,
in uno stretto passaggio in cui il visitatore è costretto ad attraversare un
corridoio ricoperto da pezzi di metallo, calpestabili, modellati in modo da
ricordare dei volti. Posarvi sopra il piede ha un ovvio valore simbolico, oltre che
atmosferico, al quale si aggiunge anche il suono stridente del metallo che
sembra un pianto o un lamento.
Altro esempio: dietro a una porta spessa e pesante si trova una stanza
chiamata torre dell’olocausto. Vuota, buia, fredda d’inverno e calda d’estate. L’unica debole fonte di luce è una stretta feritoia posta troppo in alto perché sia
possibile guardare all’esterno. Tutti gli stimoli sensoriali risultano attutiti, in
quell’ambiente, difficili da decifrare, così che lo scopo dichiarato dell’intera esperienza è quello di creare disagio in chi la vive.
Il principio di fondo su cui si basa la concezione museale di Libeskind
consiste infine nel tramandare il ricordo della Shoah, non tanto attraverso
8
Per un’estetica della memoria Beniamino Fortis
l’esposizione di documenti – che pure non mancano –, quanto attraverso
l’evocazione / ri-evocazione, a livello sensoriale, esperienziale e quindi emotivo
di un’atmosfera. Poiché questa, meglio di un’asettica rassegna di dati, riesce a
rendere l’idea di ciò che è stato, trasmettendolo secondo modalità convergenti
con la concezione ebraica della memoria.
b. Stolpersteine
Un altro fenomeno inscrivibile nell’ambito di un’estetica atmosferica della
memoria è rappresentato dalle cosiddette Stolpersteine, che significa pietre
d’inciampo.
Si tratta di piccole targhette di metallo che vengono fissate al suolo in
prossimità delle abitazioni delle vittime della Shoah. Le targhette riportano varie
informazioni, come date di nascita e di morte, luogo di deportazione ecc…, ma
la più importante, ovviamente, è il nome proprio della vittima. A riguardo,
l’artista Günther Demnig cita il Talmud: «un uomo è dimenticato solo quando si
dimentica il suo nome». Anche in questo caso, quindi, la questione ruota
intorno alla memoria.
E anche in questo caso, il punto non è tanto ricordare, quanto il modo in
cui si ricorda. Con l’idea delle pietre d’inciampo, non si raggruppano i nomi delle
vittime in un’unica forma di commemorazione che, in fondo, le astrarrebbe dalla
dimensione del quotidiano e le ridurrebbe a un’impersonale lista di nominativi.
Le persone ricordate tramite le targhette di Demnig non rischiano di diventare
oggetto in un’ufficialità fredda, distaccata e distanziante, ma vengono al
contrario lasciate nella comune vita di tutti i giorni, nel quotidiano. E intendo,
qui, la quotidianità della persona ricordata, perché, leggendone il nome di fronte
a un’abitazione ordinaria, si ha la disturbante percezione di una normalità
bruscamente interrotta. Ma mi riferisco, allo stesso tempo, anche alla nostra
quotidianità che, come suggerisce il titolo dell’opera, si blocca, s’inceppa, per
l’appunto, inciampa su quelle pietre, come su qualcosa di inspiegabile, di
inassimilabile, una sorta di “nota stonata” che irrita, confonde, suscita disagio –
ma, proprio per questo, induce a pensare.
Beniamino Fortis
[email protected]
9