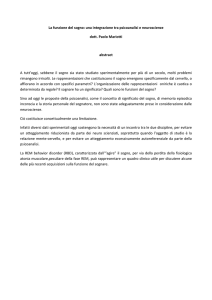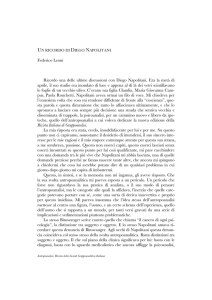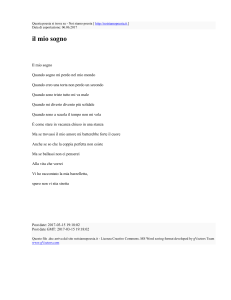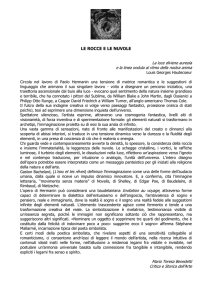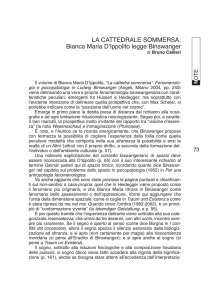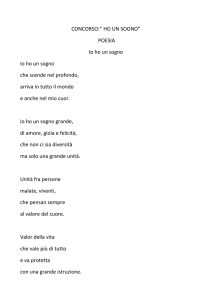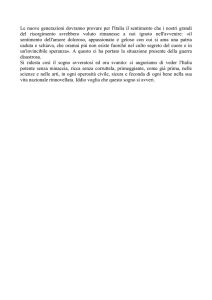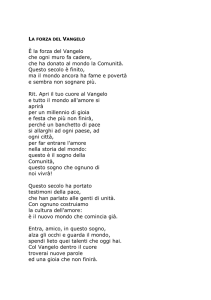INDICE
Editoriale
Diego Napolitani
Dalla psiche come mito all’antropos come esistenza
pag. 2
4
Federico Leoni
Là dove era la psiche, deve farsi spazio l’evento
29
Diego Napolitani
Un primo commento a “Là dov’era la psiche, deve farsi
spazio l’evento” di Federico Leoni
36
Federico Leoni
Risposta al commento di Diego Napolitani
38
Claudia Napolitani
La mia stanza d’analisi
39
Daniele Terranova
Narrazione di un incontro
47
Antropoanalisi. Rivista della Società Gruppoanalitica Italiana
EDITORIALE
Il presente numero zero di Antropoanalisi inaugura una profonda trasformazione della Rivista Italiana di Gruppoanalisi sia nella sua “architettura” molto più dialogica sia nella sua apertura, attraverso la sua edizione online, all’ampio dibattito in corso sull’impianto teorico, epistemologico e metodologico delle pratiche psicoterapeutiche.
Abbiamo scelto di essere presenti online in modo da permettere una comunicazione più immediata che, eliminando i tempi morti e le lungaggini dello
stampato, possa raggiungere un pubblico più vasto. L’edizione cartacea, anch’essa rinnovata nella grafica, avrà una diffusione più limitata e un uso prevalentemente interno, a disposizione di chi ne faccia espressa richiesta alla segreteria della SGAI. La direzione della rivista è affidata a Federico Leoni, Sergio
Perri e Paolo Tucci Sorrentino (Direttore responsabile). La redazione e il comitato di consulenza sono in via di definizione.
In questo numero “zero” sono proposti alcuni lavori teorici, clinici e filosofici che lo rendono come un manifesto programmatico dell’orientamento culturale cui la SGAI è ora approdata.
Nel primo contributo Dalla psiche come mito all’antropos come esistenza,
Diego Napolitani si sofferma sulla condizione neotenica dell’antropos, sulla scelta del campo di ricerca, la Daseinsanalyse, e sugli ancoraggi cui resta legata nell’orientamento fenomenologico dominante. Infine accenna alla profonda differenza del senso della “cura” nella prospettiva oggettivistica della tradizione psicoanalitica rispetto al suo senso in una prospettiva antropoanalitica.
Seguono due lavori a carattere essenzialmente clinico. Daniele Terranova in
Narrazione di un incontro, riporta il caso di una paziente in setting individuale
soffermandosi in particolare sui momenti di condivisione tra il “terapeuta” e il
“paziente”. Interessante è anche una sua riflessione su lo “spazio-tra” in cui è
possibile cogliere il “diaframma fra passato-noto e divenire-ignoto”.
Claudia Napolitani, in La mia stanza d’analisi, racconta il farsi di una storia
psicoterapeutica iniziata in un setting individuale e proseguita in un setting gruppale, in cui accadono momenti di pervasiva alienazione della coscienza (compresa quella dell’analista), da cui progressivamente emerge una capacità di riflessione dialogica e una conseguente trasformazione dei modi relazionali.
Il lavoro di Federico Leoni Là dove era la psiche, deve farsi spazio l’evento, ha un taglio filosofico. A partire dalla difficoltà di tradurre in italiano il termine tedesco Daseinsanalyse, abbozza la storia, e i problemi conseguenti, del
2
progetto binswangeriano di emanciparsi dall’idea di psiche come “cosa” per lasciar spazio all’evento. A questo lavoro segue uno scambio di commenti tra
l’autore e Napolitani.
Infine alcuni ringraziamenti. Ad Alberto Lampignano, che è stato direttore
della Rivista di Gruppoanalisi per un decennio; a Luciano Cofano, che ha sostenuto il lavoro redazionale in tutti i momenti critici; infine a tutti coloro il cui
impegno, anche in tempi passati, ha consentito questo nuovo sviluppo della nostra attività editoriale nel segno di una profonda apertura sociale e culturale.
Paolo Tucci Sorrentino
3
DALLA PSICHE COME MITO ALL’ANTROPOS COME ESISTENZA
Diego Napolitani
Introduzione
La mia ricerca, sul piano teorico come su quello della pratica clinica, si è
sviluppata negli ultimi trent’anni in una rete molto fitta di scambi non solo tra i
Soci della SGAI, ma anche con cultori di discipline umanistiche diverse. Potremmo dire, ricorrendo alla dicotomia cartesiana, che alle modeste dimensioni della
sua res extensa, la SGAI ha per lo più vissuto la sua res cogitans in un modo torrentizio, con momenti di grande “piena” e correlati smottamenti del terreno che
attraversava, alternati a momenti in cui si riduceva a poco più che a un rigagnolo: una cogitazione pressoché permanente. “Cogitare” deriva da un cum-agitare, l’agitarsi dentro di sé, nella propria mente, di tante sue componenti in relazione con quel mondo cui la mente si apre e da cui viene aperta. L’ultimo passo
di questa collettiva cogitazione è consistito nello sviluppo della nostra identità
culturale, dalla sua implicita continuità con la matrice psico- e poi gruppo-analitica a un indirizzo fenomenologico-ermeneutico-genealogico, in una parola,
antropo-analitico, che segna una radicale discontinuità col riduzionismo scientista del mito freudiano, e più generalmente con ogni psicologismo fondato su
una distinzione ontologica di soggetto e oggetto.
L’essere-uomo si muove in un oceano d’incertezze o meglio di certezze
parziali e transitorie, e la sua coscienza non può non essere che goccia di quello
stesso oceano in cui è immersa. Ma la coscienza specificamente umana produce
anche un sapere di essere goccia di questo oceano, un sapere che, se gli consente appena di nominarsi “Io”, lo mette a confronto con la propria insaturabile
mancanza: ogni accertamento della consistenza di tale Io e dell’oceano di cui è
parte è appena una porta che dischiude il proprio sapere su nuovi imprevedibili
orizzonti e quindi, fondamentalmente, sulla cognizione che l’unica certezza che
il sapere dischiude è il proprio inesauribile non-sapere. Se l’uomo non sviluppasse “particolari competenze” (termine molto spesso usato da Luciano Cofano1
nelle sue ricerche in campo neuro-fenomenologico) non potrebbe mai emergere
dalle onde in cui è immerso, non potrebbe neanche credere ai piedi che comunque gli sono spuntati e alla zolla di terra ferma che sembra proprio essere lì da1
L. Cofano (2010), “Neurobiologia della mente relazionale”, Rivista Italiana di Gruppoanalisi, XXIV, 1.
4
vanti a lui per ricevere l’orma del suo passo: non potrebbe cioè neanche credere
alla possibilità di procedere, al suo stesso divenire.
Il termine “competenza” acquista in embriologia un significato apparentemente del tutto dissonante con altri significati, più usuali, del medesimo termine
(il competere in senso agonistico, o la competenza come abilità acquisita in specifiche pratiche): esso indica la capacità genetica di un’area o territorio embrionale di svilupparsi come un organo o un tessuto in un determinato momento
dello sviluppo. Louis Bolk2 ha proposto che l’intera organizzazione biologica
dell’uomo è permanentemente caratterizzata da una competenza embrionica, affermando:
Ciò che nei nostri progenitori era uno stadio di passaggio nel corso della loro formazione, nell’uomo odierno è lo stadio finale. Nel corso dello sviluppo storico la forma adulta acquistò
un’impronta fetale sempre più marcata, essa fu – vorrei definirla – fetalizzata. L’ominizzazione della forma che si realizzava storicamente era essenzialmente una fetalizzazione.
Questo è il principio di ciò che vorrei chiamare ipotesi della fetalizzazione (pag. 53).
La fetalizzazione si manifesta in prima istanza con i caratteri anatomo-fisiologici del neonato umano che conserva per lungo tempo la condizione di assoluta dipendenza dall’ambiente materno, molto prossima a quella sperimentata nel
lungo periodo di gestazione, cosa che Bolk richiama così:
Ma sapete indicarmi una seconda forma di vita in cui la coscienza si desta solo dopo così
tanto tempo dalla nascita, una seconda forma di vita che ha bisogno delle cure e dell’assistenza dei genitori per un periodo di tempo così lungo dopo la nascita e che è capace di rendersi autonoma in un’età così avanzata? (pag. 65, op. cit.).
Ma è proprio questa fetalizzazione che induce l’uomo a stabilizzare questa
necessaria e prolungata convivenza multigenerazionale in quella istituzione squisitamente culturale che è la famiglia, cosa che Bolk riassume in questi termini:
Infatti non dobbiamo intravedere nella lunghissima durata del periodo in cui un bambino
deve essere nutrito dai suoi genitori e ha bisogno della protezione dei genitori, la causa naturale dell’origine della famiglia umana, dunque il fondamento dell’intera società umana? Il
ritardo dello sviluppo ha come conse-guenza necessaria un prolungato rimanere insieme di
due generazioni consecutive. In ciò è data all’uomo la base biologica della sua vita sociale
(pag. 66, op. cit).
Trascorsero alcuni decenni di aspri dibattiti intorno a questi temi, prima che
essi fossero affrontati da Arnold Gehlen il quale sviluppa in modo organico, sia
2
L. Bolk (1926), Il problema dell’ominazione, Deriva Approdi, Roma 2006.
5
dal punto di vista biologico sia da quello filosofico, il tema della condizione embrionica dell’uomo, quell’animale unico che si è trovato ad avere come permanenti alcune caratteristiche che nelle altre specie risultano transitorie. Ciò costituisce il fondamento dei concetti di mancanza e di apertura al mondo a cui non è
vincolato in forza di determinate e specifiche pulsioni (“L’animale ha un “ambiente”, non un mondo” (pag. 210)3 ma in funzione delle particolari rappresentazioni che se ne fa: la propria coscienza è costituita da una continua ri-ad-presentazione (vedi nota 4 sulla polisemia di rappresentazione)sia di quanto è stato presente nelle sue esperienze passate (come memoria esplicita e implicita), sia di
quanto è presente nell’azione, cioè nella fabbricazione del suo futuro, il tutto intimamente intrecciato con quanto è presente nella realtà sensibile contingente.
Vedremo come il pensiero fenomenologico, in particolare nei suoi sviluppi
antropoanalitici, si riferisca fondamentalmente a questi dati antropologici riferiti
alla coscienza (l’essere in quanto essere-nel-mondo, l’intenzionalità, la trascendentalità, ecc.) per cui viene nettamente distinto il mondo genericamente vivente
dal mondo specificamente umano. Si potrebbe dire che mentre il motore della
vita è a tergo di ogni evento biologico, il motore dell’esistenza è davanti al proprio sguardo, è nel proprio divenire, nel proprio processo di ominazione, che nel
linguaggio attuale è detto “antropo-poiesi”.
Vita ed esistenza non sono fenomeni cartesianamente contrapposti, ma contrapposte possono divenire le rappresentazioni del Reale in cui questi fenomeni
sono inseriti: in una rappresentazione scientista ogni fenomeno può essere spiegato risalendo alla sua genesi, alle cause che lo hanno prodotto, mentre in una rappresentazione propriamente fenomenologica il fenomeno tende a essere compreso nel complesso intreccio tra cause sperimentalmente accertabili e finalità variamente congetturabili. Il prendere-insieme, il com-prendere, questi due momenti
nei loro reciproci rimandi, sembra oggi essere la conditio sine qua non si rende
possibile l’incontro tra uomini nelle loro diversità e il lavoro di composizione in
ogni singola coscienza tra vincoli genetici (o genealogici) e la libertà di concepimenti auto-poietici.
Scienza e coscienza
3
4
A. Gehlen (1978), L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano
1983.
Rappresentazione: sinonimo di spettacolo teatrale; immagine pittorica o scultorea; è un'immagine mentale, comunque distinta dall'immagine mnestica, da un'idea, da un pensiero che
compaia nella mente di un soggetto. Essa è il modo attivo della messa in scena della coscienza nei vari modi della sua evoluzione, dal primitivo modo alienato, al modo conforme,
al modo della sua alterità singolare.
6
La umana competenza embriologica implica dunque un “farsi dell’uomo”
che, se esonerato da un’immediata e quasi automatica traduzione nei suoi comportamenti delle sue pulsioni geneticamente definite, è strettamente vincolato
alla necessità di stabilire con i suoi simili relazioni convenienti: il modello originario della famiglia è il prototipo di una relazione sufficientemente stabile e
istituzionalmente organizzata a cui convengono più individui, ciascuno con le
proprie singolari risorse, con le proprie motivazioni diversamente modulate dalla coscienza (anche in relazione al livello di sviluppo delle strutture neuronali),
e quindi con le proprie rappresentazioni del mondo di cui fanno esperienza.
Tutte le successive forme di aggregazioni, anche quelle non costituite da individui di diversa generazione, conservano tracce più o meno rilevanti della cultura
famigliare di ciascun partecipante, tracce della natura embrionica di quell’essere necessariamente insieme (l’ontologico Mit-da-Sein heideggeriano) in cui variamente confluiscono personali rappresentazioni di bisogni biologici ed economici, con rappresentazioni di un comune divenire progettuale. Ognuna di queste
aggregazioni prenderà nomi diversi a seconda del contesto culturale in cui vengono promosse o secondo cui vengono categorizzate: gruppi di lavoro o ludici o
sportivi, gruppi etnici o religiosi o politici, associazioni economicamente produttive o associazioni culturali, e così via indefinitamente in rapporto ai paradigmi categoriali con cui queste insiemità vengono osservate.
La gruppoanalisi è stata per tanti anni, sin dalla sua fondazione, il referente
teorico della SGAI sia per la sua netta contrapposizione alla visione oggettivistica
della cosa-psiche, sia per la rilevanza che essa conferisce al carattere strutturalmente relazionale dei processi mentali. Non mi dilungo in un’esposizione dei
cardini teorico-metodologici della gruppoanalisi, ma è suggestivo ricordare qui
una frase di Trigant Burrow, il suo fondatore, che afferma5:
Nel suo attuale coinvolgimento sociale inconscio, la psicoanalisi non è lo studio di una nevrosi; è una nevrosi. Non è una scienza oggettiva applicata a una malattia soggettiva; è un
riflesso soggettivo proprio della stessa malattia che essa presume di sottoporre a uno studio
scientifico oggettivo.
Ritengo che la SGAI abbia dato importanti contributi allo sviluppo teoricometodologico della gruppoanalisi fino ad affrontare il fondamentale snodo della
coscienza nella sua formazione storica e nei suoi sviluppi: la coscienza è una
parola composta dal prefisso cum e dalla voce scire, la quale sembra derivare
dal sanscrito chid col significato di scindere, tagliuzzare, separare le cose, per
5
T. Burrow (scritti 1913-1929), in Dalla psicoanalisi alla fondazione della gruppoanalisi,
IPOC, Milano 2009.
7
cui il sapere (scire, scienza) è quanto un soggetto apprende di un oggetto fattualmente analizzato. La preposizione cum può essere letta come un rafforzativo di questo scire, ma a me sembra più convincente l’ipotesi che il cum rimandi
a un “con”, come insieme, per cui il cum-scire, la coscienza in termini cognitivi, è il prodotto di una composizione rappresentazionale, come già accennato,
del passato e del divenire confluenti nei segmenti della realtà da cui si è toccati
nel presente per un proprio inter-esse, per un proprio ritrovarcisi dentro. Nella
dimensione etica la coscienza si riferisce a un sapere condiviso dei valori e correlati vincoli comportamentali del proprio gruppo di appartenenza, a cominciare
ovviamente dal gruppo famigliare con il suo specifico costume (ethos, costume,
dimora) e il complesso di norme esplicite e implicite (la normalità del gruppo)
secondo le categorie del bene/male e del giusto/ingiusto.
Ma la gruppoanalisi, nonostante le sue serrate critiche alla metafisica freudiana, non fa che sostituire all’ente “inconscio individuale” l’ente “inconscio
sociale”, trattando quindi il gruppo come l’oggetto di osservazione, di ricerca e
di cura con i medesimi paradigmi epistemologici su cui Sigmund Freud ha contraddittoriamente (v. in seguito) fondato la sua metapsicologia e sinteticamente
riproposti a conclusione della sua vita6:
Mentre nella psicologia della coscienza non si è mai andati oltre a quelle serie lacunose di
fenomeni, che palesemente dipendono da qualcos’altro, l’altra concezione, quella secondo
cui lo psichico è di per sé in-conscio, ha permesso di sviluppare la psicologia fino a farne
una scienza naturale come tutte le altre.
Ma proprio a partire dalle scienze fisiche si è prodotta nel secolo scorso una
rivoluzione radicale nei fondamenti espistemologici della ricerca di una verità
sperimentale e quindi universale dei fenomeni naturali: basti pensare al “principio di indeterminatezza” di Heisemberg, o alla “sfida della complessità” come
enunciata da Morin7, o al “principio di casualità” che sostituisce quello di causalità lineare nei processi di trasformazione o di mutazione autopoietica in biologia (Pievani8), o alle recenti scoperte neuroscientifiche sulla strutturale intersoggettività dei processi mentali. Di pari passo le cosiddette scienze umane
sono state investite dal pensiero fenomenologico che, come un ciclone, ne ha
messo in crisi i loro fondamentali metafisici.
Riporto qui, esemplificativamente, le citazioni di due eminenti scienziati:
6
7
8
S. Freud (1938), Compendio di psicoanalisi, in Opere, vol XI, Bollati Boringhieri, Torino
1981.
E. Morin (1982), Scienza con coscienza, FrancoAngeli, Milano 1984.
T. Pievani, Introduzione alla filosofia della biologia, Laterza, Bari 2005.
8
Francisco Varela che si è occupato della natura della materia cerebrale, e Ludwig Binswanger che si è occupato della esperienza vissuta attraverso cui quella
medesima materia consente di rendere specificamente umana l’esistenza di questo “animale embrionico”.
Afferma Varela9:
Invece di cercare di trovare un “ingrediente in più” per spiegare come la coscienza emerga
dalla materia e dal cervello, la mia proposta riformula il problema nei termini di un tentativo di trovare delle connessioni significative tra due irriducibili domini fenomenici.
La riduzione fenomenologica non “scopre” qualche territorio oggettivo, ma produce piuttosto nuovi fenomeni all’interno del dominio esperienziale, con uno schiudersi di molteplici
possibilità. La seconda sfida lanciata dalla mia proposta (la neuro-fenomenologia) è quella
dell’esigenza di trasformazione dello stile e dei valori della stessa comunità dei ricercatori.
Se non accettiamo il fatto che, a questo stadio della nostra storia intellettuale e scientifica, è
necessaria una sorta di ri-apprendimento radicale, non possiamo sperare di fare un passo
avanti e spezzare la ciclicità storica di fascinazione-rifiuto della coscienza nella filosofia
della mente e nella scienza cognitiva.
E, dal suo luogo di osservazione, scrive Binswanger10:
Con la dottrina heideggeriana dell’essere-nel-mondo (In-der-Welt-Sein) come trascendenza
è stato eliminato il cancro che minava alla base tutte le precedenti psicologie e si è finalmente aperta la strada all’antropologia. Il cancro è rappresentato dalla dottrina della scissione del “mondo” in soggetto e oggetto. In forza di questa dottrina l’esistenza umana è stata
ridotta a mero soggetto privo del suo mondo. È un “soggetto” nel quale hanno luogo tutti i
possibili processi, eventi, funzioni, che ha tutte le possibili caratteristiche e compie tutti i
possibili atti, senza che nessuno sia in grado di dire, salvo supporlo attraverso mere “costruzioni” teoriche, come possa incontrarsi con un “oggetto” e cominciare a intendersi con altri
soggetti. Essere-nel-mondo significa sempre, per dirla in breve, essere nel mondo con i
miei simili, essere con le altre esistenze (Mitdaseiende). Heidegger, postulando l’esserenel-mondo come trascendenza, non soltanto ha superato la scissione tra soggetto e oggetto
della conoscenza, non soltanto ha colmato lo hiatus tra Io e mondo, ma ha anche illuminato
la struttura del soggetto come trascendenza, ha aperto un nuovo orizzonte di comprensione
e ha dato impulso nuovo all’indagine scientifica sull’essere dell’uomo in genere e sui particolari suoi modi di essere. È dunque chiaro – e ciò mi preme particolarmente sottolineare –
che in luogo della scissione dell’essere in soggetto (uomo, persona) e oggetto (cosa, ambiente) subentra qui, garantita dalla trascendenza, l’unità tra persona e mondo.
In entrambe queste citazioni viene posto in massimo rilievo la crisi del concetto di scienza come di un sapere che sogna (come in un mito) di raggiungere
la padronanza assoluta del mondo attraverso le sue procedure di analisi, di frantumazione dell’unità del Reale, a partire dalla scissione di soggetto e di oggetto.
9
10
F. Varela (1997), Neurofenomenologia. Una soluzione metodologica al “problema difficile”, in Pluriverso n. 3, anno II, 1997.
L. Binswanger (1946), L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria, in Il caso Ellen West e
altri saggi, Bompiani, Milano 1973.
9
La comunità scientifica nel suo insieme è oggi esposta alla necessità di un “riapprendimento radicale” (Varela), che consenta di sviluppare le sue ricerche in
una incessante coniugazione con l’esperienza della coscienza, sottraendosi alla
fascinazione che la scoperta delle “leggi di natura” assuma il carattere di verità
solo a condizione della neutralità dell’osservatore, del suo sospendere la propria
coscienza nelle sue radici storiche e nelle sue rappresentazioni del divenire. È
quanto Binswanger precisa nei termini di trascendenza intesa nell’orizzonte fenomenologico come qualità costitutiva dell’esistenza umana, che può essere
studiata solo abbandonando il mito delle oggettivazioni psicologistiche per
comprenderla nella sua interezza propriamente antropologica.
Questo discorso non riguarda soltanto quel vertice delle procedure di conoscenza che definiamo scienza, in rapporto oppositivo o integrativo con la coscienza nella sua intenzionalità, ma può essere esteso a ogni atto di conoscenza
nel quale ci troviamo automaticamente nella posizione di osservatori. Osservare
un evento significa coglierne alcune “distinzioni” (è il termine adottato da Wilfred Bion11 per sottolineare il carattere del Reale che resta misterioso per quante
costruzioni possano essere compiute a partire dalle “distinzioni” di cui ciascuno, soggettivamente, può fare esperienza), connetterle tra loro con un legame
cognitivo razionale, infinite volte sperimentato nella sua pratica utilità, e connotato per lo più non come la ratio, la ragione dell’osservatore ma come la “ragione d’essere” di quell’evento, come la sua qualità oggettiva indipendente dalle
logiche, dalle tecniche adottate dall’osservatore, e dalla sua coscienza. Oggetto
e soggetto, nella loro contro-apposizione, appaiono quindi come enti distinti e
separati dei quali il primo, l’ob-jectum, è ciò che è gettato contro l’altro ente, il
sub-jectus, che non può non subirlo, obbedire percettivamente agli stimoli che
dall’oggetto provengono. Ma l’osservare ha una doppia declinazione semantica: rimanda a una condizione di servizio come quello del servo osservante la
legge del padrone, o quella del libero osservatore che conserva l’esperienza dell’incontro con un oggetto in una sua inventiva rappresentazione, per cui quell’esperienza viene serbata come un momento trasformativo della propria stessa coscienza. È solo in questa seconda eventualità che il servo può diventare il padrone della propria esperienza, farne cioè l’uso che conviene alla sua protensione progettuale.
L’essere al mondo dell’uomo come di ogni altra sostanza vivente, è detto
vita nella sua esatta misurabilità temporale – dalla nascita alla morte –, nella precisa descrivibilità delle sue concrete contingenze, nel giudizio di senso comune,
specifico della comunità di appartenenza, sul perché delle sue scelte in base a
11
W. Bion (1965), Trasformazioni, Armando, Roma 1973.
1
precise gerarchie di convenienze. Freud riduce a questi caratteri vitalistici genericamente “animali” l’essere al mondo dell’uomo, cosa che esplicitamente riassume così:12
Mi pare che l’evoluzione del genere umano fino a questo momento non abbia affatto bisogno di una spiegazione diversa da quella che vale per gli animali; quell’infaticabile impulso
verso un ulteriore perfezionamento che si può osservare in una minoranza di individui umani può essere facilmente spiegato come conseguenza della rimozione pulsionale su cui è
fondata la civiltà umana in tutto ciò che ha di più valido e prezioso.
Ridotto alla sua deriva animalista, tutto dell’uomo è spiegabile come effetto
di cause endogene, in sé perfette, perché esattamente corrispondenti al suo adattamento al proprio ambiente. Per qualsiasi specie animale abbiamo la possibilità
di individuare le porzioni di mondo che corrispondono alle sue convenienze nel
senso di soddisfarle o in quello di comprometterle, e di generazione in generazione si ripetono comportamenti pressoché identici in tutti gli individui di quella specie, con piccole variazioni corrispondenti a modeste variazioni dell’ambiente: variazioni incompatibili sono catastrofiche, e portano all’estinzione dell’intera specie.
Ma qual è il “proprio ambiente” per l’uomo? Nulla di simile a quel che accade per ogni altra specie vivente secondo una congruenza perfetta tra dispositivi organici con le loro convenienze biologiche e il mondo che abita e da cui viene immediatamente abitato. Tra uomo e mondo si frappone una naturale sostanza opaca, vischiosa, a volte tanto compatta e unica per ciascun individuo da
consentirgli di distinguersi nella sua singolarità da qualsiasi cosa che del mondo
colpisce i suoi sensi, a volte invece tanto fluida, aeriforme come un alito, che
penetra nella più intima struttura delle cose – altri uomini o il mondo intero –
non potendosene distinguere come se fosse immerso in una continuità senza
nome. Questa sostanza (sub-stantia, ciò che sta al di sotto di ogni cosa o fatto
concreto) è la coscienza, sia nei suoi sviluppi nel segno della discontinuità tra
soggetto e oggetti sia, al contrario, nel segno della continuità nella reciproca
compenetrazione tra i due termini che essa stessa ha con “certezza” separato.
Ed è proprio la coscienza che fa emergere l’esserci da quei limiti biologici che
chiamiamo vita, al di là della quale si apre quell’esperienza vissuta che chiamiamo esistenza.
Quindi, confermando l’enunciato di Gehlen per cui solo l’animale ha un
proprio ambiente mentre l’uomo è esposto al “mondo” nella sua infinita inde12
S. Freud (1920), Al di là del principio di piacere, in Opere, vol. IX, Bollati Boringhieri,
Torino 1981.
1
terminatezza, sostengo che “mondo” non va inteso nella sua immediata cosalità,
ma nell’infinita variabilità delle sue “rappresentazioni” che la coscienza costruisce costruendosi. Tra l’oggetto e il soggetto c’è di mezzo il dispositivo evocativo, emotivo, prospettico, auto- etero-poietico che è la coscienza nel suo duplice
passo, dove quello razionale, geometrico, causale si alterna con quello intuitivo,
paesaggistico, imprevedibilmente casuale. Questi due “passi” convengono in
quel fenomeno in cui consiste l’esperienza del procedere tra il già noto e l’imprevedibile, tanto da poterci rappresentare l’esistenza come il convegno incessantemente convocato tra le convenienze razionali e quelle intuitive.
La “fenomenologia pura” di marca husserliana, per dirla molto in breve,
cerca la risposta all’interrogativo “qual è l’essenza di ogni fenomeno?” presumendo di poter mettere tra parentesi (sospendere in una epoché) ogni riferimento teorico: l’essenza si può solo intuire ma non pensare, con il medesimo criterio scissionistico dello scienziato della natura che sostiene la necessità che il ricercatore sia “oggettivo”, “neutrale”, non influenzato da affetti o emozioni.
L’ontologia heideggeriana sviluppa per buona parte l’assunto husserliano per
cui il fenomeno è puro “evento che si sottrae” a ogni legittima spiegazione, essendo proprio questo il fondamento di un’ontologia dell’esserci. Io sono tra
quelli che pensano di assolvere il loro compito di osservatori cercando una via
di negoziazione tra due modi di apparizione della coscienza apparentemente incompatibili. In una mia relazione13 avevo esordito dicendo:
L’uomo cammina a partire dal suo essere fermo in un equilibrio relativamente stabile
all’interno del suo perimetro di base. Poi qualcosa lo spinge, da fuori o da dentro, e se
egli non vi oppone adeguata resistenza, se cede alla spinta, pro-cede. Nel momento iniziale di questo pro-cesso egli si trova su un piede solo, in un equilibrio instabile cui può
porre rimedio solo appoggiando nuovamente il piede già sollevato sulla terra. Se la
spinta iniziale insiste, egli poggerà il piede davanti a lui (pro-) che è la condizione che
prefigura un nuovo passo. E così via. Possiamo utilizzare questa metafora corporea (di
cui Varela, forse, direbbe che è “qualcosa più di una metafora”) per illustrare il concetto di integrazione tra i due modi della cogni-zione umana, quello razionale, percettivo,
categoriale, e quello non-razionale, intuitivo, olistico […]. Nella dimensione razionale
il mondo è noto, notificabile e infinitamente conoscibile, e se appartiene a questa dimensione la “spinta da dentro” a cui la mente cede ne può nascere quella pratica che
chiamiamo scienza. Se al contrario è in una dimensione non-razionale che nasce la
spinta ciò che ne può nascere è quell’azione che chiamiamo artistica se concretamente
compiuta nel suo darsi all’osservazione del mondo, o che chiamiamo sogno se compiuta solo nell’intimità della propria coscienza.
13
D. Napolitani, Le due gambe del procedere cognitivo, relazione al 2° Congresso Sepi, Firenze, 24-26 marzo 2006, in Che cosa unisce gli psicoterapeuti (a cura di T. CarereComes), Vertici, Firenze 2007.
1
Riprendendo qui la domanda più su formulata: “Ma qual è l’ambiente dell’uomo?”, potremmo ora rispondere che esso è costituito dalla sua coscienza,
che, procedendo sui suoi due piedi, si apre uno spazio specificamente umano, il
suo proprio Mit-da-sein che diventa concreta presenza nei suoi eventuali convegni (d’amore, di lavoro, di cura). Ma a me pare di poter sapere che questo aprirsi un proprio spazio comporta un lavoro equivalente al travaglio della nascita
(vedi in seguito), e come questa esso è esposto a rappresentazioni totalmente
contrastanti della coscienza, come se un passo si movesse in un senso, in una
direzione, contrastante con quella assunta dal passo precedente. Un genitore
aspetta di vedere, dopo tanta attesa, il “suo” bambino e quando questi, apertosi
il suo spazio, si trova “gettato”14 nel mondo, è festa grande: quanto è stato intenzionalmente concepito in un convegno d’amore è ora lì nella sua, pur sempre
relativa, autonomia, a dar corpo a quell’evento per cui una donna o un uomo diventano genitori, sperimentano la loro esistenza come trascendenza.
Ma da dove viene fuori questo e-ventus? Sappiamo tutto, o quasi, sulla fisicità biologica, della fecondazione, della gestazione, del parto, e quindi sulla naturalità della nascita, eppure, molto diffusamente, il figlio è connotato dal passo onirico, pre-razionale della coscienza come un dono, pur restandone del tutto ignoto il
munifico autore, o identificandolo in una coscienza religiosa con il Creatore, unico e assoluto. Ma perché emerge in modo anche se non esplicito questo sentimento di essere destinatario di un dono con la nascita di un figlio? Franco Di Maria e Calogero Lo Piccolo15 riflettendo sui termini “comune”, “comunità”, indagano il significato di munus che ne è la radice etimologica: il costituirsi di un
bene comune o di una comunità, evento propriamente antropologico, può essere
considerato come un munus, ma nel senso di un dono non gratuito, non svincolato da particolari obblighi di cui il beneficiario viene in-caricato. Soltanto la condizione di immunità, che i “potenti” in genere si autoconferiscono, esonera il beneficiario del comune bene dai vincoli obbligazionari che ne conseguono.
Con la nascita di un figlio accade, come un munus, la formazione della prima comunità umana, che la coscienza sognante sperimenta come del godimento
di una trascendenza, ma che la coscienza razionale misura col metro degli obblighi, e delle relative rinunce, che ne derivano. Le cose vanno così, nell’alternanza dei due passi coscienziali, finché resta viva l’esperienza della trascendentalità dell’evento. Ma quando questa viene corrosa dalla quotidianità degli atti,
14
15
La gettatezza nel gergo fenomenologico è la condizione permanente dell’esserci nella sua
attitudine ad aprirsi sempre nuovi spazi singolari nel mondo (nda).
F. Di Maria F., C. Lo Piccolo, Psicologia clinica per la strada: una strada per la psicologia clinica, in Psicologia al plurale (a cura di G. Ruvolo), Ed. Offset Studio, Palermo 2007.
1
o dagli oneri eccessivi a cui il munus sottomette, o da nuove passioni che portano lontano dalla comunità per quanto, fin lì, autenticamente amata e servita, e
se non ne consegue una scelta pienamente coscienziale, si apre la possibilità di
un contro-evento, di una contro-esistenzialità che per lo più consiste in una dissoluzione della “memoria del futuro”, di quel “divenire O” con cui Bion nomina i caratteri essenziali dell’ex-sistentia. Può succedere che nell’eclissarsi della
polarità diveniente del tempo vissuto16 si verifichi una specie di dissolvimento,
di lisi dell’antropos, di colui che vede oltre la finitudine della propria arcaica
identità, per ripiombare nei modi storicamente vissuti nel proprio ambiente coscienziale dei primi tempi della sua vita. Nei tempi cioè in cui egli non poteva
vivere al di fuori dell’arbitrio dell’altro, incarnando in sé l’insieme delle norme,
esplicite o implicite, che regolamentavano le convenienze diverse e per lo più
contraddittorie dei “padroni di casa”.
Ma questo intimo convegno coscienziale tra razionalità e intuizione17 non è
un fenomeno solipsistico, è inestricabilmente connesso con l’incontro di due o
più persone motivate da una comune convenienza, cioè da medesime prospettive di trarre un vantaggio da quel particolare incontro con quell’Altro/Altri le
cui “ragioni” sembrano corrispondere alle “ragioni” personali di ciascun convenuto. Tutti noi passiamo da convegno in convegno (quelli di lavoro, quelli ludici, quelli d’amore, e così via), e questo ondulante, e incerto nei suoi esiti, Mitda-Sein è sia l’esito dell’intimo convegno coscienziale di ciascuno, sia l’occasione o la causa che lo produce. Ogni convegno è dunque un mistero perché nasce dall’intreccio di complessità, esterne/interne, di cui afferriamo solo alcune
distinzioni, perché resta imprevedibile nei suoi sviluppi, e perché, infine, il farne piena esperienza, quale che sia il suo ambito, modifica per parti più o meno
estese o riconoscibili la nostra stessa fin lì consolidata identità. Farne “piena
esperienza” significa parteciparvi non per saturare bisogni vitali (economici, di
potere, di soddisfazione sessuale o agonistica, e simili) ma per affrontare il proprio “sapere di non sapere” trasformandolo da limite ontologico, a cui arrendersi, in apertura al proprio poter sapere qualcosa in più. Ma questo “in più” anziché ridurre aumenta il proprio “sapere di non sapere” perché estende i confini
con il non ancora noto, aumentando così potenzialmente sia lo spirito di avventura verso ulteriori conoscenze, sia il sentimento di precarietà e di incertezza di
fronte ai propri acquisiti domini cognitivi.
È qui che nascono i miti come grandiosi paesaggi che, pur desunti dalle no16
17
E. Minkowski (1969), Il tempo vissuto, (a cura di F. Leoni), Einaudi, Torino 2004.
H. Bergson (1909), La filosofia dell’intuizione, Carabba, Lanciano, 2008.
“
(1919), Il cervello e il pensiero, Editori Riuniti, Roma, 1990.
1
stre esperienze sensoriali, vanno oltre la loro fisicità e temporalità per diventare
la componente meta-fisica del nostro sapere, un ancoraggio sicuro a una “verità” oggettivata che esonera l’uomo dalle incertezze sui limiti del proprio sapere.
Ogni mitologia induce quel medesimo stato di certezza che si vive nel sogno in
cui si è totalmente immersi, le cui immagini e trame, impensabili nella condizione di veglia, sono vissute come verità assolute, non corrose da quel dubbio
che così facilmente si insinua in ogni esperienza di “verità” vissuta a occhi
aperti. Di questa imprevedibile verità onirica l’uomo si è fatto da sempre attento
osservatore, l’ob-servus, per cui da sempre egli ha attribuito a un ente estraneo
al proprio ragionevole Io la proprietà di esserne l’autore, tanto certo quanto certa è stata l’esperienza del sogno: la ratio variamente modulata ha riconosciuto
nel sogno il munus (il dono vincolante) dei propri antenati defunti, o di potenze
cosmiche benevole o malevole, o di qualche divinità, o di quell’autorità tanto
intima quanto estranea, tanto certa quanto indefinitamente inconoscibile, quella
stessa che Freud ha nominato “inconscio”.
La certezza nell’esistenza di un Autore variamente personificato (o cosificato come “principio di realtà” o come “legge di natura”), diventa certezza del
proprio sapere perché anche le sue evidenti lacune sono espressione della volontà di un dominus, di cui possiamo in qualche modo condividere il potere solo
dalla posizione di osservatori-osservanti. Ed è qui che si dischiude l’ulteriore e
radicale rimedio alla disperante incertezza ontologica dell’uomo: la coscienza
pervasa da una verità mitica può continuare a sapere di non sapere, per legge di
natura o per volontà di Dio, ma si libera dal più enigmatico e insolubile buco
nero della sua esistenza: il non sapere di non poter sapere in modo esaustivo e
conclusivo. Fatto “scomparire” questo buco nero, aggrappato all’imperscrutabile verità del mito, l’uomo “addomestica” la sua ontologica apertura nel modo illuministico, laico o religioso, scientifico o teologale, del “sole dell’avvenire” e
può “tranquillamente” chiudere gli occhi sul buio da cui viene e verso cui embrionalmente va, e continuare a… sognare.
Se il sogno è rappresentabile come un abbozzo mitico individuale, così il
mito è un sogno collettivo, inizialmente formalizzato da personalità dotate di
grande potere carismatico, a cui convengono moltitudini la cui ampiezza è di
per sé conferma della veridicità “oggettiva” del mito. Gli “osservanti” alimentano la loro fede convenendo in convegni, variamente regolati nei più svariati
modi e tempi, che oltre a una funzione celebrativa svolgono quella di controllo
ed eventuali aggiornamenti delle pratiche adottate. I miti che si riferiscono a
una legge divina, come congettura razionale che crea esatte sintassi dell’inesauribile sogno umano di sapere dei fondamentali del mondo, producono una mol1
teplicità di codici tanto diversi e per lo più reciprocamente contraddittori da far
entrare in gioco, nel reciproco confronto, categorie altrettanto universali e inverificabili quali quelle del vero e del falso, o del bene e del male assoluti, con la
conseguenza di “guerre di religione” che fino a oggi insanguinano il mondo. La
mitologia scientista che fa riferimento a “leggi di natura” origina dal medesimo
sogno di giungere a una verità senza residui, e pur sapendo del carattere relativo
di ogni suo enunciato (per cui tende a concepire convegni dei propri osservanti
non a excludendum, ma, al contrario, confrontandosi con gli apporti sperimentali di ogni altra disciplina scientifica) lo tratta come un momento veritativo in
fieri, come atto che consolida come pietra miliare il percorso del proprio specifico percorso paradigmatico. Ma che anche la scienza sia pervasa da una componente mitologica, di cui l’uomo è simultaneamente artefice e prigioniero, viene icasticamente riassunto dalle parole con le quali Umberto Galimberti chiude
la sua Introduzione a un libro di Binswanger18:
Se alienazione significa allontanamento (Ent-fremdung) dell’uomo da sé, per Binswanger
non c’è alienazione più grande di quella che oggi l’uomo patisce sotto il potere incontrastato della scienza. Forse la crisi del nostro tempo, a cui anche la fenomenologia binswangeriana tenta di reagire, è proprio nel pericolo che l’uomo appartenga alla scienza più di quanto la scienza non appartenga all’uomo; che, da metodo escogitato dall’uomo per l’interpretazione della natura, la scienza assurga al livello di indiscusso a priori esistenziale in grado
di decidere il modo umano di vivere e di pensare, e quindi, in un senso profondo e crudamente letterale, che l’uomo perda la sua mente.
Le componenti mitiche della “scienza psicologica”.
Per tornare ora alla nostra “scienza psicologica”, essa è stata inaugurata dal
Convegno psicoanalitico proposto da Sigmund Freud nel 1904 con l’intento di
sottrarre la res cogitans dal mito religioso per concepirla come l’Inconscio della
biologia umana. Il termine inconscio perde il suo valore attributivo per acquistare quello sostantivo: esso indica cioè la sostanza del secreto di un organo
(come la bile lo è del fegato) che, ignoto – inconscio – al suo portatore è pressoché totalmente conoscibile da chi lo indaga, dal suo analista. Ho usato prima la
parola convenienza per intendere la prospettiva di trarre un vantaggio dall’incontro col mondo in specifiche contingenze: il convegno inaugurato da Freud
esprime un insieme di sue convenienze personali in cui le congetture scaturite
dalle sue convenienze culturali e professionali sono intimamente intrecciate con
18
U. Galimberti, in L. Binswanger (1955), Per un’antropologia fenomenologica, Milano,
Feltrinelli 2007.
1
dati della sua storia e della sua tradizione, a cui egli stesso ha più volte fatto allusione ma di cui è stato per lo più “inconscio” portatore: rimando al secondo
capitolo del mio Individualità e gruppalità19 per più precisi e diffusi dettagli.
Quel che voglio qui sottolineare è che, nel suo intento di demolire la natura metafisica, religiosa dell’anima, e per ricondurre questa sotto il dominio delle leggi
naturali, Freud l’ha concepita al di fuori e contro la coscienza (fenomeno in
quanto esperienza vissuta, Erlebnis), che è invece squisitamente relazionale nella sua struttura, nella sua storia, nella sua espressività e fondamentalmente connesso alle passioni del sapere e della libertà, riducendola a un serbatoio di energie indipendenti da qualsiasi finalità specificamente antropologica e quindi culturale, e da qualsiasi forma di convenienza nel senso di apertura al mondo in un
processo di reciproche trasformazioni. La psiche diventa così un ente che caratterizza il genere umano, con le medesime caratteristiche metastoriche e quindi
metafisiche dell’anima, tale da diventare il fondamento di un mito biologistico
che si serve di tutti gli strumenti logici, ritualistici e pragmatici di quella “scienza naturale” che è la medicina. Ma che essa sia diventata una religione laica lo
mostra con massima evidenza il fatto che il Convegno freudiano si è caratterizzato sin dalle sue origini per una rigida intolleranza, o un’arrogante ignoranza,
per qualsiasi congettura che mettesse in questione la centralità mitica dell’inconscio: la verità rivelata non ammette relativizzazioni di sorta, e ciò ha prodotto, e continua a produrre, una quantità enorme di giudizi di eresia e il costituirsi
di un’altrettanta quantità di “chiese protestanti”.
Ma lo stesso Freud, a differenza della maggior parte dei suoi epigoni, ha mostrato più volte nel corso della sua opera di “sapere” del carattere mitografico della sua metapsicologia, e del suo riaffermarla con tanta più determinazione quanto
più covasse evidentemente nel suo animo il dubbio che la “pura razionalità” delle
cosiddette scienze della natura fosse in fondo affine a quella razionalità su cui si
sostengono i miti, primi fra tutti quelli religiosi. Nel 1927 egli scrive L’avvenire
di un’illusione20 in cui sostiene che la religione finirà col soccombere sotto i colpi
delle verità scientifiche, come le “metanoie” psicopatologiche sono destinate a
dissolversi nell’impatto con le verità che la scienza psicoanalitica oppone loro.
Ma in questa stessa opera egli afferma:
Una ricerca che proceda indisturbata come un monologo non è del tutto esente da pericoli.
Si cede troppo facilmente alla tentazione di scartare, accantonandoli, pensieri che intendono
interromperla e si genera in cambio un senso di insicurezza che alla fine si vuole superare
19
20
D. Napolitani (1987), Individualità e gruppalità, II ed, IPOC, Milano 2006.
S. Freud (1927), L’avvenire di un’illusione, in Opere, vol. X, Bollati Boringhieri, Torino
1981.
1
con una risolutezza eccessiva (pag. 451).
Mi chiedo: ma non avrà forse lui stesso colto il carattere monologante delle
sue costruzioni in un tempo in cui si proponeva già con forza, sia in campo filosofico sia in quello scientifico, il carattere illusorio di ogni asserzione presuntivamente universale, atemporale nei modi di un’inconfutabile “verità ultima”?
La cosa viene ulteriormente confermata in una sua frase21 tanto breve quanto
possibile espressione di “pensieri che intendono interromperla”, quella sua ricerca monologante:
La dottrina delle pulsioni è, per così dire, la nostra mitologia. Le pulsioni sono entità mitiche, grandiose nella loro indeterminatezza. Non possiamo prescinderne, nel nostro lavoro,
un solo istante, e nel contempo non siamo mai sicuri di coglierle chiaramente (p. 204).
Un nuovo confronto con “il sapere di non sapere”
Nella prospettiva (neuro)fenomenologica, oggi sperimentalmente sostenuta
dalle neuroscienze, possiamo dire che la psicologia è sempre più pervasa dal
tormentoso interrogativo sull’origine delle sue “rappresentazioni” che, quanto
più codificate mitograficamente, tanto più producono una crescente moltiplicazione delle aggregazioni di psicologi, una contro l’altra armata, ciascuna con la
pretesa di essere l’unica portatrice di “verità”. Più che per ogni altra disciplina,
per la psicologia “è necessaria una sorta di ri-apprendimento radicale”, secondo
il monito di Varela: i nostri Convegni devono sempre più imperativamente aiutarci a uscire da una condizione statica della nostra identità professionale ancorata a un mito naturalistico, per azzardare un incontro con quel mondo che noi
stessi contribuiamo a creare. Ciò che deve caratterizzare il nostro incontro con
il paziente (la nostra pratica psicoterapeutica) è una nuova, radicale, rappresentazione di questo incontro, nella consapevolezza che in esso confluiscono, oltre
agli inevitabili canoni teoretici razionalmente codificati, anche la nostra memoria, prossima e remota, unitamente a una necessità propriamente antropologica
di “con-sistere” nel e col mondo nel suo possibile e imprevedibile divenire, di
“de-sistere” dalla quasi automatica “in-sistenza” nel nostro ordine genealogico e
mitologico (la tradizione), di protenderci oltre questo “naturale” stare, e quindi
letteralmente di ex-sistere.
Binswanger, nel brano su citato, sostiene che “eliminato il cancro della
21
S. Freud (1932), Introduzione alla psicoanalisi, in Opere, vol. XI, Bollati Boringhieri, Torino 1981.
1
scissione tra soggetto e oggetto (…) si apre la strada all’antropologia”. Ma perché egli ricorre qui all’uso di un termine disciplinare pressoché totalmente ignorato nel linguaggio delle psicologie? Come se alludesse al fatto che per affrontare il tema dell’esistenza specificamente umana distinguendola dalla vita come
fenomeno pertinente al genericamente biologico, egli dovesse servirsi di una
parola metaforica, di un tropo allusivo di un fenomeno privo di un nomen o un
nomos autonomi. La stessa parola “uomo” è una voltura metaforica che fa implicito riferimento alla sua origine terrestre (homo da humus) e indica la sua
specie, definita, dopo molti passaggi paleontologici, come homo sapiens sapiens. Ma l’attributo sapiens sembra rompere la continuità filogenetica che unisce le più diverse organizzazioni viventi, dall’ameba ai primati, dove l’ultimo di
questi non è caratterizzato dal suo essere animale terrestre, per quanto il più
evoluto, ma dal suo introdurre nel mondo quella catastrofe22 che è il sapere, la
sapienza, la sua coscienza trascendentale.
È qui che io ritengo che ci viene incontro una voce antica che indica metaforicamente l’uomo come il generatore di metafore. La parola antropos viene
letta etimologicamente dal Tommaseo come la combinazione di tre elementi: =
sopra, oltre – tropo (da τρέπω) = volgere – oy = occhio, sguardo, quindi “colui
che volge lo sguardo in alto, sopra le cose” , dove questo “volgere lo sguardo in
alto, oltre” costituisce esattamente il tropo, la metafora in cui si incarna linguisticamente il sapere. E per dare un particolare valore suggestivo a questa sua
costruzione etimologica Tommaseo cita anche Ovidio (Metamorfosi, Libro I,
favola 1), laddove dice:
Os homini sublime dedit, coelumque tueri iussit” (“Diè [Iddio] all’uomo altera la fronte, e
comandò di fissare il cielo.
L’essere presi dal fenomeno nella sua immediatezza percettiva finisce col
distogliere lo sguardo da ciò che “un Dio comandò di fissare”, da quel “cielo”
che è simultaneamente immagine di infinitudine ed esperienza prima del tempo.
È al cielo che si riferisce Heidegger quando scrive:
…noi affermiamo quindi che il tempo è reperito con uguale immediatezza in ciò che è fisico e in ciò che è psichico, e non in quello tramite questo. Il “tempo” si rivela innanzitutto
proprio nel cielo, cioè là dove esso è esperito quando ci si regola naturalmente in base a
esso; ed è a causa di ciò che il “tempo” è senz’altro identificato col cielo. 23
22
23
T. Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi, Meltemi, Roma 2002.
M. Heidegger (1927), Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976.
1
Umberto Galimberti24 scrive:
Col termine mondo si deve intendere ciò per cui all’uomo si dà un mondo di cose (UmWelt) e di altri uomini (Mit-Welt). Questo “ciò per cui”, questo fondamento ontologico che
distingue l’uomo dalla totalità degli enti è da ricercarsi nel suo essere che, in quanto e-sistenza, non è in sé come tutte le cose, ma sempre fuori di sé, presso (bei) le cose (…). Ma
intanto l’uomo può pro-gettare (Ent-werfen) un mondo e in questo progetto trovare la sua
identità (Selbstheit) in quanto nel mondo è gettato (Geworfen). La situazione in cui si trova
gettato condiziona il suo progetto del mondo, così come questo pro-getto trascende la sua
originaria situazione. In quanto gettato, l’uomo non sceglie di occuparsi del mondo, ma
consiste in questa occupazione. Il mondo, cioè, non è ciò di cui l’uomo si occupa, ma è ciò
che lo pre-occupa, nel senso che lo occupa prima che l’uomo possa scegliere se occuparsene o meno.
Questo essere occupati dal mondo prima di poter scegliere se e come occuparsene, consiste in un’esperienza concretamente vissuta e sperimentalmente
verificata dai recentissimi sviluppi delle neuroscienze fenomenologicamente
orientate, esperienza che nella prolungata neonatalità del figlio dell’uomo ne
costituisce il fondamento esistenziale trascendentalmente inteso. L’insieme delle intenzionalità, delle aspettative (per lo più contraddittorie se non incompatibili tra loro), del rifiuto nei confronti del neonato (componente universale dell’esperienza umana al suo esordio, come icasticamente presentificato nel mito
biblico con la cacciata che un Dio-padre opera nei confronti dei suoi primi figli
dal proprio mondo), insomma tutto ciò che anima la disposizione dell’ambiente
viene, nel tempo immemore delle origini, letteralmente “incarnato” 25 nel bambino nella sua identità ancora totalmente alienata. 26 Questa condizione di alienazione originaria non può non essere vissuta che come la normalità del mondo di
cui il bambino è parte centralmente costitutiva, normalità che sarà progressivamente sottoposta al vaglio critico di una coscienza dotata di quei dispositivi intuitivi e razionali che lo sviluppo e le imprevedibili trasformazioni dell’architettura neuronale porranno in essere. Se il “con” di co-scienza in età neonatale indica il processo di pressoché assoluta assimilazione da parte del bambino dei dispositivi cognitivi e affettivi dell’ambiente (per lo più personificato dal mondo
materno), producendosi in lui così un’identità normalmente identificatoria, cioè
“alienata”, nello sviluppo successivo dell’auto-etero-poiesi il “con” indica una
mutazione della qualità strutturalmente relazionale della coscienza: non più
“materia” pressoché totalmente “occupata” da un Altro non ancora distinto nel24
25
26
U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, Feltrinelli, Milano 1991.
V. Gallese, La molteplicità condivisa. Dai neuroni specchio alle relazioni interpersonali, in
S. Mistura, Autismo. L’umanità nascosta, Einaudi, Torino 2006.
A. Gaston, Genealogia dell’alienazione, Feltrinelli, Milano 1998.
2
la sua singolarità esistenziale, quindi propriamente un alieno, bensì “materia”
che si va costruendo nel riconoscimento della diversità dell’Altro. Questo processo non è soltanto un’acquisizione conoscitiva dell’Altro in quanto soggetto
diverso da Sé, ma rende Altro lo stesso Sé nella sua identità fin lì consolidata.
In questa inesauribile alterificazione (e quindi disidentificazione) consiste il fenomeno della crescita della coscienza, dalla sua originaria conformità alle norme genetiche e ambientali (la sua primitiva “normalità”) al suo tendenziale
aperturismo concepitivo del binomio Sé/mondo.
Ogni momento rilevante nel processo di crescita della coscienza individuale
è esperienza di separazione dalla “casa madre”, dalla “base sicura”, per usare la
felice espressione di John Bowlby, 27 con quella trepidazione che tipicamente accompagna l’atto di varcare un confine tra un passato, che comunque ha garantito
la sopravvivenza, e un futuro che seduttivamente invita a nuovi convegni, intuitivamente còlti come occasioni di apertura di nuove strade, nuovi incontri col diverso, nuove possibilità di accoppiamenti d’amore, nuove possibilità concepitive.
È la trepidazione di questo possibile varco del confine ciò in cui consiste il pathos dell’esistenza umana: non la patologia che la riduzione biologistica diagnostica come borderline, ma il pathos propriamente antropologico dell’esperienza
di ambiguità tra apertura a un nuovo grado di libertà e chiusura nel recinto definito del già noto.
Dichiarava Immanuel Kant 28 in un’opera per lo più ritenuta minore rispetto
alle sue “Critiche”, nel capitolo intitolato “Dell’inclinazione alla libertà come
passione”:
Essa è la più violenta fra le passioni dell’uomo di natura, in uno stato in cui egli non può
evitare di trovarsi con gli altri in un rapporto di reciproche pretese. (…) Chi può essere felice soltanto in base all’arbitrio di un altro (sia poi questo tanto benevolo quanto si vuole), si
sente a ragione infelice (p. 159).
La felicità in base all’arbitrio di un altro è quanto rimanda alla normale
condizione neonatale, a quello stato di coscienza che io ho nominato alienato,
ma il persistere in questa condizione “felice” anche quando si è raggiunto uno
sviluppo neurologico adeguato per una sufficiente autonomia, non può che rendere infelici, ed è questo bisticcio che io riassumo nel termine “normo-patia”:
non si tratta qui del pathos che accompagna il varco del confine, ma del pathos
27
28
J. Bowlby (1988), Una base sicura, Cortina, Milano 1989.
I. Kant (1798), Antropologia pragmatica, Laterza, Bari 1969.
2
che qualifica l’esperienza di rinuncia al proprio divenire nel senso della propria
libertà di pensiero e di scelte, di coartazione della “più violenta fra le passioni
dell’uomo di natura”, che anziché venire es-pressa, rimane mortificatamente depressa. L’esperienza di uni-dualità madre/bambino, per quanto totalmente immemore, resterà per sempre il terreno in cui sono impiantate tutte le radici di
ogni esperienza successiva, tanto da poter forse dire che non c’è idea, sogno,
passione che emerga nella coscienza come “fatto nuovo” e potenzialmente trasformativo, che non riproduca metaforicamente il travaglio della nascita. È profondamente suggestivo che si usi il termine “travaglio” (etimologicamente tormento, arcaicamente connesso a una tortura) per indicare il faticoso processo di
separazione di un neonato dal corpo materno, come se ciascuno dei due enti
fosse “naturalmente” il carnefice dell’altro nel processo di reciproca separazione.
È nell’ombra lunga di questa stravolgente esperienza che lo status quo ante,
il persistere nel grembo culturale nel quale siamo stati allevati, e quindi condivisibile con comunità più o meno ampie nella forma del mito, diventa, forse il
più delle volte in ogni esistenza individuale, l’attrattore prevalente nella condizione ambigua di confine. Per evitare la tragedia di una separazione, ciascuno
può sentirsi costretto a refluire in sue private normopatie per tratti temporali più
o meno estesi, o per particolari zone esperienziali di contatto col mondo, o per
credenze tiranniche che costringono i comportamenti in costumi severi e rituali,
dove l’aggettivo privato indica una condizione opposta a quella di pubblico o
comune. Se all’interno delle mie mura domestiche ho comportamenti che riproducono normopaticamente tratti delle normali relazioni tra le quali sono nato e
allevato, ciò non comporta necessariamente un contrasto con le convenienze
pubbliche o comuni. Non solo, ma è proprio l’affinità tra normopatie private
generate da un’etica comune della comunità etnica di appartenenza, che consente il formarsi e lo stabilizzarsi di un senso comune mitograficamente codificato,
che garantisce diritto di cittadinanza e garanzia di appartenenza a chiunque vi
aderisce passivamente, o meglio, “autorevolmente”. Il senso comune, la κοινῆ
αἴσθησις, come accomunamento di sensi privati genealogicamente condivisi, diventa allora il potente produttore di giudizi sul bene e sul male, sul giusto e il
non giusto, sul vero e il non vero del comportamento di ciascuno col metro della conformità a esso.
È così che il senso comune produce discipline e tecniche atte a distinguere
normopatie comuni o pubbliche come espressione di valori, e normopatie private non condivisibili dal senso comune come espressione di devianze da correggere, isolare, fino alla eliminazione fisica dei devianti. Se comportamenti auto2
lesivi fino al suicidio, o rigidamente ossessivi, o visionari fino alle forme del
delirio o delle allucinazioni sono inscrivibili nell’insieme delle norme (la normalità) tradizionalmente, miticamente, stabilizzate, essi possono essere celebrati come espressione di una legge assoluta o laicamente della “natura” o ideologicamente della cultura o religiosamente della “volontà divina”. Ma se gli stessi
comportamenti conservano delle caratteristiche totalmente private, cioè non
comprese dal senso comune, essi sono connotati come pazzia o come delinquenza.
Conclusioni
La voce Antropoanalisi, coniata dallo psichiatra svizzero Binswanger, con
il suo sinonimo di “Analisi esistenziale”, e che fa da titolo a questa nuova Rivista della SGAI, esprime un orientamento filosofico per il quale l’uomo viene
compreso nel suo modo affatto singolare di disporsi all’incontro-con, o alla
fuga-da, il mondo (i suoi simili, gli oggetti, il se stesso) e non spiegato secondo
criteri naturalistici o religiosi che ne definiscono comunque una identità definita
una volta per tutte.
Quanto ho fin qui succintamente raccontato è appena una premessa del racconto del mio faticoso passaggio attraverso le psicologie (le psichiatrie, le psicoanalisi, la gruppoanalisi), fino alla costruzione dei fondamenti di una congettura ermeneutico-fenomenologica strutturalmente storicistica. Ho abbandonato
la visione terapeutica come comunemente intesa, con tutto il suo corteo di pratiche medicalistiche (la sintomatologia, la diagnosi, la prevedibilità statistiche dei
guasti-malattie), perché ho adottato il criterio etno-antropologico che non distingue le organizzazioni sociali secondo parametri di normalità e di patologia,
ma secondo parametri squisitamente culturali: come ogni comunità umana si
qualifica per la sua specifica organizzazione che dal nostro vertice occidentale
di osservazione possiamo distinguere come diverse (come più primitive o come
più evolute e non come “malate o sane”), così in un’antropologia individuale o
di piccole comunità mi pare di poter distinguere tutti i soggetti umani come
esposti alla tirannia di un loro “senso privato”, che per parti più o meno estese,
e con un grado variabile di consapevolezza critica, li induce a ripetere coattivamente tratti affettivi, ideativi, comportamentali di quel mondo che li ha originariamente generati e allevati, e, per dirla con Galimberti, letteralmente pre-occupati per un lungo tratto della loro neonatalità. In questa prospettiva storicisticoculturale del fondamento dell’identità individuale, tutto ciò che appare come
2
una devianza da quel “senso comune” sul quale ogni comunità definisce il grado di convenienza dei comportamenti individuali, relegando quelli non convenienti nei confini delle istituzioni giudiziarie o psichiatriche, non può più essere
visto come il prodotto di un guasto autoctono delle dinamiche psichiche personali, ma come la testimonianza di una realtà trans-personale, trans-generazionale, essenzialmente trascendentale.
Voglio qui raccontare una recente esperienza in cui sono stato personalmente protagonista di due sviluppi di un unico evento, totalmente contrastanti:
quello concretamente vissuto e quello vissuto in una sua rappresentazione onirica. Si è trattato di un invito da parte di un cattedratico di Psicologia di presentare nella sua sede universitaria una relazione sul medesimo argomento che sto
trattando qui, e che avevo cripticamente titolato “Psicologie/Antropologia”. Il
presentare a un pubblico di psicologi una proposta critica nei confronti dell’oggettivazione naturalistica della psiche creava in me una specie di trepidazione
che ho affrontato con un’attenta organizzazione di questo mio intervento, animata dal medesimo senso di sfida che accompagna oggi l’apparizione di questa
nuova rivista della SGAI. Il convegno è stato molto partecipato e ha avuto un
buon successo.
All’impegno della mia coscienza vigile, razionale, in questa mia convenienza resa pubblica ha fatto da contrappunto il manifestarsi di una mia coscienza
onirica, pre-razionale, assolutamente contraddittoria rispetto ai miei atti di coscienza razionali e programmati. Pochi giorni prima dell’appuntamento palermitano, mi sono svegliato da un sogno tanto turbolento da crearmi un’inquietudine ai limiti di uno stato angoscioso che è durato un certo tempo dopo il risveglio. Ero in una grande casa, simultaneamente a me famigliare eppure del tutto
estranea. Doveva essere una festa con tante persone, alcune delle quali mi sembrava di riconoscere confusamente, e tutte le altre assolutamente ignote. Ma la
cosa che anticipava una mia crescente inquietudine consisteva nel non sapere se
fossi io un ospite fra tanti di uno sconosciuto padrone di casa, o se fossi io stesso il padrone di casa ma totalmente immemore della ragione della festa e dei
miei inviti. A un certo punto uno dei partecipanti, con una divisa militare da generale o giù di lì, sfodera… il suo pene, e maneggiandolo come una spada si avvicina minaccioso, senza profferir parola, ora all’uno ora all’altro degli ospiti,
sia maschi sia femmine. Nulla di erotico, ma soltanto un muto, perentorio comando che tutti si conformassero (con chiara allusione all’uniforme) all’abito
(l’ethos) del “Generale”. Ciò induce, prima uno e poi altri, a correre verso una
finestra spalancata e a lanciarsi nel vuoto. Nel sogno mi sembra di “sapere”, per
quel tanto di “famigliare” con cui sentivo quella casa, che forse non si trattava
2
di un suicidio collettivo, perché molto fugacemente “vedevo” oltre la finestra,
giù in basso, una grande vasca piena di escrementi, un letamaio nel quale si sarebbero tuffati i presunti suicidi: una possibilità di salvezza! Non so quale posizione io avessi assunto nel sogno, ma quale che fosse sapevo di avere “la testa
vuota”, nessun pensiero, nessun affetto, se non la certezza di essere ormai travolto da una catastrofe per la quale non potevo immaginare alcun rimedio.
Ogni psicoanalista potrebbe formulare interpretazioni di questa rappresentazione scenica secondo i propri canoni di scuola, sostenendola come testimonianza di una verità capace di smentire le pretese di verità di altre interpretazioni. Voglio qui dire soltanto che il sogno è un evento tanto reale quanto lo può
essere in questo momento il mio essere seduto davanti al computer, e che il suo
autore è tanto misterioso nel suo enigmatico racconto, quanto certo – certificato
– è l’autore di queste righe.
Che in entrambi i casi io, Diego Napolitani, sono l’osservatore di questi
eventi, l’ob-servus, e che tocca a me, in questa posizione, svolgere il lavoro per
il mio Autore che a momenti si chiama “Io” (quando servo e Autore sembrano
coincidere) e a momenti, come nel sogno, l’Autore (il padrone di casa) si rende
irriconoscibile lasciando l’ob-servus in uno stato demenziale, come decerebrato.
Se analizzo il mio sogno secondo parametri scientisti, se Io ob-servus mi facessi psico-analista, avrei a disposizione una gamma pressoché infinita di interpretazioni possibili: ogni immagine, ogni segno, ogni emozione percepiti nel sogno sono traducibili nei termini di cui si compone il mio mito psicologistico, e io
disciplinariamente (disciplinatamente) osserverei il materiale perseguendo la migliore interpretazione-traduzione possibile. Ma se mi dispongo a comprendere
l’esistenza di questo mio “paziente”, guardo al sogno non più come un fatto oggettivo da decifrare, ma come un atto della sua coscienza che si trascende intenzionalmente nella mia: il mio più proprio ambiente (la mia coscienza storica) ne
viene toccato al punto da esserne coinvolto, al punto da sentire quell’evento come
evocatore di eventi simili da me storicamente sperimentati. Poiché il “paziente”
di cui sto parlando sono io stesso, per rendere più agevole la mia riflessione, fingo che il sogno mi venga proposto da un Altro a me estraneo, come del resto io
risulto estraneo a me stesso nel contesto del sogno. L’estraneo mi comunica:
• di trovarsi in una casa a lui sconosciuta per quanto famigliare
• il convegno che si svolge in quella casa (molto prossimo al Convegni
che l’estraneo si approssima e realizzare nell’Università di Palermo) si annuncia
come una festa
• egli non sa chi sia il “padrone di casa”, sentendosi quindi ospite tra tanti,
2
in una sorta di spaesante anonimato
• la scena viene quindi egemonizzata dal “Generale” che, servendosi del
suo pene come di una spada, sembra volere imporre un proprio Ordine, presumibilmente conforme alla propria uniforme
• lui la fa da “padrone” pur persistendo l’incertezza su chi possa essere il
“vero” padrone di casa
• gli ospiti, terrorizzati, si gettano dalla finestra, al di sotto della quale
“l’estraneo sa” esserci un letamaio che potrebbe salvare le loro vite
• l’estraneo resta ai margini della scena, privo di movimenti, vuoto di pensieri, pervaso soltanto da un presagio di fine, la catastrofe.
Se mi soffermo ad ascoltare quel “paziente” che io sono a me stesso, nella
duplice rappresentazione del mio Convegno, sono portato a com-prenderli, ad
assumerli inscindibilmente insieme come si fa con una moneta con due facce da
prendersi come un tutt’uno per poterla spendere in qualsiasi bottega. Ma la moneta che sto ora trattando presenta su una faccia il momento costruttivo di un
mio atto auto-poietico, la preparazione appassionata di un mio Convegno, e sull’altra faccia chiari segni negativi rispetto alla prima, come se ne dichiarassero
la proibizione, per cui l’intera moneta sembra diventare “fuori corso”, inspendibile. La lisi della mia esistenza, come drammatizzata dalla mia coscienza onirica nei modi del totale smarrimento di me stesso, potrebbe essere liquidata in quanto espressione della “irrealtà” di un sogno essendo contemporaneamente rassicurato dal soddisfacente procedere dei miei impegni concreti. Ma
quel paziente che è venuto alla mia bottega, rigirandosi tra le mani quella moneta, insiste: “Ho certamente fatto esperienza di una dissoluzione di me e continuo
a tormentarmi nel chiedermi da dove sia nata questa “fantasia” e che incidenza
potrà mai avere sul mio futuro”. “Tu porti alla mia bottega – gli rispondo – un
inquietante enigma, ma io non sono attrezzato per risolverlo attraverso uno sminuzzamento delle sue parti, per dare a ciascuna un suo nome sottraendolo così
al groviglio di pieghe tra le quali si ritrova affondato, cioè di s-piegartelo. Posso
solo provare a narrarti una storia che, a partire da questa inquietante contingenza, e grazie ai tanti racconti che tu mi hai fatto, possa mostrarti come nella mia
coscienza si sia andata figurando la formazione della tua coscienza nella sua duplicità”.
Non si dà una coscienza uguale a se stessa dai suoi primordi alla sua presuntivamente compiuta attualità, ma essa non solo cambia in un suo naturale
processo di formazione, ma in ogni momento essa può rituffarsi nel proprio “letamaio”, in quella raccolta di deiezioni “giù, sotto la finestra” da cui è costituito
2
il nostro oblio, il nostro privato Lete. Quando la coscienza assolve il suo compito di ob-servus che gli consente di dare una ragione sua propria a ciò che osserva ne trae un inconfutabile convincimento di essere egli stesso dotato di una ragione a cui conferisce il crisma di verità. È lui stesso allora il “padrone” di sé e
del mondo e gode della felicità della propria autonomia, della propria libertà.
Dal groviglio di pieghe che compone il suo essere quell’ente nominabile solo
con la metafora di antropos non si distingue più una figura che lo padroneggia e
di cui lui sia solo l’osservante esecutore di compiti. E della ragione che lui ha
attribuito all’intero cosmo che osserva, egli ha costruito miti nei quali depone,
come in una cassaforte, quanto ha dedotto essere la propria personale ragione,
la propria (illusoria) padronanza di sé e del mondo.
Ma nel suo pro-cedere succede che egli possa trovarsi su una linea di confine, nella condizione cioè di fare una scelta esistenzialmente rilevante: al di là un
suo progetto, un convegno che celebri l’atto di nascita di un suo nuovo concepimento, molto spesso accompagnato dal tremore che gli stessi convenuti lo avversino fino al punto di negargli ogni autonomia, ogni libertà. Ma questo tremore che accompagna ogni atto dell’e-sistenza, può essere accolto come una sfida,
come la misura dell’importanza del suo pro-gettarsi, e lui si lancia. Ma al di qua
della linea di confine continua a insistere la sua storia, il grembo di ogni suo attuale o potenziale neo-concepimento, l’intelaiatura delle regole ordinate da quel
mondo alieno che lo pre-occupa da sempre.
Nel momento di muovere il passo oltre la linea di confine può succedere
che questa alienazione originaria, questa retentio nel linguaggio binswangeriano, possa prevalere come attrattore esistenziale su qualsiasi protentio, per cui la
presentatio di quell’individuo diventa concretamente e storicamente aliena (le
infinite forme della mitologia psicopatologica).
In che cosa consiste allora una cura fenomenologica di condizioni esistenziali marchiate dalla propria genealogia? Lo è per me, insieme ad altri con cui
conveniamo nella medesima Associazione, l’antropoanalisi. La stessa parola
analisi, sottratta ai vincoli mitici e pragmatici dei feticci psiche-socio-gruppoecc. che la rende pertinente alla dissezione anatomica di un ente, acquista qui il
significato di un antropos che si occupa di un suo simile nella diversità, quell’occuparsene che chiamiamo cura non nel senso transitivo del terapeutico aggiustare guasti, ma nel senso di prendersi cura della capacità di osservazione di
tutti i partecipanti al medesimo convegno, l’incontro analitico, del processo di
formazione della coscienza, dello zoppicante e incerto processo antropo-poietico.
Se è il dissolversi della propria protentio, la propria lisi esistenziale ciò di
2
cui analista e paziente convengono di prendersi cura, il loro gettare lo sguardo
oltre l’immediatezza sintomatica della presentatio del paziente (e quante volte
anche dell’analista!) per inserirla nel loro tempo vissuto, è letteralmente αναλ�σις, e il luogo in cui si pratica e i metodi adottati richiamano l’antico concetto
di “bottega” dove qualcuno considerato più capace di altri maneggia i più diversi materiali per farne oggetti d’uso e/o di godimento estetico. Quindi, “andare a
bottega” significa acquisire o affinare le proprie abilità nel maneggiamento dei
medesimi materiali che il “maestro” adopera per esprimere la sua più o meno
eccellente capacità concepitiva, e una volta raggiunto pazientemente un certo
grado di formazione ogni allievo si disporrà a esprimere autonomamente quello
che la propria coscienza avrà tratto dalla sua esperienza in bottega.
Diego Napolitani
Via Vesio, 24
20148 Milano
[email protected]
2
LÀ DOVE ERA LA PSICHE, DEVE FARSI SPAZIO L’EVENTO
Federico Leoni
Note filologiche su psicoanalisi e daseinsanalisi
Il titolo qui sopra è anche una specie di motto, “là dove era la psiche, deve
farsi spazio l’evento”. Mima scopertamente quello di Freud: Wo Es war, soll
Ich Werden, dove era l’Es deve giungere l’Io. Lo mima, ma anche lo stravolge
da più punti di vista. E lo fa in termini grosso modo heideggeriani: là dove era
l’io, la psiche, il soggetto, deve farsi spazio, o forse bisogna lasciare essere, l’evento. Quale possa essere il senso di questa traduzione, o provocazione, proverò
a dire brevemente qui di seguito.
Anzitutto un passo indietro. “Antropoanalisi” è uno dei modi in cui è stato
tradotto in italiano il termine Daseinsanalyse. Le ipotesi italiane sono state innumerevoli: antropoanalisi, analisi esistenziale, analisi della presenza. Sono variamente attestate, in momenti e autori diversi, nella produzione di Cargnello o Callieri, tra i primi a diffondere questo approccio in Italia. All’origine di questa incertezza, o pluralità di possibili vie traduttive, c’è un problema lessicale di fondo
su cui è istruttivo riflettere. Nessuno, a esempio, ha mai dubitato che la traduzione più opportuna di Psychoanalyse, la creatura di Freud, dovesse essere “psicoanalisi”. Alla parola tedesca (e in verità greca, psyché) corrispondeva esattamente,
ed era disponibile nell’uso italiano corrente, il termine “psiche”. Lo stesso per
“analisi”. Diverso il caso di Daseinsanalyse, l’analisi di qualcosa di difficilmente
traducibile, in italiano, come il Dasein. Tutte le difficoltà nascono da qui.
Non dimentichiamo che Binswanger aveva coniato il termine Daseinsanalyse precisamente allo scopo di smarcarsi dalla psicoanalisi freudiana, alla quale
pure era stato molto legato: era un ammiratore di Freud, aveva rapporti personali con lui, e si direbbe che la sua pratica di psicoterapeuta non sia stata troppo
dissimile da quella di uno psicoanalista freudiano dell’epoca. Binswanger vedeva però nell’approccio freudiano, e nella parola “psicoanalisi” che doveva riassumerlo, un rischio che intendeva evitare, e che potremmo indicare complessivamente come il rischio di un’oggettivazione della psiche. È noto, infatti, il monito binswangeriano: la scissione soggetto/oggetto è il cancro che affligge la disciplina della psicologia. Il senso del monito è, almeno per quanto ci riguarda in
questa sede, che una volta scisso il soggetto dall’oggetto, si sarà fatto anche del
soggetto un oggetto, si sarà distrutto ciò che si intendeva porre al centro della
2
scena. Dunque, parlare di io, psiche, soggetto (e di psicoanalisi, psicoterapia,
ecc.) , soggiace a una decisione preliminare, a un paradigma incentrato appunto
sulla scissione e sulla conseguente oggettivazione del soggetto, che Binswanger
si propone anzitutto di schivare.
Il monito di Binswanger aveva insomma il significato di invitare, al seguito
di Heidegger, a compiere una mossa, o un insieme di mosse, decisive. Rimetteva al posto del soggetto “oggettivato” dalla psicoanalisi (o dalla psicoanalisi
quale poteva conoscerla e comprenderla Binswanger) qualcosa che poteva corrispondere al Dasein heideggeriano. Faceva del Dasein heideggeriano il nuovo
ambito intorno a cui riflettere, intorno a cui costruire una psicologia nuova (o
meglio una non-psicologia, posto che la premessa era quella di andare al di là o
a monte della scissione tra psiche e mondo; la nuova disciplina non poteva essere una psicologia senza essere allo stesso tempo una cosmologia, per così dire)
e un nuovo modo di praticare la psicoterapia (o meglio una non-psicoterapia,
dato che, tolta la scissione tra psiche e mondo, è tolta anche la scissione tra un
soggetto che studia e manipola “tecnicamente” un certo oggetto che è la psiche
del suo paziente, e la psiche del paziente che se ne lascia passivamente manipolare ed eventualmente trasformare; non più psico-terapia, ma qualcosa che non
è propriamente “psicologico” né “terapeutico”: ci torneremo).
Una difficoltà di parola
Che cosa mettere, a questo punto, al posto delle “scissioni” che ancora
Freud manteneva saldamente? In una battuta, potremmo rispondere tornando al
motto da cui eravamo partiti. Se il motto della psicoanalisi è stato questo: dove
era l’es, deve giungere l’io; il motto della Daseinsanalyse voleva essere, o
avrebbe potuto essere, o avrebbe dovuto essere, quest’altro: dove era la psiche,
deve giungere il Dasein. Era per dire questa cosa, che Binswanger aveva preso
a prestito da Heidegger la parola Dasein, battezzando la sua creatura Daseinsanalyse.
È noto con quanta diffidenza Heidegger abbia accolto il lavoro di Binswanger, e con quanta sofferenza Binswanger abbia incassato le critiche di quello
che considerava comunque come il suo maestro. Heidegger in sostanza obiettava che al di là del nome e della direzione che essa segnava (Daseinsanalyse anziché “psicoanalisi”: bene), le analisi che Binswanger svolgeva nei suoi testi
erano ancora troppo “metafisiche”, cioè reintroducevano di continuo, più o
meno inavvertitamente, categorie e presupposti dualistici, cartesiani, psicologi3
stici, ecc. Il cancro della scissione soggetto-oggetto era tutt’altro che superato.
L’analisi di un qualsiasi testo binswangeriano può documentare ampiamente la
fondatezza dell’accusa di Heidegger. Tuttavia non è questo il luogo in cui soffermarci sugli scivoloni di Binswanger lettore di Heidegger. Atteniamoci all’intenzione che, almeno come intenzione, Binswanger condivide appieno col suo maestro. Si tratta di porre al centro della scena quella cosa, che non è una cosa, che è
il Dasein.
Dasein in tedesco significa in fondo esserci, essere qui, essere presenti. Nomina una presenza molto concreta, un essere tra le cose e presso gli altri. Dice
qualcosa di molto più quotidiano e di molto meno astratto di ciò che la filosofia
moderna nomina come “soggetto”, e che la psicologia eredita in blocco dalla filosofia, spesso inconsapevolmente. È un fatto che nessuno di noi, chiacchierando con gli amici, direbbe di sé di essere un soggetto, di avere di fronte a sé degli
oggetti, e così di seguito. Dasein è invece una locuzione talmente diffusa, in tedesco, da ricoprire proprio quell’esperienza comunissima e primordiale che
Heidegger vuole scandagliare. Il “soggetto” è una sorta di costrutto artificiale,
che affonda le radici in un ordine di esperienze, in un modo di esistere e praticare il contesto dell’esistenza, molto precedente. Per altro verso, la parola Dasein
si presta abbastanza agevolmente a tutti gli usi che Heidegger le impone, perché
quei giochi così tipici della sua scrittura si svolgono quanto meno in un ambiente omogeneo, quello di un tedesco colloquiale su cui Heidegger svolge tutti i
giochi, le manipolazioni e le creazioni che presiedono alla formazione del lessico tedesco ordinario.
Più in salita la strada per un traduttore italiano. Giocare con la parola esserci
diventa subito pesante, e moltiplica le pesantezze che anche in tedesco si generano immediatamente, non appena Heidegger si mette a giocare (seriamente, nessuno lo nega) con le parole: essere il ci, aver da essere il proprio esserci, e così di
seguito. La fatica tuttavia è ben spesa, e non è senza motivo che i francesi, dotati
di una lingua molto simile alla nostra, e di uno spirito nazionalistico ben più vivace del nostro, hanno infine deciso di mantenere il tedesco Daseinsanalyse, moltiplicando le difficoltà linguistiche e impigliandosi in una gran quantità di problemi, che hanno avuto forse risvolti anche positivi. Certo giocando continuamente
col tedesco si fa di questa “cosa” un oggetto un po’ esoterico. E questo è un problema, specie in tempi in cui domina l’inglese e l’anglofilia, magari spacciata per
scientificità dai solerti funzionari della normalità disciplinare (lontanissimi peraltro dal chiedersi se il problema non stia appunto nell’idea di “scientificità” che
adottano, e nel loro automatismo mentale per cui qualsiasi disciplina sarebbe degna di interesse solo se dotata di quella e non altra “scientificità”). La Daseinsa3
nalyse francese è diventata un’avventura ampiamente costeggiata dai filosofi, già
familiari con un certo lessico che hanno faticato meno a riprendere in mano, e
molto meno dagli psichiatri e psicoanalisti, che la pensano appunto come un oggetto troppo “filosofico” quando non addirittura “letterario” (salvo eccezioni,
come Lacan o Fédida). Problema aperto, come dicevo.
Allo stesso tempo, qualche vantaggio, in tutta questa fatica, c’è. Ad esempio, il vantaggio di tener viva l’attenzione su un altro problema, che è quello di
non ricadere nell’oggettivismo delle scienze naturali e nell’ovvietà di certe abitudini categoriali, che le scelte lessicali più comuni trascinano con sé. Parlare di
soggetto costringe a supporre che quel soggetto sia separato dal mondo, che
fronteggi degli oggetti, e che esso stesso sia quindi un che di isolato, circoscritto, immobilizzato, ovvero un altro oggetto.
Per tanti motivi che Heidegger ha illustrato, e Derrida ha scavato in ogni
dettaglio, tanto la scelta di parlare di “uomo” quanto di “presenza”, e dunque
tanto la scelta di parlare di “antropoanalisi” quanto quella di parlare di “analisi
della presenza”, per citare qualche alternativa possibile e già praticata in Italia,
racchiudono qualche rischio di ricaduta in questa stessa direzione. Se diciamo
“antropoanalisi” non reintroduciamo forse, sotto sotto, la categoria del soggetto,
l’idea che ci sarebbe qualcuno che se ne sta separato dal mondo, di fronte a una
serie di oggetti, sovrano di fronte alla natura, sorta di monade bell’e fatta anziché intesa e pensata nel suo farsi? Se diciamo “analisi della presenza”, non reintroduciamo col riferimento alla presenza qualcosa che Heidegger ha voluto evitare in ogni modo, cioè di pensare l’esperienza o l’esistenza a partire dal presente, da ciò che c’è, dall’oggettività del qui e ora, assegnando invece un privilegio
decisivo al futuro, all’assenza, al vuoto, e a tutte le altre figure di quel punto di
mira quasi innominabile del suo pensiero, che a un certo punto ha iniziato a meditare incessantemente sotto il nome di Ereignis?
Aperti alle stelle
Potremmo notare che non a caso Diego Napolitani fa ricorso, nell’introdurre nel suo percorso teorico il termine “antropoanalisi” e nel perimetrare l’ambito di ciò che intende per uomo, anthropos, a un gioco etimologico che ha esattamente il significato di riportare in primo piano, per dirla in una battuta, il vuoto
in quel pieno che l’”uomo” rischia sempre di diventare, e che la parola “uomo”
rischia sempre di trascinare con sé nei nostri pensieri, nelle nostre teorie e nelle
nostre pratiche.
3
L’anthropos sarebbe invece – se leggiamo il testo con cui si apre questo numero zero della rivista – colui il quale guarda in alto, destabilizzato da questa sua
strana postura, da questa apertura al non previsto e al non immediatamente dato,
da questa incompletezza sua e del suo mondo, da questa sua anatomica e perciò
trascendentale instabilità e squilibratezza, da questa sua strutturale e insormontabile embrionalità e divenienza. L’anthropos di Napolitani è insomma aperto all’evento, e non semplicemente interessato a fare esperienza di “oggetti”, perché non
è un soggetto ovvero non è un altro oggetto, ma un evento esso stesso – e proprio
perciò un evento che accade con il suo mondo e con i suoi “altri”, trasformandoli
e venendone trasformato a ogni istante e cioè a ogni altro evento o a ogni evento
dell’altro.
Beninteso: ciascun evento è poi evento di sé ed evento dell’altro, o è l’altro
e l’alterità che accade, trascinando nel suo divenire quel sé e quell’altro del sé
che ne sono gli effetti tutti interni. La distinzione, la discontinuità tra il sé e il
mondo, tra il sé e l’altro sé, cade. Non è più logicamente sostenibile, se si è inteso il monito di Binswanger, e l’analitica esistenziale di Heidegger che in esso
risuona. Quella distinzione lascia il posto a un pensiero della perfetta continuità:
tutto il mondo è inscritto nell’accadere del mio essere nel mondo, e tutto il mio
essere nel mondo non è che l’accadere del mondo stesso nel mio evento – o in
quell’evento che, per pura comodità, diremo “mio”, o “io”.
Il mondo è insomma una grande stoffa che si piega e ripiega senza sosta, e
l’essere nel mondo non è che la piega di stoffa che senza soluzione di continuità
si prolunga nella stoffa intera o nel mondo intero, trascinato e rigenerato da
ogni altro movimento del mondo e da ogni altra piega che in esso si formi. Oppure (ed è lo stesso): ogni “soggetto” è la grande stoffa nella quale sono racchiusi tutti gli altri e tutto il mondo e tutti i mondi degli altri, e a ogni evento di
quegli altri che ne sono le pieghe, quella stoffa che è ogni soggetto si sposta e si
ripiega a sua volta. Non c’è un dentro e un fuori, uno stesso e un altro, un prima
e un dopo, ma degli effetti di interiorità ed esteriorità, identità e alterità, passato
e presente; effetti che accadono a partire da questo continuo movimento che è
anche e anzitutto il continuum in quanto movimento, o in quanto evento.
Un’antropologia antiumanistica?
Si potrebbe dire che questa è un’antropologia radicalmente
“antiumanistica” nel senso di Heidegger e della sua battaglia contro l’umanismo
(sartriano, per esempio). È un’antropologia, peraltro, dotata di una sua storia il3
lustre, sorta di controstoria della metafisica che stranamente Heidegger ignora
nel costruire quello che chiama “storia dell’essere”. È l’antropologia di Pico
della Mirandola (la sua idea della “dignità” dell’uomo è l’idea di un evento, nei
termini neoplatonici di cui disponeva questo illustre “umanista”; la dignitas è
l’essere al di là di ogni sostanzialità, l’essere una hyperousia e non una ousia,
non un soggetto o un sostrato di eventi ma un evento esso stesso, nel quale si
iscrivono eventualmente delle soggettivazioni o delle sostantivazioni di quello
stesso evento) o di Giordano Bruno (la sua idea centrale, e fondamentalmente
copernicana, è quella di un infinito in atto, per cui ciascuno degli infiniti mondi
è la ricapitolazione di ogni altro mondo, e ogni altro mondo ricapitola ciascun
altro in maniera insieme integrale e integralmente prospettica, senza dimenticare nulla dell’infinito universo e degli infiniti altri mondi e allo stesso tempo dimenticando tutti gli altri in quanto altri, perché riassorbiti nella propria stoffa e
fatti accadere in quanto alterazione “propria”, non in quanto alterità
dell’”altro”).
Lasciamo ora da parte tutto questo, e lasciamo da parte una piega del discorso, per dire così, che andrebbe qui affrontata, e che lasceremo in sospeso: cioè
che il “gruppo” bioniano e il “divenire-O” bioniano hanno indubbiamente qualcosa a che fare con un pensiero del continuum e del continuo differenziarsi ricapitolandosi di quel continuo. Intorno al concetto di “gruppo”, che Napolitani liquida come foriero di un’oggettivazione tendenzialmente positivista, c’è, come
Napolitani sa meglio di tanti altri, un pensiero, o almeno la promessa di un pensiero, della complessità, cioè appunto della piega e dell’implicazione dei molti
che fanno uno e dell’uno che accade nei molti essendone ricapitolato e rilanciato
ogni volta. Torniamo invece un’ultima volta al motto da cui eravamo partiti: là
dove era il soggetto, deve farsi spazio l’evento.
Quel motto fotografa per un verso una certa fenomenologia della nostra esistenza, del nostro “posto” nel mondo, della materia di cui siamo fatti. Questa materia, potremmo dire riassumendo la questione da un altro punto di vista, è il senso come direzione di un divenire. È quanto fa il filosofo che rinuncia alla categoria del soggetto e ai tutti gli automatismi che le sono legati. Pensare senza soggetto, pensare l’esperienza e il senso dell’esperienza senza un soggetto che le conferisca senso, detenendolo chissà dove, dentro di sé, come se il soggetto fosse una
scatola, cioè ancora un oggetto, dentro a cui sta un senso, pensato ridicolmente
come un altro oggetto, forse più piccolo. Il soggetto non è una matriosca, ovvero
non c’è soggetto. Le due cose sono tutt’uno. Il senso fa tutt’altro tragitto, è tutt’altra cosa da questa. E cioè non è una cosa, è un movimento, una direzione, un
evento appunto. La “cura” filosofica del senso ha a che fare con questo esercizio,
3
con questo rimettere in movimento i fossili del senso che troppo spesso crediamo
vivi, e scambiamo per il senso stesso.
Ma questo è quanto fa, per parte sua, lo psicoterapeuta, nel momento in cui
non è più uno psicologo e neppure un terapeuta, ma qualcosa di strano, che in
molti da tempo tentano di battezzare in modo nuovo. Lo psicoanalista non è uno
psicoterapeuta, lo psicoterapeuta non è un medico o un ortopedico o un normalizzatore; lo psicoanalista non è uno psicoterapeuta, o lo psicoterapeuta non è un
medico, perché il bene che può venire da un’analisi è quasi un effetto collaterale
dei suoi procedimenti sedicenti curativi; tutte formulazioni correnti nel dibattito,
pur raro e ristretto a qualche isola pensante, che ricorre intorno a questi temi. Dal
nostro punto di vista, potremmo semplicemente ripetere che, comunque si chiami
e si ponga il terapeuta, ciò che fa o si sforza di fare, ereditata questa lunga vicenda heideggeriana o binswangeriana, e condivisa magari qualcuna delle sue ragioni zoppicanti, è di fare in modo che là dove c’era effettivamente un soggetto, cioè
un sostrato, una sostanza, una ousia, qualcosa insomma che non diviene, torni a
farsi spazio l’evento, il dispiegarsi e il ripiegarsi del mondo, il movimento di
quella vita che è tutt’altra dalla vita di “un” soggetto o di un “soggetto”; e che è il
divenire e il pullulare di mondi nuovi in mondi nuovi.
BIBLIOGRAFIA
Bion W., Trasformazioni, Armando, Roma 2001.
Binswanger L., Per un’antropologia fenomenologica, Feltrinelli, Milano 2007.
Bruno G., De l’infinito, universo e mondi, in Opere italiane, vol. 2, Olschki, Firenze 1999.
Bruno G., De la causa, principio et uno, in Opere italiane, cit.
Heidegger M., Lettera sull’umanismo, Adelphi, Milano 2006.
Heidegger M., Essere e tempo, Longanesi, Torino 1969.
Heidegger M., Tempo ed essere, Longanesi, Milano 2007.
Maldiney H., Pensare l’uomo e la follia, Einaudi, Torino 2007.
Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo, Fondazione Pietro Bembo-Guanda Editore, Milano 2003.
Sartre J.-P., L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 1990.
Federico Leoni
Via Cesariano, 10
20154 MILANO
[email protected]
3
UN PRIMO COMMENTO A “LÀ DOV’ERA LA PSICHE, DEVE FARSI SPAZIO L’EVENTO” DI
FEDERICO LEONI
Diego Napolitani
Trovo molto suggestivo il confronto tra il motto che fa da titolo all’intervento di Federico e quello freudiano su Es ed Io. Nell’oggettivismo di Freud
l’Es è “la cosa psiche”, e più precisamente l’inconscio, essendone l’Io un prodotto che poi tenta di farla da padrone, per Federico chi deve “farla da padrone”
è l’evento, il “venir fuori” della “azione” (ricordando qui quanto Sini ha posto
al fondamento dell’esserci). E l’azione è il modo di apparire della presenza, del
Dasein, dell’esistenza che non è la sommatoria di tutti i segmenti anagrafici di
cui è indubbiamente composta, ma ne è una composizione: così come musicalmente una sinfonia non è la somma delle sue note ma un singolare modo di
comporle.
Una seconda nota: il mio lavoro tratta centralmente del fenomeno della coscienza in quanto azione in pectore che originariamente viene fuori da una inscindibile uni-dualità (un “evento” sin dalle sue origini) per dare progressivamente un senso, una direzione, all’infinito complesso di esperienze vissute, dalle sue immemori origini al suo indefinibile divenire. La coscienza è l’evento
singolare di ciascuna presenza che compone in rappresentazioni polifoniche la
quantità di “note” in essa depositate e da essa concepite. Mi chiedo se sia un
“puro caso” che Federico faccia riferimento a Freud oltre che per la sintassi del
suo motto anche per la semplice omissione del termine coscienza dal suo commento, come Freud fa nell’intera sua opera.
La coscienza non è un evento? E se lo è chi ne è l’autore, da dove viene
fuori? E se cerchiamo di darle un senso, finiamo col cosificare un puro fantasma? Ma anche se scivolassimo (come a Binswanger sembra più volte di essere
capitato) in questa direzione, non sarebbe sempre la coscienza, nelle sue stratificazioni storico-culturali, a esserne responsabile? O per rimanere nella “purezza
fenomenologica” siamo costretti a bandire dal nostro linguaggio ogni parola
contaminata dal pensiero razionale per usarne solo quelle tanto “pure” da diventare evanescenti? Evento come “è vento”?
Non conosco l’opera di Giordano Bruno, ma quel che Federico ne riporta si
riassume nella parola “ricapitolazione” (“per cui ciascuno degli infiniti mondi è
la ricapitolazione di ogni altro mondo” ); ma sia “ricapitolazione” sia “infinito”
così combinati tra loro sono “pure intuizioni” sottratte a qualsiasi forma di
3
esperienza vissuta nella sua pienezza, pienezza che si realizza solo nell’incessante alternarsi d’intuito e di razionalità, di paesaggi e di geometrie, di tuttunità
e di distinzioni Io/non-Io. Anziché ricapitolazione io uso la parola “ri-appresentazione” che si manifesta come una “sostanza” fluida e opaca, prodotta dalla
materia cerebrale (ecco la cosa) che fa da medium tra l’esperienza di sé (le memorie del passato e del futuro), le esperienze senso-percettive (le cose del mondo) e l’esperienza del continuo confronto tra le due. Questo medium (o mezzo o
tra-) è il cum-scire della coscienza la cui azione specifica è la produzione di
senso.
Diego Napolitani
3
RISPOSTA AL COMMENTO DI DIEGO NAPOLITANI
Federico Leoni
Diego Napolitani nota, nel suo commento al mio articolo “Là dov’era la
psiche, deve farsi spazio l’evento”, che non uso il termine coscienza: vero, confermo; lo faccio con coscienza; e provo a spiegare perché.
Altrove l’ho usato, provando a spingerlo il più possibile in una direzione
estranea alla sua tradizionale semantica. Nell’ultimo numero online di Psiche,
per esempio, ho provato a dire che la psiche è un evento, senza padrone e senza
autore, nel quale si iscrive ogni esperienza, compresa quella dell’assenza, dell’oblio, dell’inconscio. Senza qualcosa che pensa senza sosta, e che non sono
certo io o che non è mai un “Io”, manca persino il luogo nel quale mettere quei
buchi e quegli strappi che tanto colpivano Freud. La mia era una mossa sostanzialmente husserliana, col pregio di mettere in luce alcune cose, e, come sempre, col limite di metterne in ombra altre.
Ora, in questo articolo per Antropoanalisi, lavoravo piuttosto nel solco di
Heidegger; “coscienza” sarebbe stata una parola fuori posto, perché il punto,
per me, era soprattutto ragionare sul perché Binswanger avesse opposto a Freud
e alla “sua” psicoanalisi una Daseinsanalyse, che per mille motivi non avrebbe
avuto senso, né per Binswanger né per il suo maestro Heidegger, definire come
una Bewusstseinsanalyse, come un’analisi della coscienza. La coscienza era per
entrambi un termine troppo compromesso, troppo segnato da una tradizione che
ne faceva quasi esclusivamente un soggetto di fronte a un oggetto, e ciò era tanto urgente per entrambi loro, che stentarono sempre a capire il motivo per il
quale il loro comune maestro Husserl, appunto, potesse invece accontentarsi del
termine coscienza, purché se ne facesse buon uso e cioè vi si individuasse qualcosa che ora definirei sinteticamente come un campo anonimo, un evento inaggirabile, un luogo assoluto e incessante (col che torniamo a quanto detto sopra,
e su Psiche).
Sono questi ultimi tratti che possono avermi fatto pensare a Giordano Bruno o Pico della Mirandola, e alla loro idea di “uomo”. Anche per loro l’uomo è
il luogo assoluto nel quale accade il mondo. Esattamente come ogni sasso e
ogni lucertola, si dovrebbe aggiungere. Anche il loro è un pensiero dell’assoluto, per cui ogni parte del cosmo è il tutto, ricapitolato e reso presente in quella
parte e a partire da quella parte. Pensiero del continuum, del “tutto in tutto”, che
non significa però indistinzione e uguaglianza universale, come mi sembra te3
mere Diego Napolitani. Ogni parte riassume il tutto nella sua prospettiva, è
vero; ma con gradi e misure diverse. E cioè non astrattamente e genericamente,
ma concretamente e con tutta la forza di quella concretezza o di quell’incarnazione. È forse questo accadere di tutta la storia del mondo qui e ora, a contrassegnare e produrre il suo essere, insieme, conscia e inconscia, perfettamente
rammemorata e insieme e ogni volta dimenticata “come tale”; dimenticata come
tale proprio perché rammemorata, ovvero rilanciata e agita, non “come tale” ma
“quale io” sono qui e ora, intanto che lui è là e allora, e così via.
Ogni contrapposizione tra conscio e inconscio o tra coscienza e mondo viene meno. Ciò che qui si dà a pensare è la gradazione continua dell’accadere:
sempre la stessa stoffa eppure sempre nuova, sempre tutta quella stoffa eppure
tutta nel gesto che la solleva in questo punto e non in un altro; altro punto nel
quale peraltro anche si solleva, sollevando di rimbalzo questo primo punto, e di
nuovo rammemorandolo e insieme perdendolo “come tale”. Che vi sia inconscio non significa forse nient’altro che il senso è nelle mani dell’evento dell’altro o dell’altro in quanto evento; il quale altro o altro evento è a sua volta nelle
mani dei mille altri eventi che esso è, e che insieme lo fanno essere. Dunque,
psicoanalisi? Daseinsanalisi? Antropoanalisi? Non è un caso, credo, se Eugène
Minkowski, venendo da Bergson, che non cito, ma ho costantemente presente, e
che non vedrei tanto estraneo alla tradizione dei Bruno o dei Pico, concludeva
la trilogia dei suoi grandi libri degli anni Trenta proponendo una “cosmologia”.
Cosmoanalisi, allora? Analisi dell’evento del mondo, e mondo che accade analizzandosi, disperdendosi e cioè raccogliendosi e significandosi nei suoi infiniti
eventi?
Federico Leoni
3
LA MIA STANZA D’ANALISI
Claudia Napolitani
Una donna intelligente
Anna è una donna intelligente, bella, brillante nelle relazioni sociali e lavorative, che viene da me perché non riesce a stabilire alcun rapporto sentimentale
in una dimensione anche appena vivibile: rapporti solitamente di brevissima durata costellati da sue violente sfuriate (definite da lei stessa come scene isteriche
e spesso causate da futili pretesti), che estenuano sia lei sia il partner di turno
fino all’inevitabile separazione, vissuta sempre come grande catastrofe. Di solito la sua disperazione si protrae fino a quando, incontrato un altro uomo, inizia
una nuova relazione, sempre identica nelle modalità a quella precedente. Dopo
alcuni mesi di incontri individuali, in cui si riesce a stabilire una buona intesa,
decidiamo di proseguire il lavoro in gruppo, dove Anna sembra ambientarsi immediatamente con molta facilità, senza alcun problema particolare. Anzi, sin
dal primo incontro incomincia a parlare, in modo molto dettagliato, delle grandi
difficoltà vissute nel suo attuale rapporto con un uomo sposato. Il gruppo a sua
volta la accoglie con interesse senza manifestare particolari disagi per il gran
spazio che Anna si piglia a ogni incontro. Un paio di volte Anna, con accenti disperati, racconta i difficilissimi rapporti che vive in casa con genitori e sorelle,
aprendo quindi al gruppo, almeno in parte, il racconto della sua vita familiare, e
ottenendo così un livello di empatia maggiore da parte di molti di loro.
Sin dai nostri primi incontri individuali, Anna presenta la sua situazione familiare nei seguenti modi: la madre, pur essendo sofferente sin da giovane per
una forma depressiva importante che la costringe a letto la maggior parte del
tempo, è raccontata come essenziale figura di riferimento affettivo; il padre, pur
non essendo stato medicalizzato come la madre (seguita da psichiatri con cure
farmacologiche), viene però descritto come persona molto rigida, afflitta a sua
volta da depressione, con scatti rabbiosi di inusitata violenza, soprattutto verbale, rivolti tanto alla moglie quanto alle figlie. Le sorelle hanno sempre avuto
uno scarso rapporto tra loro. Quando si addentra nella storia della sua infanzia
emergono però nodi problematici soprattutto nel rapporto con la madre: sin da
bambina Anna veniva chiamata dalla madre al capezzale del suo letto perché
lei, solo lei, con la sua presenza, poteva agganciarla alla vita. Se Anna cercava
di sottrarsi alla tortura dell’esserle accanto, nella stanza in perenne penombra,
4
subissata dai suoi continui lamenti, si sentiva molto in colpa, mentre invece se
le restava vicino sottraendo così il suo tempo ai giochi o alle volte anche alla
scuola, provava una gran rabbia, che finiva però, in ogni caso, col trasformarsi
in senso di colpa: solo un insensibile, o un animo cattivo poteva prendersela
con una persona così sofferente!
Torniamo al gruppo. Mi accade spesso che quando Anna parla dei suoi problemi amorosi io mi senta insofferente, annoiata. Questo mio stato d’animo
(non presente quando ci vedevamo in individuale), mi avvolge interamente lasciandomi un senso di torpore fastidioso. Mi dico che forse, anche in questo
caso, emerge la mia consueta impazienza che ben conosco e che devo riuscire a
tenere più a bada: in fondo le persone che entrano in gruppo hanno sempre bisogno di prendere le misure del proprio e altrui tempo prima di capire come
funziona il nostro gioco gruppale. E poi è giusto che lei possa esprimere i suoi
disagi per come li vive, c’è da fare ancora tanta strada insieme! Passano così un
paio di mesi. Nel frattempo una ragazza, Livia, annuncia di sentirsi pronta per
finire il suo percorso d’analisi ma, in modo abbastanza insolito, nessuno nel
gruppo sembra dare rilievo alla cosa. In diversi incontri provo a chiedere come
mai questo annuncio sia così caduto nel vuoto ma le risposte che ottengo sono
abbastanza evasive, e la stessa Livia sembra non essere più di tanto interessata a
mantenere aperta la questione, diventando sempre più silenziosa. Mi sento in
difficoltà, non mi è chiara questa reazione del gruppo anche perché Livia è sicuramente una delle figure più attive e centrali. Finisce che farfuglio qualche frase
fatta sulla difficoltà di separazione. Capita anche, sempre più frequentemente,
che alcune persone del gruppo inizino a dire che non si sentono più tanto invogliate a parlare delle loro difficoltà, ipotizzando una loro maggior autonomia
dal bisogno di cercare aiuto dal gruppo. E ancora io non riesco a cogliere quello
che sta accadendo, e soprattutto non do molto rilievo al fatto che anche io mi ritrovi sempre con meno tempo a disposizione per far emergere spunti riflessivi:
su circa tre ore di lavoro insieme riesco a ritagliarmi, e a volte con fatica, gli ultimi 10-15 minuti.
Un giorno una ragazza racconta di aver fatto un sogno angosciosissimo:
dalla finestra della sua stanza vede Anna, nella casa di fronte, che viene massacrata a pugnalate. Chiedo al gruppo cosa possa rappresentare il personaggio di
Anna in questo sogno, o come possa essere vissuta Anna da loro. Vagamente,
ponendo questa domanda, avverto un desiderio di complicità con il gruppo contro Anna: in fondo l’immagine di questo sogno, nonostante sia così cruenta, mi
risuona, me la sento vicina. Ma non riesco a prendere fino in fondo contatto con
4
questa sensazione che mi pesa dentro come un groppo inesprimibile. Come ormai succede da qualche tempo a questa parte nessuno risponde e io lascio cadere l’argomento: continuo a non avere chiarezza e il sogno mi si pone ora davanti
come un enigma che non afferro. Nell’ultima seduta Anna, come al solito, incomincia a parlare delle consuete, inesorabili scenate con il nuovo fidanzato ritagliandosi i suoi abituali tre quarti d’ora. Conclude il suo lungo racconto chiedendosi però se il gruppo le sia utile a elaborare questi problemi che da una vita
la fanno così soffrire. Invece del solito silenzio pesante che ristagna ogni volta
dopo i suoi lunghi racconti, con mia sorpresa Rosa interviene subito dicendo
che in effetti c’è qualcosa che negli ultimi tempi sembra essere una difficoltà di
tutti: è come se nessuno riuscisse mai ad arrivare al nocciolo dei problemi. A
questo punto la discussione si anima come non succedeva da tempo. C’è chi
dice di avvertire in se stesso come negli altri una mancanza di spontaneità, chi
riprende le questioni che avevo aperto sull’apparente mancanza di interesse rispetto alla prospettiva di Livia di finire l’analisi chiedendosi a sua volta come
mai accada questo, chi incomincia a parlare della difficoltà a seguire i racconti
di Anna per uno strano senso di oppressione e di schiacciamento, pronto però a
scusarsi immediatamente con lei dicendole che sicuramente questa è una difficoltà del tutto personale, chi, invece, incomincia a protestare perché Anna occupa un grande spazio di tempo lasciandone molto poco agli altri. Livia, che ultimamente ha sempre parlato pochissimo, sottolinea come questa mancanza di
tempo sia stata per lei pesante anche perché i miei interventi si sono drasticamente ridotti rispetto a prima: che senso ha se tutti parlano e la “dott.“ non ha il
tempo per rimandare qualcosa di quanto è stato detto? Dice poi che, pur accorgendosi di questo mancato coinvolgimento del gruppo sul suo proposito di finire l’analisi, si è ritrovata a non pensarci più, come se fosse qualcosa che non
aveva più valore manco per lei. Racconta infine due sogni. In uno aveva acquistato una casa nuova con sua sorella, ma nell’andarci le scappavano i suoi amatissimi gatti che, azzuffandosi tra loro e correndo di qua e di là finivano col perdersi. Solo al risveglio si accorge che la casa “nuova” è quella in cui è nata e
dove è rimasta fino alla sua adolescenza. Nell’altro sogno invece deve valutare
se affittare una camera nella casa di una donna nel centro storico di Palermo.
Sicuramente la stanza non ha tutte quelle comodità a cui è abituata, inoltre la
convivenza con questa donna, a lei estranea, pone una serie di problemi visto
che è abituata a vivere da sola. Per non parlare del fatto che è per lei stravagante
l’idea di abitare in una casa in affitto visto che è una grande fautrice della casa
di proprietà e, come se non bastasse, il quartiere del sogno è malfamato e pieno
di rischi per una donna sola come lei; ma, nonostante tutte queste buone ragio4
ni, alla fine decide di starci perché dalla finestra della sua camera può godere di
un panorama unico che si apre sui tetti e le cupole della città vecchia. Si è svegliata con un senso di leggerezza dal sapore di libertà.
Ho seguito con emozione e interesse tutto questo vivace dibattito, e il sogno
di Livia offre anche a me un senso di libertà che da tempo, ora me ne accorgo,
non avevo più in gruppo. Rivedo con improvvisa chiarezza il mio essermi sentita fino a quel momento impacciata, goffa, inadeguata. L’aver avuto poco tempo
per parlare lo avevo finora vissuto con una forte ambivalenza, mai però del tutto
consapevolizzata: da un lato con un senso di costrizione sentendomi relegata
nell’angolino di fine seduta, ma dall’altro con il desiderio di rimanere nell’ombra, sentendomi appiattita senza nulla di veramente importante da dire. Ma
quanto mi è noto questo mio sentire! Mi accompagna sin da tempi remoti, da
quando è iniziato un confronto con i genitori vissuti, almeno in parte, come figure gigantesche, irraggiungibili. Bambina delle elementari suscitai perplessità
nella maestra quando le consegnai il disegno fatto in classe dove dovevamo rappresentare la mamma: io disegnai una specie di vestale, dal lungo abito bianco,
una corona in testa e, su una sola mano, aperto frontalmente, un grande libro.
Una distanza infinita tra me e questa sacerdotessa della sapienza. Questo confronto problematico me lo sono poi trascinato nelle relazioni col mondo. Sicuramente oggi, dopo un gran lavoro su me stessa, le cose non sono più come allora, ma il “cattivo passato” ritorna a fare capolino in momenti di crisi o in situazioni critiche, come quella vissuta in questo periodo nel gruppo. La natura di
questo cattivo passato porta sempre una sorta di ottundimento, un silenzio di
fondo, in cui naufragano le proprie risorse o le proprie intuizioni, appiattendo
l’immagine di sé, e quindi quella del mondo, sui personaggi interiorizzati di un
già-noto, di un sempre-stato, quel mondo delle origini che ci ha insegnato quel
particolare lessico familiare con cui vengono “normalmente” (secondo le norme
che la propria normopatia detta) designate le cose che abitano dentro e fuori di
noi. Quando prevale questa dimensione l’apertura nei confronti dell’alterità si
restringe tanto da impedire l’emergere di aspetti nuovi o semplicemente diversi
nella relazione con se stessi e con gli altri.
Risvegliata dal torpore in cui ero immersa ritrovo finalmente parola e dico:
“È vero, sono stata molto in silenzio ultimamente, ma penso che non dipenda semplicemente da una mal ripartizione del tempo cronologico che ognuno di
noi si ritaglia in gruppo. Mi sono sentita rintanata, appiattita, senza pensiero,
con l’unica preoccupazione di dover dire qualcosa per mantenere ai vostri occhi
inalterata la mia figura di terapeuta. Ma questo stato d’animo penso di averlo
condiviso con molti di voi, con tutti quelli che improvvisamente si sono ritrova4
ti più silenziosi sul racconto di se stessi o inerti rispetto alle novità che possono
spalancarsi, come a esempio l’annuncio di Livia di finire l’analisi. Ma cosa ci
ha ‘posseduto’ così intimamente da stravolgere il più consueto dialogo che ogni
volta, magari anche con fatica, cerchiamo di aprire tra noi? Parlo dell’essere
posseduti per mettere in risalto quella condizione del possesso che compare nel
primo sogno di Livia, quello in cui ha acquistato una casa che poi scopre essere
quella dov’è nata. In questa casa delle origini abbiamo tutti fatto esperienza dell’essere di proprietà di mamma e papà, di essere cioè stati dipendenti in modo
assoluto da loro, nel bene e nel male. Questa nostra dipendenza può essere stata
declinata nei modi più o meno conflittuali e contradditori che, in misura variabile, ogni relazione implica. Anna ha fatto sicuramente un’esperienza forte in
questo senso: è stata per sua madre il suo personale aggancio alla vita, come se
fosse però un suo stesso prolungamento. Immagino qualcosa del genere, come
implicito discorso intercorso tra loro: ‘Figlia mia, tu sei quella che mi rispecchia
più di chiunque altro, e più di chiunque altro ti sento a me appartenente. E allora
devi starmi vicina, occuparti di me, della mia depressione, della mia rabbia e della mia colpa, non puoi allontanarti per la strada della tua vita lasciandomi sola. La
mia sofferenza oscura ogni dove della nostra esistenza, ma questo è l’unico mondo che conosco. Solo tenendoti con me, dentro di me, ho l’illusione di mantenere
un contatto con me stessa. Ma sappi che se ti allontani mi distruggi, mi pugnali
alle spalle. Resta con me, dentro di me, nel buio’.
Anna, così ingoiata, non può che far vibrare la voce materna come se fosse
la propria, e noi, tutti attorno a lei, patiamo qualcosa di molto simile a quello
che lei ha sempre vissuto sin dalla più tenera età: al cospetto di questa madre
sofferente tutti noi diventiamo dei figli ammutoliti, incapaci di ‘andare al nocciolo dei nostri problemi’, di essere spontanei, creativi, aperti nel gioco col
mondo. Oscuramente sentiamo rabbia (‘Anna prende troppo spazio’), o ci sentiamo in colpa se le diciamo che i suoi racconti ci opprimono, perché la sentiamo piccola, sofferente. Ma la nostra parola o la nostra presenza non rappresenta
necessariamente per questa Anna-madre una luce nel buio: i miei dieci minuti li
ho potuti ritagliare il più delle volte interrompendola perché avrebbe altrimenti
continuato a parlare facendo a meno dei miei interventi. Come dire: importante
che io ci sia ma non quello che dico; mi sento importante come lo può essere un
gabinetto per i bisogni del suo proprietario. Naturalmente questo che oggi viene
drammatizzato attraverso Anna ci riguarda tutti, me compresa, perché altrimenti
avremmo trovato immediatamente altre strade da quelle percorse che finiscono
col ripercorrere fedelmente la sua storia. Storia che si riattiva ogni volta nel suo
disperato tentativo di possedere degli uomini che sono al contempo fondamen4
tali per il suo sentirsi in contatto con se stessa ma assolutamente inesistenti riguardo alle loro specificità. Ma rispetto a questa dimensione di possesso così
soffocante e disperante, che alternative abbiamo? Ce lo suggerisce sempre Livia
con il suo secondo sogno, che sembra fare da contraltare al primo. Nel primo
abbiamo visto che Livia non deve prendere nessuna decisione sul comprare o
meno la casa: la casa è già lì, di sua proprietà, proprio perché è la casa delle origini; viene però messa in luce la sua pre-occupazione per i gatti che azzuffandosi finiscono col perdersi. Nella casa delle origini domina, potremmo dire così, la
dimensione dell’essere pre-occupati proprio per come ne ho parlato ora per la
situazione di Anna: veniamo occupati da quelle figure genitoriali che ci pre-occupano rispetto al nostro interagire col mondo, e immersi in tale preoccupazione facciamo fatica a emergere nella nostra capacità di occuparci, cioè di prenderci responsabilmente cura, di ciò che ci riguarda. Ed è ciò che ha attraversato
il gruppo in questo periodo. Nel secondo sogno la situazione cambia radicalmente: ora Livia deve prendere una decisione sul dove andare ad abitare. Qui
non vi è alcuna pre-occupazione proprio perché Livia si sente libera di valutare,
e quindi scegliere senza vincoli costrittivi, qualcosa che apparentemente va in
una direzione opposta alle sicurezze della casa di proprietà. Se la casa di proprietà si connota come la casa della nostra pre-occupazione, è contemporaneamente anche ciò di cui abbiamo maggiore sicurezza, il nostro fondamento: niente in fondo è più sicuro di ciò che da sempre conosciamo, per come lo abbiamo
sempre visto e vissuto, e per come da sempre ci viene rimandato. È come se Livia nel sogno accetti invece di vivere l’avventura di ciò che sicuro non è: andare
a vivere in una semplice camera in affitto senza quelle comodità a cui è abituata
(che ruolo importante ha l’abitudine nel nostro stare al mondo!), implica necessariamente il suo dover convivere con un’estranea, cioè con quella se stessa che
riesce ad avere un diverso rapporto col mondo da quello finora vissuto: negli ultimi tempi abbiamo infatti potuto apprezzare il suo riuscire a dare un valore,
tanto a se stessa quanto agli altri, non più impigliato in quel continuo e incessante rimbalzo di critiche, colpe e inadeguatezze che la sua voce genitoriale ha
da sempre determinato. Questa Livia, libera dal giogo, tanto invisibile quanto
assoluto, delle sue appartenenze, può accettare oggi la sfida di vivere in un
quartiere pericoloso pur di godere lo splendido panorama che si gode da quella
nuova finestra aperta sul mondo. Ma oggi Livia ci insegna anche come la nostra
libertà vada ogni volta riconquistata e come noi ci possiamo spesso ritrovare a
vagheggiare case di proprietà e camere in affitto”.
Quando finisco di parlare si avverte sensibilmente nel gruppo un’aria più
4
leggera e gli sguardi sono più accesi e attenti. Anna invece sembra essersi accartocciata sulla sua poltroncina, visibilmente accigliata. Quando le viene chiesto come si sente, risponde laconicamente che ovviamente sta malissimo visto
che si è sentita accusata da tutti, dottoressa compresa, di essere la causa di ogni
male. Sono in molti a risponderle, sottolineandole, in modi diversi, come invece
è stata una importante occasione quanto si è andato intrecciando in questi ultimi
tempi grazie alla sua presenza: si è potuto toccare con mano e riflettere su quel
senso di mortificazione che spesso ci accompagna nella vita e che ci paralizza o
ci fa esplodere senza costrutto nei soliti modi. È qui che riesco a cogliere come
possa essere avvertito dal gruppo il senso profondo di una trasformazione, sia
gruppale sia individuale: il vero incontro con l’altro, quello che promuove il
processo di alterificazione, avviene quando si riesce a uscire da quei nuclei coscienziali legati alle nostre originarie alienazioni, emergendo così dai rimandi
conosciuti dell’universo della colpa, e aprendo l’orizzonte della responsabilità e
del prendersi cura, in una ricorsività proficua, tanto di sé quanto dell’altro.
Claudia Napolitani
Largo Primavera, 9
90143 Palermo
[email protected]
4
NARRAZIONE DI UN INCONTRO
Daniele Terranova
L’autenticità della cura consiste in un atto che a partire dalla trascendentalità
della coscienza (empatia) si prende cura della libertà dell’altro: il suo farsi testimone “solerte e premuroso” della fatica che l’altro compie per sottrarre il suo futuro all’oblio, a quell’oblio prodotto dal suo essere smarrito nei labirinti del proprio passato.
Diego Napolitani (2008)
Introduzione
Farò riferimento, nel presente elaborato, ad alcuni colloqui avvenuti nel
mio studio professionale nel corso dell’ultimo anno, che mi hanno svelato, sorprendendomi ancora una volta, quanto l’incontro fra due mondi, il mio di terapeuta e quello della paziente, sia sempre gravido di scoperte reciprocamente trasformative.
A partire dal resoconto di tre sogni che utilizzerò come incipit, articolerò
nel seguente lavoro delle riflessioni che si sono, via via, abbozzate nel corso di
questi ultimi anni di formazione che mi hanno appassionato e sorpreso per aver
messo in moto e realizzato un diverso modo di leggere l’incontro in psicoterapia.
Nell’argomentare intorno all’incontro, tratterò sui “modi della conoscenza”
facendo anche un breve riferimento, in epilogo, alla coscienza, nel tentativo di
trovare metafore che articolino fra loro i suddetti temi. Le mie riflessioni, o meglio, i pensieri che mi sono venuti in mente, e che hanno poi trovato una qualche forma praticabile e dicibile, hanno come riferimento fondamentale il preziosissimo pensiero di Diego Napolitani, che mi ha coinvolto col suo amore per
la conoscenza interessandomi ad altre e ulteriori letture.
Alla ricerca di un linguaggio che mi consenta di rievocare e di orientarmi
per quella particolare e sempre irripetibile esperienza, che si declina nell’incontro occasionale col mondo dell’altro, cercherò di avvalermi più di note e partiture musicali che di codici analitici, più di immagini evocative di paesaggi che di
carte geografiche.
Nel rappresentare e trasporre la viva esperienza dell’incontro in una narrazione comprensibile, non posso però che confrontarmi col mio procedere vacillante
e incerto, con la percezione del mai compiuto e del sospeso; proverò quindi ad
avventurarmi per dei sentieri della conoscenza che hanno la peculiarità di abboz4
zarsi nello stesso momento in cui si percorrono, affacciandosi su quel mondo-altro-sconosciuto condiviso col nostro interlocutore allo stesso modo di come le
“Città invisibili”, tinteggiate da Marco Polo all’imperatore Kublai Khan di ritorno dal suo viaggio, si vanno rappresentando nell’omonimo libro di Calvino.
Una conoscenza che è già-sempre un risuonare nell’incontro intenzionante,
unica possibilità o possibilità più propria, per usare un lessico heideggeriano,
cui riferirmi per alludere a quel punto zero, immaginario, da cui si dipanano le
più diverse narrazioni e/o immagini di cui l’uomo può farsi interprete divenendo autore della propria avventura esistenziale.
Due sono le figure suggestivamente evocatemi dall’incontro con la paziente, quella del funambolo e quella del danzatore, dalle quali mi sento preso e sedotto, ora dall’una ora dall’altra, in una alternanza dialogante.
Il funambolo, nel mantenere una stabilità che si configura più come un
equilibrio tremante, addomestica la vertigine a cui si protende la sua esistenza.
Il danzatore, invece, fa della sua perdita d’equilibrio, momentanea, un lasciarsi
andare verso movimenti fluidi e armonici, che si dispiegano nello spazio tracciando sempre nuove figure; al contrario dell’equilibrista, che nel suo attraversare lo spazio, sulla sua fune tesa, individua un punto d’arrivo prefissato che si
configura come obiettivo finale o meta salvifica.
Nella loro polarizzazione tali rappresentazioni esprimono, a mio parere, due
diversi modi della conoscenza: uno, fondamento di quelle scienze, incluse le psicologie, che attuano come presupposto della loro ricerca conoscitiva una scissione del mondo in soggetto conoscente e oggetto conosciuto; l’altro che, configurando l’essere-nel-mondo come trascendenza (In-der-Welt-sein, Heidegger,
1927), apre un nuovo orizzonte di comprensione dando impulso, come afferma
Ludwig Binswanger (1946), “all’indagine scientifica sull’essere dell’uomo in genere e sui particolari suoi modi di essere” .
È a partire da un procedere danzante, piuttosto che dalla tensione all’equilibrio del funambolo, che nel rapporto con la paziente (che chiamerò Maria), ho
intravisto la possibilità di riconoscere la mia mancanza e la mia incompiutezza,
in quella particolare esperienza fra il già noto e il non ancora che si compie nella conoscenza nei modi della trascendenza.
Alcuni cenni biografici
Maria, ventotto anni, decide di intraprendere un’analisi cinque anni fa,
dopo la morte della madre, che conclude una sua esistenza “disgraziata” fra
4
continui ricoveri in ospedale assistita dalla figlia stessa.
A seguito del divorzio tra i genitori, avvenuto durante la sua adolescenza,
Maria resta nella casa coniugale con la madre di cui diviene il principale riferimento affettivo; il padre, commerciante, si trasferisce in un’altra casa con la
giovane seconda moglie da cui ha un’altra figlia.
Il precedente rapporto tra i coniugi viene descritto come violento e rivendicativo: durante le lunghe assenze del padre per lavoro, la madre inizia a bere aggravando fino alla morte una epatite contratta durante il parto della figlia.
All’epoca dei nostri primi incontri Maria, interrotta l’università, fa una vita
da reclusa in casa, trascorrendo il tempo con amici che vengono a trovarla presso la propria abitazione coi quali fa un consumo sostenuto di droghe di vario
genere, alternando fra loro cannabis, cocaina e allucinogeni.
L’uso della cocaina inizia in realtà ai tempi del liceo permettendole, unito a
una spiccata intelligenza, delle ottime performance che la mettono a riparo da
critiche rispetto alla sua carriera scolastica, conferendole una visibilità da prima
della classe.
La vita fuori dalla scuola è segnata invece dalla ciclicità di umori che connota il rapporto con la madre, in cui grande complicità e confidenza si alternano
a periodi di dichiarata conflittualità, contraddistinti da offese svalutanti e violente percosse.
La famiglia della madre si fa complice nel nascondere al padre l’alcolismo
e il comportamento violento della moglie nei confronti di Maria, minacciando
la giovane di ulteriori maltrattamenti fisici e verbali se si fosse confidata col padre, perché, così facendo, sarebbe stata la causa dell’inevitabile separazione fra
i genitori.
Maria sembra riuscire ad affrancarsi nelle relazioni con gli amici e nei successi scolastici. Nell’adolescenza intraprenderà una relazione sentimentale in
cui, in una qualche misura, riproporrà le stesse modalità controllanti e violente
del rapporto con la madre. Da questo ragazzo Maria non riuscirà a separarsi se
non dopo alcuni anni d’analisi.
Sogni...
“Mi trovo in ospedale dove riconosco esserci anche mia madre… a
differenza dei sogni precedenti questa volta non mi trovo nella sua stessa stanza
ad assisterla, ma in un’altra stanza dove incontro un’infermiera che mi informa
che mia madre sta per morire, è agli sgoccioli, non c’è più niente da fare ormai
4
per lei... firmo dei documenti per le dimissioni di mia madre ormai morente per
portarmela a casa” .
“Sono a casa e mi sento richiamata, sollecitata a uscire perché apprendo che
la mia macchina nuova è stata rubata, ma scopro poi che il furto non è altro che
uno scherzo di amici. Sono angosciata a uscire da casa, guardo dalla finestra e
intravedo il mio giardino... esco e mi ritrovo in un giardino diverso dal mio:
molto luminoso… una luce strana, ci sono più alberi del normale e una più ricca
vegetazione; incontro degli esseri strani, deformi verso i quali provo ribrezzo,
ripugnanza, sono esseri umani con il volto da vegetali, questi esseri orrifici mi
indicano la strada per ritrovare la mia macchina” .
“Sono in un palazzo, tipo la “palazzina cinese”, molto colorato... mi ritrovo
all’ultimo piano nei pressi delle scale che portano fuori, dietro di me c’è il fratello del mio ragazzo che mi spinge da dietro verso le scale invitandomi a uscire
fuori.. io sono molto angosciata, spaventata, ma quando mi ritrovo fuori sento
un senso di liberazione” .
Queste tre narrazioni oniriche, le cui metafore condensano, nella loro drammaticità, l’esistenza di Maria, rappresentano e rivelano quel gioco comune, quel
gioco esistenziale, che si anima e si articola fra me e l’altro nel mio studio, uno
dei tanti scenari in cui si dispiega la mia esistenza.
Nel mio ascoltare la paziente, durante il racconto dei suddetti sogni, “vengo
preso” da un interesse che ha la qualità e il sapore di qualcosa che si annuncia,
che sta per nascere; provo stupore, curiosità e uno strano senso di liberazione.
Il tema emergente attraverso cui si articolano i tre diversi sogni riguarda, a un
mio sguardo, l’esperienza del “venir fuori”, tema intriso d’angoscia e di paura.
Prenderò ora di seguito in disamina alcuni stralci di sedute che s’interpongono ai sogni trascritti; a partire dal loro intimo intreccio articolerò le mie riflessioni, testimonianza di un percorso di formazione condiviso con la mia paziente e avviato dal mio stesso “venir fuori”; rivelerò così il modo di essere sotteso alle nostre esistenze nel percorrere insieme un sentiero, impervio a entrambi e per lo più sconosciuto.
L’incontro precedente al racconto delle esperienze oniriche da parte di Maria è contraddistinto da un’atmosfera prevalentemente atonale, piatta, di una
monotonia cromatica; ci sovrasta un cielo grigio, cupo, chiuso, una luce crepu5
scolare che, diffondendosi, illumina le cose di un medesimo colore plumbeo,
tinteggiando un paesaggio che piange come piange il cielo nei pomeriggi d’inverno.
Tale qualità climatica e cromatica, ricorrente durante i primi anni di lavoro
insieme, definisce ancora una volta lo sfondo del colloquio.
Maria mi parla della fatica a venire nel mio studio, del suo avvertire l’insensatezza della sua vita e del mondo, di un malessere non altrimenti specificato se non in un’impotenza che pervade il suo essere. Come altre volte ci ritroviamo impaludati in quelle cromie descritte sopra, scenografia di un prologo
che si ripete sempre uguale, una litania, intercalata dal suo pedante ritornello ripetuto: “sono una merda” .
Diversamente dalle altre volte, tuttavia, Maria arriva puntuale al nostro
appuntamento settimanale e, nonostante non abbia il denaro per pagare, giustificazione spesso addotta per le sue difficoltà a rispettare la cadenza delle sedute,
mi dichiara che qualcosa di nuovo l’ha spinta a venire. Intercetto in questa dichiarazione una certa inquietudine che via via si anima incarnandosi nei suoi
gesti, nei movimenti nervosi delle sue mani, delle sue gambe e nel suo guardare
qua e là per la stanza, come di qualcuno che ha perso qualcosa di importante e
che ora ricerca freneticamente, mosso dalla preoccupazione di non ritrovarlo.
Dice: “Vorrei lasciare il mio ragazzo, vorrei iscrivermi all’università ma penso di non riuscire... ho paura, non so che c’entra ma penso al peccato” .
Solitamente nei momenti difficili in cui la colpa e l’angoscia governano la
sua vita, Maria non esce da casa perché, dice, “resto a letto a vegetare” , frase
utilizzata per descrivere il posto che, in questi momenti, occupa nel mondo. Il
vegetare in Maria non è nel senso del fiorire e del verdeggiare, ma invece metafora del suo restare immobile alle sollecitazioni del mondo prendendo le sembianze, nel suo ritirarsi nel letto per intere giornate, di un degente in un letto
d’ospedale.
Questo suo modo particolare di prendersi cura di sé si impone puntualmente quando Maria si sente spinta, “punzecchiata”, da un qualche “Altro”, e si
struttura come risposta “normale” al patimento che le suscita la possibilità di
aprirsi a un diverso inter-esse verso il mondo. Faccio qui riferimento tanto al
concetto di “normopatia”, intesa come “patimento di assimilazioni uniformanti
e di apprendimenti conformanti” (Napolitani, 2012), quanto alla qualità “estrosa” dell’incontro con l’“estraneo”, così come espressa in “Assimilazione,
apprendimento, alterificazione” (ibidem). Il passaggio dal farsi pagare le sedute
dal padre al trovare in sé, nelle proprie qualità e conoscenze, le risorse da spendere e investire, trovando lavoro come insegnante di doposcuola, è stato uno de5
gli attraversamenti che ha permesso a Maria di occupare un diverso posto rispetto al suo mondo originario, di abitare nuovi spazi lasciando quel letto in cui
era incatenata.
Questo, come altre circostanze in cui si intravedeva la possibilità di un suo
divenire altro rispetto alla proprie abitudini, nel senso dei modi abituali di abitare il mondo, erano spesso carichi di quell’angoscia che la bloccava in casa e che
la portava a disertare i nostri incontri.
Un disertare, spesso senza alcun preavviso, cui co-risponde un mio “prendere parte” che col passare del tempo diviene ai miei occhi sempre più chiaro
nei termini di un sentirmi svalutato, maltrattato, pieno di rabbia e fastidio.
Ascoltando questo mio modo-mondo particolare di sentire emerge via via più
netta una visione: una scena in cui si drammatizza un dialogo fra un superiore
grande e grosso che si rivolge a un piccolo impaurito in modo rimproverante e
rabbioso, richiamandolo al rispetto e all’obbedienza, in altre parole all’ordine.
Provo a condividere questa mia visione-rappresentazione con Maria mettendola
in relazione al suo disertare la sedute.
Maria mi comunicherà di quanto questo nostro scambio la faccia pensare al
rapporto con la propria madre, nei termini di una madre maltrattante che improvvisamente cambia umore passando dalla simpatia nei confronti della figlia
alla rabbia rivendicativa più feroce, che spesso esitava in percosse e maltrattamenti di vario genere. Aggiungerà poi che a questi repentini cambiamenti “climatici” della madre corrispondeva in lei un senso di impotenza e paura che la
portava a nascondersi rifugiandosi nella propria stanza o sotto le coperte.
Con fiducia apre così il suo mondo ai miei occhi allo stesso modo in cui io,
con altrettanta fiducia, le svelo il mio, in una sorta di riconoscimento reciproco.
Il nostro rapporto si accorda su una diversa qualità tonale, si inaugura un’altra
partitura su cui accordiamo i nostri strumenti, più aperta e disponibile a una più
autentica visibilità.
In seguito Maria continuerà a piantarmi in asso disattendendo gli appuntamenti o dimenticandosi di pagare e, nonostante la mia disposizione a esplicitare
il mio sentirmi, ancora una volta, maltrattato e svalutato – io nei panni di quella
Maria in balia degli umori della madre e lei stessa quella madre maltrattante – si
insinuavano in me ulteriore inquietudine e fastidio.
È proprio durante un mio girovagare nervosamente per la stanza, in attesa
di Maria, che i miei vincoli identitari si rivelano risuonando in modo assordante: non sento altra musica che quella da me prodotta, la frustrazione di un bambino che vive la presenza della propria madre come intermittente e assente.
Emerge un ricordo, una scena della mia infanzia in cui, furente con mia ma5
dre, piango facendo a pezzi, a morsi, una spugna da bagno: dall’altra parte della
stanza da bagno lo sguardo freddo e distante di mia madre mi osserva indifferente.
Non ricordo ora la ragione della mia rabbia di allora, cosa fosse accaduto
per sollecitare in me così tanto risentimento, ma è nitido il vissuto di quel bambino che richiama la propria madre immobile, un bimbo che urla e patisce, fatto
a pezzi dallo sguardo indifferente della propria madre.
Se potesse parlare adesso quel bambino, probabilmente, direbbe: “Non riesco a incontrarti e vivo una distanza infinita dove mi disperdo” . È questa scena
che affiora alla mia coscienza sollecitata, punzecchiata, dal mondo di Maria.
Maria mi richiama a prendere posto, ad abitare in un mondo condiviso. Il mio
mondo e il suo, pur nelle ovvie differenze biografiche, si sovrappongono, in
qualche misura, nella dimensione esperienziale, nel senso di un con-sonare.
Dare valore a questa mia visione, renderla accessibile, esplorabile, mi consente di praticarla, di metterla “a servizio di” piuttosto che esserne asservito e
assoggettato. Inizio così a parlare non della rabbia evocatami dalla paziente, ma
del mio desiderio di incontrarla, del mio aspettarla prima dei nostri incontri,
della mia solitudine.
Questa mia dichiarazione d’amore apre nuovi scenari, facendomi vivere
questo disattendere le mie aspettative come un gioco interessante, rivelando soprattutto un noi condiviso che emerge come un tesoro da cui attingere e che, al
contempo, mi permette di aver cura della relazione tra quel bambino e la sua
mamma assente, rivolgendole, ora, il mio sguardo desiderante e innamorato,
come quello che offro a Maria.
Alla fine della seduta Maria mi pone una domanda che ancora una volta mi
spiazza e mi disorienta: mi chiede se sono credente, intendendo conoscere la
mia appartenenza religiosa.
A questa sua domanda, un’altra se ne dischiude dentro di me: quanto posso
rivelare la mia appartenenza? Quanto posso farmi vedere nel mio essere diverso-altro da lei credente? Esito nel rispondere, poi con fermezza rispondo: “No,
non sono credente” .
A questa mia dichiarazione Maria si rattrista, e con un’espressione del volto
delusa e contrita, mi comunica che avrebbe preferito che fossi credente. Ancora
una volta, il mio rispondere alla domanda di Maria mi segnala e informa sulla
mia non-fede, sul mio trasgredire a una famiglia, ora professionale e psicoanalitica, che declina l’appartenenza attraverso l’osservazione di leggi che prescrivono la “neutralità” dell’analista.
Il mio discostarmi dalla tradizione culturale, il mio dichiararmi eretico, se
5
inizialmente, nel tempo del mio esitare a rispondere, mi fa vivere la scomodità,
subito dopo nel mio rivelarmi definisce la mia apertura.
Nello stesso periodo in cui prendono corpo questi incontri, intravedo in un
mio sogno quanto il nostro rapporto andasse risentendo sempre di più di una disponibilità verso l’altro che per entrambi diveniva sempre più praticabile. Nel
sogno mi ritrovo a dormire, di notte, nel mio vecchio studio che, in una sovrapposizione tipica dei sogni, coincide con la mia camera da letto. In piena notte
sono svegliato dal sentire che qualcuno sta aprendo la porta d’ingresso, ho paura, mi ritiro sotto le coperte e penso che sono il solo a possedere le chiavi di accesso allo studio. Suppongo che solo un ladro possa essere l’autore di quel gesto, mi accorgo poco dopo che il mio cane, che fino ad allora riposava al fianco
del mio letto, svegliato anche lui dai rumori sospetti, si avvia verso l’uscio. Mi
sento momentaneamente rassicurato, sollevato dalla paura, certo che il mio cane
avrebbe svolto il suo compito di guardiano. Mi sorprendo però quando il mio
cane, anziché abbaiare, si avvicina scodinzolante e festoso verso il presunto ladro... Mi alzo e fra paura e curiosità mi avvio nel buio verso l’ingresso.
Il sogno mette in luce, a mio parere, il dischiudersi della possibilità di incontrare, allo stesso modo dei sogni di Maria, quegli aspetti trasformativi tenuti
dietro la porta, a distanza, ancora una volta rappresentati come estranei, e per
questo temuti, personificati nel supposto ladro.
Il ladro, per definizione, entra di nascosto dentro le case altrui trasgredendo
alle norme codificate e condivise, per rubare al proprietario qualcosa custodito
nella sua dimora. Questo condensarsi, nel sogno, fra stanza da letto e stanza
d’analisi declina due accezioni possibili di significare e/o modi di vivere quei
luoghi: uno come luogo dell’accoppiamento concepitivo, l’altro del riposo, tutelato dalle mura domestiche e preservato, ulteriormente, da un fedele cane pronto a garantire la “sicurezza” del mio sonno e della mia casa, con i relativi valori,
da possibili incursioni esterne.
Quel cane “fedele” mi sorprende, perché anziché svolgere la funzione per
cui è stato addestrato, tradisce il proprio padrone per accogliere festosamente il
ladro. La mia parte più fedele e addomesticata a rispondere al comando, si rende così libera dal proprio concepimento, aprendosi la strada, fra paura e curiosità, verso le buie stanze, in quello che si annuncia come incontro con l’estraneo.
Napolitani, nell’articolo “Assimilazione, apprendimento, alterificazione”
(2012), coniuga il termine “Altro” con quello di straniero, esplicitandone il rapporto:
Chi è l’altro? Non certo, un’altra persona qualunque, oggetto fra gli oggetti del mondo, pre-
5
cocemente appreso e distinto dal sé, la cui sagoma risulta diversa da quella delle figure già
note. Ma si tratta di quell’altra persona che viene soggettivamente e specificamente connotata come un estraneo-che-ci-riguarda, come quello straniero, unico fra tanti, che, per quanto non ancora noto, promuove in noi un qualche interesse, un’oscura emozione per cui ne
siamo attratti o per cui ne siamo intimoriti, come quell’unico forestiero che vorremmo poter
ospitare nella nostra casa o da cui vorremmo ripararci come da una minaccia che pur non
presenti alcun ragionevole indizio.
L’Altro e l’Identico si rendono protagonisti tanto del mondo della paziente
quanto del mio, attraverso un sognare emergente dai nostri scambi, dal nostro
reciproco risuonare, che facendo breccia in essi ci permette di farne una conoscenza per “compenetrazione”, che ha qualità più intuitiva che analitica.
Riprendendo il riferimento ai modi della conoscenza citati in premessa, vorrei ora qualificarli nei termini in cui ne parla Henri Bergson in Introduction à la
métaphisique (1903), distinguendo due forme di conoscenza del reale: quella superficiale da quella profonda che denomina, rispettivamente, “analitica” e “intuitiva”. La prima procede tendendo a scomporre l’oggetto della conoscenza, sempre di più, in elementi ultimi e costitutivi per studiarne il rapporto interno o elaborare ulteriori oggetti utili a ulteriori conoscenze, mutando i rapporti spaziali tra
gli oggetti materiali precedentemente scomposti quali, a esempio, i concetti.
Per Bergson questa forma di conoscenza si àncora, per così dire, a tre pilastri categoriali, quali lo spazio, per il suo porre elementi l’uno accanto all’altro,
l’intellettualità, per la possibilita-necessità di astrarre e formulare teorie per leggere e codificare il reale, e la materialità, in quanto conoscenza che ha finalità
applicative.
La conoscenza intuitiva, al contrario di quella analitica, tende a unire, assimilare e a far coincidere lo stesso soggetto conoscente con l’oggetto conosciuto,
in altre parole procede per compenetrazione.
Il processo conoscitivo rappresentato dai sogni di Maria, a partire dal coabitare l’identità “malata” della madre ospedalizzata, si avvia verso la dimissione
di Maria-madre morente.
La figura dell’infermiera, cui Maria stessa attribuisce una funzione di mediazione fra sé stessa e la madre, allude simbolicamente a una sorta di istanza
terza che, nel mediare, designa e certifica la possibilità di una separazione-allontanamento, separazione che si annuncia come morte imminente attraverso
l’espressione: “essere agli sgoccioli”.
Anche nel secondo sogno Maria è dentro la casa materna ed è sollecitata a
uscire da notizie che parlano di perdita, del furto della propria automobile (di
recente acquisto) che rappresenta la sua possibilità di allontanarsi da casa, di
5
prenderne le distanze, in qualche misura la sua auto-nomia. Sembra che il permanere nella casa della madre sia vissuta come minaccia all’autonomia in quanto è proprio l’uscire fuori che permette il disvelamento dello scherzo.
Maria scruta attraverso la finestra e intravede fuori un mondo che si annuncia angosciante e raccapricciante, popolato da esseri particolarissimi, uominipianta, parti “vegetali” di sé che prendono forma umana e che entrano in rapporto dialogante con lei indicando la direzione per recuperare la propria “autonomia” situata, nel sogno, fuori dal cancello dell’abitazione.
In questo sogno, rispetto al precedente, acquisisce maggiore rilievo una
zona intermedia fra interno ed esterno abitata da esseri che mediano e che indicano la direzione: nel primo sogno, l’infermiere nel proprio ufficio, nel secondo
l’ambiente del giardino rinvigorito e animato dagli uomini-pianta.
Queste aree intermediarie che emergono e si rappresentano, mi fanno pensare a una zona intermedia dell’esistenza, che declinata su un piano temporale
potrebbe essere ascritta al “qui e ora” dell’esperienza, in cui gli incontri, con il
loro domandarci, porre questioni, fanno da diaframma fra passato-noto e divenire-ignoto, fra tradizione ed esperienza, intendendo per esperienza la possibilità di comprendere l’ignoto, rappresentato come fuori: il fuori dall’ospedale, il
fuori dal cancello della propria casa.
Lo “spazio-tra”, cosi come rappresentato nei sogni, diviene area di incontro
dialogante, allo stesso tempo foriero d’angoscia e di profezie (la morte annunciata, la direzione per raggiungere la propria auto-nomia), un’esperienza, fuori dal
noto, che si protende verso il divenire, un luogo delle azioni possibili. Questa “dimensione”, altra e fuori, resta come presagio, come luogo da esplorare, come
possibilità di esercitare il proprio potere.
Nel terzo sogno l’incontro avviene in una palazzina cinese, cultura altra per
eccellenza, molto colorata, che mi rievoca tanto il mio studio professionale
quanto la mia dichiarazione di non essere credente, palazzina da cui Maria viene sospinta fuori dal fratello del fidanzato, connotato come il suo opposto sia
per il rapporto di ascolto reciproco che li lega sia per il suo dichiararsi ateo.
Anche in questo sogno il contatto con chi ci spinge verso fuori, con la parte
di noi protesa al divenire, con la nostra e-sistenza, è un contatto angosciante che
esita, tuttavia, in un’esperienza di libertà che inevitabilmente “alterifica”.
Napolitani, in uno scritto del 1995 intitolato “Si è per esser-ci”, individua
già in quella “eventualizzazione” del mondo di esclusiva pertinenza umana, il
modo attraverso cui, nel rapportarsi al suo ambiente, si manifesta la predisposizione progettuale dell’individuo:
5
Se l’autos esaurisse una volta per tutte la sua organizzazione del rapporto tra il suo essere
individuale e il suo ambiente attraverso un iniziale processo a termine di ambientalizzazione, l’individuo resterebbe il medesimo (l’idem), il costantemente identico all’intreccio tra
memorie filo- e onto-genetiche sviluppatosi fino al termine di tale processo. Il se stesso
(l’ipse) consisterebbe allora soltanto nel continuo adattamento strategico alle circostanze
ambientali esterne che l’autos opererebbe sull’idem. Ma a differenza delle rimemorazioni
filogenetiche, quelle ontogenetiche si accrescono indefinitamente pur mantenendo quelle
più primitive un carattere di fissità, di stabilità, e una funzione informazionale su tutti i successivi processi auto-ri-organizzatori. Ogni esperienza vissuta è tale in quanto l’evento viene inserito in un processo auto-poietico (l’autoriorganizzazione) da cui l’idem resta coinvolto e quindi, per estensione variabile, modificato. Gli eventi non sono solo accadimenti
che emergono dalla opacità dell’ambiente esterno, ma sono anche quelli che emergono dall’opacità dell’ambiente interno. Direi di più: gli accadimenti esterni diventano eventi solo
nella misura in cui toccano/sono toccati dall’ambiente interno. Questa eventualizzazione
del mondo è di esclusiva pertinenza umana, è il modo nel quale si manifesta l’autos inscindibilmente connesso alla sua memoria ontogenetica, quindi storicamente, culturalmente segnato. L’idem è dunque la materia mediante la quale l’autos produce l’evento (la trasformazione di un “fatto” in “evento” è manifestazione della predisposizione progettuale, dell’autos)
e trasforma l’ambiente, sia quello esterno che quello interno, il suo proprio idem.
Nei tre sogni l’identità-madre o l’idem, che si distingue, per lo più, attraverso le immagini riferite al dentro (ospedale, casa, palazzina cinese) viene trasformata da contatti che hanno luogo in quell’area d’incontro intermedia o eventuale, da me descritta precedentemente. A tal proposito è esemplificativo il secondo sogno: l’ambiente identitario materno, equivalente alla casa circondata da
vegetazione in cui Maria è rinchiusa, descrive un modo di essere connotato dal
“vegetare”. Quel “vegetare” materno che si modifica trasfigurandosi nell’immagine chimerica, sorprendente e ripugnante al tempo stesso, degli uomini dal volto vegetale, commistione fra l’identico che vegeta e un nuovo-umano modo di
essere che, contattato, indica una direzione.
Quest’esperienza, narrata e drammatizzata attraverso i sogni, non è a mio
avviso ascrivibile, tout court, a un percorso verso l’autonomia in cui un terapeuta “spinge”, esorta o conduce la propria paziente, ma è un percorso con-diviso in cui si intrecciano, certamente, la storia e l’esperienza di due mondi, quello
del cosiddetto “terapeuta” e quello del cosiddetto “paziente”, che convengono a
un incontro trasformativo, se aperti a quel coltivare esperienza di libertà che
consiste nel loro spogliarsi reciproco, nel loro prendere le distanze da abiti-abitazioni rassicuranti. Per riprendere la metafora dei danzatori, la libertà risiede
nel loro fare della perdita d’equilibrio, condivisa e momentanea, un affidarsi
“ingenuo” all’altro affinché la danza si compia nel suo dispiegarsi.
Nella storia di Maria il nascere, il venir fuori assume una sua specifica rilevanza. La madre contrae l’epatite per una trasfusione successiva al parto e alla
5
nascita di Maria. Nell’esistenza della madre l’epatite diventa così l’ombelico attorno al quale si avvitano e si polarizzano tutte le disgrazie, da quel momento in
poi, patite: il mondo non può che essere ingiusto, un mondo “di merda” in cui
non si può che vegetare. Un mondo a cui attribuire la colpa di ogni sofferenza e
su cui scaricare tutta la propria rabbia.
Tra le disgrazie, una relazione col marito che la inchioda a un’esistenza votata alla dipendenza, sia sul piano economico sia sul piano affettivo – per quanto possibile distinguerli – punteggiata da un reciproco controllo in cui l’ammaestramento dell’altro si declina attraverso varie forme di violenza e maltrattamento.
La madre affogherà il suo sentirsi dis-graziata, la sua esistenza percepita
come fallimentare, nell’etilismo che esiterà, negli anni, in cirrosi epatica fino a
ratificare la propria morte.
Maria è, per parti più o meno estese, quel mondo materno votato al “vegetare” dal quale non riesce a distinguersi e di cui si fa interprete, un mondo in cui
l’esistenza stessa, nella sua accezione pro-gettuale, è intrisa di colpa e angoscia
di morte e le relazioni sono vincoli incastranti dove il gioco relazionale decade
in un giogo insopportabile intriso di violenza, in cui l’altro è il colpevole della
mia sorte, del mio destino.
Napolitani nel suo articolo “Fenomenologia del dolore” (2007) sostiene:
Il fare conoscenza materno del proprio figlio (non solo nel senso di conoscerlo, ma anche
nel senso di produrre conoscenza) ha il potere fattuale di una profezia: nelle tradizioni religiose il profeta è colui che annuncia un disegno divino nei termini del destino o del fato a
cui restano consegnati un singolo uomo o intere collettività. Nella prospettiva di un’antropologia fenomenologica la madre “soffia” nel suo bambino la propria anima gonfia delle
esperienze vissute con la sua propria ascendenza, attraverso gli specifici modi comunicazionali che adotterà con lui, e, come un disegno divino, essa graverà sull’intera esistenza
del figlio. Questo il suo “destino”, il suo mito radicale, che sarà l’indispensabile culla in cui
si annida e si nutre ogni suo possibile pensiero sorgivo o in cui questo potrà restare soffocato
appiattendosi nel dominio discorsivo del proprio mito.
L’incontro seguente a quello in cui condividiamo un’interpretazione sul
senso dei sogni di Maria, assume tutto un altro sapore rispetto al solito. La paziente, diversamente dalle altre volte, riferisce di sentirsi meglio, più leggera,
mi racconta di avere avuto, usando le sue stesse parole, una consapevolezza.
Racconta un episodio, accaduto durante una cena con gli amici con cui condivide la casa ereditata alla morte della madre, in cui un commensale le dichiara
quanto fosse fortunata rispetto agli altri potendo lavorare in casa con i ragazzi
cui dà lezioni private, evitando così il disagio di allontanarsene.
5
Questa dichiarazione si presenta a Maria come una rivelazione di quanto
avesse sprecato la propria vita chiudendosi in casa e relegando i propri valori,
amici e lavoro, nel chiuso della propria abitazione. Mi comunica quanto l’apparentemente innocua osservazione dell’amico le abbia evocato, istantaneamente,
un’immagine di sé rinchiusa e costretta in una camicia di forza; aggiungendo,
ancora, quanto questa consapevolezza emersa, per un verso l’avesse rattristata
ma per l’altro l’avesse fatta sentire vivificata: “ho sentito l’adrenalina che si diffondeva per tutto il mio corpo” .
Maria descrive questa sensazione come misto di paura e voglia di fare, una
sensazione per certi versi provata da me nel sogno nell’avviarmi verso l’ipotetico ladro e nuovamente ricontatta in quello stesso istante in cui Maria ne faceva
menzione.
Dopo una breve pausa, Maria dichiara con un tono vibrante ed esclamativo,
come di chi annuncia al mondo l’avvento di qualcosa di nuovo: “Mi sento
viva!”. A questa sua dichiarazione, all’unisono, ci commuoviamo. Un momento
di conoscenza intuitivo in cui si condensa la storia e l’esperienza di entrambi in
un ri-conoscersi, non solamente nell’accezione di un reciproco ritrovarsi ma anche nel fare nuova conoscenza di sé attraverso l’Altro.
La nuova conoscenza ha la qualità del venire alla luce, che per Maria apre a
essere altro da quel “mondo di merda” materno a cui il proprio destino è stato
consegnato; da parte mia, il ri-conoscere attraverso uno sguardo amorevole quel
bambino che soffre l’assenza, mi affranca a mia volta da un vincolo identitario
che si costituisce come assenza dell’altro.
Napolitani nel suo articolo “Ospiti: il reciproco farsi dell’altro” (2008), definisce lo spazio psicoterapeutico come:
spazio che specificamente favorisce un flettersi sulle proprie flessioni, una pratica ri-flessiva.
E questa non consiste soltanto in una ricerca ed eventuale ritrovamento di cause razionalmente categorizzate, ma nel favorire l’emergenza di un “ospite” interno/esterno fin li sconosciuto
o emarginato come un intruso minaccioso.
O, in altre parole, lasciare che emerga, nell’immediatezza e nell’ istantaneità imprevista di un incontro, l’intima esperienza dell’Altro che mi fa altro, mi
“alterifica” in una rinascita. Quest’esperienza consonante, questo vibrare d’anime all’unisono, si presenta come promessa di un “impensabile nuovo” che si fa,
nel suo darsi, nutrimento reciproco, cibo che fa mondo.
Quest’esperienza trasformativa, deformante, trova luogo in quell’occasione
di cui parla Vladimir Jankélévitch (2012) in un suo recente testo:
5
L’occasione non è solo un favore imprevisto di cui si deve saper approfittare e che esige
anime perfettamente disponibili per la grazia occasionale dell’imprevisto: è al contempo
qualcosa di cui la nostra libertà va alla ricerca e che, quando occorre, suscita. Tutto può diventare occasione per una coscienza inquieta, capace di alimentare il caso. È l’occasione a
elettrizzare il genio creatore – poiché l’occasione è l’elettrochoc dell’ispirazione; ma è per
il genio creatore che l’incontro, anziché limitarsi a una circostanza muta, diventa un’occasione ricca di senso.
Come raffigurare quella coscienza in stato di grazia che si dispone all’occasione di cui parla Jankélévitch?
Ulteriori considerazioni si potrebbero azzardare, facendo dello sfondo indistinto delle riflessioni finora fatte la figura su cui volgere il nostro interesse, mettendo tra parentesi, per quanto possibile, la nostra tendenza a de-finire.
Nel nostro procedere conoscitivo possiamo ipotizzare allora un momento
precedente all’oggettivazione della conoscenza che definisce il proprio e l’assunto, come un momento pre-analitico, intuitivo che corrisponde all’essere coscienti
nell’accezione d’essere ascoltanti e aperti a un flusso sussurrante, a una corrente
che ci attraversa e porta altrove. Un momento conoscitivo che si approssima a
quell’esperienza che si dà all’origine nello sviluppo dell’essere umano di cui tratta Napolitani (2012) e che consiste nel suo
essere aperto al movimento dell’altro verso di lui, movimento che consiste nella trans-fusione da parte di una presenza materna di tutti i propri “umori” nel corpicino inerte del neonato. Non solo latte, che fa del neonato un mammifero in crescita, ma anche “umori dell’anima”, le intenzionalità, che fanno del neonato una coscienza in fieri.
Una coscienza che diviene conoscenza nel rendere noto da uno sfondo indistinto, ovvero, da un mondo con-diviso, una certa distinzione che, assunta come
appartenente al proprio “dominio conoscitivo”, diviene al tempo stesso riferimento per altri “slanci conoscitivi”.
Emerge, in questo senso, una raffigurazione della conoscenza che procede
per consonanze e approssimazioni, avvalendosi di qualità come la transitorietà e
l’impermanenza, la fugacità e l’incompiutezza in un continuo scorrere e divenire. Una conoscenza che rivela, nel tempo stesso in cui diviene, le qualità di
quella coscienza che intenzionando il mondo, in cui si trova già-da-sempre, lo
impregna, divenendo così riconoscibile.
Nel tentativo di illuminare l’intimo rapporto che ci coniuga al mondo potrebbe allora orientarci una metafora, quella della medusa, che nel suo lasciarsi
condurre dalle correnti compie una danza leggera in quel mondo con-diviso che
è il mare, e che diviene in un continuo movimento incorporante, acqua ricca di
6
memoria di infiniti altri transiti, scandendo in sospensione, attraverso il suo ciclico gonfiarsi e stendersi, il fluire del tempo.
Un tempo che non possiamo mai cogliere e definire se non attraverso l’ambigua esperienza che continuamente, al di là di ogni nostra volontà, ne facciamo: quella della durata (Bergson, 1903) e dell’irreversibilità, che fanno di ogni
evento, di ogni emersione, come ricorda lo stesso Jankélévitch (2012), “una prima-ultima volta”, in quanto la prima esperienza è anche l’ultima che possiamo
farne. Questa disposizione a incontrare altri transiti, di cui possiamo farci momentanei interpreti con la nostra arte, si rivela come una qualità della coscienza.
Possiamo nondimeno intuire diversi mondi coscienziali che si declinano
nelle diverse qualità tonali di concedersi al tempo. È nell’ambiguità dell’incontro che si apre la possibilità di transitare da un’immobilità percepita, a un fluire,
a un disperdersi. Da una costrizione a riprodurre fedelmente “con occhio attento
allo spartito” quel brano musicale incarnato che non accetta nessuna reinterpretazione che abbia un sapore diverso dall’originale, a un’esperienza di tempo che
ci si offre come partitura incompiuta su cui possiamo improvvisare, intrattenendoci, diventandone interpreti più o meno originali.
E viceversa dall’immagine della medusa di cui prima mi sono avvalso può
emergere quella rappresentazione mitica di Medusa, donna che pietrifica con lo
sguardo, trasformando in immobili statue chi incontra sul proprio sentiero, arrestandone improvvisamente il procedere.
Le due meduse, quella marina, che fa del suo comprendere-incorporante il
mare il suo incessante movimento e il suo nutrimento, e la Medusa del mito,
pietrificante all’incontro con l’altro, polarizzano, a mio avviso, due essenziali
modi di stare nell’incontro. Fra medusa e Medusa, risuoniamo, in mobili intrecci temporali.
BIBLIOGRAFIA
Bergson H., (1903), Introduction à la métaphisique, trad.it. Introduzione alla metafisica, Laterza, Bari
1970.
Binswanger L., (1946), “L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria”, in Il caso di Ellen West e altri saggi,
Bompiani, Milano 1973.
Calvino I., Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972.
Heidegger M., (1927), Sein und Zeit, trad. it. Essere e Tempo, Longanesi, Milano 1976.
Jankélévitch V., Berlowitz B., Da qualche parte nell’incompiuto, Einaudi, Torino 2012.
Napolitani D., “Fenomenologia del dolore”, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi n. 3/2007 vol XXI.
–
“Ospiti: il reciproco farsi dell’Altro”, Atti del Convegno Oltre la soglia. Sguardi a confronto sui
modi della relazione, Ischia 2008.
6
–
–
–
“Assimilazione, apprendimento, alterificazione”. Atti del Convegno Confronto tra alienazione e
psicopatologia (con Federico Leoni), Milano 2012.
“Identità, alterità, culture”, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi n. 2/2008, vol XXII.
Napolitani D., “Si è per esser-ci. Riflessioni epistemologiche sul soggetto collettivo, con particolare riguardo all’opera di E. Morin”, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi 1/1995, vol x.
Daniele Terranova
Via Vincenzo Barbera, 25
90144 Palermo
[email protected]
6