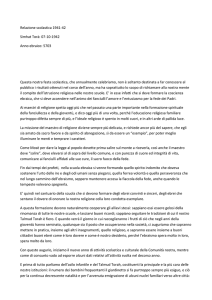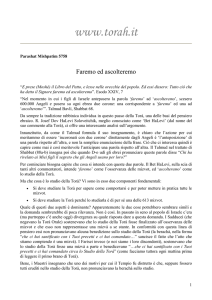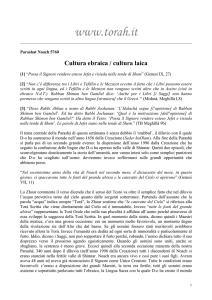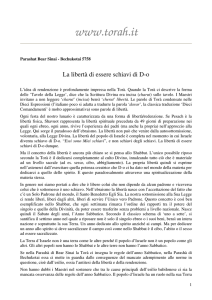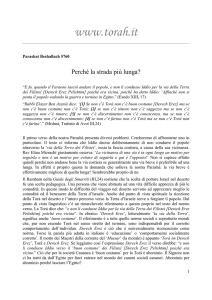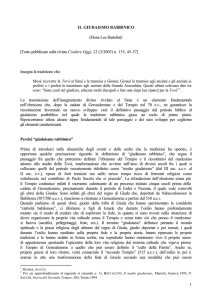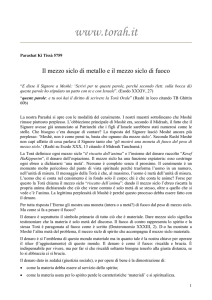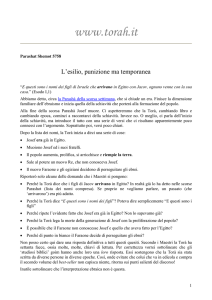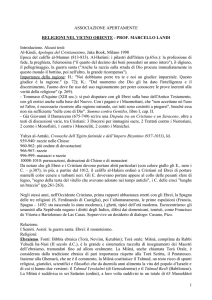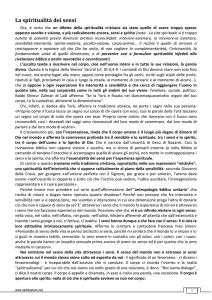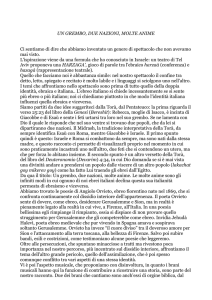1
“Chi si occupa della Torà è chiamato amico ed è amato….la Torà diventa come una fonte
inesauribile e come un fiume che scorre sempre ricco di acqua” (Pirqê Avot 6,1)
Alcune libere riflessioni in merito a Pirqê Avot
Ci sono almeno due motivi che inducono a leggere e riflettere su questo passo del trattato Pirqê
Avot (= Capitolo dei Padri, Massime o Detti dei Padri):
1) Il primo è all’interno del complesso problema del dialogo ebraico cristiano, dialogo che ha la sua
origine nel fatto che noi cristiani abbiamo assunto la Bibbia degli Ebrei come parte integrante della
nostra Bibbia (AT) e principalmente nel fatto che quando, secondo la nostra fede, Dio entra nella
storia umana, sceglie come strumento per la sua azione salvifica il popolo ebraico. Gesù era ebreo e
pienamente uomo del suo tempo e dell'ambiente ebraico palestinese del I sec.; Gesù condivise con
la maggioranza degli ebrei palestinesi di quel tempo alcune dottrine farisaiche, come la risurrezione
dei corpi, e certe forme di pietà, come l'elemosina, la preghiera e il digiuno; Gesù ha adoperato
metodi di lettura e di interpretazione della Scrittura, metodi di insegnamento che erano in uso presso
i farisei. Come gli ebrei, Gesù diede il primato al comandamento di Dio e del prossimo.
Una dichiarazione del 1980 dei Vescovi cattolici della Repubblica Federale Tedesca sul rapporto
della Chiesa con l’ebraismo afferma: “ Chi incontra Gesù incontra l’ebraismo”. Ma da 1980 in poi
altri documenti sono usciti e altre dichiarazioni: cito fra tutti il documento della Pontificia
Commissione Biblica: “Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana” del 2001, il
quale dichiara: “Gli scritti del Nuovo Testamento sono solidamente radicati nella lunga esperienza
religiosa del popolo di Israele”.
Pinchas Lapide in uno dei suoi libri sulla figura di Gesù, pubblicato sotto il titolo “Predicava
nelle loro sinagoghe”, osserva che: “Chi dal Nuovo Testamento tagliasse con una forbice tutti i 452
passi e citazioni dell’Antico Testamento si ritroverebbe in mano un troncone di testo frammentario,
in cui nessun decifratore saprebbe leggere un racconto seguìto. Tanto giudaico è il terreno da cui
nascono i quattro vangeli, tanto ebraica è la struttura portante” (p. 18).
Anche solo da questi rapidi esempi sembra evidente, dunque,come la comprensione del pensiero
ebraico possa aiutarci alla comprensione del Gesù dei cristiani, alla comprensione del linguaggio
dei Vangeli. In questo senso Pirqê Avot offre un particolare utile contributo, in quanto alcune delle
massime dei padri in esso contenute offrono interessanti paralleli con alcuni detti di Gesù nei
Vangeli e ci aiutano a comprenderli nel loro genuino significato.
2) Il secondo è nel fatto che Pirqê Avot, un trattato della Mishnah, la cosiddetta Torà orale
presenta un particolare interesse in riferimento al problema del valore educativo della scuola e
dell’insegnamento. Alcune delle massime si riferiscono infatti in modo esplicito al rapporto tra
alunno e discepolo, al significato e al valore dello studio.
Tuttavia, prima di svolgere questo tema, è necessario riflettere almeno brevemente sul concetto di
Torà.
a) Che cosa è la Torà
2
Per gli ebrei il termine Torà ha significato ampio. Etimologicamente, la sua radice richiama il
verbo “sparare, colpire il bersaglio” ad indicare una istruzione pratica. In senso particolare il
termine può essere usato per un determinato complesso di leggi: le dieci parole date a Mosè sul
Sinai, i primi cinque libri della Bibbia che erano considerati anche i più autorevoli, ma in seguito
esso si è esteso ad indicare anche tutti i libri della Bibbia.
Per gli ebrei la Torà è un dono: mattàn Torà. Essa gode nell' ebraismo autorità indiscussa: la sua
santità e dignità sono incomparabili. Per i rabbini essa è considerata preesistente, era già presso Dio
prima della creazione. Essa fu donata da Dio a Mosè ed è quindi di origine celeste. Dice la fede
giudaica: Torà min hashamain, la Torà viene dal cielo.
Tuttavia per gli ebrei è altrettanto importante, accanto a questa Torà scritta, la cosiddetta Torà
orale, cioè, secondo una definizione generica, la lettura e la interpretazione ebraica della Scrittura. .
Anch’essa è stata rivelata a Mosè sul Sinai, accanto alla Torà scritta.
Ma in che modo è giunta fino a noi questa Torà orale?
Il problema va ricondotto a quello più generale di come avveniva la trasmissione del sapere
presso il popolo ebraico.
Non sappiamo con chiarezza dai testi biblici se ci fossero prima della distruzione del Tempio nel
70 d.C. delle scuole pubbliche. Nel Talmud, l’altro testo normativo del giudaismo, la cui
composizione si chiuse nel V sec. d.C., troviamo due tradizioni: una che parla di scuole pubbliche,
l’altra che parla di insegnamento che si tramanda di padre in figlio. Di quest’ultima abbiamo chiara
conferma dai testi della Bibbia, nella forma della kinderfrage, la domanda che i figli rivolgono ai
genitori (vedi ad es. la catechesi sulla pasqua di Es 12,24-27 ) ed anche da testi non biblici (vedi l’
haggadà di Pesach, cioè il testo nel quale viene riportato il seder pasquale, cioè l’ordine delle
cerimonie pasquali). Tuttavia, dice il Talmud, in mancanza del padre, i figli devono essere portati in
una scuola. Dalle testimonianze che possediamo, si può dedurre che nel I sec. esistessero scuole in
tutte le città ed anche nei più piccoli insediamenti. Secondo Safrai Stern, uno studioso del problema,
esistevano vari modi e luoghi nei quali si praticava l’insegnamento e lo studio della Torà per gli
adulti. Essi erano: 1) Il bet midrash, termine già presente in Sir 51,23, dove però sembra riferirsi
piuttosto alla letteratura sapienziale che allo studio tradizionale della Torà e dei Profeti, ma che
durante il periodo del Secondo Tempio era la scuola degli scribi e divenne la più comune istituzione
dello studio nel paese di Israele e nella diaspora e dove si trasmetteva la Torà scritta e orale; 2) La
sinagoga, dove un pubblico più ampio era istruito durante una liturgia; 3) Altri momenti di incontri
per varie occasioni nei quali trovavano posto anche lo studio e l’istruzione.
Pirqê Avot ci mostra un particolare modo di trasmissione del sapere sia nella forma che nel
contenuto. Questa modalità di insegnamento offre paralleli interessanti, problema che però non
svolgo in questa sede, con il modo con il quale Gesù insegnava ai discepoli.
La catena della tradizione
Secondo Pirqê Avot, la Torà orale ci è stata tramandata oralmente attraverso quella che è
chiamata la "catena della tradizione": da Dio a Mosè, da Mosè a Giosuè, da Giosuè agli anziani e
infine agli uomini della Grande assemblea (Pirqê Avot 1,1). E’ quanto dice il primo versetto del
trattato Avot, inserito nella Misnah, dove le interpretazioni orali dei rabbini, un un periodo variabile
tra il III sec. a.C. e il II sec. d.C. vennero messe per iscritto. I Pirqê Avot hanno lo scopo di tracciare
3
la storia della tradizione rabbinica: i detti dei Padri, da Shim’on il Giusto, identificato da alcuni
come il sommo sacerdote Simone di cui si fa l’elogio al cap. 50 del libro del Siracide fino a Rabbi
Jehudà ha Nasì, detto il Principe, che sembra abbia portato a termine l’opera.
Questo insieme di detti si presenta come una raccolta sapienziale e si inserisce dunque in una
tradizione biblica, particolarmente a quella che si rifa al libro dei Proverbi. E’ stata infatti definita
da alcuni studiosi come “una specie di libro dei Proverbi talmudico”. Tuttavia essa mostra alcune
importanti innovazioni sia nella forma che nel contenuto.
Mi riferisco innanzi tutto alle prime:
1) Mentre la sapienza tradizionale è generalmente anonima, cioè vengono riportati vari detti
ma non vengono attribuiti a un nome, i detti dei Pirqê Avot hanno tutti un Padre. Questa
sottolineatura del carattere personale del detto evidenzia l’importanza dell’autore, del
Maestro.
2) Inoltre ogni maestro, secondo Pirqé Avot, ha detto “tre cose” o “tre parole”. I detti dei
maestri hanno carattere ternario, mentre si dice solitamente che la sapienza biblica ha
carattere “binario” cioè si regge sulla legge del parallelismo , che può essere antitetico, cioè
di contrasto, come ad es. in Pr 24,16: “Es. Sette volte cade il giusto ma si alza/mentre gli
empi inciampano nel male”, oppure sintetico, cioè che ribadisce due volte lo stesso concetto,
come ad es. in Pr 24,27: “Se il tuo nemico cade non gioire/ e se inciampa, non si allieti il
tuo cuore”. Non è chiaro a che cosa sia dovuto questo cambiamento, ma pare intenzionale.
Alcuni altri testi della tradizione rabbinica possono forse aiutarci a capire questa volontà di
“triplicare l’insegnamento della Torà”.
Dice un testo midrashico:
“Tutto è trino (o triplice). La Torà è trina: Torà, Profeti e Scrittura. La preghiera è trina:
sera, mattina e pomeriggio: La santificazione è trina: “Santo, Santo, Santo” (Is 6,3). Israele
è trino: sacerdoti, leviti e Israeliti. Mosè il cui nome ha tre lettere (mem – shin –he)…è
discendente da tre (padri): Abramo, Isacco e Giacobbe”.
La Torà al centro dell’insegnamento rabbinico
Non mi voglio dilungare su questo problema, che evidentemente richiama al valore simbolico che il
numero tre, e più in generale i numeri, hanno nel pensiero ebraico, ma mi soffermo su uno degli
insegnamenti triplici di Pirqê Avot.
Simeone il Giusto soleva dire: «Su tre cose si regge il mondo: sulla Torà, sul culto e sulle opere di
benevolenza» (Av 1,2)
Il passo ha un parallelo con un passo di 2 Cr 31,21, dove leggiamo: “Tutto ciò che egli
intraprese per il culto nella casa di Dio, per la Torà e per il precetto, lo fece per cercare il suo Dio
con tutto il suo cuore, e ci riuscì”.
Tuttavia nel parallelismo notiamo alcune differenze che sembrano indicare una trasformazione o
una evoluzione del pensiero ebraico rabbinico, quale è, come abbiamo detto, quello alla base di
Pirqê Avot. Nel detto di Simeone, che pure forse doveva essere sommo sacerdote, al primo posto
non viene il culto nella casa di Dio, cioè il servizio del santuario, ma la Torà. Inoltre al posto del
4
precetto (mitzvà) troviamo un’espressione più ampia (ghemilut chasadim) che inizialmente doveva
avere un significato più legato alla preghiera personale e alla devozione privata (distinta dal culto
del tempio) ma nel testo diventa l’esercizio di opere di misericordia. Anche il culto subisce una
trasformazione diventando la preghiera pubblica (avodà). Ma è soprattutto sulla espressione Torà
che viene ad operarsi la rifondazione del giudaismo rabbinico dopo il 70, come possiamo vedere da
una lettura più attenta dei detti di Pirqé Avot.
Si dice nella prima terna:
Radunate molti discepoli” (1,1)
Lo studio della Torà non era dunque riservato a specialisti. Tuttavia su questo punto esistevano
due scuole di pensiero in contraddizione tra loro, i cui maestri erano i rabbini più rappresentativi al
tempo di Gesù: Hillel e Shammaj. Ora la scuola di Shammaj diceva: “ Si deve insegnare solo a chi è
molto dotato, docile, di stirpe illustre e ricco”. La scuola di Hillel diceva invece: “Si deve
insegnare ad ogni uomo, poiché ci sono stati molti peccatori in Israele che furono spinti allo studio
della Torà e da loro sono discesi molti uomini giusti, pii e personaggi illustri del popolo”.
“Procurati un maestro”(1,6)
Ogni ebreo maschio deve cercarsi un maestro fisso che gli insegni gli Scritti Sacri, perché
studiare la Torà può essere perfino più importante del comandamento di onorare i genitori, superare
le opere di carità e l'obbligo di ristabilire la pace. Studiare la Torà è servire Dio. E’ tanto grande la
considerazione in cui sono tenuti i maestri che, ai loro discepoli, si raccomanda di riverirli più del
padre.
Dice un testo rabbinico: “Nello studio della Torà, se un figlio ha acquistato molta sapienza
sedendo davanti al maestro, il maestro viene prima del padre perché ambedue, padre e figlio, sono
tenuti ad onorare il maestro. Il padre infatti lo ha solo messo al mondo, mentre il maestro,
insegnandogli la sapienza, lo introduce nella vita del mondo a venire”.
Il motivo fondamentale nella ricerca dei discepoli è dunque nella necessità di continuare una
tradizione, la quale tuttavia continuamente si rinnova e si amplia, attraverso le interpretazioni che si
susseguono, a partire da Mosè, il quale “ricevette e trasmise”. Un aspetto caratteristico
dell’insegnamento è proprio nella varietà e compresenza delle interpretazioni. La scuola non è vista
come una istituzione statica, ma come luogo di ricerca e di scambio di idee. Essa è basata
sull’ascolto e sulle frequenti ripetizioni, almeno quattro volte, si dice, finchè il discepolo possa
comprendere e ritenere la materia; ma di un certo Rabbi Perida viene detto in modo iperbolico che
per un discepolo particolarmente debole abbia ripetuto ogni insegnamento quattrocento volte e in
una data occasione perfino ottocento volte.
Numerosi altri detti parlano del rapporto che ci deve essere tra alunno e insegnante nella loro
ironica saggezza. Propongo una delle tante definizioni rabbiniche che riguardano i discepoli:
“Ci sono quattro specie di discepoli dei sapienti: spugna, imbuto, filtro, setaccio. Spugna, perché
ritiene ogni cosa; imbuto perché ciò che entra da una parte esce dall'altra; filtro, perché lascia
passare il vino e ritiene la feccia; setaccio, perché lascia passare la crusca e ritiene il fior di
farina”.
5
Ma ci sono anche altri testi, i quali enumerano le qualità del maestro: Non deve essere
impaziente e deve conoscere i propri limiti. Gli viene quindi anche consigliato: “Insegna alla tua
lingua a dire Non lo so”. Non deve essere troppo severo. Dice un saggio: “Se si vede un discepolo
al quale lo studio è diventato pesante come il ferro, questo accade perché il suo maestro non gli
rivolge uno sguardo gentile”.
D’altra parte il discepolo non deve essere timido, poiché chi si vergogna di porre domande non
fa mai progressi. Tramite il suo domandare e il suo rispondere alle domande del maestro, il
discepolo non solo entra più profondamente nella materia ma è perfino in grado di rendere sapiente
il suo maestro. E uno dei saggi ammette di aver appreso molta Torà dai suoi maestri, ancor di più
dai suoi colleghi, ma soprattutto dai suoi discepoli.
Grande è il rispetto che viene richiesto non solo al discepolo verso il maestro, ma anche al
maestro verso il discepolo. Un testo rabbinico dice: l'onore del tuo discepolo ti sia caro quanto il
tuo, nel senso che il maestro deve impegnarsi per la formazione dell'alunno ma anche, ad esempio,
visitare i discepoli ammalati e considerarli come i propri figli.
Dio compagno del maestro e del discepolo
Ma, e questo è l'aspetto più importante dell'insegnamento: il maestro deve cercare i suoi
discepoli solo per amore della Torà. Amare la Torà vuol dire amare Dio, che diventa allora il terzo
compagno nel rapporto maestro-discepolo. Attraverso lo studio dunque maestro e discepolo
diventano compagni ed amici di Dio.
Dice ancora Pirqê Avot:
“Quando gli studiosi sono insieme e studiano, Dio va dall'uno e dall'altro e li benedice. Quando
dieci sono insieme e si occupano della Torà, Dio risiede in mezzo a loro, così quando sono solo
cinque, ma anche solo tre o soltanto due; anche chi studia da solo riceve un premio da Dio.
Quando tre siedono a tavola e parlano della Torà, allora la tavola diviene l'altare ed essi, in un
certo senso, mangiano alla tavola di Dio” (3.2.3.6).
La sapienza è studio della Torà
Più volte i maestri dicono: “Lo studio della Torà viene prima di tutto”. E da questo consegue che,
secondo la tradizione ebraica, secondo la tradizione rabbinica, studiare è un precetto, un obbligo.
Non è una facoltà di cui ci si può avvalere o meno. Non è opzionale. Ogni uomo ha l’obbligo di
studiare e si capisce il perché: lo studio è lo strumento fondamentale per la relazione con Dio. Non è
solamente uno strumento per la relazione con se stessi, per la propria formazione intellettuale, ma lo
strumento per la relazione con Dio.
Questo particolare valore della Torà lo si può dedurre anche dalla storia del trattato Pirqê Avot, in
riferimento a due elementi:
1) A partire dalla metà del VII sec. si stabilisce l’usanza di leggere e studiare il trattato,
inserito, come già detto in precedenza nella Mishnah, per conto suo, come parte della
liturgia sabbatica.
2) Sempre nella stesso periodo viene aggiunto al trattato, un intero capitolo, il VI, totalmente
dedicato alla Torà e alla sua acquisizione, per la quale si enumerano ben 48 condizioni.
3) Il nome del trattato cambia da Avot in Pirqê Avot (=Detti dei Padri).
6
L’introduzione del trattato nella liturgia sabbatica non vuol certamente dire che esso si sostituiva
alla preghiera, né tanto meno alle opere di misericordia, ma significa che esso stesso diviene culto
(avodà).
Torà per sé stessa ? (li-shemah)
Questo concetto viene ulteriormente approfondito in un detto attribuito ad un altro dei padri del
giudaismo, Antigono di Sokko:
“Non siate come quei servi che servono il maestro per ricevere un premio, ma siate di quei servi
che servono il maestro non per ricevere un premio; e il timore del cielo sia su di voi”.
Il problema sottostante a questo detto è quello del rapporto tra lavoro e servizio: si lavora cioè
per ottenere un guadagno o il lavoro è un servizio che di per sé stesso costituisce un premio?. Su
questo interrogativo c’è varietà di pareri nel pensiero rabbinico ma io qui vi riporto la particolare
risposta di un certo Rabbi Jonà, il quale sostiene: “Un uomo deve servire il Signore a condizione di
non ricevere un salario, ma per la misericordia che gli ha usato centomila volte tanto, e per la
grandezza del padrone, che è degno di ciò”. A conferma della sua risposta, Rabbi Jona cita la
preghiera, lo Shema’ recitato quotidianamente dagli ebrei credenti: “Amerai il Signore con tutto il
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze” (Dt 6,5).
Nel giudaismo rabbinico, questo insegnamento viene trasferito alla stessa Torà, il cui studio,
essendo parte del servizio di Dio, deve essere ugualmente disinteressato. Nasce così
quell’espressione che in Pirqê Avot 6,1 viene attribuita a Rabbi Meir: “la Torà per il suo nome
(Torà li-shemah), cioè per se stessa. In concreto questo significa che chi studia la Torà non deve
farlo “in vista di insegnare”, ma solo per amore dello studio, “per amore di lei”.
Tuttavia questo atteggiamento radicale non viene condiviso da tutti i maestri, anzi è all’origine di
un dibattito, le cui conclusioni possono essere così: l’importante è che si studi la Torà! Alla base di
questa affermazione c’è un atteggiamento pedagogico che si esprime in un detto ripetuto più volte
nel Talmud: “Un uomo si occupi sempre della Torà, anche se non fosse per amore di lei, perchè dal
fatto di occuparsene non per amore giungerà ad occuparsene anche per amore” (Talmud, bPesachim
50b). Ma altri rabbini precisano che Torà per sé stessa non vuol dire “fine a se stessa”; non vuol dire
che lo studio non deve essere finalizzato all’azione, ma indica uno studio amoroso, gratuito e quindi
anche gioioso. Studiare la Torà vuol dire cercarvi anche un senso per me e ad ogni scoperta il cuore
si allieta e si dilata (vedi anche Sal 119,32: la gioia della Torà).
C’è un midrash che amplia ancora questo concetto.
In Dt 30,6 leggiamo: «Per amare il Signore vostro Dio»
Ecco il commento:
“Caso mai tu dicessi: Ecco, io studio la Torà per diventare ricco, per essere chiamato Rabbi, per
ricevere una ricompensa nel mondo che viene, la Scrittura insegna: “Per amare il Signore vostro
Dio”. Tutto quello che fate, fatelo per amore”.
All’inizio di un nuovo anno scolastico/accademico, l’augurio è che tutti coloro che operano nella
scuola: studenti, docenti, educatori, collaboratori, possano far fruttare questo insegnamento, nella
piena libertà della loro coscienza.