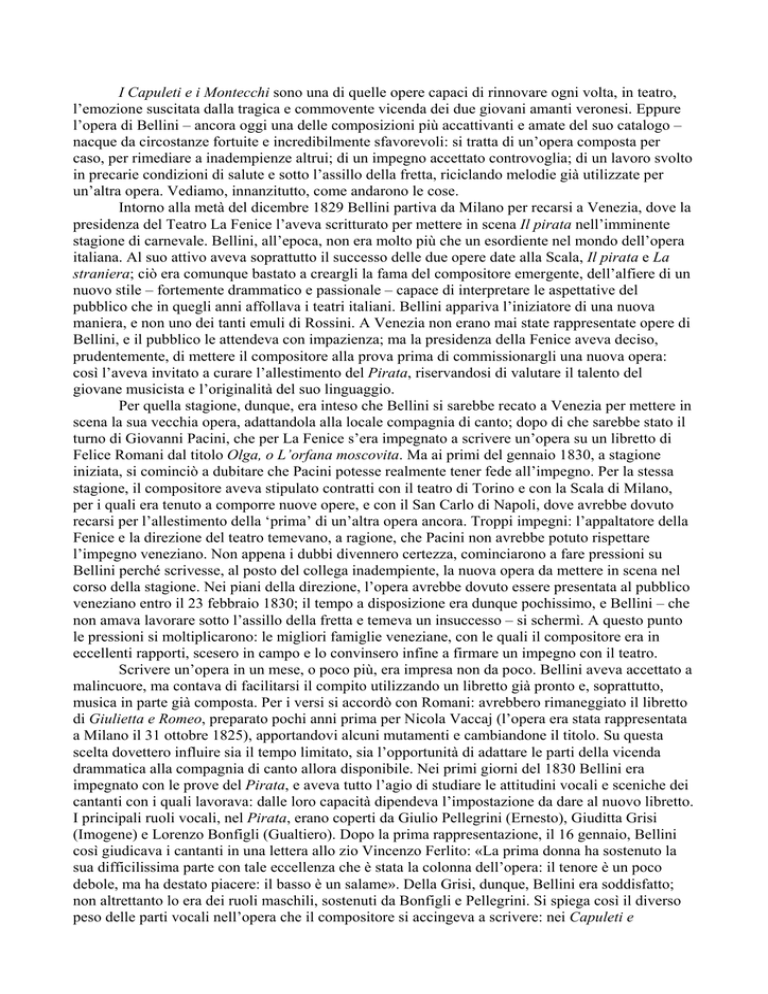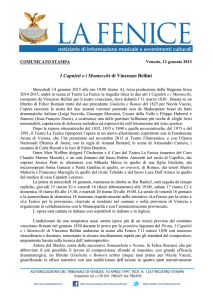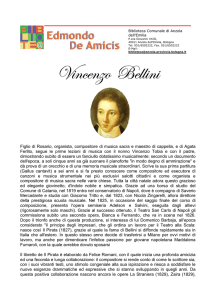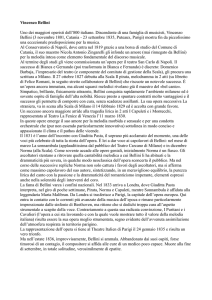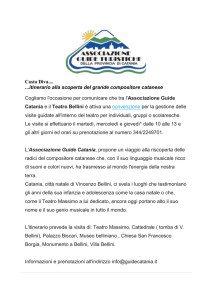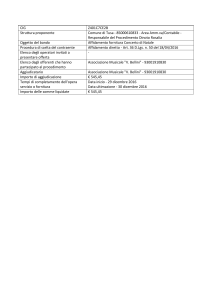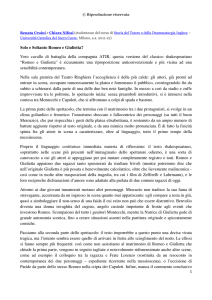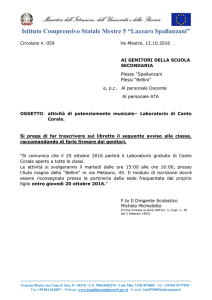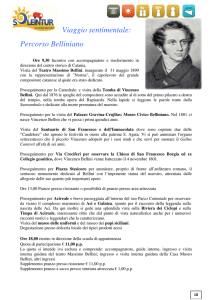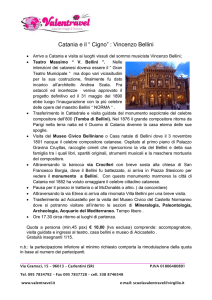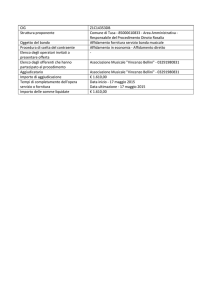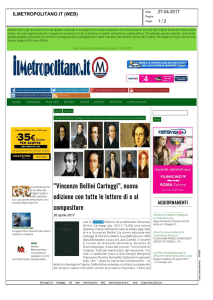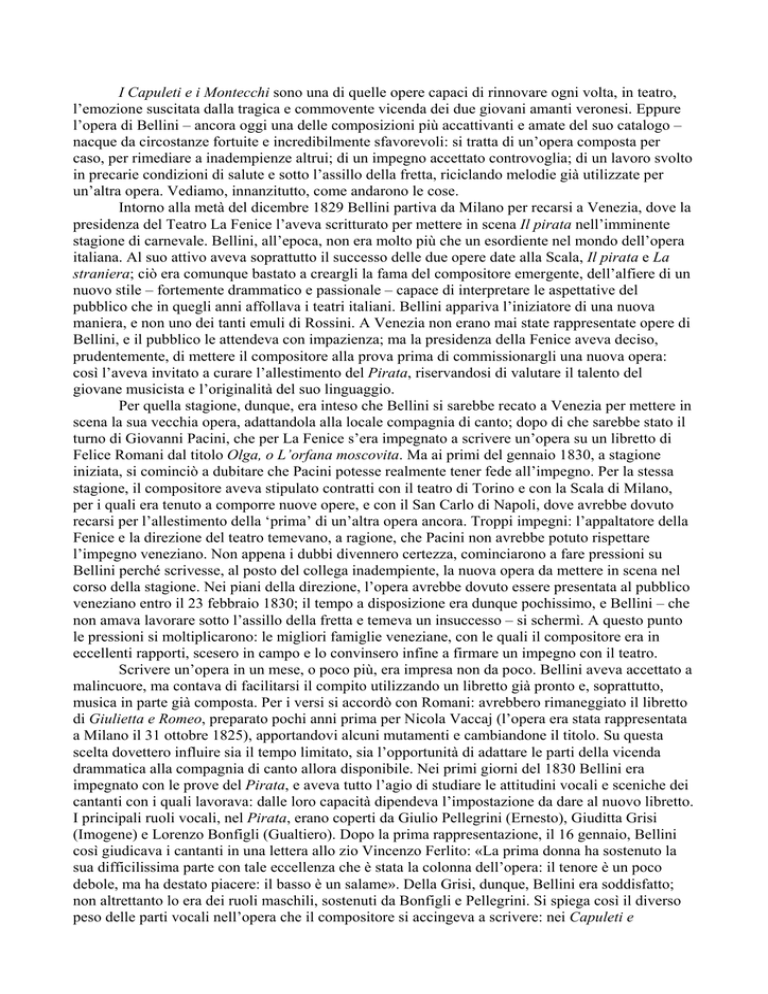
I Capuleti e i Montecchi sono una di quelle opere capaci di rinnovare ogni volta, in teatro,
l’emozione suscitata dalla tragica e commovente vicenda dei due giovani amanti veronesi. Eppure
l’opera di Bellini – ancora oggi una delle composizioni più accattivanti e amate del suo catalogo –
nacque da circostanze fortuite e incredibilmente sfavorevoli: si tratta di un’opera composta per
caso, per rimediare a inadempienze altrui; di un impegno accettato controvoglia; di un lavoro svolto
in precarie condizioni di salute e sotto l’assillo della fretta, riciclando melodie già utilizzate per
un’altra opera. Vediamo, innanzitutto, come andarono le cose.
Intorno alla metà del dicembre 1829 Bellini partiva da Milano per recarsi a Venezia, dove la
presidenza del Teatro La Fenice l’aveva scritturato per mettere in scena Il pirata nell’imminente
stagione di carnevale. Bellini, all’epoca, non era molto più che un esordiente nel mondo dell’opera
italiana. Al suo attivo aveva soprattutto il successo delle due opere date alla Scala, Il pirata e La
straniera; ciò era comunque bastato a creargli la fama del compositore emergente, dell’alfiere di un
nuovo stile – fortemente drammatico e passionale – capace di interpretare le aspettative del
pubblico che in quegli anni affollava i teatri italiani. Bellini appariva l’iniziatore di una nuova
maniera, e non uno dei tanti emuli di Rossini. A Venezia non erano mai state rappresentate opere di
Bellini, e il pubblico le attendeva con impazienza; ma la presidenza della Fenice aveva deciso,
prudentemente, di mettere il compositore alla prova prima di commissionargli una nuova opera:
così l’aveva invitato a curare l’allestimento del Pirata, riservandosi di valutare il talento del
giovane musicista e l’originalità del suo linguaggio.
Per quella stagione, dunque, era inteso che Bellini si sarebbe recato a Venezia per mettere in
scena la sua vecchia opera, adattandola alla locale compagnia di canto; dopo di che sarebbe stato il
turno di Giovanni Pacini, che per La Fenice s’era impegnato a scrivere un’opera su un libretto di
Felice Romani dal titolo Olga, o L’orfana moscovita. Ma ai primi del gennaio 1830, a stagione
iniziata, si cominciò a dubitare che Pacini potesse realmente tener fede all’impegno. Per la stessa
stagione, il compositore aveva stipulato contratti con il teatro di Torino e con la Scala di Milano,
per i quali era tenuto a comporre nuove opere, e con il San Carlo di Napoli, dove avrebbe dovuto
recarsi per l’allestimento della ‘prima’ di un’altra opera ancora. Troppi impegni: l’appaltatore della
Fenice e la direzione del teatro temevano, a ragione, che Pacini non avrebbe potuto rispettare
l’impegno veneziano. Non appena i dubbi divennero certezza, cominciarono a fare pressioni su
Bellini perché scrivesse, al posto del collega inadempiente, la nuova opera da mettere in scena nel
corso della stagione. Nei piani della direzione, l’opera avrebbe dovuto essere presentata al pubblico
veneziano entro il 23 febbraio 1830; il tempo a disposizione era dunque pochissimo, e Bellini – che
non amava lavorare sotto l’assillo della fretta e temeva un insuccesso – si schermì. A questo punto
le pressioni si moltiplicarono: le migliori famiglie veneziane, con le quali il compositore era in
eccellenti rapporti, scesero in campo e lo convinsero infine a firmare un impegno con il teatro.
Scrivere un’opera in un mese, o poco più, era impresa non da poco. Bellini aveva accettato a
malincuore, ma contava di facilitarsi il compito utilizzando un libretto già pronto e, soprattutto,
musica in parte già composta. Per i versi si accordò con Romani: avrebbero rimaneggiato il libretto
di Giulietta e Romeo, preparato pochi anni prima per Nicola Vaccaj (l’opera era stata rappresentata
a Milano il 31 ottobre 1825), apportandovi alcuni mutamenti e cambiandone il titolo. Su questa
scelta dovettero influire sia il tempo limitato, sia l’opportunità di adattare le parti della vicenda
drammatica alla compagnia di canto allora disponibile. Nei primi giorni del 1830 Bellini era
impegnato con le prove del Pirata, e aveva tutto l’agio di studiare le attitudini vocali e sceniche dei
cantanti con i quali lavorava: dalle loro capacità dipendeva l’impostazione da dare al nuovo libretto.
I principali ruoli vocali, nel Pirata, erano coperti da Giulio Pellegrini (Ernesto), Giuditta Grisi
(Imogene) e Lorenzo Bonfigli (Gualtiero). Dopo la prima rappresentazione, il 16 gennaio, Bellini
così giudicava i cantanti in una lettera allo zio Vincenzo Ferlito: «La prima donna ha sostenuto la
sua difficilissima parte con tale eccellenza che è stata la colonna dell’opera: il tenore è un poco
debole, ma ha destato piacere: il basso è un salame». Della Grisi, dunque, Bellini era soddisfatto;
non altrettanto lo era dei ruoli maschili, sostenuti da Bonfigli e Pellegrini. Si spiega così il diverso
peso delle parti vocali nell’opera che il compositore si accingeva a scrivere: nei Capuleti e
Montecchi, infatti, Romeo (interpretato dalla Grisi) avrebbe avuto una parte preponderante, mentre
la parte di Tebaldo sarebbe stata decisamente secondaria e quella di Capellio addirittura
trascurabile.
Che il personaggio del giovane amoroso fosse interpretato da un ‘musico’, cioè da una
donna in abiti maschili, rispondeva a una tradizione di lunga data; sia nella vecchia opera di
Zingarelli sullo stesso soggetto, sia in quella di Vaccaj, la parte di Romeo era affidata a una voce
femminile, perché ritenuta più consona all’espressione dei sentimenti d’amore. Nel 1830 la prassi
del travesti non appariva ancora antiquata; per un ‘musico’, infatti, Bellini aveva appena scritto la
parte di Nerestano nella Zaira, e scriverà ancora quella di Ernani nell’opera abbozzata verso la fine
del 1830 (nel ruolo principale avrebbe dovuto esibirsi Giuditta Pasta). Ma è anche vero che nel
1830 la vecchia prassi era ormai prossima a cadere definitivamente in disuso; I Capuleti e i
Montecchi furono dunque una delle ultime opere nelle quali il protagonista maschile è interpretato
da una donna.
Bellini e Romani, accordatisi per il rifacimento del libretto che lo stesso Romani aveva
scritto per Vaccaj pochi anni prima, procedettero di comune accordo: effettuarono tagli, cuciture,
modifiche, valorizzarono certi aspetti della fonte piuttosto che altri, crearono nuovi motivi di
contrasto interpersonale che andarono ad arricchire il conflitto drammatico nel plot. Per Romani,
un’operazione simile dovette certamente essere fonte di un certo disagio, le cui tracce si colgono
nell’Avvertimento dell’autore premesso al libretto a stampa: «Chi sa quanto costi camminare su
tracce di già segnate, e sostituire nuovi concetti ai già scritti, che pur sempre ricorrono al pensiere,
scuserà di leggieri i difetti di cui di certo abbonderà il mio lavoro». Anche Bellini, da parte sua,
intendeva riutilizzare materiale già pronto: nei Capuleti confluì infatti parte della musica della
precedente Zaira, opera che i veneziani non conoscevano, essendo stata ritirata dalle scene dopo
l’insuccesso della ‘prima’ al Teatro Ducale di Parma nel maggio 1829.
La composizione della nuova opera occupò Bellini, che vi si applicò subito alacremente,
all’incirca tra il 20 gennaio e il 3 marzo. A testimoniarne le fasi restano alcune lettere a Giuditta
Turina e ad Alessandro Lamperi, dalle quali emerge il quadro di un lavoro accanito e faticoso,
accompagnato da preoccupazione, tensione nervosa, problemi di salute. «Fattigo dalla mattina alla
sera e sarà un miracolo se me la sorto senza qualche malanno», scriveva alla Turina il 26 gennaio; e
a Lamperi, pochi giorni dopo: «Io mi trovo affatigatissimo. Scrivere un’opera per esserne stato
forzato dalle tanto gentili maniere, e scriverla in un mese che il solo doverla finire mi confonde le
idee, è il mio soffrente martoro». A complicare le cose s’era aggiunto il freddo, davvero
eccezionale, di quell’inverno veneziano, che causava non pochi problemi di salute al compositore;
ma il motivo principale dell’affaticamento e della tensione nervosa risiedeva nella natura stessa del
lavoro: Bellini non riutilizzava semplicemente musica già scritta, ma la rimaneggiava
profondamente, sottoponendosi a un faticoso processo di vera e propria ri-creazione. Se il materiale
melodico riversato nella nuova opera proveniva, in gran parte, dalla sfortunata Zaira, per uno dei
numeri, la Cavatina di Giulietta nel primo atto, Bellini fece ricorso anche all’opera con la quale, al
termine degli studi, si era congedato dal conservatorio napoletano: Adelson e Salvini. La natura
della parodia è molto varia: si va dalla ripresa quasi letterale della melodia alla sua libera
rielaborazione, che può portare anche molto lontano dall’originale.
Al termine di un mese e mezzo d’intenso lavoro la nuova opera era terminata. Il 23 febbraio
iniziarono le prove, e la sera dell’11 marzo I Capuleti e i Montecchi andarono in scena. Nei ruoli
principali si esibivano il soprano Rosalbina Carradori Allan (Giulietta), il mezzosoprano Giuditta
Grisi (Romeo) e il tenore Lorenzo Bonfigli (Tebaldo); completavano il cast il tenore Ranieri
Pocchini Cavalieri (Lorenzo) e il basso Gaetano Antoldi (Capellio). Il pubblico veneziano accolse
col più grande calore la nuova opera di Bellini. Una breve notizia, a firma Tommaso Locatelli,
comparve subito – fatto alquanto straordinario – sulla Gazzetta privilegiata di Venezia del 12
marzo. Il recensore, nel riportare «l’esito più strepitoso e felice» e le «acclamazioni ed applausi
senza fine al principio al mezzo ed al termine di ogni atto», riferiva che il pubblico si era
entusiasmato soprattutto per pagine quali la cavatina del tenore e il finale del primo atto, «piene di
ogni bellezza e novità di pensieri, di canto e di armonie»; anche «la scena e la grand’aria delle
Tombe, sostenuta con quel magico potere dalla Grisi, e il duetto tra lei e la Carradori, che segue
subito dopo, rinnovarono il premiero entusiasmo e sì il pubblico non fu contento finché al termine
dello spettacolo, maestro e cantanti non si presentarono per ben cinque o sei volte sul
palcoscenico». Un altro breve resoconto uscì, il 15 marzo, sull’Eco di Milano; il corrispondente del
giornale – che in passato aveva espresso qualche perplessità sulla musa belliniana – lodava senza
riserve la nuova opera, giudicandone la musica («bella, commovente, e tutta italiana») superiore a
quella del Pirata e della Straniera.
Dopo queste prime impressioni, recensioni più lunghe apparvero sulla Gazzetta privilegiata
di Venezia, L’eco, I teatri, l’Allgemeine musikalische Zeitung; tutte concordavano nel riconoscere lo
straordinario successo dell’opera, che crebbe ancora con la seconda e le successive
rappresentazioni. La legittima soddisfazione di Bellini traspariva appieno dalla lettera che il 16
marzo mandava a Lamperi: «Io, mio buono amico, sono al colmo del contento: questo furore è stato
sino a me stesso inaspettato». Al termine della terza recita il compositore fu accompagnato a casa
alla luce delle fiaccole e al suono di una banda militare che intonava i pezzi favoriti delle sue opere;
con manifestazioni analoghe si festeggiarono le due prime donne. L’entusiasmo del pubblico della
Fenice toccò l’apice la sera del 21 marzo, data dell’ultima rappresentazione; poi, giunta al termine
la stagione di carnevale, il teatro fu costretto a chiudere. Ai veneziani restò il rammarico di non
poter godere più a lungo dell’opera cui avevano decretato un successo così completo.
Il pubblico, i recensori e i corrispondenti da Venezia si trovarono concordi nel sottolineare
la nuova strada imboccata dall’arte belliniana con I Capuleti e i Montecchi: «vi sono dei pezzi
bellissimi e di un genere tutto nuovo, non istrepitoso, ma ragionato, armonioso, dolcissimo, e che fa
sentire le voci senza opprimerle con gli strumenti», scriveva Gerolamo Perucchini a un
corrispondente siciliano; e la Gazzetta privilegiata di Venezia annotava che «uno dei pregi della sua
musica ell’è una certa soavità di maniere, certe facili melodie che rapiscono per non so quale loro
dolcezza». Nei Capuleti e Montecchi, in effetti, Bellini attenua lo stile asciutto e la declamazione
rigorosa della Straniera, ancora sensibili nella Zaira, per tornare a uno stile melodicamente
espansivo, a un’effusione lirica che poggia su melodie morbide e seducenti, che nella loro dolcezza
si adattano perfettamente alla tragica storia messa in musica. All’effusione melodica si
accompagnano un canto altamente espressivo, un’attenzione estrema per il testo poetico intonato,
forme nette e ben delineate (perfettamente aderenti ai modelli della tradizione italiana) e una
strumentazione equilibrata, tesa a valorizzare il canto al massimo grado.
Nei Capuleti è evidente, rispetto alla Straniera, anche il ritorno a un’articolazione più
tradizionale del libretto e dei singoli ‘numeri’ dell’opera. I personaggi principali (Romeo, Giulietta
e Tebaldo) si presentano in scena ciascuno con la propria aria di sortita, che li definisce dal punto di
vista emotivo e psicologico e pone le premesse del dramma prima che l’azione entri nel vivo.
L’assetto dei ‘numeri’ e la tradizionale scansione in momenti ‘statici’ (il cantabile, la cabaletta) e
‘cinetici’ (il tempo d’attacco, il tempo di mezzo), che già il libretto prefigura, non sono d’impiccio
al musicista nella ricerca di una continuità drammatica: i momenti lirici sono inseriti coerentemente
in scene più ampie, nelle quali si innestano preludi strumentali, recitativi e interventi corali.
Memorabile, in questo senso, è l’ampio e articolato Finale primo. Nella stretta i due amanti,
oppressi dallo scontro generale tra le fazioni nemiche, intonano una lunga e suggestiva melodia
(“Se ogni speme è a noi rapita”); il tema (che proviene dalla Zaira) è pronunciato all’unisono dai
due protagonisti, che danno voce in questo modo a una perfetta comunanza d’intenti e di sentimento
e incrementano al massimo grado l’effetto della struggente melodia. Il passo suscitò l’ammirazione
di uno spettatore come Berlioz (peraltro ben poco indulgente nei confronti di Bellini), che
assistendo a una rappresentazione fiorentina dei Capuleti ebbe a dichiarare: «Queste due voci,
vibrando assieme come una sola, simbolo di un’unione perfetta, danno alla melodia una forza
d’impatto straordinaria. Sia per il modo in cui la frase melodica è incorniciata ed è ripresa, sia per la
stranezza ben motivata di questo unisono che non ci si aspetta affatto, sia infine per la melodia
stessa, confesso d’essermi commosso all’improvviso e d’aver applaudito con trasporto».
Anche il finale dell’opera, con la lunga scena del sepolcro, è assolutamente degno di nota.
D’impianto elastico, privo delle articolazioni formali così nette nel resto dell’opera, l’ultimo
‘numero’ dell’opera belliniana trapassa libero dal recitativo all’arioso, vigilmente attento ai trapassi
psicologici del principale personaggio sulla scena. E chiude in poche battute, repentino ed efficace,
con il rientro in scena di Capellio, di Lorenzo e del coro subito dopo la morte di Romeo e di
Giulietta. Con il suo stile fortemente espressivo e patetico, con la sua concisa tensione drammatica,
il finale belliniano diede subito origine a reazioni discordanti: di fronte a una minoranza che ne
apprezzò la novità, vi fu una parte del pubblico e della critica che ne rimase sconcertata. La pagina
finì per evocare l’ombra dei due modelli – all’epoca ben noti e apprezzati – che l’avevano
preceduta, il finale delle opere di Zingarelli e di Vaccaj sul medesimo soggetto: e in genere il
paragone si risolse, come vedremo, a sfavore di Bellini.
Dopo la ‘prima’ veneziana, I Capuleti e i Montecchi s’inserirono rapidamente nel circuito
teatrale italiano e straniero; entrata stabilmente nel repertorio, l’opera fu, in assoluto, tra le più
rappresentate dell’Ottocento. Alla fine del 1830 I Capuleti e i Montecchi inaugurarono la stagione
di carnevale al Teatro alla Scala di Milano. La compagnia di canto scritturata per l’occasione
comprendeva, oltre a Bonfigli e alla Grisi (già protagonisti a Venezia), un’altra prima donna,
Amalia Schütz Oldosi; perché quest’ultima, mezzosoprano, potesse sostenere la parte di Giulietta,
scritta in origine per il soprano Rosalbina Carradori, Bellini dovette procedere a rimaneggiare
ampie porzioni della partitura. Tale adattamento comportò l’abbassamento della parte della
protagonista e l’aggiustamento delle altre parti vocali, il trasporto di alcuni brani, il rifacimento di
alcune sezioni di raccordo, il ritocco della strumentazione. L’esito di questa versione rimaneggiata
non fu particolarmente entusiasmante: Bellini, che vi assisteva, deluso e irritato per la cattiva
prestazione dei cantanti non uscì neppure a ringraziare il pubblico che lo chiamava sul
palcoscenico. Alle rappresentazioni successive le cose andarono progressivamente migliorando; il
compositore era tuttavia insoddisfatto della nuova versione dell’opera, nella quale stentava a
riconoscere il lavoro così entusiasticamente acclamato a Venezia. Miglior fortuna toccò ad altri
allestimenti. Nel corso della stessa stagione di carnevale, I Capuleti e i Montecchi furono presentati
alla Pergola di Firenze, al Carlo Felice di Genova, al Carolino di Palermo, al San Benedetto di
Venezia. A Cremona, Rovigo e Udine l’opera arrivò con la stagione estiva; al San Carlo di Napoli,
a Trieste, Novara e Dresda in autunno. In seguito, a partire dalla stagione di carnevale del 1831-32,
la diffusione si fece ancora più capillare: grazie ai circuiti impresariali l’opera toccò tutti i teatri
principali e secondari della penisola e arrivò, tradotta in varie lingue, in tutti i paesi europei nei
quali si allestivano opere italiane. Nel 1833 approdò al King’s Theatre di Londra e al Théâtre Italien
di Parigi. Intorno agli anni Quaranta dell’Ottocento, poi, in concomitanza con l’espansione
dell’‘industria’ del teatro musicale italiano e la conquista di nuovi mercati (facilitate dalla
costruzione delle vie ferrate e dall’istituzione di linee transoceaniche regolari), l’opera di Bellini
giunse in centri remoti quali L’Avana, Città del Messico, New Orleans, Rio de Janeiro, Trinidad,
Buenos Aires, Valparaiso. Nel 1859 l’opera belliniana fu rappresentata, col titolo Roméo et Juliette,
all’Opéra di Parigi, tradotta in francese e trasformata in un grand opéra.
Ai Capuleti e Montecchi legarono il proprio nome – oltre alle prime interpreti Giuditta Grisi,
Rosalbina Carradori e Amalia Schütz – tutti i principali cantanti attivi fra gli anni Trenta e Quaranta
dell’Ottocento. Nel ruolo di Romeo si cimentarono, tra le altre, Giuseppina Ronzi De Begnis,
Almerinda Manzocchi, Maria Malibran, Giuditta Pasta, Carolina Unger, Fanny Tacchinardi
Persiani; in quello di Giulietta Luigia Boccabadati, Giulia Grisi, Sophie Dall’Oca Schoberlechner,
Henriette Méric-Lalande; sostennero il ruolo di Tebaldo (pur meno gratificante) tenori del calibro di
Domenico Reina, Giovanni Battista Rubini e Domenico Donzelli. In Germania, dove l’opera
belliniana ebbe una diffusione immediata e capillare, furono celebri le esibizioni di Wilhelmine
Schröder-Devrient (nei panni di Romeo), che fece dei Capuleti uno dei suoi cavalli di battaglia;
dalla sua interpretazione fu vivamente impressionato, tra gli altri, Richard Wagner, che dedicò alla
cantante righe di fervida ammirazione. Nel Novecento I Capuleti e i Montecchi furono ripresi
dapprima a Catania nel 1935, in occasione del centenario della morte di Bellini, poi in vari teatri a
partire dagli anni Cinquanta (alla Scala di Milano nel 1966, in un discusso allestimento diretto da
Abbado, la parte di Romeo venne affidata al tenore Giacomo Aragall); oggi l’opera occupa
nuovamente un posto stabile nel repertorio dei teatri lirici. In tempi recenti al ruolo di Giulietta
hanno legato il loro nome Mariella Devia, Katia Ricciarelli e Cecilia Gasdia; a quello di Romeo
Agnes Baltsa, Martine Dupuy e Diana Montague.
Un capitolo a parte, nella storia della ricezione dell’opera belliniana, è rappresentato dalla
sostituzione del finale. All’epoca in cui Bellini compose I Capuleti e i Montecchi circolavano nei
teatri italiani altre due opere sullo stesso soggetto: il vecchio lavoro di Zingarelli del 1796, Giulietta
e Romeo, e quello più recente di Vaccaj, dallo stesso titolo. La vecchia opera di Zingarelli era stata
un cavallo di battaglia del sopranista Girolamo Crescentini; rimase in circolazione fino ai primi
anni Trenta dell’Ottocento, quando a riprenderla fu Giuditta Pasta, che amava prodursi nei panni del
giovane Montecchi. L’ultimo atto dell’opera, in particolare, offriva alla cantante la possibilità di
mettere in luce le proprie doti d’attrice drammatica; ed erano soprattutto queste scene finali che
giustificavano la ripresa – di norma accompagnata da inserzioni estranee – di un’opera che il
pubblico avvertiva chiaramente come un prodotto ormai antiquato dell’antica scuola.
L’opera composta da Vaccaj sullo stesso soggetto, più recente, costituiva per I Capuleti e i
Montecchi di Bellini un riferimento più immediato. Anche in questo caso era il finale dell’opera a
costituire un modello autorevole, e assai apprezzato, d’arte drammatica. L’invenzione di Vaccaj è
incanalata nelle forme della tradizione italiana, caratterizzate da una chiara scansione e da passaggi
ben percepibili da una sezione all’altra; ciò permette al compositore, tra l’altro, di mettere in risalto
i momenti lirici, strutturati come pezzi chiusi e in sé compiuti. Uno di questi, il cantabile di Romeo
“Ah! se tu dormi, svegliati”, fu sempre considerato il punto d’eccellenza del finale. Questa pagina
ammiratissima, che rimase per anni nel repertorio di grandi interpreti, fu presa a paradigma di
esemplare scrittura vocale; la naturalezza di un canto moderatamente espressivo, che procede di
preferenza per piccoli intervalli e non acconsente a forzature, il giusto equilibrio tra effusione lirica
e accenti drammatici, ne fanno effettivamente un esempio magistrale dell’antica e gloriosa
tradizione belcantistica italiana. Il finale belliniano, al contrario, privilegia la concisione
drammatica e non concede molto alle velleità esibizionistiche di una prima donna.
È presumibile che queste caratteristiche rendessero più familiare e più gradito agli interpreti
e al pubblico il finale di Vaccaj rispetto a quello dei Capuleti e Montecchi, che dalla tradizione è
molto meno condizionato. Fu così che a un certo punto il finale dell’opera di Bellini fu sostituito
dalle pagine corrispondenti di quella di Vaccaj. La prima sostituzione avvenne quasi subito. Nel
corso delle rappresentazioni fiorentine iniziate il 26 febbraio 1831, la protagonista Santina Ferlotti
sostituì il finale dell’opera di Bellini, poco apprezzato dal pubblico, con le scene corrispondenti
dell’opera di Vaccaj, suscitando la più viva approvazione. Anche Maria Malibran, esibendosi nel
ruolo di Romeo a Bologna nell’ottobre del 1832, sostituì il finale di Bellini con quello di Vaccaj (né
si fece scrupolo di introdurre nell’opera un duetto di Mercadante e un altro di Celli); mantenne la
sostituzione in tutte le successive rappresentazioni cui prese parte, e il suo esempio fece scuola. La
sostituzione, tuttavia, non venne affatto accolta da pareri unanimi. E nella primavera del 1834, alla
Pergola di Firenze, Giuseppina Ronzi De Begnis andò controcorrente e ripristinò il finale originale,
ottenendo – a quanto pare – l’approvazione del pubblico. Ciò non impedì, tuttavia, che sino alla fine
dell’Ottocento I Capuleti e i Montecchi venissero di norma rappresentati con il finale sostituito;
fece anzi notizia il fatto che per una rappresentazione dell’opera, nel 1895 al Teatro Mercadante di
Napoli (con Emma Carelli nei panni di Romeo e un giovane Enrico Caruso in quelli di Tebaldo),
venisse ripristinato il finale originario di Bellini. Ma intanto I Capuleti e i Montecchi erano usciti di
scena: la prassi del travesti era da troppo tempo in disuso, e il pubblico mostrava disaffezione per
un’opera nella quale avvertiva un’eccessiva dose di inverosimiglianza drammatica. Solo dalla
riproposta dei Capuleti in occasione del centenario belliniano, nel 1935, scaturirono una più corretta
comprensione dell’opera – benché occorresse attendere ancora un paio di decenni per il suo stabile
rientro in repertorio – e il definitivo rovesciamento del giudizio sul finale.
È ben noto come nella storia del melodramma il ‘codice’ condiviso prevalga assai spesso
sull’innovazione; ciò che è familiare è più gradito, al pubblico del teatro d’opera, di ciò che nega le
sue aspettative, cosicché il sistema delle convenzioni e la ripetitività delle formule possono
comprimere – o addirittura sopprimere – il testo di un autore nei casi in cui questo contrasti
apertamente con il codice stesso. Le ultime scene dei Capuleti e Montecchi mettono in discussione
quella sorta di sospensione temporale che si produce nel cantabile, che lo spettatore si aspetta e
percepisce all’istante grazie all’andamento regolare e simmetrico delle frasi vocali, all’orchestra
che si ritira ad eseguire formule d’accompagnamento, al giro sintatticamente chiuso delle cadenze.
Il procedimento è tanto più evidente nel finale dei Capuleti, dal momento che nel resto dell’opera
Bellini impiega strutture assolutamente regolari, perfettamente ritagliate sulle consuetudini
morfologiche del melodramma italiano dell’epoca. Il finale di Vaccaj offre allo spettatore più legato
alla tradizione esattamente ciò che si aspetta: arie dalla fattura elegante, frasi melodiche ben tornite,
che sono pensate in primo luogo in funzione dell’esibizione vocale, lasciando l’effetto drammatico
in secondo piano. Oggi, ripristinata definitivamente nei Capuleti la lezione belliniana, siamo in
grado di apprezzare in pieno il pathos drammatico di una pagina che all’epoca dovette apparire,
forse, troppo innovativa. L’afflizione estrema e l’esaltazione più intensa del sentimento, l’elegiaco
delirio amoroso espresso dalle linee vocali, discretamente punteggiate dall’orchestra, costituiscono
senza alcun dubbio uno dei vertici assoluti dell’arte di Bellini.
Claudio Toscani