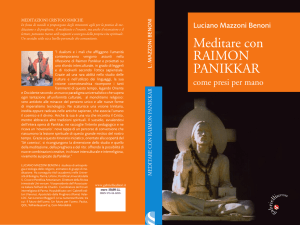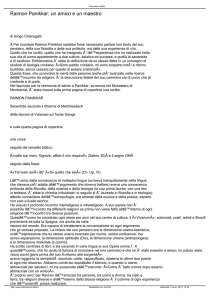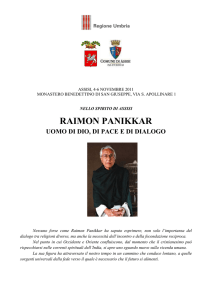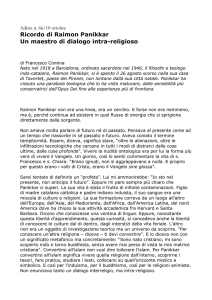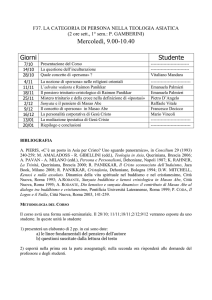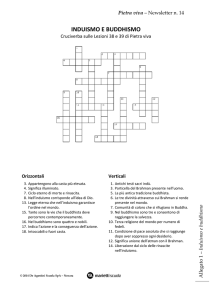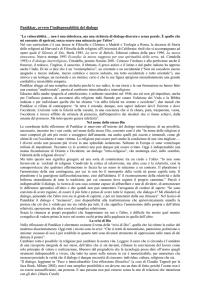Federico Battistutta
La profezia nuova di Thomas Merton e Raimon Panikkar
0. Il termine profeta deriva dal tardo latino prophèta che ricalca a sua volta il greco antico
προφήτης, parola composta dal prefisso προ- (davanti, prima) e dal verbo φημί (parlare, dire). Il
profeta è letteralmente “colui che parla prima”, nel senso di colui che anticipa ciò che sta per
accadere, annuncia il veniente; non il futuro dei futurologi che è comunque una declinazione del già
dato, del movimento del passato, ma il novum radicale che sfugge a ogni previsione. E non è vero,
come sostengono tanti, gli eterni rassegnati o gli amministratori dell’esistente, che non si dà più
profezia, è che non sappiamo coglierla, abbiamo disimparato a leggere i segni del nostro tempo. A
testimonianza di ciò, qui, in forma sommessa, presentiamo due personaggi che hanno saputo
cimentarsi con l’arduo alfabeto della profezia, preannunciando gli esiti possibili di un pluriverso
interculturale e interreligioso. Ci riferiamo a Thomas Merton e a Raimon Panikkar.
Cominciamo ripercorrendo i momenti significativi della loro esistenza.
1.1. Thomas Merton nasce nel 1915 in Francia; a causa dello scoppio della “grande guerra”, nel
1916 si trasferisce con i genitori vicino a New York (la madre era statunitense). In seguito si
sposterà alle isole Bermuda, di nuovo in Francia, infine in Inghilterra, dove inizia gli studi
universitari che completerà alla Columbia University di New York, discutendo una tesi sulla poesia
di William Blake. Intanto, scopre l'aspetto sociale del Vangelo e decide di accostarsi alla religione
cattolica.
Dopo la laurea, si dedica per qualche anno all'insegnamento della letteratura inglese. In seguito a un
ritiro spirituale presso un’abbazia trappista rimane profondamente segnato dalla vita di solitudine e
preghiera dei monaci e matura la decisione di entrarvi; nel 1947 pronuncerà i voti solenni,
diventando monaco. In quegli stessi anni perde anche suo fratello, caduto in combattimento durante
la seconda guerra mondiale: tale evento contribuì molto a far maturare in lui una profonda
avversione nei confronti delle guerre, diventando uno dei principali punti di riferimento del
movimento pacifista degli anni ’60, schierandosi con convinzione anche a sostegno del movimento
nonviolento per i diritti civili, che egli definì come «il più grande esempio di fede cristiana attiva
nella storia sociale degli Stati Uniti». Durante la guerra del Vietnam, Merton maturò un profondo
interesse per il buddhismo, intraprendendo numerosi viaggi in Oriente, incontrando anche il Dalai
Lama. Nel 1968, a Bangkok, durante uno di questi viaggi, trovò la morte, folgorato da un
ventilatore difettoso. Doveva partecipare a un congresso monastico panasiatico con una relazione
intitolata Il marxismo e le prospettive della vita monastica. In quel testo, fra le altre cose possiamo
leggere: «Lo scopo della vita monastica è quello di vivere di amore: una formula semplice tanto
popolare in Occidente era la trasformazione agostiniana della cupiditas in caritas, dell’amore
egocentrico nell’amore altruistico. (…) In Marx stesso si può trovare qualcosa di quel desiderio di
passare dalla cupiditas alla caritas. L’idea centrale del comunismo è stata quella di un’evoluzione
dall’avidità capitalistica verso la dedizione comunista. Secondo la formula marxista il comunismo
consisterebbe nel fatto che ognuno dà ciò che può e prende ciò di cui ha bisogno; ma questa è anche
la definizione della comunità monastica».
1.2. Raimon Panikkar nasce a Barcellona nel 1918, dunque tre anni dopo Merton, da madre catalana
e padre indiano. Studia a Barcellona, Madrid e in Germania, conseguendo prima una laurea in
Scienze e poi in Lettere. Negli anni ’40 si avvicina al primo nucleo di fedeli laici dell’Opus Dei,
divenendo membro di tale organizzazione per vent'anni (in seguito parlerà con reticenza di tale
periodo). Nel 1946 ottiene l’ordinazione sacerdotale e inizia l’attività di insegnamento presso
università e seminari diocesani.
Negli anni Cinquanta si reca in India; l'incontro e la conoscenza dell’induismo e del buddhismo
modificano alla radice la sua sensibilità religiosa. Dirà in proposito: «Sono partito cristiano, mi sono
scoperto hindu e ritorno buddhista, senza cessare per questo di essere cristiano».
Nel 1961 svolge la dissertazione della propria tesi in Teologia a Roma; il testo, The Unknown
Christ of Hinduism, diventerà uno dei suoi libri più tradotti e pubblicati; in esso Panikkar espone la
presenza viva di Cristo nell'induismo, esaminando la relazione tra questo e il cristianesimo. Nello
stesso periodo partecipa a Roma alle attività del Concilio Vaticano II. Negli anni Settanta è invece
negli Stati Uniti, all’università di Santa Barbara in California, pur continuando a recarsi
periodicamente in India. Ritiratosi in seguito dalla vita accademica, Panikkar si stabilisce a
Tavertet, in Catalogna, dove morirà nel 2010. Descriverà il ritorno in questa terra come il
completamento del proprio karma: «chiudere il cerchio o radicare la mia vita, tornando al luogo
dove sono nato». Quasi la metà dei suoi lavori vengono pubblicati negli anni ‘90.
2. Com’è intuibile non è possibile nello spazio di poche pagine dar conto della valenza profetica di
queste due figure. Focalizzeremo l’attenzione sull’inestimabile contributo che ci hanno lasciato per
quanto riguarda il dialogo interreligioso, dove tale termine non va inteso in un’accezione ristretta,
quella riguardante il confronto fra le diverse confessioni religiose. Limitarsi a ciò significherebbe
chiudere il cerchio prima ancora di averlo aperto, deprimere ogni apertura, meglio ancora, lo
sfondamento di orizzonti che è possibile intravedere. Insomma, qui ci interessa cogliere il respiro di
una prospettiva più ampia in grado di scorgere i lineamenti di una religiosità al di là delle religioni
stesse.
2.1. Iniziamo con Merton. Egli laddove parla di meditazione e di preghiera le descrive nei termini di
pratiche aventi come esito «una profonda integrazione personale». Al di là quindi dei conflitti come quelli fra vita attiva e vita contemplativa, fra sfera sacra e sfera profana, fra naturale e
soprannaturale - che rivelano nell’esperienza diretta e concreta la loro inconsistenza, nell’intima
consapevolezza che «tutta la vita sulla terra debba fondere elementi di azione e di riposo, di lavoro
corporale e di illuminazione mentale». E ancora: «Un falso soprannaturalismo che immagina il
‘soprannaturale’ come una specie di regno platonico di essenze astratte totalmente separato e
opposto al mondo concreto della natura, non offre alcun vero sostegno a una vita genuina di
meditazione e di preghiera. La meditazione non ha nessuno scopo e nessuna realtà se non è
fermamente radicata nella vita. Senza queste radici, non produce altro che frutti di disgusto, di
indifferenza, e perfino di morbosa e degenerata introversione, masochismo, dolorismo, negazione».
Vita contemplativa est similior caelesti quam activa, diceva Tommaso d’Aquino, citando Agostino,
tracciando la medesima via calpestata da altri prima di lui e che altri percorreranno. Noi qui
seguiamo Merton: vita attiva e vita contemplativa sono due ambiti differenti, com’è ovvio, ma non
significa che siano due opposti in cui uno costituisce l’azzeramento dell’altro (opposizione reale,
reciproca repulsione alla relazione, realrepugnanz, in termini kantiani), bensì sono due poli in cui
l’uno non può stare senza l’altro, poiché nei confronti degli opposti c’è attrazione reciproca perché
esiste un fondo soggiacente, non-duale, su cui entrambi si distendono (advaita, direbbero gli hindu).
Non solo: il dispositivo profetico di Merton passa a mettere a confronto pratiche meditative di
differente provenienza. Monaco trappista e profondo studioso delle vie meditative e contemplative
della tradizione cristiana, egli volge il suo interesse verso l’Oriente, in particolare verso il
buddhismo e nello specifico verso lo zen. In un testo dedicato proprio all’esplorazione dello zen
così scrive a proposito dell’impasse del pensiero teologico occidentale: «La coscienza moderna
tende a creare questa bolla solipsistica di consapevolezza – un io-sé imprigionato nella propria
coscienza, isolato e fuori da ogni contatto con gli altri ‘sé’ in quanto sono tutte cose più che
persone. E’ questo il tipo di coscienza esacerbata fino all’estremo, che ha reso inevitabile la
cosiddetta ‘morte di Dio’. Il pensiero cartesiano cominciò col tentativo di raggiungere Dio come
oggetto partendo dall’io pensante. Ma quando Dio diventa oggetto, presto o tardi ‘muore’».
Proprio partendo da simili considerazioni egli intravede una possibile uscita dalla crisi per l’uomo
occidentale volgendosi a Oriente e in particolare allo zen. Scrive ancora: «Nel cristianesimo la
dottrina oggettiva mantiene la priorità sia di tempo sia di valore. Nello zen l’esperienza precede
sempre, non nel tempo ma in importanza. Ciò perché il cristianesimo è una religione della grazia e
del dono divino, quindi di totale dipendenza da Dio. Lo zen non è classificabile come ‘religione’ (è
infatti separabile da ogni matrice religiosa e potrebbe fiorire sul terreno delle religioni non buddiste
o di nessuna religione), e in ogni caso cerca, come ogni buddismo, di rendere l’uomo
completamente libero e indipendente, anche nei suoi sforzi per la salvazione e l’illuminazione».
Soffermiamoci su alcune parole-chiave presenti nella citazione sopra riportata. C’è l’affermazione
della priorità dell’esperienza rispetto all’adesione a principi dogmatici; c’è un riferimento
all’interculturalità e all’interreligiosità; c’è un cenno, ancor più lungimirante, alla possibilità che la
sensibilità e il cuore dello zen possano fiorire anche al di fuori di qualsiasi confessione religiosa,
intravedendo l’inedita prospettiva di una via religiosa senza le religioni. Come si può notare siamo
al centro della questione di una religiosità al di là delle confessioni religiose.
2.2. Veniamo ora a Panikkar. Egli ci ha lasciato una messe di materiali verso cui ci vorrà del tempo
per apprezzarne fino in fondo la portata. Lo sfondo su cui si muove la riflessione panikkariana è che
la realtà è sempre più ricca di qualunque teorizzazione o concettualizzazione; queste sono delle
semplificazioni, in qualche misura inevitabili, di cui va al contempo ben mantenuta la
consapevolezza dello scarto. Egli, negli ultimi anni della sua vita riconosceva di aver assunto nel
corso della sua esistenza una quadruplice identità: cristiana, essendo nato ed educato nel
cristianesimo; hindu in quanto l’induismo faceva esso pure parte della sua origine, pur scoprendolo
poco a poco («Dovevo lasciarlo emergere in me»); buddhista, «quale risultato del lavoro interiore»
che col tempo il buddhismo andò sviluppando in lui e, ultima ma non ultima, l’identità secolare
quale risultato del suo contatto col mondo occidentale.
In Panikkar possiamo dunque notare non solo il forte riferimento alla prospettiva interreligiosa
(l’asse cristiano-hindu-buddhista), ma accanto a questi la tradizione secolare come lascito della
modernità dell’Occidente (dal pensiero scientifico a quello filosofico sino al mondo letterario), la
quale nella misura in cui si confronta con “questioni ultime” è condotta a confrontarsi con le
tradizioni religiose.
Ad esempio, quando si interroga su quale significato il buddhismo possa assumere nel mondo
attuale, di fronte all’odierna crisi globale ed epocale, egli giunge a dire che tale contributo può
toccare due tematiche che nella via di Buddha posseggono una forza carismatica: l’ateismo
religioso e il silenzio come metodologia espressiva. Ma l’ateismo religioso di Buddha non è,
secondo Panikkar, una contrapposizione alle varie forme di teismo presenti nelle tradizioni
religiose, né, tantomeno, è riducibile all’affermazione della non esistenza di Dio: è invece una
forma quanto mai affinata di religiosità, purgata da ogni ombra di idolatria, pertanto assai prossima
alla sensibilità culturale che connota la condizione dell’Occidente contemporaneo. «Se quindi ci
rivolgiamo ora al messaggio del Buddha predicato venticinque secoli fa, non è per un desiderio
anacronistico o per un interesse apologetico, ma perché ci sembra di scorgervi un elemento
indispensabile per una spiritualità contemporanea. Entrambe le culture, infatti, quella moderna di
impronta occidentale e quella buddhista, sono atee e presentano un atteggiamento apofatico di
fronte agli interrogativi ultimi sulla realtà». Per questo la predicazione del Buddha può riguardare
l’uomo occidentale, perché chiede la liberazione, perché mira a rendere l’uomo libero, libero da
tutto: «da un Dio oggettivato, da un’Umanità idealizzata, da una Società programmata, da una
Scienza sognata».
Tratto da “NonCredo”, n.20/novembre-dicembre 2012, pp. 571-574.