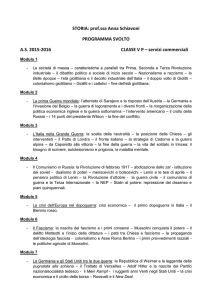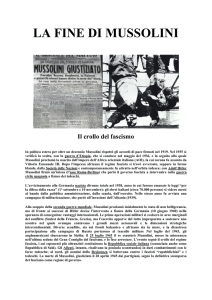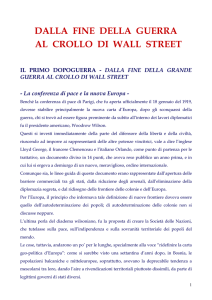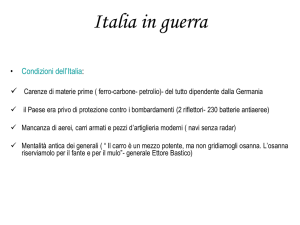Carlo Fruttero e Massimo Gramellini
LA PATRIA, BENE O MALE
Almanacco essenziale dell’Italia Unita
(in 150 date)
Collezione Strade blu
ISBN 978-88-04-60329-0
© 2010 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano
Prima edizione novembre 2010
In collaborazione con «LA STAMPA»
ART DIRECTOR: GIACOMO CALLO
PROGETTO GRAFICO: CRISTINA BAZZONI
IN COPERTINA: ELABORAZIONE DI CRISTINA BAZZONI
CORNICI E COCCARDA © ISTOCKPHOTO
FOTO DI CARLO FRUTTERO: © ALBERTO CONTI/CONTRASTO
FOTO DI MASSIMO GRAMELLINI: © MAURO VALLINOTTO
Indice
La Patria, bene o male ________________________________________________________ 10
Prefazione ______________________________________________________________________ 11
Dieci ______________________________________________________________________ 13
17 marzo 1861 ________________________________________________________________________ 14
Un’Italia, anzi due _______________________________________________________________ 14
18 aprile 1861 ________________________________________________________________________ 16
Due italiani, anzi tre ______________________________________________________________ 16
29 agosto 1862 ________________________________________________________________________ 18
Garibaldi fu ferito _______________________________________________________________ 18
25 luglio 1864 ________________________________________________________________________ 19
Briganti e pentiti_________________________________________________________________ 19
21 settembre 1864 _____________________________________________________________________ 20
«Torinesi, crié nen» ______________________________________________________________ 20
20 luglio 1866 ________________________________________________________________________ 21
«Daghe dosso che la ciapèmo!» _____________________________________________________ 21
1 settembre 1867 ______________________________________________________________________ 22
La penna e lo schioppo____________________________________________________________ 22
3 novembre 1867 ______________________________________________________________________ 23
Né Roma né morte _______________________________________________________________ 23
7 gennaio 1869________________________________________________________________________ 24
La tassa sulla fame _______________________________________________________________ 24
15 giugno 1869 _______________________________________________________________________ 25
Lobbia e bastone_________________________________________________________________ 25
Venti ______________________________________________________________________ 26
20 settembre 1870 _____________________________________________________________________ 27
Con chi comanda ________________________________________________________________ 27
2 luglio 1871 _________________________________________________________________________ 28
Il Papa non è Re _________________________________________________________________ 28
22 maggio 1873 _______________________________________________________________________ 29
Manzoni, chi era costui? __________________________________________________________ 29
25 giugno 1873 _______________________________________________________________________ 30
Scrivania di Stato ________________________________________________________________ 30
6 agosto 1874 _________________________________________________________________________ 32
Fuochino a Bologna ______________________________________________________________ 32
18 marzo 1876 ________________________________________________________________________ 33
Rivoluzione all’italiana ___________________________________________________________ 33
17 gennaio 1878_______________________________________________________________________ 34
Nel nome dei Padri _______________________________________________________________ 34
18 agosto 1878 ________________________________________________________________________ 35
Il barrocciaio mistico _____________________________________________________________ 35
4 novembre 1878 ______________________________________________________________________ 36
Il Vate e l’Aquilotta ______________________________________________________________ 36
17 novembre 1878 _____________________________________________________________________ 37
L’amaro lucano _________________________________________________________________ 37
Trenta _____________________________________________________________________ 38
7 luglio 1881 _________________________________________________________________________ 39
Un pezzo di legno ________________________________________________________________ 39
20 dicembre 1882______________________________________________________________________ 40
Kamikaze a Nord-Est_____________________________________________________________ 40
11 maggio 1883 _______________________________________________________________________ 41
Il primo inciucio _________________________________________________________________ 41
8 settembre 1884 ______________________________________________________________________ 42
Vedi Napoli...____________________________________________________________________ 42
6 giugno 1886 ________________________________________________________________________ 43
Povera Italia ____________________________________________________________________ 43
10 giugno 1886 _______________________________________________________________________ 44
Il bambino talpa _________________________________________________________________ 44
18 ottobre 1886 _______________________________________________________________________ 45
Cuore __________________________________________________________________________ 45
26 gennaio 1887_______________________________________________________________________ 46
Termopili d’Africa _______________________________________________________________ 46
30 luglio 1887 ________________________________________________________________________ 47
L’Uomo Forte ___________________________________________________________________ 47
9 giugno 1889 ________________________________________________________________________ 48
Fra Massone ____________________________________________________________________ 48
Quaranta___________________________________________________________________ 49
15 agosto 1892 ________________________________________________________________________ 50
La «prima» dei socialisti __________________________________________________________ 50
1° febbraio 1893_______________________________________________________________________ 51
Da genio a genio _________________________________________________________________ 51
17 agosto 1893 ________________________________________________________________________ 52
Fobia del forestiero_______________________________________________________________ 52
25 novembre 1893 _____________________________________________________________________ 53
Così fan tutti ____________________________________________________________________ 53
8 dicembre 1895_______________________________________________________________________ 54
Il bricoleur _____________________________________________________________________ 54
1° marzo 1896 ________________________________________________________________________ 55
Bandiera bianca _________________________________________________________________ 55
6 marzo 1898 _________________________________________________________________________ 56
Il guantone fatale ________________________________________________________________ 56
7 maggio 1898 ________________________________________________________________________ 57
Cannonate in Galleria ____________________________________________________________ 57
1° marzo 1900 ________________________________________________________________________ 59
Gabri e Lenor ___________________________________________________________________ 59
29 luglio 1900 ________________________________________________________________________ 60
Tre colpi di pistola _______________________________________________________________ 60
Cinquanta __________________________________________________________________ 62
9 ottobre 1901 ________________________________________________________________________ 63
Il giustiziere_____________________________________________________________________ 63
2 settembre 1902 ______________________________________________________________________ 64
Vaso di Pandora _________________________________________________________________ 64
3 novembre 1903 ______________________________________________________________________ 65
Un borghese piccolo grande________________________________________________________ 65
13 dicembre 1906______________________________________________________________________ 66
Il gran ballo dei tavolini___________________________________________________________ 66
5 novembre 1907 ______________________________________________________________________ 67
Il Trapanatore __________________________________________________________________ 67
24 luglio 1908 ________________________________________________________________________ 68
L’uomo che perse la vittoria _______________________________________________________ 68
29 dicembre 1908______________________________________________________________________ 69
Fra Scilla e Cariddi ______________________________________________________________ 69
12 marzo 1909 ________________________________________________________________________ 71
Un italiano di nome Joe ___________________________________________________________ 71
1° aprile 1910_________________________________________________________________________ 73
Ti à piaciato?____________________________________________________________________ 73
4 giugno 1911 ________________________________________________________________________ 75
Mostro ma sacro _________________________________________________________________ 75
Sessanta ___________________________________________________________________ 76
21 agosto 1911 ________________________________________________________________________ 77
Il ladro patriota _________________________________________________________________ 77
28 settembre 1911 _____________________________________________________________________ 78
Bel suol d’amore _________________________________________________________________ 78
26 aprile 1913 ________________________________________________________________________ 79
Da Zero a tutto __________________________________________________________________ 79
24 maggio 1915 _______________________________________________________________________ 80
Il maggio radioso ________________________________________________________________ 80
17 agosto 1916 ________________________________________________________________________ 81
Zang Tumb Tumb!_______________________________________________________________ 81
24 ottobre 1917 _______________________________________________________________________ 82
Una caporetto ___________________________________________________________________ 82
20 settembre 1918 _____________________________________________________________________ 84
Da imbroglione a santo ___________________________________________________________ 84
4 novembre 1918 ______________________________________________________________________ 85
La vittoria mutilata ______________________________________________________________ 85
23 marzo 1919 ________________________________________________________________________ 86
Antemarcia _____________________________________________________________________ 86
12 settembre 1919 _____________________________________________________________________ 88
Il Comandante __________________________________________________________________ 88
Settanta ____________________________________________________________________ 89
22 marzo 1920 ________________________________________________________________________ 90
Lo sciopero delle lancette__________________________________________________________ 90
9 maggio 1921 ________________________________________________________________________ 92
Manicomio! _____________________________________________________________________ 92
24 luglio 1921 ________________________________________________________________________ 93
Terror dei comunisti _____________________________________________________________ 93
28 ottobre 1922 _______________________________________________________________________ 94
Colpetto di Stato _________________________________________________________________ 94
10 giugno 1924 _______________________________________________________________________ 95
Il buco nero _____________________________________________________________________ 95
1° gennaio 1926 _______________________________________________________________________ 97
Sceriffo antimafia ________________________________________________________________ 97
6 febbraio 1927 _______________________________________________________________________ 98
Il ladro professore _______________________________________________________________ 98
23 giugno 1928 _______________________________________________________________________ 99
La Tenda Rossa _________________________________________________________________ 99
11 febbraio 1929 _____________________________________________________________________ 100
Provvidenza e dintorni___________________________________________________________ 100
6 luglio 1929 ________________________________________________________________________ 102
Cervello in fuga_________________________________________________________________ 102
Ottanta ___________________________________________________________________ 103
24 aprile 1932 _______________________________________________________________________ 104
Telefoni bianchi (e rosa)__________________________________________________________ 104
19 dicembre 1932_____________________________________________________________________ 105
Littoria e altre paludi ____________________________________________________________ 105
19 luglio 1933 _______________________________________________________________________ 106
L’altro fascista _________________________________________________________________ 106
16 agosto 1933 _______________________________________________________________________ 107
Nastro Azzurro _________________________________________________________________ 107
18 ottobre 1934 ______________________________________________________________________ 108
Il Feroce Saladino_______________________________________________________________ 108
18 dicembre 1935_____________________________________________________________________ 109
«Noi tireremo diritto» ___________________________________________________________ 109
27 aprile - 9 giugno 1937 _______________________________________________________________ 110
Compagni d’Italia ______________________________________________________________ 110
15 gennaio 1938______________________________________________________________________ 111
Ha vinto Lei____________________________________________________________________ 111
3 maggio 1938 _______________________________________________________________________ 112
Due dittatori e un intruso ________________________________________________________ 112
15 luglio 1938 _______________________________________________________________________ 113
La grande vergogna _____________________________________________________________ 113
Novanta___________________________________________________________________ 114
1940-1945 __________________________________________________________________________ 115
La Tragedia (in cinque atti)_______________________________________________________ 115
15 aprile 1944 _______________________________________________________________________ 120
Professor Gentile? ______________________________________________________________ 120
26 settembre 1945 ____________________________________________________________________ 121
L’urlo della Magnani ____________________________________________________________ 121
2 giugno 1946 _______________________________________________________________________ 122
L’ostetrica Palmiro _____________________________________________________________ 122
1° maggio 1947 ______________________________________________________________________ 123
Turiddu di Stato ________________________________________________________________ 123
2 luglio 1947 ________________________________________________________________________ 124
Le belle del reame_______________________________________________________________ 124
22 dicembre 1947_____________________________________________________________________ 125
Fondata sul lavoro ______________________________________________________________ 125
18 aprile 1948 _______________________________________________________________________ 127
Dio ti vede, Stalin no ____________________________________________________________ 127
6 maggio 1948 _______________________________________________________________________ 128
L’indicibile ____________________________________________________________________ 128
4 maggio 1949 _______________________________________________________________________ 129
I Campionissimi ________________________________________________________________ 129
Cento _____________________________________________________________________ 130
11 aprile 1953 _______________________________________________________________________ 131
Il pediluvio ____________________________________________________________________ 131
7 giugno 1953 _______________________________________________________________________ 132
Destino cinico e baro ____________________________________________________________ 132
31 luglio 1954 _______________________________________________________________________ 134
La donna del K2 ________________________________________________________________ 134
9 marzo 1955 ________________________________________________________________________ 135
Bum bum______________________________________________________________________ 135
26 novembre 1955 ____________________________________________________________________ 136
Controfagotto __________________________________________________________________ 136
31 gennaio 1958______________________________________________________________________ 137
Sanremo, oh oh _________________________________________________________________ 137
20 febbraio 1958 _____________________________________________________________________ 138
Un bel casino ___________________________________________________________________ 138
5 febbraio 1960 ______________________________________________________________________ 139
La dolce vita ___________________________________________________________________ 139
30 giugno 1960 ______________________________________________________________________ 140
Magliette a strisce_______________________________________________________________ 140
3 settembre 1960 _____________________________________________________________________ 141
L’arcangelo frigido______________________________________________________________ 141
Centodieci _________________________________________________________________ 142
11 ottobre 1962 ______________________________________________________________________ 143
Un prete conciliante _____________________________________________________________ 143
27 ottobre 1962 ______________________________________________________________________ 145
Petrolio! _______________________________________________________________________ 145
9 ottobre 1963 _______________________________________________________________________ 147
Morte per acqua ________________________________________________________________ 147
15 luglio 1964 _______________________________________________________________________ 149
Tu vuo’ fa’ il sudamericano_______________________________________________________ 149
30 marzo 1966 _______________________________________________________________________ 151
Non capisco più niente ___________________________________________________________ 151
30 aprile 1966 _______________________________________________________________________ 152
Nome d’arte ___________________________________________________________________ 152
25 settembre 1967 ____________________________________________________________________ 153
Anonima Rapine________________________________________________________________ 153
31 dicembre 1968_____________________________________________________________________ 154
Il botto ________________________________________________________________________ 154
4 settembre 1969 _____________________________________________________________________ 156
Potere operaio__________________________________________________________________ 156
12 dicembre 1969_____________________________________________________________________ 157
Il rosso e il nero_________________________________________________________________ 157
Centoventi _________________________________________________________________ 159
1972-1978 __________________________________________________________________________ 160
Shot river (Fiume di piombo)______________________________________________________ 160
31 agosto 1971 _______________________________________________________________________ 165
«Venghi ragioniere!» ____________________________________________________________ 165
2 dicembre 1973______________________________________________________________________ 166
Appiedati ______________________________________________________________________ 166
12 maggio 1974 ______________________________________________________________________ 168
Dissolubili _____________________________________________________________________ 168
29 settembre 1975 ____________________________________________________________________ 169
Libero killer ___________________________________________________________________ 169
2 novembre 1975 _____________________________________________________________________ 170
Ragazzo di vita _________________________________________________________________ 170
6 maggio 1976 - 23 novembre 1980 ______________________________________________________ 172
Terrenord e Terresud ___________________________________________________________ 172
10 luglio 1976 _______________________________________________________________________ 173
La fabbrica dei profumi__________________________________________________________ 173
15 giugno 1978 ______________________________________________________________________ 175
Il Leone e l’Antilope _____________________________________________________________ 175
11 luglio 1979 _______________________________________________________________________ 176
Controcorrente _________________________________________________________________ 176
Centotrenta ________________________________________________________________ 178
1980-1983 __________________________________________________________________________ 179
Misteri... ______________________________________________________________________ 179
14 ottobre 1980 ______________________________________________________________________ 183
Flusso e riflusso_________________________________________________________________ 183
13 maggio 1981 ______________________________________________________________________ 185
La filiera ______________________________________________________________________ 185
10 giugno 1981 ______________________________________________________________________ 186
Bambino pubblico ______________________________________________________________ 186
11 luglio 1982 _______________________________________________________________________ 187
Patrioti________________________________________________________________________ 187
3 settembre 1982 _____________________________________________________________________ 188
«Non siamo stati noi!» ___________________________________________________________ 188
17 giugno 1983 ______________________________________________________________________ 189
Giustizia in bancarella ___________________________________________________________ 189
20 ottobre 1984 ______________________________________________________________________ 190
La rivolta dei puffi ______________________________________________________________ 190
22 gennaio 1987______________________________________________________________________ 191
Milano da bere _________________________________________________________________ 191
12 novembre 1989 ____________________________________________________________________ 192
Che Cosa? _____________________________________________________________________ 192
Centoquaranta _____________________________________________________________ 194
20 maggio 1990 ______________________________________________________________________ 195
I picconatori ___________________________________________________________________ 195
7 luglio 1990 ________________________________________________________________________ 196
Nessun dorma __________________________________________________________________ 196
17 aprile 1991 _______________________________________________________________________ 197
Massacro a Nord-Est ____________________________________________________________ 197
1992-1994 __________________________________________________________________________ 199
La rivoluzione __________________________________________________________________ 199
1992-1993 __________________________________________________________________________ 203
Cose Nostre ____________________________________________________________________ 203
17 gennaio 1993______________________________________________________________________ 206
Un manto di stelle _______________________________________________________________ 206
22 dicembre 1994_____________________________________________________________________ 207
Ribaltoni ______________________________________________________________________ 207
26 gennaio 1998______________________________________________________________________ 209
Il Grande Piccolo _______________________________________________________________ 209
9 settembre 1998 _____________________________________________________________________ 210
Tu chiamale se vuoi, poesie _______________________________________________________ 210
5 giugno 1999 _______________________________________________________________________ 211
Globulo rosa ___________________________________________________________________ 211
Centocinquanta ____________________________________________________________ 212
18 settembre 2000 ____________________________________________________________________ 213
Gi Effe ________________________________________________________________________ 213
20 luglio 2001 _______________________________________________________________________ 214
Gli Uomini Neri ________________________________________________________________ 214
11 settembre 2001 ____________________________________________________________________ 215
Invasione? _____________________________________________________________________ 215
1° gennaio 2002 ______________________________________________________________________ 216
Zero virgola____________________________________________________________________ 216
4 marzo 2005 ________________________________________________________________________ 217
Morire da italiani _______________________________________________________________ 217
27 luglio 2005 _______________________________________________________________________ 219
I furbetti del telefonino __________________________________________________________ 219
10 febbraio 2006 _____________________________________________________________________ 221
Capitale di ritorno ______________________________________________________________ 221
9 maggio 2006 _______________________________________________________________________ 223
Il potere della parola ____________________________________________________________ 223
11 dicembre 2006_____________________________________________________________________ 224
L’Erba del vicino _______________________________________________________________ 224
25 aprile 2009 _______________________________________________________________________ 226
Da Orma a donna _______________________________________________________________ 226
Ringraziamenti _________________________________________________________________ 228
La Patria, bene o male
Agli italiani, coraggio!
Prefazione
Non sembra il caso di suggerire ai nostri lettori di non aspettarsi i grandiosi
affreschi di Tucidide o Tacito, di Machiavelli o Gibbon. Tutti sanno che non siamo
storici e non avremmo comunque il mestiere ed il genio per guardare a tali altezze.
Ma da quei maestri una lezione l’abbiamo pur appresa: la Storia obiettiva, la Storia
imparziale, la Storia definitivamente veritiera non esiste, può essere soltanto
un’aspirazione, una meta intravista e irraggiungibile.
Ogni pagina di questo libro è arbitraria e contestabile.
Abbiamo scelto 150 giornate a nostro avviso significative, distribuendole
equamente fra i quindici decenni dell’Italia Unita. Ma cosa vuol dire significative?
Alcune erano obbligatorie, la breccia di Porta Pia, Caporetto, la marcia su Roma, la
Liberazione, il sequestro Moro, Mani Pulite eccetera. Ma molte altre, non senza
lunghe discussioni tra di noi, sono state incluse o escluse, con intendimenti
ragionevoli e tuttavia opinabili. C’è cronaca rosa e c’è cronaca nera, sinistri figuri
stanno accanto a purissimi eroi, non manca Pavarotti, ma è assente la Callas. C’è il
Vajont, ma non il Polesine. L’assassinio di Casalegno e non quelli di Tobagi e Ilaria
Alpi. Primo Carnera, Enrico Cuccia e Alberto Sordi non sono chiamati sul palco, solo
citati di sfuggita.
Abbiamo letto un numero impressionante, ma sempre insufficiente, di testi relativi
a ogni episodio, a ogni personaggio, ciascuno dei quali meriterebbe, e in certi casi ha
meritato, un intero volume, se non interi scaffali. Ma ad ogni capitoletto di questa
ormai lunga vicenda abbiamo cercato di dare un taglio narrativo, di partire da un
particolare più vivido (il rivoluzionario Bakunin che fugge da Bologna travestito da
prete, Roberto Saviano sulla sua Vespa scassata in un’esplosiva piazza di Napoli) per
evitare ai lettori la triste impressione del grigiore scolastico. Sono 150 racconti
contratti, ridotti all’essenziale e dolorosamente privi di infiniti risvolti, sacrifici
dettati dalle necessità grafiche del quotidiano torinese «La Stampa» che ha avuto
l’idea e che ha pubblicato nei mesi scorsi queste pagine.
Il nostro intento era di offrire un’infarinatura di storia d’Italia a tutti coloro che ne
hanno perso memoria o non l’hanno mai avuta. Si tratta di una categoria di persone
che conosciamo bene, avendone fatto parte anche noi prima di metterci all’opera.
Non che avessimo dimenticato proprio tutto. Ma certo si trattava di ricordi confusi.
Di alcuni episodi conoscevamo il titolo, però non i particolari, che spesso ne
costituiscono l’essenza. Altri li ignoravamo completamente. Altri ancora credevamo
di conoscerli, attribuendo azioni e parole a personaggi che in realtà non le avevano
mai compiute e pronunciate. Ci è venuto il sospetto che non fossimo i soli a trovarci
in questa condizione. E, da buoni italiani, abbiamo cercato di metterci una pezza.
La nostra impressione finale è che questa Patria sia una difficile Patria, più volte
sull’orlo del baratro, più volte nel baratro precipitata, con continue riprese anche
stupefacenti, anche ammirevoli. C’è di che inorgoglirsi, ma purtroppo anche di che
vergognarsi. Un Paese esasperante, spesso scoraggiante, quasi sempre dilaniato da
emotività contrapposte e che potrebbe fare molto di più, come dicevano gli insegnanti
alle nostre mamme. E ovviamente molto di più avremmo potuto fare anche noi,
narrando questa Patria nel bene e nel male.
Dieci
L’Italia è fatta. Fra litigi, tasse e scandali cominciamo a fare gli italiani. Venezia si
concede, Roma non ancora, mentre il Sud e Torino forse hanno già cambiato idea.
17 marzo 1861
Un’Italia, anzi due
L’Italia nasce a Torino, di domenica. Battezzata dalla Camera per acclamazione e dal
Senato con due voti contrari (leghisti precoci?), la creatura viene mostrata in pubblico
per la prima volta sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 marzo 1861 con questa frase:
«Vittorio Emanuele II assume per sé ed i suoi successori il titolo di Re d’Italia».
I travagli del parto hanno attraversato le guerre d’indipendenza e l’epopea dei
Mille per sfociare nel bombardamento della fortezza di Gaeta, dove il Re borbonico
ha tentato l’ultima resistenza. Si è arreso il 13 febbraio, appena in tempo per non
turbare l’inaugurazione del primo Parlamento italiano, celebrata cinque giorni dopo
nell’aula che l’architetto Peyron ha costruito a Torino nel cortile di Palazzo
Carignano. Vittorio Emanuele vi è giunto fra due ali di folla e squilli di fanfara. E ha
letto ai 443 rappresentanti della nuova nazione il discorso preparatogli da Cavour:
«Signori senatori! Signori deputati! L’Italia confida nella virtù e nella sapienza
vostra!». Illusioni di gioventù.
Nord e Sud (all’appello mancano solo Roma e Venezia) tornano a vivere insieme.
Non accadeva dalla caduta dell’Impero romano. A deciderlo però è stata un’esigua
minoranza. Alle elezioni di gennaio ha partecipato l’1% degli italiani:
duecentoquarantamila maschi con un carico d’imposta di almeno quaranta lire.
L’Italia è fatta, ma senza i cattolici (la Chiesa ha proibito le urne ai fedeli), le donne,
gli analfabeti, i poveri e gli evasori fiscali: il restante 99%, insomma. Cavour, che ne
ha presi più di tutti, nel suo collegio ha ottenuto appena 620 voti. Ma sono le
minoranze decise a fare la Storia e, conquistato il potere, a imporla alle maggioranze
inerti come epica collettiva. Accade così che generazioni di italiani siano cresciute
nel culto di gesta alle quali il popolo aveva fatto da spettatore.
La formula battesimale allude a Vittorio Emanuele II e quel «II» la dice lunga
sull’idea che i vincitori hanno dell’Italia: non uno Stato nuovo, ma il prolungamento
di quello vecchio, le cui leggi vengono estese in modo automatico alle altre regioni,
con conseguenze disastrose soprattutto al Sud. Gli spaesati luogotenenti sabaudi,
scesi nell’ex Regno delle Due Sicilie per governarlo come una colonia, devono
appoggiarsi ai consiglieri locali e ai loro maneggi: per qualche mese ai vertici della
polizia napoletana ci sarà il capo della camorra.
Forse non si può fare meglio. Di sicuro non può farlo una Camera che pullula di
notabili meridionali, assai simili a quelli raccontati nel Gattopardo, custodi gelosi dei
propri privilegi. Da Torino a Palermo, la Destra di governo rappresenta una classe
compatta, l’alta borghesia, ed è guidata da un genio completo, Cavour. Invece la
Sinistra è divisa e anche il genio che la guida è spaccato in due: ha la testa di Mazzini
e il braccio di Garibaldi, in baruffa perpetua tra loro. La morale della favola
risorgimentale è che i democratici ne scrivono le pagine più romantiche, ma sono
sempre i moderati a incassare i diritti d’autore.
Comunque sia, oggi è domenica e l’Italia è nata. Ha una madre possessiva, la
Destra, e un padre severo, il Piemonte. Gli altri italiani devono imparare a sentirla
figlia propria. Non sarà un’impresa facile, tanto è vero che dopo centocinquant’anni
vi siamo ancora impegnati.
18 aprile 1861
Due italiani, anzi tre
Nonostante i medaglioni risorgimentali li mostrino serenamente affiancati, i Padri
della Patria non vanno d’accordo quasi su nulla. Come noi figli, del resto. Cavour non
si fida di quella testa calda di Garibaldi, pur riconoscendogli il merito di aver rivelato
al mondo che gli italiani sanno combattere. E Garibaldi disprezza quel maneggione di
Cavour, pur ammettendone la superiorità intellettuale.
L’impresa dei Mille ha scompaginato i progetti del Conte, originariamente limitati
al Nord Italia. Ma il primo ministro è un uomo pragmatico e si è subito premurato di
volgerla a proprio vantaggio. Con la scusa di imbrigliare la rivoluzione garibaldina,
che poi non è nemmeno tanto una scusa, ha spedito l’esercito sabaudo nelle terre
«liberate» del Sud. Il Generale, c’era da immaginarselo, non l’ha presa bene ed
aspetta la seduta che la Camera dedicherà all’«armata meridionale» per fargliela
pagare.
Il deputato di Napoli Giuseppe Garibaldi irrompe a Palazzo Carignano in camicia
rossa, sombrero e poncho grigio sulle spalle, fra gli applausi della Sinistra e i
sarcasmi della Destra. Il primo pensiero gentile è per il rivale seduto al banco del
governo: «Domando ai rappresentanti della Nazione se come uomo potrò mai
stringere la mano a colui che mi ha reso straniero in Italia». Allude alla cessione di
Nizza, sua città natale, escogitata da Cavour per far digerire alla Francia i plebisciti
che hanno sancito l’annessione di Emilia e Toscana al Piemonte.
Il Conte non reagisce e l’onorevole Garibaldi si sente autorizzato a continuare: «I
prodigi operati dall’armata meridionale furono offuscati solamente quando la fredda e
nemica mano di questo ministero faceva sentire i suoi effetti malefici. Quando
l’orrore di una guerra fratricida provocata da questo ministero...». Stavolta Cavour
perde le staffe:
«Non è permesso di insultarci!». Ma il Generale gli dà sulla voce: «Sì, una guerra
fratricida!».
A scontrarsi in Parlamento non sono soltanto due visioni dell’Italia, ma due tipi di
italiano. L’uno, Cavour, preparato, concreto, frequenta le élite ed ama il suo Paese
come solo può amarlo uno straniero («Meno male che abbiamo fatta l’Italia prima di
conoscerla» gli scappa detto a Firenze e chissà cosa avrebbe aggiunto, se avesse
proseguito il viaggio). L’altro, Garibaldi, improvvisatore, idealista, seduce le folle ed
ama il suo Paese come solo può amarlo un avventuriero di gran cuore.
Ciascun lettore si eserciti a trovare i loro epigoni nella storia patria. Ma non
dimentichi l’esistenza del terzo italiano, interpretato nella circostanza dal garibaldino
Nino Bixio. «Io sorgo in nome dell’Italia e della concordia!» esordisce.
E i deputati, che si stavano scannando, all’unisono gli rispondono:
«Bravo!».
Il colonnello Bixio rende omaggio a Garibaldi come soldato e a Cavour come
politico. Quindi appoggia la proposta di inquadrare le camicie rosse nell’esercito
regolare ed ottiene sul posto la promozione a generale. Alla fine il vero Padre della
Patria potrebbe essere lui. L’eterno democristiano.
29 agosto 1862
Garibaldi fu ferito
Due anni dopo la grande impresa, il primo dei Mille decide di tornare in Sicilia.
Nessuno sa esattamente perché, forse nemmeno lui. Ai compagni di traversata
confida:
«Andiamo verso l’ignoto, sarà quel che sarà». Durante un bagno di folla a Marsala
sente echeggiare «O Roma o morte!» e lo slogan, destinato a diventare lo «Yes we
can» italiano, gli schiarisce le idee: risalirà il Sud liberato per invadere il Lazio,
ultima ridotta del potere temporale del Papa.
Comincia a reclutare volontari e i soldati piemontesi di stanza nell’isola lo lasciano
fare. Un atteggiamento ambiguo che alimenta le voci secondo cui Garibaldi agirebbe
in combutta col Re e col nuovo primo ministro Urbano Rattazzi, che dopo la morte
improvvisa di Cavour si sforza di imitarne le mosse senza possederne il talento
acrobatico.
Le camicie rosse si impadroniscono di due piroscafi e salpano verso il continente.
Quando l’ammiraglio Albini, che incrocia nello stretto di Messina, telegrafa al
ministro Persano per avere lumi, ottiene una risposta che è un piccolo capolavoro di
italianità: «Agite a seconda dell’occasione, ma tenete sempre presente il bene del
Paese». E quale sarà questo bene? Nel dubbio l’ammiraglio gira la testa dall’altra
parte ed i garibaldini approdano indisturbati in Calabria, dove però sono accolti a
fucilate: evidentemente lì l’esercito ha ricevuto altri ordini.
Gli «irregolari», ammesso che sia lecito chiamarli così (in fondo due anni prima il
Sud lo hanno liberato loro), si rifugiano sull’Aspromonte e saccheggiano per fame un
campo di patate. Qui vengono sorpresi da un reparto di bersaglieri. Garibaldi non
vuole la guerra civile. Avanza da solo incontro ai soldati regi, la mano destra sull’elsa
della sciabola. Gli sparano addosso. La prima pallottola lo colpisce a una coscia, la
seconda si conficca nel malleolo. «Andate fuori, gridando viva l’Italia!» ordina alle
camicie rosse, prima di accasciarsi. Nella mischia rimangono sul terreno dodici
uomini: italiani uccisi da italiani.
Il Generale viene appoggiato a un pino (che esiste ancora), in bocca ha il solito
mezzo toscano. Sarà il colonnello Pallavicini ad arrestarlo, ma solo dopo avergli fatto
il saluto militare. La marcia dei bersaglieri che tanti di noi hanno storpiato a scuola
per imparare le vocali («Garibaldi fu ferito...») trae origine da quell’episodio
inglorioso.
A Londra una manifestazione di protesta raccoglie centomila persone. Con grande
sprezzo del ridicolo, il governo di Torino premia i feritori di Garibaldi e promuove
Pallavicini generale. Il ministro Persano, che è all’origine del pasticcio, resta ancorato
alla poltrona. In compenso invita l’ammiraglio Albini a dare le dimissioni. Li
ritroveremo entrambi nel disastro di Lissa. L’Italia è appena cominciata, ma si
assomiglia già.
25 luglio 1864
Briganti e pentiti
Anche l’Italia ha avuto il suo Afghanistan e non se lo ricorda più. Quella che lo Stato
combatte contro i briganti è una guerra vera, con migliaia di morti e crudeltà inaudite
da ambo le parti. Per vincerla il generale Cialdini deve trattare il Meridione alla
stregua di una provincia occupata, passando per le armi chiunque possegga un fucile.
Il forte piemontese di Finestrelle si trasforma in un teatro di torture come
Guantanamo e il professor Lombroso studia i teschi dei briganti uccisi per cercare le
prove scientifiche dell’attitudine di certi uomini al male. I briganti, dal canto loro,
usano i teschi dei bersaglieri a mo’ di boccali per le libagioni. La geografia del Sud
viene devastata per sempre boschi sterminati diventano deserti. Ma anche la Storia
non si riprenderà mai completamente: per molti meridionalisti il brigantaggio
conserva tuttora i caratteri dell’epopea.
Il «Braveheart» nostrano sarebbe Carmine Crocco, contadino lucano la cui
famiglia è stata distrutta dai soprusi di un signorotto locale: il padre in galera senza
aver fatto nulla, la madre incinta picchiata a morte. Quando un altro prepotente della
zona sfregia in volto la sorella Rosina, colpevole di averlo respinto, Carmine lo
uccide e si dà alla macchia. Nel 1860 combatte per i Mille di Garibaldi, che gli ha
promesso l’amnistia. Invece, cacciati i Borboni, il nuovo Stato unitario non lo premia.
Anzi, lo fa arrestare.
Sentendosi vittima dell’ennesima ingiustizia, Crocco evade, passa al nemico e,
grazie al carisma e a doti indubbie di stratega, diventa il generalissimo della
Resistenza. Nei piemontesi, più che degli invasori, vede gli alleati dei signorotti che
gli hanno distrutto la vita: i cosiddetti «galantuomini» che hanno pilotato l’annessione
del Sud all’Italia per conservare i loro privilegi.
Le sue bande sono foraggiate dal Re di Napoli in esilio, benedette dai preti e
ingrossate dalla sciagurata decisione del governo italiano di non inquadrare gli ex
soldati borbonici nell’esercito regolare. I congedati si trasferiscono armi e bagagli
presso i briganti, che seminano il panico dalla Basilicata alla Calabria. Occorreranno
tre anni e un tradimento per domarli: Crocco s’innamora della donna del suo braccio
destro, Caruso, il quale per vendetta si trasforma nel primo pentito dell’Italia Unita,
indicando ai piemontesi il covo del «terrorista».
Il 25 luglio 1864 Crocco viene snidato dal generale Pallavicini, quello
dell’Aspromonte, e costretto a combattere sulle rive dell’Ofanto una battaglia
definitiva. Catturato, la sua condanna a morte sarà commutata nei lavori forzati a vita.
L’Italia dei «galantuomini» esce dall’incubo, però le menti più lucide non possono
fare a meno di porsi l’interrogativo che agita Massimo D’Azeglio: «Ma [i
meridionali] ci vogliono o no? Io so che di qua dal Tronto non ci servono 60
battaglioni, mentre di là sì. E pare che non bastino».
21 settembre 1864
«Torinesi, crié nen»
La colpa è dei giornalisti, come sempre. Alle due del pomeriggio esce la «Gazzetta
di Torino» con un articolo che rivela i contenuti della Convenzione appena firmata
dai governi francese ed italiano. Il primo accetta di sloggiare da Roma in cambio di
un analogo impegno sabaudo a non occuparla, suggellato dalla scelta immediata di
una nuova capitale al posto di Torino, ma alternativa alla Città Eterna: Firenze.
L’articolo non si limita a dare la notizia. Sostiene che è buona. La gente s’aggira
furibonda con il giornale fra le mani. «Se almeno non si chiamasse “di Torino”.
Andiamo a staccargli l’insegna».
La rivolta comincia così. La dipingeranno come un episodio di campanilismo, ma a
protestare in piazza San Carlo sono anzitutto i ministeriali che temono di perdere il
posto: quei Monsù Travet (signor Travicello) che l’anno precedente hanno fischiato a
teatro la prima dell’omonima commedia di Vittorio Bersezio, ritenendola lesiva del
loro onore di impiegati statali.
Davanti alla sede della «Gazzetta» va in scena il prologo di un dramma vero:
pietre, tafferugli, qualche contuso. Poi tutti a far ressa sotto casa del sindaco:
«Torinesi, crié nen», non gridate, esordisce il marchese di Rorà affacciato al balcone.
«Parla italiano, siamo italiani». «Torinesi, voi avevate un gioiello». «Ce l’hanno
rubato, assassini!» «Un gioiello, dicevo: la fama di popolo tranquillo e civile». «Che
gusto matto prendersela coi giornalisti» insinua uno, probabilmente un giornalista.
«La colpa è del governo. Abbasso i ministri!»
Il malumore trasloca così in piazza Castello, sotto l’ufficio del ministro Peruzzi:
toscano e come tale sospettato di aver ordito lo scippo. All’improvviso un drappello
di carabinieri esce dal palazzo e spara a casaccio sulla folla: dodici morti, quaranta
feriti. Ma i torinesi non scappano. Si fanno sotto ai carabinieri, urlando: «Tira,
carogna! Tira, caplòn! [cappellone]».
Il giorno dopo i contestatori sono cresciuti di numero. Scrive il De Sanctis,
testimone oculare: «Il popolo mantiene un aspetto di tristezza taciturna che fa paura».
In piazza San Carlo avviene la più assurda delle carneficine. Guardie e carabinieri si
sparano fra loro, entrambi convinti di rispondere al fuoco inesistente dei dimostranti,
e lasciano sul selciato decine di vittime raggruppate al centro della piazza sotto la
statua di Emanuele Filiberto (il Caval d’Brôns).
Il Re si rende conto di aver sottovalutato gli effetti del cambio di capitale ed offre
ai concittadini lo scalpo del presidente del Consiglio Minghetti, emiliano, affidando il
governo al piemontese La Marmora. In seguito visiterà i feriti e assegnerà una
pensione agli orfani. Ma nessun gesto potrà lenire un trauma che non è mai stato
davvero superato. Il lamento, molto torinese, secondo cui ogni cosa che nasce a
Torino viene prima o poi deportata altrove, è cominciato lì.
20 luglio 1866
«Daghe dosso che la ciapèmo!»
La terza guerra d’indipendenza parte male e continua peggio. A Custoza, vicino
Verona, gli italiani perdono una battaglia che gli austriaci non si erano neanche
accorti di aver vinto. Il generale La Marmora si ritira rovinosamente, mentre il
collega Cialdini, che lo detesta, rimane accampato dalle parti di Modena con l’altra
metà dell’esercito, senza degnarsi di accorrere in suo aiuto.
L’umiliazione è grande, immediata la necessità di riscatto. Agostino Depretis,
futuro presidente del Consiglio, viene spedito ad Ancona per convincere l’ammiraglio
Persano ad abbandonare gli atteggiamenti da crocierista e passare all’azione. Un bel
tipo, questo Persano. Più abile a maneggiare la politica che il timone. Servile con i
superiori almeno quanto è arrogante con i sottoposti, obbedisce controvoglia e
trascina la sua flotta all’arrembaggio dell’isolotto di Lissa, litigando quasi subito con
i due vice, Albini e Vacca.
La mattina del 20 luglio, ecco profilarsi all’orizzonte le navi austriache. Sono
meno delle nostre e peggio equipaggiate. Ma piene di veneti. Anche chi le comanda,
Tegetthoff, ha imparato il mestiere a Venezia ed è in dialetto che impartisce gli ordini
al capo timoniere Vincenzo Vianello. «Daghe dosso, Nino, che la ciapèmo!» gli urla,
appena vede l’ammiraglia italiana in difficoltà.
Vianello la manda a fondo e il capitano della Re d’Italia, Emilio Faà di Bruno, si
rifiuta di abbandonare la nave colpita a morte. Persano, invece, è già saltato da tempo
su un altro scafo per dare l’unico ordine che gli riesca spontaneo: la ritirata. La flotta
italiana perde due imbarcazioni e seicentoventi persone, quella austriaca solo
trentotto. «Uomini di ferro su navi di legno hanno battuto uomini di legno su navi di
ferro» annuncia Tegetthoff ai propri marinai, che lanciano il berretto in aria, al grido
di «Viva San Marco!».
La crociata per la liberazione del Veneto è stata affondata dai veneti. Ed è soltanto
il primo schiaffo. Il secondo arriva alla fine della guerra quando l’Austria, battuta
certo non per merito nostro, si rassegna a cedere Venezia. Ma non a noi. Alla Francia,
che a sua volta la trasferisce all’Italia. Napoleone III ci scherza su: «Questi italiani!
Ancora una sconfitta e mi chiederanno Parigi».
Secondo un costume collaudato, Persano assurge a capro espiatorio: processato e
degradato. A giusto coronamento dell’impresa, i giornali rivelano una storia di
tangenti nella costruzione delle navi.
L’unico a salvare la faccia è il solito Garibaldi, spedito sui monti del Trentino con i
suoi volontari male in arnese. Trionfa a Bezzecca ed è ormai a un passo da Trento
quando viene fermato dal telegramma di La Marmora che gli ordina di interrompere
le ostilità. La sua è una delle risposte più sofferte e sintetiche della storia:
«Obbedisco». Un soldato vero, lui.
1 settembre 1867
La penna e lo schioppo
È la data di pubblicazione del romanzo Le confessioni di un italiano di Ippolito
Nievo, che l’aveva scritto dieci anni prima. Nievo è scomparso in mare nel 1861 nel
naufragio di un piccolo e malconcio vapore tra Palermo e Napoli, i cui resti non
furono mai ritrovati. Aveva 27 anni e un cospicuo passato letterario, ma la sua fama è
dovuta alle Confessioni, romanzo «di formazione» dove il piccolo Carlino racconta le
prime esperienze di vita nel castello di Fratta, in Friuli.
Qui, fra torrette e torrioni, merli e ponti levatoi, è tuttavia dominante l’immensa
cucina, la cui descrizione era ritenuta indispensabile dai compilatori di sussidiari.
Giustamente, perché Nievo l’arreda con misteriosi chiaroscuri, vasti armadi, un
caminetto monumentale; e la illustra con memorabili incisioni: di cuoche, servette,
preti di vario rango, cavallanti, gente d’armi, sguatteri, una piccola folla in continuo
movimento, dove Carlino trova sempre un angolo buio e qualche osso da rosicchiare.
È infatti un parente povero dei conti di Fratta che lo tengono per compassione, ma
nella vita di questo trascurato monello entra improvvisamente l’amore. La Pisana,
figlia della contessa e cugina di Carlino, è una bambina con un paio d’anni meno di
lui e diventa la sua crudele e generosa padrona. Ha già tutte le arti seduttive di una
donna fatale, capricciosissima, affettuosa, civetta, imperiosa. Carlino subisce i suoi
rimbrotti e le sue bizzarrie, si vede preferire certi ragazzetti azzimati dei castelli
circostanti, piange di rabbia e gelosia, sopporta, ama. A10 anni la Pisana è una delle
più affascinanti creature femminili della nostra letteratura.
Nievo è sì un letterato ma anche un autentico patriota, un eroe risorgimentale. Alto,
bellissimo, semitrasparente (come egli stesso si definisce), uno di quegli uomini di
penna e d’azione non rari nella nostra storia. Combatte con Garibaldi nella seconda
guerra di indipendenza e quando ha notizia che il Generale tenterà una spedizione in
Sicilia non esita a presentarsi a Quarto.
Gli viene affidata la cassa del piccolo esercito, quarantamila lire. Della lunga
traversata ci ha lasciato note telegrafiche fino allo sbarco a Marsala. Lo scontro di
Calatafimi, dove con grande ansietà deve abbandonare la sua cassetta
nell’accampamento per prendere lo schioppo e correre all’assalto, il mese di marce e
contromarce diurne e notturne stanno in poche righe. Combatte a Palermo, viene
nominato colonnello, comincia una guerra estenuante coi burocrati scesi da Torino.
Il Generale è accusato di finanza allegra e Nievo è costretto a stendere
minuziosissimi e impeccabili rendiconti. Gli concedono una licenza nell’amato Friuli,
torna a Palermo, mette a punto le ultime precisazioni contabili e, pur di andarsene,
s’imbarca su quella carretta inaffidabile. E sparisce per sempre.
3 novembre 1867
Né Roma né morte
Garibaldi è alle prese con un nuovo nemico: l’età. Combatte l’ansia di invecchiare
mettendo al mondo un’altra figlia e infiammando gli italiani con la sua bella voce in
una serie di comizi che hanno un solo traguardo, Roma, e un solo bersaglio, il Papato,
«negazione di Dio», «vivaio di vipere» e «pestilenziale istituzione», amen.
Fosse un politico, tutto si esaurirebbe in qualche titolo di giornale. Ma Garibaldi è
uomo d’azione. L’accordo stipulato con la Francia impedisce all’Italia di invadere lo
Stato Pontificio, però nulla dice a proposito di un’eventuale rivolta dall’interno. E
proprio a quella pensa il Generale. «Alla rinfrescata muoveremo» annuncia alle
camicie rosse, nel dar loro appuntamento per l’autunno.
Come al solito, il Re e Rattazzi sembrano tenergli bordone. Poi però si spaventano
del loro stesso ardire e lo spediscono agli arresti domiciliari nel suo eremo di Caprera.
Ma Garibaldi ha mille risorse. Nella notte una specie di canoa passa silenziosa
accanto alle navi da guerra che presidiano l’isola. Sopra, un uomo con la barba tinta
di nero e un remo fra le mani insidiate dall’artrite. È lui. Sbarcato alla Maddalena, i
suoi lo traghettano in continente al comando delle truppe. Basterà un segnale della
quinta colonna garibaldina nascosta in città e i romani si ribelleranno in massa alla
«pestilenziale istituzione», spalancando le porte del Campidoglio ai liberatori.
La solita illusione. La quinta colonna il segnale lo dà: a Villa Glori, dove Enrico e
Giovanni Cairoli cadono sotto il fuoco papalino e vanno ad aggiungere i loro nomi
alla lista della famiglia più martirizzata del Risorgimento. Ma i romani non si
muovono. Piove, fa freddo. E a Civitavecchia è appena sbarcata la fanteria di
Napoleone III. Garibaldi insiste: occupa Monterotondo e accende i falò sulle alture
per farsi vedere dagli abitanti dell’Urbe. Immagina che adesso, sapendolo così vicino,
insorgeranno. Invece non ci pensano proprio. Da millenni hanno un fiuto infallibile
per i vincitori. E il carro giusto su cui saltare ha ancora la targa francese.
Quando anche i mazziniani abbandonano la partita, Garibaldi è costretto ad
arretrare verso gli Appennini, ma il 3 novembre 1867 viene raggiunto a Mentana
dall’esercito pontificio del generale Hermann Kanzler. Nell’attacco alla baionetta le
camicie rosse reggono l’urto, però di rincalzo ai papalini arrivano i francesi, dotati di
fucili nuovissimi: gli chassepot. Napoleone III darà a essi il merito della vittoria, e
mal gliene incoglierà perché quegli aggeggi, che si inceppano sempre e si
surriscaldano subito, lo tradiranno nel 1870 a Sedan.
Garibaldi, lui, si sente tradito da tutti: il Re, il governo, Mazzini, i romani, il
mondo intero. Meglio la morte. Mentre i suoi uomini, che non valgono i Mille,
sbandano davanti agli chassepot, è colto da un delirio autodistruttivo e decide di
lanciarsi all’attacco da solo. Lo salva il fedele Stefano Canzio afferrando il morso del
suo cavallo. «Per chi vuol farsi ammazzare, Generale?» Già, per chi?
7 gennaio 1869
La tassa sulla fame
Quando le campane a stormo lo tirano giù dal letto, il possidente Astorre Sassoli,
vicesindaco di San Giovanni in Persiceto, non riesce a credere ai propri occhi:
popolani in piazza, nei vicoli, ovunque. Agitano minacciosamente i forconi, gridando
«Viva Pio IX! A morte i signori!». Nella mischia il vicesindaco riconosce l’arciprete,
che da anni si rifiuta di dir messa nei giorni delle feste patriottiche, il sarto Zaccaria
Lodi soprannominato Bell’Uccello per motivi che qui non staremo a indagare, il
calzolaio Gaetano Cotti detto Cutarèn. Ma quanti sono? Quattromila. Ed è stato
l’appetito a trascinarli fin lì.
Il 1° gennaio è entrata in vigore la tassa sul macinato: due lire per ogni quintale di
grano e una lira per il granturco e la segale con cui si impasta il pane della miseria.
Da subito battezzata «la tassa più impopolare di ogni tempo». Un record che,
nonostante la concorrenza agguerrita, detiene tuttora.
A imporla è stato il ministro delle Finanze Cambray-Digny, che cerca di tamponare
la voragine provocata al bilancio dello Stato dalle guerre risorgimentali. Ma a subirla
sono i poveri dei paesi, per i quali significa fame certa. Poiché il governo ha fatto la
tassa però non i contatori per misurarla, i mugnai vengono investiti del ruolo odioso
di esattori. Se ne sottraggono chiudendo i mulini. Morsi dalla fame e sobillati dai
parroci, i contadini si sollevano dappertutto. L’epicentro è l’Emilia e l’epicentro
dell’epicentro si trova sotto le finestre dell’Astorre Sassoli.
Dalla prefettura di Bologna gli suggeriscono di ammansire i ribelli, proponendo
una dilazione nel pagamento. Ma a mezzogiorno in punto, come nei western,
irrompono gli abitanti della frazione di San Matteo della Decima, armati di schioppi e
forconi. Entrano in municipio, bruciano gli archivi delle tasse e della leva. Poi si
dedicano alla casa del vicesindaco, non prima di averlo preso a bastonate. Arraffano
soldi, posate d’oro e botti di vino, spillandole fino all’ultima goccia.
L’arrivo dei bersaglieri di Cadorna affoga la rivolta in un bagno di sangue: dieci
morti, fra cui una ragazza (in tutta Italia le vittime saranno 257). L’arciprete si rintana
in sacrestia come se niente fosse, ma il clero rimane l’ispiratore morale dei moti.
L’unico, dal momento che mazziniani e anarchici prendono le distanze dai «brutti
fatti di Persiceto», e condannano «l’infausto trambusto de’ contadini». Democratica o
extraparlamentare che sia, la Sinistra dell’epoca afferma di agire in nome del popolo,
ma lo conosce così poco da non comprenderne i bisogni reali. Un vizio che forse non
si è mai tolta completamente di dosso.
15 giugno 1869
Lobbia e bastone
Alla ricerca disperata di denaro fresco, il ministro Cambray-Digny lancia la
privatizzazione della Regia (Monopolio) dei tabacchi, a cui vanamente si oppone
l’uomo che presto lo sostituirà alla guida dell’economia italiana: Quintino Sella.
L’appalto viene assegnato a un «pool» di banche straniere, ma dietro una di esse c’è
il finanziere livornese Pietro Bastogi, già accusato d’aver corrotto politici e giornalisti
per l’acquisto delle Ferrovie Meridionali.
Dai banchi della Sinistra si leva l’onorevole Cristiano Lobbia, un ingegnere di
Asiago che ha partecipato alla spedizione dei Mille. Accusa sessanta parlamentari
della maggioranza di «conflitto d’interesse». Sui giornali si scatenano le voci più
incredibili: persino il Re avrebbe intascato una mazzetta di sei milioni. Quando lo
scandalo sta per assopirsi, Lobbia lo rilancia con un gesto teatrale: sventola alla
Camera una busta che conterrebbe le prove della corruzione dell’onorevole Civinini,
ex garibaldino come lui.
Il Parlamento di Firenze (la capitale adesso abita lì) nomina una commissione
d’inchiesta, che convoca Lobbia per la mattina del 16 giugno. Ma la sera del 15 il
deputato è aggredito per strada da uno sconosciuto che gli tira una bastonata in testa e
lo ferisce al petto con un pugnale. L’Italia si incendia, Milano è attraversata da cortei
che invocano «mani pulite», la stampa di sinistra accusa il governo di aver tentato di
sopprimere l’avversario (Garibaldi parla di «tempi borgiani») e quella di destra
rinfaccia a Lobbia di essersi inventato l’agguato pur di evitare l’udienza della
commissione, dove si sarebbe scoperto che le sue accuse a Civinini erano un bluff.
Ad avvalorare la tesi del complotto, un testimone muore prima di poter deporre. E
il presunto attentatore, un palermitano, viene trovato affogato nell’Arno. L’ultimo
colpo di teatro arriva dalla magistratura, che trasforma la denuncia presentata da
Lobbia in un processo contro di lui per simulazione.
Il giorno della sentenza, il deputato di Asiago si presenta in aula con la bombetta
che indossava al momento dell’aggressione, mostrando l’impronta lasciatavi dal
bastone. Sarà condannato egualmente. Solo molti anni dopo otterrà un’assoluzione
per insufficienza di prove. E la commissione d’inchiesta sulla vendita del
Monopolio? Svanita nel nulla.
A trarre vantaggio dallo scandalo è solo un cappellaio di Firenze, che sfrutta la
popolarità della bombetta ammaccata per mettere in vendita «i cappelli alla Lobbia».
Una trovata che consegna il nome del moralizzatore ai posteri, ma per motivi assai
diversi da quelli che lui si sarebbe aspettato.
Venti
Roma capitale, Sinistra al governo: cambia tutto o magari niente. Un rivoluzionario
si traveste da prete, un barrocciaio da Cristo. É morto un Re se ne pugnala un altro.
20 settembre 1870
Con chi comanda
Breccia di Porta Pia, Roma capitale d’Italia. Ma la data decisiva è il 1° settembre. A
Sedan l’imperatore francese Napoleone III (detto «il Piccolo» da Victor Hugo) viene
sconfitto dai prussiani, contro i quali s’è lasciato incautamente trascinare in guerra.
Abdica e se ne va in esilio, e con lui la sua benevola protezione sullo Stato Pontificio.
A Firenze, capitale provvisoria, nessuno è così cieco da non vedere la grande
occasione: si può prendere Roma, finalmente.
Si organizza con la massima fretta un corpo di spedizione con numerosi reggimenti
di fanteria, cavalleria, bersaglieri, treni di artiglieria. Troppo? Ma le forze papaline
non sono misere, ci sono zuavi, svizzeri, italiani, mercenari di varia provenienza e
non si sa che tipo di resistenza abbia in mente il Papa (Pio IX). Farebbe bene a cedere
senza sparare un colpo, ma potrebbe anche decidere di combattere fino all’ultimo
uomo.
Il confine viene passato pacificamente, le lunghe colonne italiane marciano tra
contadini incuriositi, a volte plaudenti. Ma quando arrivano in vista della città tutte le
porte sono sbarrate e fortificate. Possibile che non ci siano trattative segrete?
Impossibile. Ma il Papa ci tiene a mostrare che il suo antichissimo regno è stato preso
con la forza. Sarà così Porta Pia a fare le spese di questo scontro simbolico.
Una batteria italiana comincia a picchiare sulla barricata mentre dai casolari e dai
villini sulle colline della Nomentana una folla di curiosi, di nobili, di giornalisti
assiste all’evento. Fuoco, fiamme, rombo di cannoni, fitta e intermittente fucileria,
ma infine una breccia si apre, i nostri entrano di corsa, ci sono ancora spari isolati e
poi tutto finisce. (I morti però non sono simbolici: cadono in 68, 49 italiani e 19
pontifici.)
All’interno della città nessuna resistenza, anzi. In poche ore spuntano da tutti i
balconi le bandiere tricolori, una folla sempre più entusiastica festeggia i «liberatori».
Il Papa si è chiuso nei palazzi vaticani, teme di essere malmenato, chiede protezione
ai suoi nemici che gli mandano un battaglione in piazza San Pietro. La folla intanto
cresce, soprattutto i bersaglieri diventano oggetto di conquista. Tutti vogliono una
penna come souvenir, i giovani militari spennacchiati si arrampicano su e giù per il
Colosseo. Baci, abbracci, canti, vino in abbondanza.
Le truppe papaline vengono frattanto fatte uscire alla chetichella dalle mura e
spedite a Civitavecchia. Di loro i romani raccontano storie di soprusi e violenze non
si sa quanto autentiche. Edmondo De Amicis, lì come inviato, è travolto da tanto
esuberante, frenetico patriottismo. Ma non manca di registrare la filosofica rassegnata
risposta di un popolano: «Noi stiamo con chi comanda».
2 luglio 1871
Il Papa non è Re
Vittorio Emanuele II fa il suo ingresso trionfale a Roma. Di tutti i volti che
compongono il corteo, il meno entusiasta è di gran lunga il suo. Si sente in colpa
verso Pio IX, che dopo la breccia di Porta Pia ha scomunicato tutto lo scomunicabile
e s’atteggia a prigioniero politico fra le mura del Vaticano. Inoltre il Re è totalmente
refrattario al fascino dell’Urbe. Ai maestri del cerimoniale che gli propongono di
salire in Campidoglio con l’elmo di Scipio risponde che «quello è buono solo per
cuocerci la pastasciutta».
I poeti di corte hanno il loro daffare nell’infondere un’epica al trasloco: arrivano a
trasformare il «Finalment ij suma» («Finalmente ci siamo»), che Vittorio borbotta in
piemontese all’amico La Marmora quando la carrozza varca per la prima volta il
portone del Quirinale, nell’aulico «Ci siamo e ci resteremo». Ma un sovrano così
allergico alla retorica non sarebbe mai stato in grado di pronunciare una frase simile
senza mettersi a ridere.
Il governo italiano, presieduto da Giovanni Lanza con il formidabile Quintino Sella
alle Finanze, ha invano fatto precedere il trasferimento a Roma dalla legge delle
Guarentigie, che concede alla Chiesa una serie di prerogative ed un appannaggio più
che discreto. Pio IX respinge in blocco «quei futili privilegi e immunità che
volgarmente sono detti guarentigie», rifiuta i «trenta denari» e proclama che «nessuna
conciliazione sarà mai possibile fra Cristo e Belial, luce e tenebre, verità e
menzogna». Non importa che la Sinistra anticlericale abbia criticato la regalia,
ritenendola troppo benevola verso la Santa Sede. Per il Papa «fra Destra e Sinistra
esiste la stessa differenza che passa fra il colera e il terremoto». Pio IX proibisce ai
cattolici di farsi infettare dal morbo della politica e addita loro l’Italia non come una
Patria da conquistare ma come un invasore da abbattere. La mancanza di senso dello
Stato, che è il male endemico del nostro Paese, ha radici lontane.
Mentre il Re prende possesso controvoglia delle stanze del Quirinale (appena può
scappa dalla Rosina, che per non dare troppo scandalo ha sistemato in un villino sulla
Nomentana), negli appartamenti vaticani Pio IX continua a fare la vittima,
dipingendo se stesso come «un povero senzatetto in cerca di un piccolo angolo di
terra».
Pur di riavere il potere temporale, non esita a rivolgersi al luterano Bismarck, che
gli propone di trasferire la sede del Papato a Berlino. Agli amici esterrefatti il
Cancelliere di ferro spiega che si tratterebbe di un ottimo sistema per ripristinare
l’unità religiosa in Germania. «Infatti è mia ferma convinzione che il giorno in cui i
cattolici tedeschi conoscessero questo Papa da vicino si convertirebbero in massa al
protestantesimo».
22 maggio 1873
Manzoni, chi era costui?
Muore Alessandro Manzoni, a 87 anni. Pochi giorni prima è andato a messa nella
chiesa di San Fedele, vicinissima a casa sua, e uscendo è scivolato e ha battuto la
testa su uno scalino. Un banale incidente, ma un amico racconta che un mese prima
l’aveva visto molto indebolito e taciturno, incapace ormai di sistemare i ciocchi sul
fuoco, operazione di cui era gelosissimo.
La sua è stata una vita di straordinaria intensità, anche se per noi la sua immagine
resta quella di uno scrittore appartato, schivo, silenzioso, sommerso dai libri della sua
immensa cultura. Di lui tutti ricordano le serate di «conversazione», la sua voce
affabile, lieve, amica, i suoi discorsi che non cedono mai al minimo luogo comune.
Eppure questo vecchio gentiluomo milanese così compìto e sorridente è passato
per tutte le fondamentali esperienze del suo tempo, i circoli illuministi, neoclassicisti,
romantici, le polemiche sulla lingua, sulla tragedia, sul romanzo storico, le imprese di
Napoleone, la Repubblica Cisalpina, l’occupazione austriaca, i primi moti
risorgimentali.
In gioventù è stato un ateo irridente, aderendo poi a una religiosità ferma ma non
fanatica che ne fa un modello di cattolico liberale. Oltre a mettere al mondo un
numero considerevole di figli, scrive moltissimo, lettere e saggi teorici, tragedie,
poemi e poemetti, inni, traduzioni. Senza partecipare a congiure e società segrete,
crede appassionatamente nell’ideale dell’unità italiana. Sotto la guida, per lui l’unica
possibile, dei Savoia e del Piemonte.
Passa lunghi periodi nella villa di Brusuglio, ereditata dall’amante della madre
Giulia Beccaria, e cura amorosamente le sue terre, si fa prendere dalla voga dei bachi
da seta. Passeggia lungo il lago Maggiore col suo amico Antonio Rosmini, discute,
progetta, torna accanitamente allo scrittoio. Un grande intellettuale, certo, di cui però
oggi solo pochi eruditi studierebbero «Ei fu siccome immobile» e «Sparsa le trecce
morbide». Ma da questo instancabile sperimentatore, attraverso una gestazione
interminabile, nasce infine il romanzo supremo della letteratura italiana, I Promessi
Sposi. Opera raffinatissima, di «genere» e nello stesso tempo testo scolastico
immediato, un classico. Letto e riletto, le sapienti spirali di quella prosa non cessano
mai d’incantarci.
Nel primo anniversario della morte viene eseguito il Requiem che Giuseppe Verdi
ha composto per lui. Ma non c’è italiano, o almeno si spera, che non si chieda ancora
sorridendo «Carneade? Chi era costui?».
25 giugno 1873
Scrivania di Stato
È il giorno, sempre rimpianto dagli italiani per bene, in cui Quintino Sella si congeda
dalla sua creatura prediletta: il ministero delle Finanze. Nel palazzo che egli stesso ha
fatto edificare accanto a Porta Pia cigolano per l’ultima volta i suoi scarponi da
montanaro.
L’economista biellese svuota la scrivania che gli è stata regalata dai maestri d’ascia
della sua città, resistendo alla tentazione di portarsela via pur di non lasciarla al rivale
di partito Minghetti, il quale con una manovra parlamentare lo ha appena costretto
alle dimissioni. Il mobile rimarrà al suo posto, fino a diventare il simbolo dello Stato
italiano. «L’unico bene pubblico che non venderei mai» ha detto Giulio Tremonti,
l’ultimo dei tanti ministri economici che in un secolo e mezzo hanno dovuto
misurarsi con quel fantasma gigantesco.
Mentre si aggira per la stanza cercando il cappellone a cencio con cui è solito
ricoprire la testa quadrata, Sella non smette di pensare alle due ossessioni politiche
della sua vita: Roma capitale ed il pareggio di bilancio. La prima meta è stata
raggiunta, la seconda soltanto sfiorata. Quando ha illustrato alla Camera la madre di
tutte le Finanziarie - l’Omnibus - si è attirato l’ostilità generale. I deputati di Destra e
Sinistra hanno in comune l’allergia alle tasse ed una passione autentica per le spese,
specie quelle militari, apprezzate anche dal Re, che chiama Sella «mercante di panni»
per via delle sue industrie laniere.
Come sempre il ministro ha fatto un discorso chiaro e pieno di numeri certificati:
dall’Unità ad oggi abbiamo compiuto sforzi giganteschi, portando da 16 mila a 50
mila i chilometri del telegrafo e da 2200 a 6200 quelli delle strade ferrate. Ma
l’edificazione di uno Stato ha un costo elevato e nonostante la vendita dei beni
ecclesiastici, l’inasprimento del balzello sul macinato e l’invenzione del Lotto («la
tassa sugli allocchi») il disavanzo supera i duecento milioni. Per appianarlo occorre
emettere nuova moneta e istituire altre imposte indirette: sui trasporti, sul registro e
sul bollo. Servono «economie fino all’osso».
La Camera ha approvato solo una parte della cura dimagrante. È stato l’inizio di
una guerriglia sorda, giunta al suo culmine in questo inizio d’estate del 1873. Quando
Sella ha riproposto l’imposta sul registro e Minghetti, anziché sostenerlo, ha
presentato un ordine del giorno assai ambiguo, in cui ogni discussione nel merito
veniva rinviata alla riapertura autunnale. Capita l’antifona, il ministro delle Finanze si
è dimesso con tutto il governo.
Ha trovato il cappello, finalmente. Sulla porta lo aspetta il suo direttore generale:
un piemontese di poche parole anche lui, che Sella ha assunto come segretario e poi
innalzato al grado più alto della burocrazia. Per costringerlo ad affinare ulteriormente
il dono della sintesi, d’inverno lo ha sempre ricevuto in ufficio con le finestre aperte.
Escono insieme dal palazzo, ma il più giovane è destinato a tornarci e a fermarvisi a
lungo, molto a lungo. Il suo nome è Giovanni Giolitti.
6 agosto 1874
Fuochino a Bologna
In una via di un quartiere popolare di Bologna arriva una sgangherata carrozza e un
prete male in arnese, biondiccio, molto alto e corpulento, fa per salirvi. Ma è troppo
grosso e tra predellino e sportello resta incastrato, metà dentro e metà fuori. Monelli e
curiosi fanno cerchio, ridono, sbeffeggiano. Alcuni notano che dalla tonaca spuntano
pantaloni borghesi. Il prete si dibatte ridendo e riesce finalmente a entrare nel veicolo.
Il vetturino parte di slancio e per strade e stradine secondarie porta fuori dall’Emilia
Michail Bakunin, il grande rivoluzionario russo che fugge da Bologna.
C’era arrivato giorni prima, convinto dai suoi fedelissimi seguàci anarchici a
capeggiare da quella città l’inizio della rivoluzione mondiale. È celebre in tutta
Europa come lo sarà Che Guevara. Non ha un soldo e vive a Locarno ozioso e
malinconico, carico di debiti. È accorso in tutte le città d’Europa in rivolta. È stato
sulle barricate di tutte le cause, ma ha sempre fallito. Ora, al tramonto, arriva da lui
Carlo Cafiero, altro iscritto all’Internazionale, che gli mette a disposizione la propria
cospicua fortuna di possidente pugliese.
Comprano una villa sulla collina, piantano, seminano, aprono la porta ai
«compagni» che da tutta Europa vengono a chiedere aiuto. Si forma una Comune di
stravaganti relitti che spendono e spandono senza limiti, litigando furiosamente sulle
possibilità della rivoluzione mondiale. Si chiamano Socialisti internazionali e odiano,
ricambiati, Karl Marx.
Dopo un paio d’anni la situazione si fa insostenibile e gli emissari di Bakunin in
Emilia lo informano che l’iniqua tassa sul macinato sta facendo di nuovo ribollire il
popolo. Un grande capo li potrebbe guidare all’insurrezione, e di lì, città dopo città...
Bakunin, stufo della Comune, che del resto si dissolve da sé, corre a Bologna e si
nasconde in casa di fidatissimi Internazionali, dove prepara un piano minuzioso per
prendere con le armi la città. Da Empoli arriveranno cinquecento compagni, un
gruppo minore assalterà il forte di San Luca sulla collina e bombarderà Bologna. E
qui, con venti uomini pronti a tutto, Bakunin in persona accenderà la scintilla.
Nulla funziona, naturalmente, come racconta accuratamente Riccardo Bacchelli nel
suo trattato storico Il diavolo al Ponte Lungo. Gli imolesi vengono bloccati su un
ponte dai carabinieri e arrestati coi loro pochi schioppi e forconi e con le bandiere
rosse prese ai ferrovieri di due stazioncine lungo la strada; il colpo di mano al forte
fallisce; i venti eroi di piazza Maggiore non si presentano. Bakunin torna a
nascondersi, vorrebbe farsi ammazzare, ma poi si taglia baffi e barba, si tinge i capelli
e, travestito da prete, fugge in Svizzera, dove morirà in casa di un amico.
18 marzo 1876
Rivoluzione all’italiana
L’ultimo governo della Destra cade alla Camera (242 voti a 181) su un ordine del
giorno che oggi apparterrebbe a un programma di sinistra: la statalizzazione delle
ferrovie. Il partito che fu di D’Azeglio e Cavour se ne va per esaurimento della
missione: unificare il Paese (con le armi e con le leggi) e mettere a posto i conti dello
Stato. Proprio due giorni prima della fine, il presidente del Consiglio Minghetti ha
potuto annunciare il sospirato pareggio di bilancio. Impresa mastodontica, realizzata
pur fra tanti errori da una classe dirigente che ha tassato sanguinosamente la
popolazione, ma solo dopo essersi ridotta al minimo lo stipendio. Una pratica di cui si
perderà presto memoria.
Certo, come in tutte le consorterie che rimangono per troppo tempo al potere, la
corruzione si è annidata anche lì: in una seduta memorabile l’ex magistrato Tajani ha
mostrato ai deputati le prove della connivenza del questore di Palermo con la mafia.
Ad accelerare la chiusura del ciclo contribuisce poi la crisi del libero scambio. Le
ultime scoperte scientifiche hanno abbattuto i costi dei trasporti internazionali e
rovesciato sull’Europa le derrate americane a basso prezzo, dirottando i rari capitali
dall’agricoltura (non più conveniente) all’industria. E un’industria che nasce ha
bisogno dei dazi per crescere e rafforzarsi. Ha bisogno, cioè, di una politica
protezionista che la Destra non ha i titoli per svolgere.
Il capo dell’opposizione Agostino Depretis riceve dal Re l’incarico di formare il
nuovo gabinetto. Ma la «rivoluzione parlamentare», come subito la battezzano i
giornali, sarà tutto tranne che rivoluzionaria. Al governo arrivano i notabili della
Sinistra garibaldina, legati anch’essi alla borghesia conservatrice ed alle clientele
meridionali. Il loro programma è imperniato sulla moralità, l’istruzione elementare
obbligatoria, l’abolizione della tassa sul macinato e il diritto di voto esteso a tutti i
maschi in grado di leggere e scrivere. Lo realizzeranno solo in minima parte, pur
rimanendo al potere per un ventennio, che in Italia non si nega a nessuno.
Rispetto ai fratelli siamesi della Destra si caratterizzeranno per una minore
efficienza amministrativa, una politica estera più avventurosa e una certa propensione
al populismo, che li esporrà talvolta, soprattutto con Crispi, a tentazioni autoritarie.
Quanto alla moralità, ecco cosa scriverà vent’anni più tardi Gaetano Salvemini:
«Andati al potere, i sinistri mangiarono più che poterono. I destri avevano mangiato
anch’essi, e appaiono onesti perché non dovettero sbalzare nessuno dal posto
occupato; ma i sinistri - va loro resa questa lode - mangiarono molto di più».
17 gennaio 1878
Nel nome dei Padri
«Giungeva il carro funebre, carico di corone, dopo aver percorso Roma sotto una
pioggia di fiori, tra il silenzio di una immensa moltitudine addolorata, preceduto da
una legione di generali e da una folla di ministri e di principi, seguito da un corteo di
mutilati, da una selva di bandiere, dagli inviati di trecento città, da tutto ciò che
rappresenta la potenza e la gloria d’un popolo, giungeva dinanzi al tempio augusto
dove l’aspettava la tomba».
Paragonata ad altre cronache dei funerali di Vittorio Emanuele II, morto di
broncopolmonite a 58 anni, quella di Edmondo De Amicis brilla per asciuttezza. Aedi
improvvisati sciolgono inni al «veltro dantesco» e «al più valoroso dei Maccabei».
Però la commozione è sincera, come il silenzio della folla che accompagna la bara:
gli applausi al feretro non erano ancora stati inventati. Unici a fare stecca nel coro, i
giornali austriaci propongono di far incidere sulla tomba il seguente epitaffio: «Qui
giace un Re cui tutto tornò vantaggioso, anche le disfatte». Di preti in corteo se ne
vedono soltanto due: il cappellano di corte e un suo collega che davanti al Pantheon
gli grida «venduto».
Vittorio Emanuele è il terzo campione del Risorgimento a congedarsi dai suoi
contemporanei per entrare nella storia e negli stradari delle città. Il primo era stato
Cavour, stroncato dalla malaria nell’agosto 1861, a Italia appena fatta e a soli 51 anni.
Torino aveva chiuso per lutto, ma il resto del Paese non se n’era quasi accorto: lo
considerava, non del tutto a torto, uno straniero.
Dopo il miglior cervello, la miglior coscienza: Giuseppe Mazzini, spentosi a Pisa il
10 marzo 1872. «È l’Italia che ho sognato? È dunque una parodia?» aveva scritto
quel grafomane in una delle ultime lettere. Di sicuro era e rimane una nazione
melodrammatica, che ha sempre considerato con fastidio le personalità rigorose.
Infatti ai suoi funerali non c’era nessuno. Non i potenti, che lo volevano in galera. E
tanto meno il popolo, che non aveva gli strumenti per capirlo, a cominciare
dall’alfabeto.
L’ultimo Padre della Patria a lasciarla orfana sarà il più popolare: Garibaldi, morto
a Caprera nel giugno 1882, quattro anni e mezzo dopo il suo Re. Obbediti da tanti in
vita, entrambi non sono esauditi al momento della morte. Vittorio vorrebbe essere
sepolto a Superga come i suoi avi, invece finisce a Roma, al Pantheon. E invano il
mangiapreti Garibaldi lascia disposizioni per la propria cremazione. Viene
imbalsamato «al fine di non offendere i sentimenti religiosi del popolo».
Si scomoderanno i paragoni con Cesare e la retorica sommergerà il dolore. Ma
dolore ve ne sarà, e autentico. Perché malgrado i suoi difetti, o proprio in virtù di essi,
Garibaldi è l’unico protagonista del Risorgimento ad avergli saputo infondere una
dimensione epica.
18 agosto 1878
Il barrocciaio mistico
Un migliaio di persone scende dal monte Amiata verso il paese di Arcidosso. È gente
poverissima: contadini, carbonai, braccianti, carrettieri. Cantano inni religiosi,
portano croci, labari, stendardi e tutti vestono costumi variamente colorati. Sono i
seguàci del Cristo dei Poveri, Davide Lazzaretti, un omone amiatino che è in testa
alla processione.
Ha una cinquantina d’anni, indossa un maglione rosso che reca sul petto una croce
con due C maiuscole, a destra e a sinistra, a simboleggiare il primo e il secondo
Cristo, cioè lui stesso. In capo ha un bizzarro cappello coloratissimo e piumato.
A metà discesa un delegato di pubblica sicurezza in cilindro e un drappello di
carabinieri ordinano al profeta di retrocedere. Lazzaretti si ferma con parole di pace.
Ma vola qualche sasso, il delegato, colpito, spara sull’inerme antagonista e lo manca
due volte. I militari fanno fuoco sulla folla disarmata (tre morti) e infine un
bersagliere aggregato appoggia il fucile sulla spalla di un carabiniere, spara e colpisce
Lazzaretti in piena fronte. La folla non reagisce, si disperde, ma il delegato ordina
ugualmente di arrestare una quarantina di seguàci, descritti come una turba
minacciosa e ciecamente fedele al suo capo carismatico.
Tra i possidenti e le autorità locali, nonché in Vaticano, si tira un sospiro di
sollievo, perché da anni Lazzaretti è un ingombro imbarazzante. Nato in una famiglia
di barocciai, mestiere che lui stesso praticherà saltuariamente, l’uomo dell’Armata
riesce, con l’aiuto di alcuni preti di campagna, a farsi una sua cultura approssimativa.
Comincia a scrivere testi religiosi, filosofici, proclami e programmi, abbandona
moglie e figli in condizioni miserrime e si fa eremita in diversi luoghi d’Italia e di
Francia.
Prega, digiuna, ha continue visioni mistiche, ma a poco a poco la sua predicazione
si rivela irresistibile. Tra debiti, cambiali, donazioni più o meno spontanee, compera
terre nei dintorni e fonda una comunità agricola. Abolisce la proprietà privata, lui
stesso divide i profitti tra i settari. Sparisce per mesi, poi ritorna più convinto di prima
di essere la reincarnazione di Cristo.
Viene arrestato due volte e sempre assolto. San Giovanni Bosco lo stima e lo
ospita. Chi è in realtà? Un furbo imbroglione o un vero profeta? Un incantatore di
gonzi o un mattoide unto dal Signore? Fa erigere una torre sul monte Labbro (mai
finita) e da qui partirà l’ultima processione verso Arcidosso e i fucili delle forze
dell’ordine. Nessuno indaga sul bersagliere che ha sparato: il suo corpo verrà trovato
in un vicolo di Livorno anni dopo, pugnalato a morte.
4 novembre 1878
Il Vate e l’Aquilotta
L’Italia ha un Vate. Leopardi e Manzoni non arrivano al ruolo per ragioni diverse. Il
solo a cantare la bellezza e grandezza della Patria è un professore di Bologna, Giosuè
Carducci. Tra i suoi ammiratori c’è la donna più affascinante del regno: Margherita,
la Regina. Carducci è fieramente repubblicano. Ma quando, nel novembre 1878,
Margherita va in visita a Bologna vuole assolutamente conoscerlo, lo riceve e lo
incanta. Gli occhi azzurri, i capelli biondi, il sorriso gentile, i modi affabili travolgono
il poeta che le dedica l’Ode alla Regina d’Italia.
Viene invitato a Gressoney, in Val d’Aosta. Il professore s’inchina e sale tra le
dentate e scintillanti vette. La sua ammirazione non ha più limiti, la Regina non solo è
una deliziosa conversatrice, ma è intelligentissima e ha capito le sue Odi barbare ben
meglio di tanti critici. Dopo il colloquio ridiscende ormai convinto: l’Unità d’Italia,
malgrado gli argomenti dei suoi amici repubblicani, non si poteva realizzare senza
Casa Savoia.
La conversione del Vate fa scandalo, ma non stupisce. Si calcola che oltre
duecento tra poeti e romanzieri abbiano dedicato versi e prose all’Aquilotta. Di madre
tedesca, il padre è però il duca di Genova e quindi la giovane donna può dirsi Savoia
due volte quando sposa suo cugino, il principe ereditario Umberto, nel 1868. Tra i
due non c’è amore, ma grande stima e rispetto. Lui è un soldato con interessi da
soldato; lei adora le feste, i tornei in costume, e ha una passione per la cultura di cui
però non resta traccia nelle lettere private, piene di svarioni e sgrammaticature.
È soprattutto la Regina delle pubbliche relazioni: quando muore Vittorio Emanuele
II e suo marito diventa Umberto I, trasforma il Quirinale in un ambito centro
intellettuale. L’ex primo ministro Minghetti le insegna il latino, il romanziere
cattolico Fogazzaro è di casa (non lo scandaloso d’Annunzio).
Non fa politica, non ha influenza sul Re Buono (...a nulla, dice una malalingua). È
religiosissima, il suo gran cruccio è l’insanabile dissidio con il Vaticano. Fa molta
beneficenza, accorre ovunque ci siano terremoti o inondazioni, il popolo la venera
come solo avverrà con Lady Diana.
È una leggenda, un mito. Quando le uccidono il marito nell’attentato di Monza
cede il passo alla nuova regina Elena e dopo il lutto riapre casa in una villa romana.
Ha qualche dubbio circa l’entrata in guerra nel 1915, ma poi prevale l’«Avanti
Savoia», la Patria. Lascerà Gressoney, si stabilirà in una villa a Bordighera. Riceverà
i quadrumviri che preparano il colpo di Stato fascista e si stupirà che il rozzo tribuno
Mussolini abbia con lei modi da perfetto gentleman. Morirà nel 1926, rimpianta da
molti italiani.
17 novembre 1878
L’amaro lucano
I Reali sono in visita a Napoli. La loro carrozza, nella quale siede anche il presidente
del Consiglio Benedetto Cairoli, procede lentamente in mezzo alla bolgia. Al largo
della Carriera Grande un giovane balza sul predellino. Dal suo fazzoletto rosso, su cui
ha inciso lo slogan «Morte al Re, viva la Repubblica universale!», sbuca un coltellino
di 8 centimetri. È con quell’arma, perfetta per sbucciare le mele, che il cuoco lucano
Giovanni Passanante colpisce Umberto I a un braccio.
«Cairoli, salvi il Re!» urla la Regina, lanciando un mazzo di fiori addosso
all’aggressore. Il primo ministro, vecchio garibaldino, afferra Passanante per i capelli
e rimedia una stilettata alla coscia destra, mentre il capitano dei corazzieri atterra il
cuoco con una sciabolata. L’episodio è minimo, l’eco enorme. Il giorno dopo a
Firenze, durante un corteo di ringraziamento per lo scampato pericolo, scoppia un
ordigno che uccide quattro persone, tra cui una ragazzina.
I giornali strillano al complotto e indicano negli anarchici i «terroristi» da
stroncare. Passanante viene torturato con ferri roventi affinché sveli un piano che non
c’è. La madre ed i fratelli sono internati in manicomio. Solo un giovane poeta
romagnolo declama in pubblico un’ode in suo onore («Con la berretta del cuoco
faremo una bandiera») e finisce in carcere. Si chiama Giovanni Pascoli.
Nonostante il comportamento eroico di Cairoli, il governo è travolto. La Destra,
per bocca dell’onorevole Bonghi (grande amico di Manzoni), invoca limitazioni alla
libertà di stampa e di insegnamento nelle scuole. A lui replica il ministro
dell’Istruzione, Francesco De Sanctis, con uno dei discorsi più belli di tutta la storia
parlamentare:
«Quando la reazione ci viene a far visita non dice “Io sono la reazione”. Tutte le
reazioni sono venute con questo linguaggio: che è necessaria la vera libertà, che
bisogna ricostituire l’ordine morale».
Parole nobili. E inutili: il ministero Cairoli cade. L’unico a mantenere un distacco
ironico è re Umberto, che a cena raccomanda ai suoi commensali di non far aspettare
i cuochi:
«Avete visto di cosa sono capaci».
Passanante, riconosciuto sano di mente, è condannato a morte e poi ai lavori forzati
a vita. Sepolto in un buco a Portoferraio con una catena di diciotto chili a straziargli
l’esile corpo, impazzisce effettivamente. Non avrà pace neppure dopo la morte: la sua
testa sarà tagliata e analizzata per studiare la «tendenza all’anarchia» che Cesare
Lombroso individua in una fossetta dietro l’osso occipitale. Solo nel 2007 i resti del
cuoco troveranno riposo nel cimitero lucano di Salvia, che per «sfuggire il disonore»
di avergli dato i natali ha dovuto cambiare nome in Savoia.
Trenta
C’era una volta: un burattino, un kamikaze, una maestra vittima di maldicenze, una
politica che oscillava fra trasformismo e pulsioni autoritarie. Quella c’è ancora.
7 luglio 1881
Un pezzo di legno
In un fumoso caffè fiorentino si radunano ogni giorno uomini di penna e pennello,
giornalisti, pittori, caricaturisti, pamphlettisti, piccoli editori. Molti di loro hanno
combattuto volontari nelle guerre di indipendenza, hanno sbeffeggiato il Granduca e
la sua censura; ma ora regna la pace, la capitale è ormai a Roma, ci si lascia andare ai
ricordi, ai rimpianti, alle burle ed al buon vino.
È un gruppo di allegri compari che fa pensare all’atmosfera di Amici miei, il film di
Monicelli, dove prevalgono le battute, gli scherzi un po’ facili, i paradossi. Ma in
mezzo a questa bonaria mediocrità c’è un genio, che non sa di esserlo, come non lo
sanno i suoi amici.
Ha scritto numerosi romanzi per bambini di notevole successo, collabora a diversi
giornaletti locali e ha appena pubblicato su «Il giornale per ragazzi» la prima puntata
di una «bambinata», così la chiama lui, che racconta le avventure di un burattino di
legno. È Carlo Lorenzini, in arte Collodi, che nei mesi successivi dà séguito alle
peripezie del suo personaggio che saranno infine pubblicate in volume. È nato
Pinocchio e nessuno se ne accorge.
Dovranno passare trent’anni prima che un critico francese, su una rivista francese,
ne riconosca la grandezza, e solo nel 1937 Benedetto Croce lo definirà un capolavoro
assoluto, sia pure nella «minore» letteratura per l’infanzia. La popolarità della
«bambinata» cresce esponenzialmente; Pinocchio viene tradotto in tutte le lingue del
mondo, recitato, filmato, telefilmato, illustrato in tutti i possibili modi e oggi fa
definitivamente parte del nostro universo mentale.
La lingua di Collodi è mirabilmente asciutta, il ritmo è di fuga, di corsa sfrenata,
gioiosa, golosa, terrorizzata, da una sorpresa all’altra. I personaggi sono simbolici,
ma hanno la presenza e la durata degli antichi miti: il grillo, la lumachina, il gatto e la
volpe, la fatina, i quattro conigli neri, i ciuchini del Paese dei Balocchi appaiono un
istante ma restano poi come scolpiti sul portale di una cattedrale.
I bambini parteggiano tutti per Pinocchio che, come loro, è nel fondo buono, ma
non sa resistere alle tentazioni più effimere. I suoi rimpianti, i suoi rimorsi, le sue
promesse, i suoi pentimenti sono sincerissimi, ma lo spirito d’avventura prevale
sempre. È un credulone ed un bugiardo, un traditore ed un figlio amoroso. È insomma
un uomo completo in cui possiamo - e dobbiamo - specchiarci senza ipocrisie.
È vero, non abbiamo avuto Emma Bovary e nemmeno Raskolnikov, ma Pinocchio
col suo irresistibile naso è lì tra loro, per sempre.
20 dicembre 1882
Kamikaze a Nord-Est
Qual è il confine tra fanatismo e martirio? Una linea sottile, che forse ha a che fare
con la purezza di cuore. Un martire paga sempre di persona e non coinvolge mai nelle
sue trame delle vittime innocenti.
In una caserma della Trieste austriaca, dove oggi sorge il mausoleo a lui dedicato,
un ragazzo di 24 anni, pallido e biondo, sale sul patibolo con un sorriso irreale.
Mentre la corda del boia gli cinge il collo, grida: «Evviva l’Italia! Evviva Trieste
libera!». Si chiama Wilhelm Oberdank ed è il figlio illegittimo di una slovena di
Gorizia, che lo ha avuto da un soldato veneto dell’esercito imperiale. Anche Wilhelm
è chiamato a servire l’Austria, ma diserta durante l’occupazione di Sarajevo per non
sparare addosso ai bosniaci in lotta per l’indipendenza.
Fugge a Roma, italianizzando il suo nome in Guglielmo Oberdan. Imbevuto di
irredentismo, dopo la morte di Garibaldi si convince che solo un gesto clamoroso
potrà «risvegliare l’animo dei giovani dal loro vergognoso torpore». Decide che quel
gesto lo compirà lui, lanciandosi come una bomba umana contro l’imperatore
Francesco Giuseppe, il marito di Sissi, atteso a Trieste per i cinquecento anni
dell’annessione della città all’Impero. Ma, proprio alla vigilia dell’attentato, un
traditore consegna l’aspirante kamikaze ai gendarmi di Monfalcone.
I romantici di tutta Europa si infiammano. Victor Hugo scrive a Francesco
Giuseppe per chiedere la grazia. Gli risponde Giosuè Carducci: «Perdoni il grande
poeta, ma Oberdan non è un condannato. È un martire. Egli andò non per uccidere,
ma per essere ucciso». E va a finire proprio così: Oberdan giustiziato, Carducci
tonante contro «l’imperatore degli impiccati» e le piazze italiane in subbuglio.
Le manifestazioni di protesta sono soffocate dal governo con un certo imbarazzo.
A maggio di quello stesso anno la Sinistra al potere ha ribaltato la tradizionale
politica estera dell’Italia, staccandola dall’influenza della Francia (che ci aveva
soffiato la Tunisia) per legarla alle sorti di Austria e Germania con un accordo
chiamato Triplice Alleanza.
Le clausole del trattato verranno rese note soltanto dopo la prima guerra mondiale
(e l’ennesimo cambio di campo). Ma, a scanso di equivoci, il cancelliere tedesco
Bismarck chiarisce subito i ruoli. «La via fra Roma e Vienna passa da Berlino»
dichiara, attribuendosi il bastone del comando.
La considerazione che nutre per il nostro esercito è racchiusa in una battuta
sprezzante: «Questi italiani hanno ottimo appetito, ma pessimi denti. L’unico
contributo che mi aspetto da loro è un caporale con la bandiera, un tamburino, e la
fronte rivolta verso la Francia invece che verso l’Austria».
La fronte di Oberdan si è dunque girata dalla parte sbagliata. Ma svetta così alta e
fiera che davanti a essa anche Bismarck deve trangugiare un borbottio di
ammirazione.
11 maggio 1883
Il primo inciucio
In un dibattito alla Camera rimasto famoso, i politici mettono ai voti la loro parola
preferita: «trasformismo». L’ha coniata nel 1876 Agostino Depretis, al momento di
formare il primo governo della Sinistra vittoriosa: «Spero di poter facilitare quella
feconda trasformazione dei partiti...». Il presidente del Consiglio ha ribadito il
concetto durante la campagna elettorale del 1882, con spudoratezza anche maggiore:
«Noi siamo progressisti. Ma se qualcun altro vuol trasformarsi e diventar
progressista, posso io respingerlo?». È così che ha trasformato la Destra di Minghetti
in un’alleata.
L’idea di assorbire i moderati dello schieramento avverso e costruire un Grande
Centro governativo che isoli le Estreme non è nuova. L’aveva già avuta il «destro»
Cavour, alleandosi col «sinistro» Rattazzi per dar vita al «connubio», che altro non
era che trasformismo sostenuto da un ideale: unire le forze per unire l’Italia.
Depretis ha ambizioni più modeste: tirare a campare. Ma in quest’arte esercita un
talento straordinario, da democristiano ante litteram. Ecco come lo descrive il
cronista parlamentare Petruccelli della Gattina: «Affabile, piaggiatore, familiare con
tutti, promette sempre, promette tutto. La sua vocazione è crear dissensi, scompigliare
partiti, gualcire caratteri. Egli è nato malfattore politico come si nasce poeta o ladro».
E Silvio Spaventa, nel tesserne l’elogio, non trova di meglio che paragonarlo a «un
cesso che resta pulito, sebbene ogni immondezza vi passi».
Gran corruttore d’uomini, personalmente Depretis è integerrimo: vive in una
soffitta e morirà senza lasciare né averi né debiti. Autentico professionista del rinvio,
sulla sua scrivania si affastellano cumuli di pratiche inevase. «Ognuna di esse avrei
dovuto deciderla entro le ventiquattro ore, se non volevo mandare in rovina l’Italia»
racconta nelle interviste. «Le ventiquattro ore sono passate, la pratica è sempre lì e
l’Italia va avanti lo stesso».
Il dibattito parlamentare sul trasformismo è un’iniziativa del ministro Giuseppe
Zanardelli, padre del Codice penale. Persona degnissima, è tormentato da un dubbio
amletico: «Ma è la Destra che è diventata progressista o la Sinistra conservatrice?». Il
«destro» trasformato Marco Minghetti gli risponde con un’altra domanda: «Dov’è
oggi il principio che ci separa?». Dai banchi dell’estrema esplode l’indignazione del
tribuno Felice Cavallotti: «Ben vengano le trasformazioni, ma le grandi, ma le vere!
Non quella che avviene in questo momento e che sa di putredine».
Al banco del governo, Depretis si limita a far ondeggiare la barba bianca, che tiene
lunghissima, come i maghi delle favole. Si procede dunque al voto. I favorevoli al
trasformismo sono 348, i contrari appena 29. L’Italia ha scelto con chiarezza da che
parte stare: in mezzo. Il puro Zanardelli si dimette da ministro e si trasforma anche
lui, ma in un disoccupato.
8 settembre 1884
Vedi Napoli...
«La via dei Mercanti, l’avete percorsa tutta? Sarà larga dieci palmi, tanto che le
carrozze non ci possono passare ed è sinuosa, si torce come un budello, le case
altissime la immergono, durante le più belle giornate, in una luce scialba e morta: nel
mezzo della via il ruscello è nero, fetido, non si muove, impantanato: è fatto di
liscivia e di saponata rancida, una miscela fetente che imputridisce».
Così Matilde Serao, napoletana, eccellente scrittrice e giornalista, si rivolge al
primo ministro Depretis che ha appena fatto una visita ricognitiva in città. Non ne
può più, la Serao, della «retorichetta» a base di «mare glauco e cielo di cobalto, di
golfo e colline fiorite» e rovescia sul capo del governo una descrizione terrificante di
quello che è l’autentico ventre di Napoli con l’aggiunta del colera. Perché il colera è
arrivato in Italia. Florence Nightingale, la leggendaria Signora con la lampada,
sospetta un nesso tra il male e le condizioni igieniche, e anche la Croce rossa diffida
della sporcizia in cui sono immersi molti quartieri delle città europee.
Questa volta sembra sia stata una nave dalla Birmania a portare il flagello in
Francia, e di lì, attraverso gli operai frontalieri, in Piemonte. Il primo caso accertato è
a Saluzzo, in breve l’epidemia si diffonde in tutta Italia. Non c’è Bertolaso, ma le
autorità ricorrono all’esercito: fanti, alpini, bersaglieri. Ogni città o quasi viene chiusa
da un cordone sanitario e dotata di un lazzaretto, i soldati si accampano fuori dalle
mura, nessuno può entrare o uscire.
Quando il colera arriva a Napoli è subito strage, considerate le condizioni
purulente descritte dalla Serao. I morti sono migliaia, re Umberto visita i «bassi»
senza risparmiarsi. Il colpevole è un vibrione, visibile al microscopio, che si trasmette
attraverso acqua inquinata, vongole, cozze. Ma nonostante l’invettiva di Manzoni
sulla caccia agli «untori» della peste, anche qui si riproduce lo stesso superstizioso e
sinistro terrore. Sono i forestieri, sono i soldati a portare il morbo. Scoppiano tumulti
e scontri. E, beninteso, accuse contro il governo che non fa il suo dovere. Il colera si
lascerà dietro trentamila vittime.
«È che il vicolo è sporco di natura. Ha mille buchi e in ognuno di essi, di notte, c’è
sempre un occhio d’animale che sorveglia. Se piove diventa un “lavinaio”. Se va in
secco ci crescono ogni genere di bestie. E tutte vorrebbero entrare a farvi visita: cani,
gatti, topi, lumache, lucertole, ragni, vermi, scarafaggi, serpenti, mosche, moschilli e
zanzare. Sono queste che portano i peli e le ali, le farfalline della malattia. Altro che
cozze!»
È ancora uno scrittore napoletano che parla, Domenico Rea. Ma adesso siamo nel
1973. Novant’anni dopo. Il vibrione del colera è tornato, a cavallo di qualche cozza.
O di qualche ragno, mosca, zanzara, fate voi. Simbolo di un Paese dove, dagli
scandali alle epidemie, tutto passa e mai niente davvero se ne va.
6 giugno 1886
Povera Italia
In un paesino sui monti attorno a Pistoia un corteo funebre si avvia al cimitero. In
testa due preti, poi la bara con una corona di rose e ginestre, poi una decina di
bambine. Nessun altro, né uomini, né donne, né ragazze. L’intero paese di Porciano,
l’infame Porciano, è rimasto in casa per desiderio della morta.
La morta è la maestrina Italia Donati. È arrivata in paese un paio d’anni prima,
guadagna quarantacinque lire al mese con cui mantiene, oltre a se stessa, tutta la
famiglia che abita a pochi chilometri. Prende alloggio in casa del sindaco dove, al
piano di sotto, ha sede anche la scuoletta. Ha 20 anni, ha entusiasmo, è gentile ed
affabile. Ma ha un difetto fatale: è bella.
Immediatamente cominciano i pettegolezzi. Al sindaco, bell’uomo con barbetta
bionda, che vive disinvoltamente con la moglie ed un’amante, viene attribuita anche
la conquista della maestrina. Poi si mormora del figlio del sindaco. Poi si sussurra del
brigadiere dei carabinieri. La povera Italia è oggetto continuo di sorrisetti, allusioni,
insinuazioni, talvolta di insulti aperti.
La ragazza chiede il trasferimento; le assegnano una scuola in un paesetto
vicinissimo che comunque, per bocca del sindaco, rifiuta «lo scarto di Porciano».
Italia non ha amici, nessuno che la difenda e allora chiede lei stessa un esame clinico
ufficiale sulla propria verginità. Medico e ostetrica confermano e la cosa viene
annunciata in consiglio comunale.
Non siamo in uno sperduto villaggio africano, non siamo nel Medioevo, ma nella
civilissima Toscana, culla del Rinascimento, terra di grandi personaggi che hanno
dato gloria e fama all’Italia. Ma Italia, la maestrina, non esce dal cerchio infernale del
gossip. Ricominciano le voci, i sospetti, le certezze assolute che stavolta sia incinta.
Troppo pallida, troppo sciupata e trasandata.
La ragazza è alla disperazione. Scrive alcune lettere, poi si allontana dal paese
verso il mulino, raggiunge una specie di piccolo stagno fangoso tra due pareti di
roccia, lascia in terra il grembiule rosso e si getta nell’acqua. Una donna di passaggio
riconosce il grembiule, sospetta il peggio e quando lo stagno viene lentamente
svuotato, appare infatti la sagoma nera della maestrina, morta per difendere il suo
onore.
In una delle lettere chiede un’altra perizia sulla propria illibatezza e di essere
sepolta nel malandato cimitero, senza la partecipazione degli infami. Sulla lapide, in
vernice rossa, le sole iniziali I D. Non c’è una vera inchiesta, nessuno è indagato, tutti
giurano di essere stati suoi amici, il parroco ammette di aver sentito quelle
maldicenze e di non avergli dato peso: erano solo voci di paese.
10 giugno 1886
Il bambino talpa
La frana di una zolfara a Campobello di Licata, nell’Agrigentino, rivela un mondo
sommerso: fra i centoquarantadue morti si contano decine di bimbi denutriti con la
schiena curva e spellata. Sono i «carusi», piccoli schiavi usati per trasportare lo zolfo
lungo le strettissime gallerie.
I picconieri li comprano a 8 anni nelle campagne, versando ai genitori
centocinquanta lire in farina di frumento. Il caruso lavora dalle quattro del mattino
alle quattro del pomeriggio, sei giorni la settimana. Il settimo lo passa a deambulare
fra i cactus in cerca d’acqua. Per guadagnare la cifra necessaria a ricomprarsi la
libertà non gli basta a volte tutta la giovinezza: sempre che riesca ad arrivarci vivo.
La legge vieta il lavoro in miniera sotto i 15 anni, però nessuno ci bada e quando
Angeleddu, che di anni ne ha 9, viene ucciso a calci nello stomaco dal suo padrone
per aver tentato la fuga, il suo caso è archiviato dalla magistratura come morte
naturale.
I primi giornalisti che si avventurano lungo i gradini scivolosi delle miniere
sentono dei gemiti ritmati. Sono i lamenti dei carusi che salgono verso la luce,
incalzati da un picconiere che per farli marciare più in fretta scotta i talloni degli
schiavetti con una lucerna. Completamente nudi, lo sguardo reso ebete dalle
privazioni, i bimbi trascinano sulle spalle i sacchi pieni di zolfo.
Uno di essi, un biondino, si accascia a metà della via crucis: «Sugnu tantu stancu
cca nun ci la fazzu cchiù a purtari lu saccu e stai pi jttarlu ‘nterra» mormora ad un
compagno di sventura, mentre le lacrime solcano le guance incavate. Il suo cesto pesa
non meno di venti chili. Prova a spingerlo in qualche modo fino alla bocca torrida
della galleria. Grondante di sudore, gli esili muscoli contratti sotto quel carico
immane, il caruso esce finalmente all’aria aperta, dov’è accolto da un vento gelido
che lo stronca del tutto. Ad aspettarlo ci sono un pezzo di pane ed una cipolla.
Quando va bene, un giaciglio duro dentro qualche grotta. Altrimenti si sdraia nudo
sotto le stelle.
Chissà a cosa pensa, ammesso che abbia ancora la forza di pensare. Per lui la vita è
quella cosa lì. Non ne conosce altre. In fondo il padrone condivide il suo stesso
incubo: l’adulto strappa il minerale alla roccia e il bambino lo trasporta in superficie.
Nella seconda metà dell’Ottocento, l’industria estrattiva dello zolfo è una delle poche
voci in attivo della bilancia commerciale italiana. Ma sono soldi che urlano, anche se
nessuno li ascolta. La vergogna dei carusi si trascinerà da una commissione
d’inchiesta all’altra, fino al secondo dopoguerra, quando le miniere siciliane non
riusciranno più a reggere la concorrenza di quelle americane e verranno chiuse per
sempre.
18 ottobre 1886
Cuore
Esce il libro Cuore di Edmondo De Amicis. Attesissimo, data la fama dell’autore e
delle sue numerose opere narrative, di viaggi, di inchieste. Sede tradizionale dei
sentimenti amorosi e degli affetti più teneri, il Cuore deamicisiano è in realtà un libro
fondamentale sull’Unità d’Italia.
La struttura è geniale: il piccolo Enrico, alunno di terza elementare in una scuola
torinese, viene riportando mese per mese quanto accade a lui e ai suoi compagni;
trascrive via via il racconto mensile che detta il maestro, raccoglie le numerose lettere
minacciosamente esortative che gli scrivono il padre, la madre e la sorella; dà conto
di piccoli viaggi e di visite a Torino e dintorni e non fa mancare nulla al lettore in
fatto di promesse, buoni propositi e buoni sentimenti.
Lo scenario cittadino s’intravede appena, forse deliberatamente, ma i personaggi
sono nitidissimi, memorabili, subito proverbiali. C’è la maestrina della penna rossa,
c’è il vecchio maestro in pensione, c’è il cattivissimo sogghignante Franti, il
compagno snob, il trafficante nato, il figlio dell’alcolista, il buonissimo Garrone e
così via. Ogni bambino, o quasi, è originario di una diversa regione d’Italia e la classe
finisce per essere un esempio di melting-pot riuscito.
Anche i racconti mensili hanno protagonisti di varie «etnie», il tamburino sardo, la
piccola vedetta lombarda, il piccolo scrivano fiorentino. Storie edificanti che vanno
dritte, appunto, al cuore. Il libro è un successo trionfale, non solo in Italia. Fa
piangere molto e non solo le anime più sensibili. L’avventura del bambino che
attraversa tutta l’Argentina in cerca di sua madre mette a dura prova le ghiandole
lacrimali. Ma oggi è facile sbeffeggiare questo libro di sincera propaganda patriottica,
fonte inesauribile di luoghi comuni, scherzi, parodie, cucinato e ricucinato dal cinema
e dalla TV, con risultati non sempre ridicoli.
Poco o nulla di quel mondo è rimasto in piedi, prevalgono problemi scolastici
d’apparenza insolubile, violenza, bullismo, droga, impoverimento generale del
semplice sapere. Ma anche se non si può dire che De Amicis avesse previsto tutto,
conosceva bene l’umana natura e si sforzava di gettare tra quei pesanti banchi di
legno i semi del coraggio, della lealtà, della solidarietà, della sincerità, pur sempre
utili alla convivenza.
Con molte lacrime, senza dubbio. Ma la sua vita privata in qualche modo ve lo
costringeva. Un matrimonio che tenne segreto per anni, perfino a sua madre, un figlio
suicida prima di un esame universitario e gli ultimi anni col figlio superstite, a
percorrere tutte le sere la stessa via, fino allo stesso ristorante ed allo stesso tavolo. Al
ritorno cambiava marciapiede.
26 gennaio 1887
Termopili d’Africa
Su una collina che costeggia il torrente Dogali in Eritrea, cinquecento soldati
italiani sono circondati da diecimila abissini pronti a sterminarli. Ma cosa ci fanno lì,
chi ve li ha mandati e perché?
Tutto è cominciato due anni prima con l’occupazione del porto di Massaua sul Mar
Rosso, dove l’Italia è andata a cercare nientemeno che «le chiavi del Mediterraneo»,
uno slogan che non significa nulla e quindi è destinato a imperitura fortuna. Lo ha
coniato il ministro degli Esteri Pasquale Stanislao Mancini, noto ai giornali
d’opposizione soprattutto per le sue disavventure coniugali. Sorpreso dalla moglie nel
letto della cameriera, si è difeso così: «Perdonami, cara, al buio l’avevo scambiata per
te». Non potendo licenziare il marito, la signora ha licenziato la cameriera.
Il colonialismo è una necessità per le nazioni a caccia di nuovi mercati, ma solo
una moda per quelle, come l’Italia, che esportano soprattutto emigranti. I
Cinquecento di Dogali vengono assaliti dalle orde di Ras Alula, padrone di Asmara,
mentre sono in marcia verso la fortezza assediata di Saati. La disparità delle forze non
concede speranze. Gli italiani si dispongono a quadrato e combattono fino all’ultima
cartuccia. Finita anche quella, useranno i fucili come bastoni.
La solita Italia, avventata nei politici e negli alti comandi, ma eroica nei suoi
soldati e ufficiali. L’ultimo a cadere è il tenente colonnello De Cristoforis, che non
avendo più armi, lancia contro il nemico una scatola di carne in conserva. Al
massacro sopravvivono in pochi. Il capitano Michelini vaga per il deserto con tre
palle nella schiena. Un caporale si finge morto e quando gli abissini, per sincerarsene,
gli ficcano la bacchetta di un fucile dentro il naso e glielo squarciano, riesce a non
urlare e si salva.
L’opinione pubblica, che all’epoca si riduce a qualche salotto e a qualche foglio di
giornale, chiede la rivincita delle «Termopili italiane», a cui la città di Roma
consacrerà la piazza dei Cinquecento. Ma i bardi del patriottismo si sottraggono al
coro. Carducci rifiuta di commemorare «una spedizione inconsulta» e il giovane
d’Annunzio definisce i nostri soldati «dei bruti morti brutalmente». La verità è che si
continua a non capire cosa sia andata a cercare l’Italia in quei deserti.
Di lì a poco, con il trattato di Uccialli, il nostro governo riuscirà a farsi riconoscere
dal negus Menelik il protettorato sull’Etiopia. La cerimonia al Quirinale è pomposa.
Il cugino del Re dei Re, sulle spalle un mantello di pantera nera e trecento piume
sulla testa, si prostra ai piedi di Umberto I e gli regala un elefante. In cambio gli
etiopi ricevono quattro milioni che spenderanno in armi da usare contro di noi. Anche
la questione del protettorato è ambigua: nel testo italiano è posta all’indicativo, in
quello etiope in forma ipotetica. Manca ancora qualche anno alla disfatta di Adua, ma
le premesse ci sono già tutte.
30 luglio 1887
L’Uomo Forte
Osservata dall’alto, la storia d’Italia è una palude di governi scarsamente
decisionisti, interrotta qua e là da picchi di autoritarismo. Non stupisce perciò che alla
morte del paludoso Depretis il potere venga affidato all’energico Francesco Crispi, la
mente politica della spedizione dei Mille, alla quale aveva partecipato, unica donna
della compagnia, Rosalie Montmasson, sua moglie. Una delle tante, perché dopo aver
sepolto la prima e scaricato la seconda (Rosalie, appunto, la stiratrice savoiarda
troppo poco chic per un notabile in carriera), Crispi si era risposato di nascosto con la
figlia di un ex magistrato borbonico. Il rivale di partito Giovanni Nicotera aveva
passato ai giornali la storia della bigamia e con le sue sei domande (nulla dì nuovo
sotto il sole) «Il Piccolo» era diventato il tormento quotidiano di Crispi, fino a
causarne le dimissioni da ministro degli Interni nel 1877.
Ma dopo un decennio il clima è cambiato e l’Italia reclama l’Uomo Forte: anche
bigamo, purché la riscatti dalle umiliazioni. Crispi è un giovanotto alla soglia dei 70
anni: «Come l’Etna, la mia fronte è coperta di neve, ma ho il cuore caldo per la mia
Patria». La retorica non gli manca e neppure la coscienza di sé: «Il domani mi ha
sempre dato ragione». Gli avversari dicono che «sembra continuamente stupefatto
dalla propria grandezza».
Per la burocrazia ministeriale è un terremoto: se Depretis cantava la ninna nanna
alle pratiche accumulate sul suo tavolo, Crispi le sventaglia in ogni angolo del Paese,
in un profluvio di circolari e decreti legge. A chi lo accusa di essere un megalomane,
risponde che l’Italia è stata fatta dai megalomani. Di tutto si occupa, anche del voto
alle donne, al quale il vecchio bigamo con amante di scorta si oppone perché «sono
troppo impressionabili per occuparsi della cosa pubblica».
Protezionista in economia, scatena una guerra doganale contro la Francia, che
soddisfa gli industriali del Nord ma getta sul lastrico i contadini meridionali. Nelle
campagne si verificano assalti ai forni di manzoniana memoria, mentre alla Borsa di
Parigi le azioni italiane valgono così poco che per spregio vengono ribattezzate
«macaroni».
In politica estera Crispi è filotedesco in odio ai francesi e colonialista per vendicare
lo schiaffo di Dogali. Ma le spese militari affossano il bilancio e quando, il 30
gennaio 1891, il presidente del Consiglio si presenta alla Camera con nuove tasse, la
Destra gli replica che per chiedere sacrifici bisognerebbe possedere la tempra morale
di un Quintino Sella. A quel punto Crispi perde la testa: «Voi non avevate problemi
di bilancio perché eravate servi dello straniero!».
L’intero Parlamento insorge in difesa delle «sacre memorie» risorgimentali e gli
vota la sfiducia. Il governo dell’Uomo Forte è durato 42 mesi esatti. Ma Crispi è una
pellaccia. Ritornerà.
9 giugno 1889
Fra Massone
In un inverno di tre secoli prima, il frate domenicano Filippo Bruno da Nola,
conosciuto come Giordano Bruno, è di fronte a una scelta: sottomettersi all’atto di
abiura delle sue tesi filosofiche o essere giudicato eretico e condannato al rogo.
Fosco e straripante personaggio, Bruno è rinchiuso da sette anni nelle carceri
romane del Sant’Uffizio. Si è difeso puntigliosamente da tutte le accuse ma le sue
opere, stampate nelle maggiori città universitarie d’Europa dove ha insegnato,
provano la sua ostinata ostilità ai dogmi della Chiesa cattolica, da cui del resto è stato
scomunicato, come dalla Chiesa anglicana e luterana. Il Nolano sembra piegarsi, ma
infine decide di non ritrattare e, la bocca serrata da una morsa perché non possa
parlare, muore bruciato in Campo de’ Fiori a Roma.
Nel 1885, quando Roma è da quindici anni capitale d’Italia, si forma un comitato
per la costruzione di un monumento a Giordano Bruno. Vi aderiscono le maggiori
personalità dell’epoca: Victor Hugo, Bakunin, Ibsen, Spencer e molti altri. Dove deve
sorgere il monumento? Ma proprio a Campo de’ Fiori, nel punto stesso in cui il
filosofo è stato incenerito.
Occorre l’approvazione del consiglio comunale, che è però retto da una
maggioranza filoclericale. Le cose cominciano ad andare per le lunghe. Il sindaco di
Roma è un Torlonia, illustre famiglia della nobiltà nera, che prende tempo, tergiversa,
nega di voler sabotare burocraticamente l’erezione del monumento, ma i sospetti si
fanno sempre più consistenti. La questione spacca, come tante altre volte, il Paese in
due. Il Papa considera la statua un’ingiuria alla Chiesa mentre è ovvio che per i
sostenitori di Bruno si tratta di una rivincita, di uno schiaffo laico alle prepotenze
presenti e passate del Vaticano.
Cominciano le manifestazioni di piazza. Gli studenti guidano cortei sempre più
rabbiosi, la polizia forma i suoi soliti cordoni, picchia, arresta. Non ci sono morti, ma
la situazione è incandescente. Il primo ministro Crispi ordina che la statua venga
comunque fusa e lo scultore è, non certo a caso, un esponente della massoneria. Il
nuovo Papa, Leone XIII, minaccia di lasciare Roma e di rifugiarsi in Austria, ma alla
fine resta dov’è. E il 9 giugno 1889 l’immagine bronzea del filosofo eretico prende il
suo posto a Campo de’ Fiori.
Durante le trattative per il Concordato, il Vaticano chiederà a Mussolini di
abbattere l’offensivo monumento e di sostituirlo con una cappella dedicata al Cuore
santissimo di Gesù. Il Duce, vecchio mangiapreti, dice di no, ma fa aprire nella
piazza un mercato di frutta e verdura.
Quaranta
Un secolo tira l’altro, fra duelli e scandali, disfatte e regicidi. È però anche Falstaff
e la Manon, d’Annunzio e la Duse, Marconi e un telegrafo senza fili.
15 agosto 1892
La «prima» dei socialisti
Abituati ai lussi della Casta, oggi quasi non riusciamo a crederci. Eppure il primo
congresso di un partito moderno si svolge a Genova perché, nel quattrocentesimo
anniversario della scoperta dell’America, a chi si reca nella città di Colombo le
ferrovie concedono uno sconto sul biglietto. In ogni regione d’Italia i «rossi» si
svenano per finanziare il viaggio dei delegati e li scortano al treno fra mille
raccomandazioni. Soprattutto una: «Se a Genova entri in un casino, sia chiaro che te
lo paghi coi tuoi soldi».
Nella sala Sivori del capoluogo ligure approdano duecento compagni pronti a tutto
e d’accordo su niente: anarchici contro socialisti, a loro volta divisi tra riformisti e
massimalisti. Il primo a prendere la parola è Casati, in nome degli operai: propone
che alla presidenza siano eletti «solo uomini con i calli alle mani». È un attacco agli
intellettuali e al loro capo Filippo Turati, che per il momento non parla. Lo fanno
invece gli anarchici, chiedendo un rinvio della discussione «onde consentire ai
delegati di esaminare meglio il programma».
La mossa è astuta, dal momento che molti dei loro rivali non hanno i soldi per
fermarsi a Genova più di due giorni. Ma a quel punto sale sul podio il turatiano
Prampolìni e, rivolto agli anarchici, grida: «Voi siete onesti quanto noi, ma siamo
troppo diversi: non ci può essere comunanza, dunque lasciateci in pace!». È tale la
sofferenza procuratagli dalla rottura che si accascia sul pavimento, colpito da malore.
I lavori del congresso vengono sospesi e Turati raduna i suoi in una trattoria.
Accanto a lui siede Anna Kuliscioff, ebrea di Odessa, testa pensante del socialismo
riformista e madre di tutti i radical-chic: il suo salotto di Milano è il ritrovo della
borghesia progressista. Anna ha amato un solo uomo, il tribuno romagnolo Andrea
Costa, da cui ha avuto una figlia. Poi si è accompagnata a Turati: un legame senza
passione, ma uno sfrigolio di cervelli. È stata lei a introdurlo ai sacri testi del
marxismo e in trattoria lo convince al grande passo: lasciare gli anarchici al loro
destino e fondare un movimento socialista che non punti per ora a rovesciare il
sistema, ma a conquistarlo attraverso le leve del partito e del sindacato.
La mattina di Ferragosto, sotto i pergolati della «Società carabinieri genovesi» cara
a Garibaldi, si ritrovano in cento. Turati domina la seduta assistito da Anna, i cui
grandi occhi azzurri vagano invano per la sala alla ricerca di Costa, che all’ultimo
non se l’è sentita di lasciare i compagni di una vita. Senza di lui, che pure ne è stato il
precursore, nasce il Partito dei lavoratori italiani. L’anno seguente aggiungerà al
nome l’aggettivo «socialista». I delegati si salutano alla stazione di Genova: inizia un
viaggio lungo un secolo, ultima stazione Tangentopoli.
1° febbraio 1893
Da genio a genio
Dopo dieci anni di silenzio Giuseppe Verdi, quasi ottantenne, ha pronta una nuova
opera, Falstaff. L’ultima. Contemporaneamente un molto più giovane compositore,
Giacomo Puccini, ha completato la sua seconda creazione, Manon Lescaut. Per Verdi
c’è la Scala di Milano, per Puccini il debutto avverrà invece a Torino, al Regio. Le
direzioni dei due teatri si incontrano per stabilire la data degli spettacoli e dopo
lunghe discussioni si decide che Puccini dovrà essere il primo. Verdi è un Padre della
Patria, una gloria nazionale, un genio ormai di statura mondiale. Se toccasse a lui la
precedenza, l’altro ne sarebbe schiacciato.
Così il primo giorno del mese di febbraio va in scena la Manon. Al libretto, tratto
dal bel romanzo dell’abate Prévost, hanno lavorato in sei e nessuno quindi lo firma.
Manon è già un personaggio operistico musicato da Massenet. Puccini non se ne
cura: è sicurissimo di sé e dei suoi mezzi, che si sono avvicinati al movimento verista.
Ma è un verismo melodioso, dolcissimo, che anticipa sontuosamente (come osserva
oggi con un fine paradosso Alessandro Baricco) la musica d’accompagnamento dei
film prima che il cinema esista.
Tragica la vicenda dei due amanti, rapinosa la musica, la Manon di Puccini ha
subito un grande successo e migliaia di melomani esultano. Sono quelli che non
hanno creduto alla coincidenza, che l’hanno vista come un rito, come il passaggio di
una fiaccola sacra dal grande maestro di ieri al nuovo eroe del melodramma italiano.
Wagner incombe, ma per questi appassionati sciovinisti il primato deve restare in
Italia.
E pochi giorni dopo, il 9 febbraio, una folla famelica si mette in coda fin dal primo
mattino al botteghino del loggione a Milano, alla Scala. I più previdenti si sono
portati sgabelli, vino, panini, altri vengono rifocillati da parenti e amici. Quando
infine comincia la distribuzione dei biglietti, deve addirittura intervenire la polizia per
sedare gli animi. Finalmente il sipario si alza e Falstaff, con una pancia enorme, entra
in scena.
Tutti sanno che si tratta di una commedia, che il vecchio Maestro ha voluto lasciar
da parte i grandi scontri sentimentali e misurarsi col capriccio, l’ironia, la farsa. E
Verdi vince anche questa volta, il pubblico è in delirio, il compositore deve
presentarsi a ricevere le ovazioni e perfino il suo librettista, Arrigo Boito, si deve
mostrare e ringraziare. In platea, tra chi applaude, c’è il Vate, Giosuè Carducci, il
grande cantore di cipresseti e di bovi. E c’è anche, naturalmente, l’erede: Giacomo
Puccini.
17 agosto 1893
Fobia del forestiero
La cittadina di Aigues-Mortes, in Camargue, è uno dei gioielli architettonici di
Francia, fondata da Luigi IX nel 1240 come cittadella armata e porto: il Re Santo vi
salpò per due Crociate, dall’ultima delle quali non riuscì a tornare. Quando il mare si
ritirò, lasciò intorno alla città vaste paludi («acque morte») che divennero una delle
maggiori risorse economiche della zona. Perché c’era il sale, il prezioso sale che
prima dei frigoriferi permetteva la conservazione dei cibi. Candide distese a perdita
d’occhio dove centinaia di uomini seminudi, protetti solo da cappellacci a larga tesa,
raccolgono gli accecanti cristalli nei loro panieri e li portano al magazzino centrale.
Sono in gran parte italiani, piemontesi, costretti all’emigrazione dai cattivi raccolti
e dalla mancanza di lavoro. Stanno accampati sotto capannoni di frasche, pochi
parlano il francese, ma sono pronti a sgobbare più degli altri e a vendere il loro
sudore a due terzi del «salario» (il sale era una forma di pagamento già in epoca
romana) accettato dai lavoratori locali, che naturalmente li disprezzano e li detestano.
Non si sa esattamente che cosa scateni la prima rissa, ma saltano fuori coltelli,
bastoni, sbarre di ferro, e comincia la caccia all’italiano. Seguono due giorni di
massacri nei quali i ritals (così li chiamano i francesi, per canzonare il modo in cui i
piemontesi pronunciano la lettera «erre») subiscono ogni genere di violenze. I morti
accertati risulteranno nove, ma le paludi inghiottono molte vittime, sotto gli occhi di
una gendarmeria poco efficiente e poco numerosa.
L’eccidio ha una risonanza enorme. In varie città italiane, ma soprattutto a Roma,
scoppiano disordini, manifestazioni, furibondi cortei di protesta. L’ambasciata
francese di piazza Farnese rischia la devastazione e soltanto l’esercito riesce a
fermare i vendicatori. Il presidente del Consiglio Giolitti viene rumorosamente
invitato a pretendere una compensazione. E il governo francese si scusa, fa dimettere
il sindaco di Aigues-Mortes, concede pochi franchi di risarcimento agli scampati, i
quali vengono convogliati verso la frontiera e se ne tornano a piedi nei loro paesetti
monferrini, ridotti alla mendicità.
C’è anche un sottofondo politico, poiché l’Italia ha da poco stretto un’alleanza con
Austria e Germania, la cosiddetta Triplice, molto mal vista nella Parigi antiprussiana
di allora. Morti per la Triplice? Ma quei miserabili migranti nemmeno sapevano che
esistesse. Cercavano pane e lavoro, marciando verso quella perla bianca. Hanno
trovato l’amaro sale della fobia per il forestiero.
25 novembre 1893
Così fan tutti
A Roma la torta degli appalti edilizi si squaglia in una poltiglia di debiti. Per
coprirli la Banca Romana - una delle sei che possono stampare moneta - ha emesso
nove milioni di lire più del consentito. La commissione Alvisi scopre la truffa, ma il
governo Crispi, che ha Giolitti al Tesoro, insabbia.
Passa qualche anno: assalito in punto di morte da scrupoli di coscienza, il senatore
Alvisi diffonde il suo memoriale, scatenando un putiferio. Giolitti adesso è primo
ministro e ordina un’inchiesta amministrativa che appura i vuoti di cassa della Banca
Romana. Il presidente dell’istituto, Bernardo Tanlongo, finisce in carcere.
Dispensatore inesausto di mance e barzellette, il sor Bernardo è l’eterna figura del
simpatico maneggione, amico di cardinali e massoni, che si ritrova in tutti gli scandali
nostrani. Confessa di aver prestato denaro a un mucchio di gente, compresi tre
presidenti del Consiglio.
Ma nel frattempo la vicenda si tinge di sangue. L’onorevole De Zerbi, accusato di
aver preso mezzo milione da Tanlongo, viene trovato morto, non si saprà mai se per
infarto o suicidio. Il direttore del Banco di Napoli è arrestato mentre, travestito da
prete, tenta di scappare all’estero con una valigia piena di soldi. E l’ex direttore del
Banco di Sicilia, Notarbartolo, denuncia altri abusi e cade vittima del primo delitto
eccellente di «maffia» (all’epoca si scrive ancora così). Come mandante è indagato
l’onorevole Palizzolo, colluso con i padrini, ma la sua condanna a trent’anni sarà
annullata per vizio di forma dalla Cassazione.
La crisi raggiunge il suo culmine quando in un’intervista Crispi ammette di aver
insabbiato il rapporto Alvisi d’accordo con Giolitti. Questi reagisce al colpo basso
presentandosi alla Camera con un plico sotto il braccio e facendo circolare la voce
che si tratti delle cambiali sottoscritte dai deputati con la banca del sor Bernardo. Se è
un bluff (pare che la cartellina contenesse fogli di giornale), riesce benissimo. In
omaggio alla regola che solo dagli scandali nascono le buone leggi, Giolitti fa
approvare da un’assemblea impaurita l’istituzione della Banca d’Italia.
A fine novembre, però, una nuova commissione d’inchiesta riconosce le
responsabilità del premier nell’insabbiamento del rapporto Alvisi. Munito di
binocolo, Crispi si gode lo spettacolo delle dimissioni del rivale dai palchi di
Montecitorio, mentre in aula risuona lo slogan: «Ladro! Ladro!». Non immagina che
tra qualche anno lo grideranno anche a lui: quando Giolitti mostrerà le lettere da cui
risulta che la signora Crispi si è indebitata con la Banca Romana per oltre un milione.
A proposito: che fine ha fatto il sor Bernardo? Ma assolto, naturalmente...
8 dicembre 1895
Il bricoleur
Il 20 luglio del 1937 le stazioni radio di tutto il mondo interrompono
contemporaneamente le trasmissioni per due minuti. Non è un blackout. Quel silenzio
è un omaggio a Guglielmo Marconi, morto poche ore prima a Roma. Il prestigio e la
fama dello scienziato sono universali. Ha ricevuto decine di lauree honoris causa, è
cittadino onorario di decine di città, presidenze ed onorificenze d’ogni genere si sono
riversate su di lui da ogni Paese.
Circolano, sulla sua attività a bordo del panfilo-laboratorio Elettra, strabilianti
leggende. Ha inventato il raggio della morte! Può bloccare un aereo in volo! Può
confondere le rotte delle navi! Ma, secondo una tradizione che si potrebbe chiamare
hollywoodiana, gli inizi di Marconi non sono stati facilissimi.
Nato a Bologna in una famiglia della buona borghesia, con madre irlandese, il
ragazzo è un pessimo studente e viene bocciato (un classico) agli esami di
ammissione all’Accademia navale di Livorno. Anche l’università di Bologna lo
respinge. Ma il giovane Marconi ha un’istintiva passione per ciò che riguarda
l’elettricità, ed è inoltre un ingegnosissimo bricoleur.
I suoi gli mettono a disposizione un’ampia soffitta nella casa di campagna vicino a
Bologna e qui il ventenne Guglielmo costruisce i suoi strumenti sul tavolaccio dove
anni prima venivano coltivati i bachi da seta. Tubetti di vetro, un po’ d’argento, un
po’ di nichel, un po’ di rame, ferro, piombo e, dopo infinite manipolazioni, infinite
sperimentazioni di autodidatta, il gran giorno arriva: è l’8 dicembre 1895, Marconi si
trova nel suo laboratorio, pronto a premere sul suo apparecchio.
Di fronte alla casa c’è una collina e, al di là, un domestico col fucile carico e il
ricevitore. Il ragazzo manda il segnale e dall’altra parte arriva il suono di una fucilata.
La telegrafia senza fili è stata inventata. Poi, come è del tutto naturale, il ministero
delle Poste italiane non mostra alcun interesse per l’invenzione. Marconi la presenta a
Londra e riceve subito incoraggiamenti e finanziamenti.
Nel 1897 si costituisce sotto la sua direzione la prima compagnia di telegrafia
senza fili e, alla fine dello stesso anno, da una stazione dell’isola di Wight, c’è la
prima trasmissione a più di trenta chilometri di distanza. Seguono le solite
contestazioni, accuse di plagio, proteste di rivali, ma è Marconi a vincere sempre.
Quando il Titanic affonda, i settecento superstiti festeggiano nell’inventore l’uomo
che con i marconigrammi ha salvato loro la vita. Marconi è un idolo, recuperato in
gran fretta dall’Italia non appena Mussolini va al potere. Nel 1937, poco prima della
guerra, la morte mette fine a una ricerca che lui e altri in Europa hanno appena
intrapreso: il radar.
1° marzo 1896
Bandiera bianca
Nei libri di scuola africani, Adua viene tuttora celebrata come l’inizio della fine del
colonialismo europeo: la prima battaglia campale in cui i neri sconfiggono i bianchi.
Proprio per scongiurare un evento di così forte impatto emotivo, le grandi potenze
dell’Ottocento si combattono di continuo tra loro, ma si guardano bene dal fornire
munizioni alle popolazioni indigene. Per armare gli etiopi contro l’Italia ci vuole
dunque l’Italia.
Quando il negus Menelik riceve le cartucce previste dal trattato di Uccialli, pensa
ad uno scherzo o a un trucco. Invece funzionano. Pur avendo Menelik disatteso i patti
(che prevedevano il riconoscimento del protettorato italiano) il nostro governo ha
ritenuto immorale non adempiere all’impegno preso. Questa decisione è la madre di
Adua. Il padre è il generale Oreste Baratieri, un ometto pingue e palesemente
inadeguato al ruolo di condottiero, a cui viene affidato il comando della spedizione.
Baratieri sottovaluta il Negus, «colosso dai piedi d’argilla», e si prende un primo
schiaffone sull’Amba Alagi, nonostante il sacrificio del maggiore Toselli e dei suoi
uomini, circondati da nemici dieci volte superiori per numero. Crispi spedisce a
Baratieri un telegramma sferzante in cui lo esorta a vendicare al più presto
l’umiliazione. Intanto si infittiscono le voci di una sua prossima destituzione: verso la
fine di febbraio del 1896 il generale Antonio Baldissera si imbarca in incognito da
Brindisi per andare in Africa a prenderne il posto.
In preda al panico, Baratieri lancia un attacco sgangherato. La mattina del 1°
marzo, sedicimila italiani assonnati sbucano nella piana di Adowa (Adua): hanno
marciato tutta la notte con il morale sotto le scarpe rotte. Ad aspettarli ci sono
centomila guerrieri abissini. Per colpa di mappe sbagliate e di guide infide, i tre
tronconi del nostro esercito hanno perso i contatti tra loro e Menelik non ha difficoltà
a spazzarli, uno dopo l’altro.
È una carneficina. Al grido di «Ebalgume, ebalgume!» («Falcia, falcia!»)
l’assatanata cavalleria etiope dissolve la brigata del generale Dabormida, i cui resti
non verranno mai trovati. Prima del calar del sole muoiono settemila italiani, più che
in tutte le battaglie del Risorgimento. Fra loro anche Luigi Bocconi, al quale il padre
intesterà la famosa università.
A Milano gli operai scendono in piazza, sostenuti dalla borghesia che non ne può
più di avventure coloniali. E a Roma il vecchio Crispi si trascina alla Camera per
annunciare le sue dimissioni. Al pari di tutti i demagoghi (il prossimo sarà
Mussolini), ha immaginato un Paese guerriero che non esiste, sospingendolo dentro
l’abisso.
6 marzo 1898
Il guantone fatale
I duellanti indosseranno camicia di batista con colletto duro. È l’unica cosa su cui i
padrini sono d’accordo. Su tutto il resto la discussione va avanti ormai da giorni. Gli
stessi padrini sono cambiati tre volte e ricominciano sempre daccapo: pistola o
fioretto, sciabola o spada? Non c’è accordo neppure su chi sia lo sfidante e chi lo
sfidato. Ma la trattativa è nota a tutti, perché si svolge nei corridoi di Montecitorio e i
duellanti sono entrambi deputati. Il conte Ferruccio Macola, direttore della «Gazzetta
di Venezia», che ha fatto insinuazioni calunniose sul suo giornale, e il calunniato
Felice Cavallotti, capo della cosiddetta «estrema», alla sinistra di repubblicani e
socialisti.
Cavallotti è una figura di primissimo piano. Ha partecipato ancora adolescente alla
spedizione dei Mille ed ha poi sempre seguito Garibaldi nelle sue imprese. Di
carattere impetuoso, ha collaborato con aspre polemiche ai più diversi giornali, ne ha
fondati egli stesso, ha scritto centinaia di versi a carattere civile, non ha risparmiato
né la destra né la sinistra e ha sempre proclamato la sua ostilità a Casa Savoia. Nel
1890 ha fondato un autonomo partito d’opposizione che, dai venti deputati iniziali, ha
raggiunto i settanta al momento del duello.
È un personaggio molto stimato, consultato anche dagli avversari. Il suo
programma prevede grandi riforme elettorali, sociali, fiscali e istituzionali, ma non si
rivolge alle masse operaie. È il primo a usare l’espressione «questione morale» e a
propugnare una politica delle «mani pulite» contro la corruzione imperante.
Orgoglioso, focoso, trova normale cedere a quella moda della società borghese che è
il duello. Si è battuto trentadue volte, uscendone sempre indenne e senza mai uccidere
l’avversario.
Questa trentatreesima sembra un po’ più complicata del solito. Cavallotti
preferirebbe il fioretto, ma il rivale insiste per la sciabola, il che comporta l’uso del
guantone che protegge l’avambraccio fino al gomito. Alla fine, pur di chiudere la
vertenza, il capo dell’estrema accetta. Fa testamento, pranza allegramente con gli
amici, manda a comprare il guantone cui non è abituato e che gli intralcia la mobilità
del polso. Poi va sul terreno dello scontro, il parco di una villa disabitata fuori Roma.
Il duello è brevissimo. Al terzo assalto Cavallotti viene ferito alla bocca, ma in
realtà la lama del rivale gli ha tagliato la carotide. Trasportato nella villa, muore per
emorragia in pochi minuti. Amici e ammiratori lo vegliano l’intera notte. Al funerale
un corteo di tre chilometri segue il feretro, Carducci scrive una sdegnata orazione
funebre. Quando l’uccisore si presenta nell’aula di Montecitorio, nessuno gli
rivolgerà la parola.
7 maggio 1898
Cannonate in Galleria
L’ennesima tassa sul pane scatena la rivolta dello stomaco. Vanamente le persone
di buonsenso suggeriscono al governo di cercare altrove (per esempio nel taglio delle
spese militari) quei ventiquattro milioni che mancano al bilancio.
Come già cinque anni prima, nella rivolta dei Fasci siciliani stroncata da Crispi,
ovunque il popolino si solleva in tumulti che hanno la parvenza di un tornado:
esplodono all’improvviso e all’improvviso si spengono per poi riaccendersi con
violenza ancora maggiore. È in questo clima tempestoso che Milano commemora i
cinquant’anni delle sue Cinque Giornate. Festeggerà le vecchie barricate erigendone
di nuove.
La miccia è l’arresto di tre operai socialisti della Pirelli, sorpresi a distribuire
manifestini di Turati. Cantando l’inno dei lavoratori, centinaia di dimostranti
circondano la questura e ne rompono i vetri a sassate. La polizia spara: sul terreno
restano tre morti. I rivoltosi indicono uno sciopero generale per il 7 maggio, con il
corollario di tram devastati e palazzi dei «sciuri» saccheggiati. Scioperano per la
prima volta anche le donne, le sigaraie di via della Moscova.
Il comandante della piazza d’armi milanese, Fiorenzo Bava Beccaris, proclama lo
stato d’assedio. Si spargono le voci più assurde (addirittura di un’invasione di
anarchici dalla Svizzera) e il generale perde la testa. In sella al suo cavallo al centro
di piazza Duomo, ordina ai soldati di sparare ad alzo zero su «qualunque
assembramento umano superiore a tre persone». Un massacro nel cuore di Milano,
che raggiunge l’apice dell’isteria quando Bava Beccaris si convince che i capi dei
sovversivi sono riuniti in un convento di frati. Lo fa spianare a cannonate, ma fra i
calcinacci, invece degli anarchici, spuntano quaranta mendicanti con i piatti della
minestra in mano.
Il resoconto finale dei disordini è tutt’altro che una burla: ottanta morti secondo le
autorità, oltre trecento per i socialisti, i cui capi vengono arrestati. Finisce in carcere
anche un sacerdote, don Albertario, con l’accusa di «aver suscitato l’odio di classe».
Ossessionate dai complotti, le autorità attribuiscono troppo peso ai leader politici
della rivolta, che è in larga parte disorganizzata e spontanea, come tutte le ribellioni
dettate dall’appetito.
L’effetto delle cannonate milanesi si fa sentire anche a Roma. Il primo ministro Di
Rudinì passa la mano al generale Pelloux, comandante della piazza militare di Bari,
che a differenza di Bava Beccaris ha gestito con sapienza i tumulti della «primavera
calda». Pelloux scarcera i politici reclusi, fra i quali Turati e la Kuliscioff. Ma poi
emana una serie di decreti che limitano la libertà di stampa e di riunione.
L’ostruzionismo delle opposizioni (una tecnica parlamentare inventata per
l’occasione) lo costringe a tornare sui suoi passi e a indire nuove elezioni. Le perde e
lascia Palazzo Chigi al presidente del Senato, l’ottantenne Saracco, al quale toccherà
gestire la prossima crisi: il regicidio.
1° marzo 1900
Gabri e Lenor
Nella campagna funestata di statue, una carrozza va tra le ville abbandonate o
cadenti nell’entroterra di Venezia. A bordo due amanti celebri: il più grande poeta e
la più grande attrice del tempo. Arrivano alla villa di Stra, s’infilano nel labirinto di
bosso, si chiamano, si invocano nella luce d’autunno che comincia a spegnersi. Sì,
sono personaggi di un romanzo attesissimo, Il Fuoco, ma senza dubbio corrispondono
ai loro originali: Gabriele d’Annunzio, che è davvero il massimo poeta vivente, ed
Eleonora Duse, che è davvero la più grande attrice dell’epoca.
Il loro amore è naturalmente tutto passione, tormento, furore, languore. Già si
conoscevano e si ammiravano a vicenda, ma la leggenda vuole che l’incontro fatale
sia avvenuto a Venezia, di notte, per caso, tra i due insonni. La Duse è amante di
Arrigo Boito, librettista di Verdi, ma poco produttivo in proprio. D’Annunzio è
sposato con una donna non equilibratissima e gli si attribuiscono, con ragione,
innumerevoli conquiste. Lui ha 31 anni, la Duse 37.
L’amore che divampa ha però forti connotazioni letterarie. La Duse è stanca del
solito repertorio fra Dumas e Sardou e vede nel giovane artista l’uomo che potrebbe
scrivere per lei testi di altissima poesia drammatica. D’Annunzio ha già una certa
fama e la sfida propostagli dall’attrice lo affascina. Lei è oggetto di culto in tutto il
mondo, accolta da ovazioni ovunque si sposti nelle sue tournée internazionali,
perennemente sull’orlo del crollo, perennemente risuscitata. Solo il suo aspetto fisico
non raccoglie l’unanimità dei consensi, ma è la Duse stessa a fornire a uno
spasimante francese la risposta giusta: «Mon ami, io sono bella quando voglio».
Recita in italiano e il pubblico segue le prodigiose interpretazioni con un breve
riassunto tra le mani. Tempesta d’Annunzio con un numero inverosimile di lettere e
soprattutto telegrammi, cui il poeta risponde a malapena, però compone le
dispendiose tragedie che lei gli ha chiesto e la grande attrice le mette in scena di tasca
propria, riuscendo (più o meno) a fare accettare al pubblico quel linguaggio tanto
sopra le righe.
Ma d’Annunzio è già stanco della relazione, le scrive che sta lavorando a un
romanzo su loro due, sulla decadenza e vecchiaia di lei. In nome non solo dell’amore
ma dell’arte, la Duse glielo lascia scrivere, lo incoraggia e quando è finito accetta di
sentirselo leggere dalla viva voce del suo Gabri.
Verrà pubblicato dall’editore Treves e sarà un libro scandaloso, un bestseller
internazionale, subito tradotto in francese ed in inglese. Di questo gossip scottante ci
restano non poche belle pagine, di Lenor ci restano le mani ignude sotto la pioggia
nel pineto.
29 luglio 1900
Tre colpi di pistola
«Io non ho ucciso Umberto, ho ucciso il Re». Così Gaetano Bresci, l’anarchico che
ha assassinato Umberto I nel parco di Monza, spiega al processo il suo gesto. Non è
certo il primo a trasferire sul piano simbolico un delitto politico, basti pensare ai
congiurati che hanno pugnalato a morte Giulio Cesare, per i quali non è stato
massacrato un uomo ma un tiranno.
È il concetto del «niente di personale» tirato in ballo nei secoli da ogni sorta di
estremisti, ma le sfaccettature e le contraddizioni di una simile idea sono infinite:
tutto cambia se l’attentatore rischia la propria vita o se spara alle spalle, se si fa
saltare in aria in una scuola elementare o se taglia la testa al Re davanti a una piazza
gremita.
Bresci si vede come un vendicatore delle vittime di Bava Beccaris, il generale
cannoneggiante che Umberto I ha elogiato e premiato con la Gran Croce dell’Ordine
militare di Savoia. Tale notizia si diffonde prontamente nei circoli anarchici dei nostri
emigrati negli Stati Uniti. Uno di costoro è appunto Bresci, operaio nella cittadina di
Patterson, che senza nessuna complicità (così risulterà al processo) acquista un
revolver, s’imbarca per l’Italia, raggiunge Milano, s’informa sui movimenti della
vittima designata e aspetta, confuso tra la folla di Monza, l’uscita del Re.
Umberto I ha assistito a un saggio ginnico della società Forti e Liberi, risale sulla
sua carrozza scoperta, scelta per via della calura. Sempre a causa del caldo il Re ha
rinunciato a indossare la maglia d’acciaio a protezione contro gli attentati. La banda
suona la Marcia Reale, la carrozza procede lenta tra la folla e nella confusione Bresci
si slancia con la pistola in pugno e spara tre rivoltellate. Colpito a una spalla, al
polmone ed al cuore, il Re muore quasi subito.
Bresci è bloccato dai carabinieri che lo sottraggono al linciaggio, mentre la Regina
si precipita all’ingresso della reggia. Passerà la notte in preghiera vegliando la salma
e la mattina dopo, quando la duchessa Litta, amante ufficiale di Umberto, chiede di
poter entrare per l’ultimo saluto, Margherita, in nome del comune dolore, cede e
lascia la stanza.
Il nuovo Re è Vittorio Emanuele III, frutto infelice di un matrimonio fra parenti
che, pur non sopportando la madre che lo ha messo al mondo, si rivelerà più
magnanimo verso l’assassino del padre che verso la sua amante. Fa infatti subito
chiudere il passaggio fra la Villa Reale e l’appartamento della duchessa Litta, mentre
concede la grazia a Bresci, che è condannato all’ergastolo da scontare nel
penitenziario di Ventotene, in una cella appositamente costruita di tre metri per tre.
Qui, nel 1901, sarà trovato impiccato, ma il suicidio è ancora oggi ritenuto da molti
un’esecuzione.
Intanto a Monza una cappella espiatoria viene eretta a ricordo del regicidio.
Qualche anno dopo, un giovane socialista romagnolo scriverà sul cancello con un
sasso scheggiato: «Monumento a Bresci». Il nome del graffitaro è Benito Mussolini.
Cinquanta
L’Italia di Giolitti è grigia solo in apparenza: la abitano banditi, trafficoni, medium,
comici, eroi. A Roma si erigono monumenti, fra Scilla e Cariddi crollano città.
9 ottobre 1901
Il giustiziere
Un tizio piccolo e scuro si aggira furtivo fra i campi intorno a Urbino con un
ombrello sotto il braccio, quando due carabinieri gli intimano l’altolà. Stanno
cercando un malvivente della zona, ma il giovanotto pensa di essere stato
riconosciuto e si mette a correre, inciampa nel filo di ferro di una vigna e cade. I
carabinieri portano in caserma quello che credono un ladruncolo e lo consegnano al
brigadiere Mattei, padre del futuro presidente dell’ENI. Di lì a poco scopriranno di
aver messo le mani sul ricercato più famoso d’Europa: il brigante Musolino.
La sua storia, giunta fino alla prima pagina del «Times», comincia
sull’Aspromonte con una scazzottata in osteria. Il giorno seguente echeggiano dei
colpi di pistola e uno dei protagonisti della rissa rimane ferito. I sospetti convergono
sul taglialegna Peppe Musolino. Lui giura di essere innocente, ma le testimonianze
non gli danno scampo e la sentenza gli assegna una pena pari alla sua età, 21 anni.
Il condannato promette solennemente ai suoi accusatori che uscirà di galera,
mangerà il loro fegato e berrà il sangue dei loro figli per poi venderne la carne al
macello. Viene rinchiuso nel carcere di Locri, ma due anni dopo evade: dice che san
Giuseppe gli è apparso in sogno per indicargli il punto in cui scavare.
È il primo tassello del mito. Ad alimentarlo sarà il vittimismo della società
calabrese, che si sente sfruttata da uno Stato vissuto come un nemico. L’innocente
condannato per un reato non commesso diventa un bandito vero: ferisce uno dei
testimoni, gli ammazza la moglie, fa saltare con la dinamite la casa del principale
accusatore. Alla fine la sua furia implacabile, sia pur non sempre sorretta da una
buona mira, si abbatterà su una decina di persone. Anche la ‘ndrangheta lo esalta e lo
protegge, identificandosi con la sua sete di vendetta e con l’idea di amministrazione
personale della giustizia.
Lo Stato organizza una costosissima caccia all’uomo. Le provano tutte per
incastrarlo: soldi, alcol, travestimenti, ragazze, perfino il sonnifero nei maccheroni.
Musolino se la cava sempre: merito di san Giuseppe, dice lui. Per chiudere il conto
non gli mancano che due «infami». Fa scrivere seriamente al Re che, se gli verrà
concessa l’autorizzazione a ucciderli, subito dopo lui si consegnerà ai carabinieri.
Braccato, lascia l’Aspromonte e risale a piedi la penisola con in tasca un santino e
una vecchia pistola, ma arrivato dalle parti di Urbino inciampa nel filo di ferro.
«Chillu filu, chillu filu!» lo sentono ripetere di continuo in cella.
Al processo fa la vittima e commuove tutti: «Voi condannate all’ergastolo un
uomo a cui restano solo pochi mesi!». Vivrà altri cinquant’anni, in tempo per essere
scagionato dal primo delitto. Un contadino calabrese emigrato in America, avuta la
certezza che il reato è caduto in prescrizione, confessa di essere stato lui a ferire il
compaesano di Musolino. Ma il bandito ormai è troppo vecchio per uscire di galera
un’altra volta e andarlo a strangolare.
2 settembre 1902
Vaso di Pandora
L’avvocato Tullio Murri lascia la seduta del consiglio comunale di Bologna. In
corridoio la portinaia dello stabile in cui vive gli comunica una notizia allarmante: un
puzzo nauseabondo si sta diffondendo per tutta la casa dall’appartamento di sua
sorella Linda. La polizia sfonda la porta e trova nel letto matrimoniale il cadavere in
decomposizione del conte Francesco Bonmartini, marito di Linda. È stato assassinato.
Con tredici coltellate.
Ci sono segni di lotta, c’è un portafoglio vuoto e un paio di mutandine femminili.
Si pensa a una rapina ma anche, fin da subito, a una messinscena. Il caso è sulla
prima pagina di tutti i giornali perché Tullio e Linda Murri sono figli di un luminare
della medicina bolognese, Augusto Murri, alfiere del positivismo ateo. Il professore,
quindici giorni dopo il delitto, informa gli inquirenti che l’assassino è suo figlio
Tullio: ha ucciso il conte suo cognato durante un violentissimo diverbio. Dovuto a
che cosa?
Qui si scatenano i giornali che faranno diventare il «caso Murri» una sorta di
romanzo d’appendice, straripante di congetture, allusioni, calunnie, falsità di ogni
genere e di forti tensioni ideologiche che spiegano il clamore anche internazionale
dell’affare. I colpi di scena intorbidano tutto: si scopre un piccolo appartamento
adiacente alla casa del delitto il cui proprietario è un affermato medico cinquantenne,
Carlo Secchi, che lo usa per i suoi convegni con Linda Murri, di cui è l’amante.
È lui l’istigatore del crimine? Ma potrebbe essere Linda la vera mandante, che si
sarebbe servita del fratello per liberarsi del marito. Incesto? L’idea dell’incesto viene
estesa anche al padre di lei, l’illustre professore, e ci sono o sembrano esserci altri
complici, altri amori illeciti: Rosa Bonetti, cameriera di Linda, che forse è l’amante di
Tullio Murri, e Pio Naldi, un giovane medico che confessa di aver partecipato al
delitto.
L’Italia ha l’impressione che si sia sollevato il coperchio di un mondo corrotto, in
apparenza rispettabile ed invece dedito alle peggiori turpitudini. Ecco il risultato di
un’educazione atea e permissiva, trionfa la parte cattolica. Da quella opposta si
sottolinea l’ottusità del conte ucciso, un baciapile incapace di apprezzare i talenti
intellettuali della moglie, e la ricchezza di questi borghesi arroganti che si sentono al
di sopra della morale comune.
Così violente sono le polemiche che il processo verrà celebrato non a Bologna, ma
a Torino, e durerà mesi e mesi con enorme «successo» di pubblico. L’assassino è
condannato a trent’anni di carcere, come Pio Naldi. Tutti gli altri ricevono condanne
pesanti e la sola Linda se la cava con otto mesi di reclusione, graziata da una giuria
contorsionista che nega sia lei la mandante del delitto, ma la considera colpevole di
«aver eccitato negli autori del fatto la risoluzione a commetterlo».
3 novembre 1903
Un borghese piccolo grande
Tutti si aspettano che il giovane Re affidi il governo al capo dei conservatori,
Sidney Sonnino. Invece tocca di nuovo a Giolitti, che lo scandalo della Banca
Romana aveva sbalzato dal potere. Con Vittorio Emanuele III si parlano in dialetto
(piemontese) e si assomigliano nei gusti e nei disgusti. Eppure, o forse proprio per
questo, l’algido sovrano non subirà mai il fascino di quel tecnocrate ancora più algido
di lui.
Fra alti e bassi, Giolitti domina la scena fino alla prima guerra mondiale,
intestandosi un’epoca. Sotto la sua guida cambiano l’economia e la società, ma non il
costume, anzi il malcostume, che resta improntato a una corruzione diffusa. Lo stesso
presidente del Consiglio vi attinge a piene mani: vince tutte le elezioni utilizzando
con spregiudicatezza il peso dei prefetti, degli affaristi e delle loro clientele.
Salvemini lo definisce «il ministro della malavita». Lui si difende col tipico cinismo
del gestore d’uomini: «Un sarto, quando taglia un abito per un gobbo, deve fare la
gobba anche all’abito».
È una delle poche frasi di Giolitti che rimangono impigliate nella memoria. Perché,
come dichiara una volta alla Camera, «io, quando ho finito di dire quel che devo dire,
ho finito anche di parlare». In fondo, un’altra sua frase celebre. Questo conservatore
dalla prosa disadorna si rivela però capace di slanci inattesi nei confronti dei più
disagiati. Il suo decennio politico è la storia del tentativo di uno statista liberale di
portare al governo le masse popolari. Il piano fa breccia nei cattolici, ma non nei
socialisti di Turati, dove viene boicottato dall’ala massimalista: un matrimonio
mancato che spianerà di fatto la strada al fascismo.
A spingere Giolitti verso sinistra è il malcelato disprezzo del burocrate statale per i
ricchi: a un latifondista che si lamenta dello sciopero degli agrari che costringe lui, il
padrone, a condurre l’aratro, risponde: «La esorto a continuare, così potrà rendersi
conto della fatica che fanno i suoi mezzadri e pagarli meglio». Ma vi contribuisce
anche la sua estraneità alle famiglie politiche del Risorgimento, che consideravano lo
Stato nato dalle guerre d’indipendenza come un patrimonio privato da gestire in
esclusiva.
Nell’Italia giolittiana i ceti meno abbienti esercitano con regolarità il diritto di
sciopero, acquistano una coscienza sindacale (nel 1906 nasce la Confederazione
generale del lavoro) e ottengono il suffragio universale, che porta alle urne per la
prima volta tre milioni di analfabeti. Il loro voto cambierà per sempre gli equilibri
politici su cui il sistema di Giolitti si regge. Ma, come diceva Cavour, è prerogativa
dei grandi uomini firmare la propria condanna a morte senza aspettare che siano gli
eventi a imporla.
13 dicembre 1906
Il gran ballo dei tavolini
Comunicare con gli spiriti dei defunti è un desiderio comune a tutti i popoli e a
tutte le civiltà, con stregoni e sciamani, negromanti e sensitivi addetti al misterioso e
impegnativo ruolo di tramite. Verso la fine dell’Ottocento si diffonde in Europa la
figura del «medium», persona dotata di particolare sensibilità, in contrasto con la
filosofia del tempo che è tutta materialistica.
Dalle sperdute campagne della Puglia compare una giovane contadina analfabeta,
Eusapia Paladino, che si stabilisce a Napoli, sposa un prestigiatore ambulante e
comincia a dar segni sempre più impressionanti dei suoi «poteri». Sposta gli oggetti
senza muoversi, parla con i morti, fa materializzare nell’aria fantasmatiche figure.
Molti testimoni confermano gli strani fenomeni e la sua fama cresce in tutta Italia.
Cesare Lombroso, massimo studioso di criminalità e follia, si rifiuta di prenderla sul
serio, ma la donna, o meglio l’opinione pubblica, lo sfida ad un confronto diretto. Il
professore accetta di assistere a una seduta e si ricrede completamente. Non ci sono
trucchi, e del suo stesso avviso sono diversi luminari della psichiatria e della
medicina, soprattutto inglesi, adepti delle società di parapsicologia proliferate in quel
Paese.
La Paladino viaggia, invitata a San Pietroburgo e New York, Varsavia e Parigi,
dove attorno al tavolino si siedono i coniugi Curie, Bergson, Flammarion. È
estremamente collerica e si lascia andare a un linguaggio sboccato quando qualcuno
dubita di lei. Un illusionista americano svela i suoi trucchetti, ma un altro è pronto a
giurare il contrario. È una bugiarda cronica, dicono i sostenitori, ogni tanto è normale
che cerchi di barare.
La sua fama continua a crescere, tutti vogliono assistere alle sedute, naturalmente a
pagamento. Il 13 dicembre 1906, il «Corriere della Sera» organizza un incontro con il
suo maggiore inviato, Luigi Barzini, cui saranno presenti Lombroso e alcuni
psichiatri serissimi e scettici. La stanza scelta è bene illuminata, nel mezzo c’è un
tavolo a quattro gambe ed alle spalle della Paladino una specie di grande gabbia
chiusa da cortine. Nessuna finestra. Le gambe della donna sono legate a quelle della
sedia, il giornalista le tiene le mani ferme sul tavolo (dall’altro lato c’è il controllo di
Lombroso) e i fenomeni cominciano.
Lo spirito di un certo John batte diversi colpi, poi si alza un vento impossibile, il
tavolo si mette a ballare, una sorta di ectoplasma si solleva e infine la donna ritorna in
sé. Una creatura davvero in contatto con l’aldilà o una truffatrice agilissima? Nessuno
dei presenti se ne farà mai un’idea precisa.
Eusapia morirà vecchia, sola, i suoi poteri ormai scomparsi, e in povertà, truffata
da loschi manager.
5 novembre 1907
Il Trapanatore
Il Senato si riunisce in Alta Corte di Giustizia per processare l’ex ministro della
Pubblica Istruzione, Nunzio Nasi. Le indagini dei magistrati Falso e Fantastico (in
questa storia sembrano inventati anche i nomi) hanno rivelato un sistema di potere
che oggi definiremmo «gelatinoso», ma è sempre lo stesso da millenni: un intreccio
di favori, sperperi e abusi, senza distinzione fra interessi pubblici e privati.
Sfilano i nemici di Nasi, tutti amici di Giolitti (che lo odia): dal socialista Bissolati
a un certo Ciccotti che l’ex ministro ha promosso professore di ruolo (ah, la
gratitudine!). Emerge il solito campionario di miserie: amanti assunte come maestre,
presidi di scuola rimossi per essersi rifiutati di togliere un’insufficienza al figlio del
ministro, lampadari acquistati a spese dello Stato ma destinati a Villa Nasi, il «buen
retiro» di Trapani dove nei fine settimana Sua Eccellenza riceve la fila dei questuanti
a caccia d’impiego. La battuta più in voga: «Nasi ha “trapanato” tutto il ministero».
Poi sfilano gli amici. Notabili meridionali del calibro di Vittorio Emanuele
Orlando, Francesco Saverio Nitti ed Ernesto Nathan, già capo della massoneria,
appena eletto sindaco di Roma. Parlano di Nasi come di uomo probo e modesto,
vittima dei maneggi di Giolitti. Ricordano le sue riforme progressiste: l’equiparazione
dello stipendio delle maestre a quello dei maestri, l’adozione nelle scuole dei Doveri
dell’uomo di Mazzini.
Qualcuno, pur di salvarlo, arriva a sostenerne l’infermità mentale. «Nasi non è un
pazzo» ribatte Ugo Ojetti dalle colonne della «Stampa», «ma un ambizioso
intelligentissimo e amorale, il quale, non avendo per anni incontrato ostacoli, ha
dimenticato che esistessero». Un ritratto che, tranne forse per
quell’«intelligentissimo», si potrebbe adattare a molti politici contemporanei.
L’opinione pubblica è schierata contro di lui. Colpire, non coprire, titolano i
giornali. E il Senato colpisce. Ma non troppo: un anno di arresti domiciliari e quattro
di interdizione dai pubblici uffici.
Trapani, la sua Trapani, insorge. Non accetta la sentenza e dà vita ad una nuova
eresia politica di cui nessuno francamente sentiva la mancanza: il nasismo. Si
staccano gli stemmi sabaudi dagli uffici, mentre le principali strade della città
vengono intitolate a Nasi e ai suoi parenti. Alle elezioni, nonostante sia interdetto,
l’ex ministro ottiene un plebiscito.
I trapanesi continueranno a eleggerlo fino all’avvento di Mussolini. Nasi farà in
tempo a salire sull’Aventino e a morire in odore d’antifascismo. Ancora oggi, sotto il
monumento che lo ricorda, si legge: «Persecuzioni e calvario lo innalzarono
nell’opinione del mondo».
Benefattore o profittatore? Entrambe le cose, probabilmente, come quasi tutti i
potenti. Ciascuno si prenda la parte di Nasi che più gli garba.
24 luglio 1908
L’uomo che perse la vittoria
Il presidente del Comitato olimpico, barone Pierre de Coubertin, avrebbe voluto
portare le Olimpiadi a Roma, ma Giolitti non se l’è sentita di spendere tutti quei soldi.
Così i Giochi sono finiti a Londra ed è proprio qui, di fronte al castello di Windsor,
che sta per partire la maratona. Fra atleti monumentali che parlano lingue a lui
sconosciute, si aggira un esile garzone di pasticceria con i pantaloncini scarlatti e la
maglia bianca numero 19. Dorando Pietri da Carpi. Quattro anni prima ha visto
passare un tizio davanti alla sua bottega e gli è corso dietro come se obbedisse a un
richiamo, restandogli incollato per chilometri. Quel tizio era il campione italiano di
maratona: il destino di Dorando è segnato.
La Londra olimpica è fasciata dall’afa e i due inglesi che partono come saette si
sgonfiano prima di metà percorso. In fuga rimane soltanto Hefferson, ma va troppo
forte, non può durare. Pietri procede col suo ritmo, raccattando rivali stremati ai bordi
della strada. A tre chilometri dal traguardo raggiunge Hefferson, appoggiato a un
muro, le mani strette sul cuore. Dorando lo sorpassa di volata e paga lo sforzo. Lo
stadio è vicino, si sente la folla urlare. E se davanti ce ne fosse ancora uno? Preso
dall’ansia, Pietri accelera ancora, bruciando le ultime energie. Sbaglia strada, torna
indietro... Lo stadio, finalmente!
La polvere della pista gli aggredisce la gola. Procede a zig-zag come un ubriaco a
cui non manchi il vino, ma l’acqua: è pallido, disidratato, cade quattro volte e quattro
volte si rialza. Per coprire gli ultimi cinquecento metri impiegherà dieci minuti.
Taglia il traguardo sorretto da un giudice, poi sviene. Quanto basta perché il secondo
classificato, l’americano Hayes, presenti un reclamo che la giuria è costretta ad
accogliere.
Il mondo si ribella, rivuole indietro il suo sogno. Pietri viene paragonato a
Fidippide, partito di corsa da Maratona per morire quarantadue chilometri dopo
sull’Acropoli, non prima di aver annunciato agli ateniesi la vittoria contro i persiani.
La regina Alessandra lo premia con una coppa speciale, Irving Berlin gli dedica la
canzone Dorando e Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes, lancia una
sottoscrizione per comprargli una panetteria.
I maliziosi insinuano: «Al traguardo puzzava di stricnina». In realtà era aceto
balsamico misto a sudore. «Io sono colui che ha vinto e ha perso la vittoria» dichiara
Pietri ai giornali. Si prenderà la rivincita al Madison Square Garden di New York,
staccando Hayes di mezzo giro.
Muore a Sanremo nel 1942. C’è la guerra e la notizia passa sotto silenzio, ma la
sua fama è intatta e quando, sei anni dopo, le Olimpiadi tornano a Londra vi trovano
Dorando Pietri, fresco come una rosa, che rilascia interviste a pagamento. È un
impostore, ovviamente. Da Carpi parte una delegazione per smascherarlo: gli parlano
in dialetto e quello, che è di Pistoia, non capisce una parola.
29 dicembre 1908
Fra Scilla e Cariddi
Alle 5,20 del mattino i sismografi oscillano con tale veemenza che escono dai
confini della carta. Dodicesimo grado della scala Mercalli, un record. Lo sconquasso
dura trentasette secondi, ma dove si starà verificando? Gli strumenti non sono in
grado di saperlo. Lo sa invece fin troppo bene il professor Gaetano Salvemini,
ordinario di Storia all’università di Messina: esattamente sopra la sua testa. Sopra e
sotto.
Svegliato da un rumore sinistro, il futuro campione dell’antifascismo balza fuori
dal letto in camicia da notte e spalanca la finestra. In quell’attimo il pavimento
precipita. A salvarlo sono la tenda a cui si è avvinghiato e le macerie dei piani
sottostanti, che attutiscono l’urto.
In un nebbione denso, alimentato da incendi ed esalazioni di gas (che secondo
studi recenti avrebbero modificato il dna dei messinesi), Salvemini brancola alla
ricerca di moglie e figli. Molti lo imitano, altri corrono verso la spiaggia, facendosi
largo fra le macerie della Palazzata, i maestosi edifici prospicienti il mare. Le acque
si ritirano per ritornare subito dopo, sotto forma di onde alte anche dodici metri. Lo
tsunami completa lo sporco lavoro del terremoto. Gli annegati si aggiungono ai
sepolti vivi, in una contabilità dell’orrore che fra Messina e Reggio, Scilla e Cariddi,
raggiunge i centomila morti.
Accorrono i primi soccorritori e sono russi, seguiti dagli inglesi: quando si
degneranno di arrivare, le navi italiane dovranno attraccare in terza fila. Su una di
esse viaggia l’inviato della «Stampa» Giuseppe Antonio Borgese, sorpreso dal
silenzio spettrale dei sopravvissuti: «Né urli né bestemmie, in un popolo così pronto
all’ira per una minima ingiustizia che venga dagli uomini, ma ebetudine tranquilla e
tacito pianto».
La macchina dei soccorsi è un’altra tragedia. «A Messina» scriverà Raimondo
Mercadante in un libro sul terremoto «si ebbe un saggio da manuale di quel che le
pubbliche autorità non devono fare in presenza di un disastro». Una leggenda sostiene
che sia stata l’incapacità del responsabile della protezione civile, generale Mazza, ad
aver dato origine al detto «non capire una mazza».
Si è salvata soltanto una casa su quattro e alcuni onorevoli suggeriscono di radere
al suolo la città per ricostruirla altrove, ma la popolazione superstite non sembra
d’accordo. I deputati proponenti, va detto, sono tutti settentrionali.
Sorgono le baracche «provvisorie», alcune tuttora abitate. Come sempre, ci riscatta
il cuore: la regina Elena commuove nei panni di crocerossina e i milanesi fanno la
coda per sottoscrivere aiuti.
Intanto Salvemini disseppellisce, per poi seppellirli di nuovo, i cadaveri della
moglie e di quattro figli. Il quinto, Ugo, non verrà mai trovato e per tutta la vita il
professore lo cercherà nel volto di ogni russo, cullandosi nella speranza che qualche
marinaio dello zar lo abbia portato via con sé.
12 marzo 1909
Un italiano di nome Joe
È un venerdì sera, a Palermo, e gli avventori della trattoria di piazza Marina non
hanno occhi che per il signore tozzo ed elegante, con le scarpe rialzate a camuffare la
bassa statura, che cena da solo in un angolo della sala. Sebbene viaggi sotto falso
nome, tutti sanno che è Giuseppe (Joe) Petrosino, il detective emigrato in America da
ragazzo e appena rientrato in Italia per impiantare una rete di informatori che gli
consenta di svelare i legami tra le due mafie al di qua e al di là dell’oceano.
La sua fama è legata al «delitto del barile», avvenuto a New York nel 1903. Un
uomo fatto a pezzi dentro una botte, con in tasca un biglietto scritto in italiano, lingua
sconosciuta ai poliziotti americani, tutti ebrei o irlandesi. Tutti tranne uno. Un ex
spazzino nato vicino a Salerno, che l’assessore Theodore Roosevelt, futuro
presidente, ha fatto crescere in polizia dopo averlo visto all’opera come informatore.
Petrosino non si è limitato a tradurre il biglietto. Attraverso un timbro sul fondo del
barile è risalito a una drogheria e da lì al ristorante in cui si è consumato l’omicidio.
Con una serie di indagini spericolate, pedinamenti e travestimenti, ha incastrato
Giuseppe Morello, il capomafia arricchitosi a spese degli emigranti.
Ne arrivano a migliaia ogni giorno «da terre assai luntane». Ad accoglierli trovano
i picciotti del padrino, che offrono protezione ed intanto rifilano dollari falsi in
cambio di lire vere, quelle raggranellate dai poveracci per raggiungere il Nuovo
Mondo. Un compare di Morello, l’ex rivoluzionario dei Fasci siciliani Vito Cascio
Ferro, si è poi inventato un nuovo ramo d’azienda destinato a imperitura fortuna:
l’estorsione. «Fateci bagnare ‘u pizzu [il becco]» scrive ai commercianti, firmandosi
con l’impronta di una Mano Nera. Petrosino ha smascherato la cosca e costretto don
Vito a ritornare in Sicilia.
Le dieci meno un quarto. Il poliziotto più famoso del mondo paga il conto e si
avvia verso il giardino Garibaldi, dove ha appuntamento con un confidente. È senza
scorta: il questore di Palermo gliene ha offerta una, ma Petrosino non si fida delle
autorità italiane, specie da quando sui muri ha visto i manifesti elettorali di certi
candidati che in America flirtano coi mafiosi.
All’improvviso tre spari, una pausa, un altro sparo. Gli avventori della trattoria
chinano la testa sui piatti, solo un marinaio accorre sulla scena del delitto. Fa in
tempo a vedere due ombre che fuggono e Petrosino a terra, colpito alle spalle.
New York gli tributa funerali di Stato. La polizia arresta gli esecutori, ma il
mandante don Vito se la ride. Ha un alibi di ferro, come il suo cognome: la sera
dell’omicidio era a cena con un deputato fatto eleggere proprio da lui... Soltanto il
prefetto Cesare Mori riuscirà, vent’anni dopo, a seppellirlo in galera.
Nel 1943 il carcere di Pozzuoli viene evacuato in previsione dei bombardamenti
americani, ma il direttore del penitenziario si «dimentica» don Vito, che morirà di
fame e di sete dietro le sbarre. Sulla mensola del suo ufficio il direttore teneva in
bella vista una foto di Joe Petrosino.
1° aprile 1910
Ti à piaciato?
La belva, dice lui, è accucciata in platea, e non si capisce se alluda al pubblico od
all’impresario Giuseppe Jovinelli, che gli ha finalmente concesso il suo teatro di
Roma. Ettore Petrolini si è scoperto attore da bambino, quando seguiva i funerali
degli sconosciuti per piangere dietro la bara, ma è diventato un comico nel luogo più
triste, il riformatorio, dove l’hanno rinchiuso con l’accusa ingiusta di aver preso a
sassate un coetaneo.
Per non impazzire ha incominciato a recitare: la parte del recluso, ovviamente,
facendo ridere persino le guardie. Tornato in libertà, si è travestito da sirena in un
baraccone e poi si è lanciato nell’avanspettacolo più surreale, comparendo sul palco
con una treccia di salamini in mano.
Massacrato dalla critica, è emigrato in Sud America. Da lì, un giorno, è arrivata la
notizia della sua morte e gli italiani, che esaltano i cadaveri almeno quanto li
dileggiavano da vivi, hanno sciolto inni per quel talento incompreso e
prematuramente scomparso. Allora Petrolini è risorto: forse la falsa notizia l’aveva
fabbricata lui.
Si spengono le luci dello Jovinelli e il comico romano sale sul palco. «Per strada
un tale mi indica un signore e dice: lo vedi, quello è il perito. Ma, dico io, come può
essere perito, se è vivo?... Aha aha...Ti à piaciato?» Non ride nessuno. Ci riprova:
«Mi spiegate perché vogliono cacciare i grandi uomini della nostra indipendenza?
Non avete visto le targhe nelle strade? Via Cavour, via Mazzini, via Garibaldi... Aha
aha... Ti à piaciato?». Appena partono i fischi, Petrolini alza un dito: «Io non ce l’ho
con quello della galleria che mi fischia. Ce l’ho col vicino che non lo butta giù...».
Qualcuno ride, finalmente, ed è come un contagio che dilaga di fila in fila. «Che
c’avete da ridere di me? Rido forse io di voi?» chiosa lui, trionfante. È nata una stella,
il maestro della comicità all’italiana, basata pochissimo sui testi scritti e molto, forse
troppo, sull’improvvisazione. Le sue maschere sono l’azzimato Gastone, l’imperatore
Nerone («Bravo!» «Grazie!») e Fortunello, «tipo estetico, asmatico, sintetico,
cosmetico». Gli eredi: Macario, il Sordi «americano a Roma», i comici lanciati da
Renzo Arbore. Ma prima e più di tutti, Totò.
Nel 1956 il principe Antonio De Curtis gira il film sulla «malafemmena». Il
copione prevede che suo «fratello» Peppino De Filippo gli detti una lettera per la
ballerina fidanzata con il «nipote» Teddy Reno. Ma la scena non funziona e si decide
di rifarla dopo pranzo. Al ritorno sul set, mentre la troupe sta ancora trafficando con
luci e microfoni, il demone di Petrolini si impossessa di Totò. Intima a Peppino di
sedersi alla scrivania e incomincia a dettare: «Signorina, veniamo noi con questa mia
addirvi...».
Qualche assistente protesta per l’inversione dei ruoli, ma il regista Camillo
Mastrocinque lo zittisce e si affretta a riprendere una gag che a Petrolini, morto da
parecchi anni (e stavolta sul serio), sarebbe «piaciata» tantissimo.
4 giugno 1911
Mostro ma sacro
In occasione del primo cinquantenario dell’Unità d’Italia, il Re inaugura un
grandioso monumento nel cuore di Roma, dedicato al nonno Vittorio Emanuele II (di
qui il nome Vittoriano), che ospita anche l’Altare della Patria. È interamente costruito
in marmo bianco estratto dalle cave del Bresciano, scelto perché di facile lavorazione.
Tutto è cominciato nel 1880 con un concorso internazionale vinto da uno scultore
francese. Ma nel 1882 c’è un secondo concorso riservato ai soli italiani. Le proposte
presentate sono novantotto, tre vengono selezionate per la scelta finale e l’opera è
infine affidata al giovane architetto Giuseppe Sacconi. L’idea è di creare una sorta di
grande Foro, una piazza sopraelevata al centro della Roma imperiale.
Il monumento sorge tra accese polemiche: per l’imperatore Traiano, per
Napoleone, per Nelson si è ritenuta sufficiente una colonna, e su una maestosa
colonna Vittorio Emanuele II domina i viali torinesi. Ma a Roma si pensa che non
basti, c’è da rievocare l’antica grandezza della Città Eterna e da bilanciare, più o
meno implicitamente, la grandiosità della basilica di San Pietro e della piazza ideata
dal Bernini.
Si procede dunque a una rivoluzione urbanistica di tutta la zona dove sorgerà il
«mostro», la «torta nuziale», la «macchina da scrivere». Viene demolito un intero
quartiere medioevale, antiche chiese e rovine romane sono tolte di mezzo, non c’è
sarcasmo, polemica, critica urbanistica che resista alla gigantesca allegoria carica di
scalinate, gallerie, recessi e passaggi di ogni genere. Nonché naturalmente di decine e
decine di statue simboleggianti il lavoro, il genio italico, le messi della Puglia, la
corona ferrea di Milano, le Repubbliche marinare, tutte le regioni, tutte le città
cosiddette «nobili» e i sei gruppi in marmo e bronzo che rappresentano i sei presunti
valori degli italiani: Pensiero, Azione, Sacrificio, Diritto, Forza, Concordia.
Con la Grande Guerra il monumento acquista ancora un altro significato. Il lungo
massacro ha acceso nell’animo dei governanti un commovente slancio retorico: l’idea
di celebrare la strage onorando le ossa di un soldato senza nome, scelto a caso sul
campo di battaglia. E il Vittoriano sembra fatto apposta per diventare anche la tomba
del Milite Ignoto. Qui, dunque, avranno modo di perpetuarsi le guardie d’onore, le
cerimonie su e giù per l’immenso scalone, le corone commemorative, gli squilli di
tromba, le visite compunte dei potentati.
Chi ci passa davanti ogni giorno non fa più caso al Vittoriano. Gli stranieri lo
guardano con un certo stupore. Una parte maggioritaria degli italiani lo trova non
solo indispensabile, ma anche bello. Una piccola minoranza continua a giudicarlo la
più grave ed ineliminabile offesa che si potesse fare a una città come Roma.
Sessanta
Qualche patriota vuole la Gioconda, qualche altro la guerra e sarà accontentato. Il
sangue sgorga dalle trincee, ma anche dalle mani di un fraticello del Sud.
21 agosto 1911
Il ladro patriota
Di lunedì il Louvre è chiuso al pubblico, non però a un copista di professione che
entra al museo per riprodurre il quadro più famoso del mondo, la Gioconda di
Leonardo. Ma sulla parete è rimasto solo il segno della cornice: il dipinto è
scomparso. Il sottosegretario francese alle Belle Arti, che si trova in vacanza, viene
avvertito con un telegramma e scoppia a ridere: prima di partire aveva infatti chiesto
di non essere disturbato «a meno che non rubino la Gioconda».
Non è uno scherzo, invece. È un atto di vandalismo? Una vendetta? Un furto per
estorcere un riscatto? O addirittura un’offesa politica, una beffa perpetrata dagli
odiati tedeschi? Il guardiano dormiva e non ha visto né sentito niente. Si passano al
setaccio tutti i collaboratori del museo, a qualunque titolo. Anche il giovane pittore
Pablo Picasso viene fermato e poi subito rilasciato; è notoriamente amico del poeta
Guillaume Apollinaire, a sua volta arrestato e trattenuto a lungo perché in uno scritto
d’avanguardia ha proposto lo svuotamento del Louvre, con tutte le sue antiche croste,
per far posto alla nuova pittura.
Si promettono ricompense a coloro che porteranno informazioni utili alle indagini.
E il prefetto di polizia in persona, forse un progenitore dell’ispettore Clouseau,
organizza e dirige la perquisizione delle abitazioni di chiunque abbia avuto rapporti
di lavoro con il museo. Tra questi c’è anche un imbianchino italiano, Vincenzo
Peruggia, e l’alto funzionario firma il verbale di avvenuta perquisizione sul suo
tavolo di cucina: proprio lì sotto, nel sottofondo di una valigetta di legno piena di
maglie di lana e scarpe rotte, c’è la Gioconda.
Passeranno due anni di ricerche accanite e vane, di sospetti, di attese e speranze. Il
Peruggia torna a Firenze con il quadro in valigia e infine si mette in contatto con un
antiquario fiorentino, scrivendogli una lettera firmata «Vincent Léonard» in cui
afferma di essere il ladro della Gioconda:
«Cinquecentomila franchi e sarà vostra». E gli dà appuntamento all’hôtel «Tripoli
e Italia». L’antiquario avverte immediatamente la polizia, che si precipita e arresta il
Peruggia, riconsegnando il celebre ritratto alle autorità francesi.
Il ladro si giustifica sostenendo di averlo rubato per motivi patriottici. È infatti
convinto che l’opera faccia parte dei molti tesori saccheggiati da Napoleone in quasi
tutte le città d’Italia. Ma non è così: la Gioconda è stata più che adeguatamente
pagata (quattromila scudi d’oro) da re Francesco I a Leonardo per abbellire i famosi
castelli della Loira.
Il tribunale di Firenze è piuttosto indulgente con il patriottico furfante e lo
condanna alla lieve pena di un anno e quindici giorni, ritenuta comunque eccessiva da
un pubblico favorevole al bel gesto. A proposito di bei gesti: all’antiquario fiorentino
che chiede la ricompensa promessa, il governo francese risponde con discreta faccia
tosta che «un’azione onesta deve sempre essere disinteressata».
28 settembre 1911
Bel suol d’amore
Tripoli, arriviamo. L’ambasciatore italiano a Costantinopoli consegna un
ultimatum che i turchi (del cui impero fa parte la Libia) discuterebbero volentieri, se
solo se ne desse loro il tempo. Ma il tempo non c’è, perché gli italiani non vogliono
Tripoli. Vogliono la guerra.
Nonostante i nazionalisti la descrivano come un incrocio fra l’Eden e l’Eldorado, la
Libia è solo «uno scatolone di sabbia», secondo la celebre definizione di Gaetano
Salvemini. Sotto lo scatolone c’è il petrolio, ma noi non lo sappiamo e comunque non
sapremmo ancora che farcene. E allora perché andarci? Per offrire nuovi mercati agli
industriali del Nord e «un posto al sole» agli emigranti del Sud?
Scuse buone per un comizio. La ragione vera è psicologica: da quando è unita,
l’Italia non ha vinto niente, conquistato niente. Il mare nostrum è tutto degli altri,
inglesi e francesi, e la sconfitta di Adua non ha mai smesso di aleggiare come un’onta
sul nostro presunto spirito guerriero.
Nel Paese si diffonde il verbo nazionalista, gorgheggiato persino dal timido Pascoli
e con ben maggiore padronanza da d’Annunzio, che ribattezza Gea della Garisenda la
soubrette che va in giro per teatri a scandalizzare le matrone cantando «Tripoli bel
suol d’amore» vestita solo di una bandiera tricolore. Gli unici a far stecca sul coro
sono due pacifisti romagnoli, che al grido di «né un uomo né un soldo» si sdraiano
davanti a un treno militare: Pietro Nenni e Benito Mussolini finiscono in galera a
giocare a scopone insieme, ma il futuro li dividerà presto.
Per non correre rischi, Giolitti spedisce in Libia un’armata intera, che conquista
Tripoli e le altre città della costa quasi senza colpo ferire. I turchi sono deboli e gli
indigeni ci amano: così almeno si illudono i nostri. Dovranno ricredersi a metà
ottobre, quando i «terroristi» sterminano un reggimento di bersaglieri.
La delusione innesca la rappresaglia. Altro che italiani brava gente: quattordici ras
locali vengono impiccati nella piazza del Pane, gli altri uccisi o deportati a Ustica.
Gheddafi non ha ancora smesso di rinfacciarcelo. La conquista delle oasi interne è un
miraggio, anzi un incubo. Le bande di Enver Bey combattono con valore ed a nulla
serve inondarle di manifesti propagandistici che annunciano la falsa morte del loro
capo. Quando i turchi scoprono che è ancora vivo e vegeto, gridano al miracolo e ne
traggono nuovo entusiasmo.
Furibondo per i soldi spesi, Giolitti accusa i suoi generali di scarso spirito di
iniziativa: appena vincono una scaramuccia, invece di inseguire il nemico e finirlo, si
precipitano a scrivere comunicati trionfali. Per arrivare a una pace decente ci
vorranno l’apertura di un secondo fronte sull’Egeo e l’impresa del solito italiano di
talento: il capitano Millo, che con un raid di navi leggère forza lo stretto dei
Dardanelli. È lui a darci un acconto di gloria militare, quanto basta per ora a placare
l’appetito dei nazionalisti, in attesa di nuove e più cruente carneficine.
26 aprile 1913
Da Zero a tutto
Al Salone dell’Automobile di Torino viene presentata la FIAT Zero. Il successo è
immediato. Se ne producono duemila esemplari, un numero cospicuo per i tempi.
Oltre al radiatore disegnato da un ventenne Pinin Farina, può vantare grande
maneggevolezza, robustezza, buona velocità. È il primo passo verso la visione
utopistica di Giovanni Agnelli: motorizzare l’Italia.
Agnelli è già un nome illustre nell’industria italiana. Tenente del Savoia
Cavalleria, ha lasciato il servizio nel 1893 per dedicarsi ai nuovi veicoli che
cominciano a circolare. Appassionato di meccanica, siede spesso in un caffè di corso
Vittorio a confrontarsi con altri entusiasti dell’auto e finisce per trovare un certo
numero di finanziatori con cui nel 1899, a Palazzo Bricherasio, fonda la FIAT.
Viene nominato segretario del consiglio d’amministrazione, ma fin da subito è lui
a manovrare la piccola azienda con l’obiettivo, rivoluzionario per l’epoca, di costruire
auto in serie. Quando scoppia la guerra di Libia avrà buone commesse per i camion
dell’esercito e negli anni a seguire assorbirà ad una ad una le altre fabbriche
automobilistiche nate a Torino e dintorni.
Tutti lo ricordano come un uomo autoritario, imperioso, di poche parole (spesso in
dialetto piemontese) ma abilissimo negoziatore, pronto a sfruttare ogni occasione di
crescita per la sua impresa. Con la Grande Guerra fornisce all’esercito migliaia di
automezzi e nel dopoguerra riesce a riconvertirsi, sia pure con molti scossoni,
all’industria di pace.
C’è il biennio rosso con scioperi, occupazione degli stabilimenti, minacce di
nazionalizzazione alla sovietica. Poi viene il biennio nero, dove la FIAT parteggia per
la legge e l’ordine, ma senza darlo troppo a vedere. Mussolini lo nomina senatore già
nel 1923 e nel 1932 lo iscrive d’ufficio al PNF, ma Agnelli fascista non è, il suo
unico partito è l’azienda.
Incontra regolarmente il capo del governo, cede su molti punti, ottiene concessioni,
privilegi, dazi contro le auto straniere, ma fa sempre prevalere il concetto che la FIAT
è un’istituzione indipendente: ai massimi livelli dirigenziali nessuno verrà mai
assunto per meriti fascisti.
E la FIAT cresce, si espande, fabbrica motori navali, motori aerei, motori per carri
armati, è già intrinsecamente avviata verso la globalizzazione. Si salva anche dalla
crisi mondiale degli anni Trenta, scampa, sia pure con gravi danni, ai bombardamenti
della seconda guerra mondiale, evita che i macchinari vengano trasportati nella
Germania nazista.
Dopo la Liberazione, Agnelli è accusato di collaborazionismo e privato
temporaneamente della proprietà delle sue imprese. Muore poco dopo. Suo nipote
Gianni, l’Avvocato, racconterà che al funerale c’erano la famiglia e una ventina di
dirigenti. Nessun altro si è scomodato.
24 maggio 1915
Il maggio radioso
Come membro della Triplice Alleanza, allo scoppio della prima guerra mondiale
l’Italia dovrebbe schierarsi con gli Imperi Centrali: Austria e Germania. Invece
rimane neutrale per mercanteggiare meglio. Trieste, Istria, Dalmazia, chi offre di più?
Il ministro degli Esteri Sidney Sonnino aspetta di capire quale sarà il vincitore per
salire sul carro giusto. Quando ritiene imminente il trionfo degli anglo-francesi, firma
con loro il Patto di Londra. Il giorno dopo gli austro-tedeschi sfondano in Galizia, ma
ormai è tardi per cambiare idea. Oppure no?
Il Patto ci dà un mese di tempo per dichiarare guerra ai nostri alleati. Gli italiani
restano in maggioranza neutralisti. Lo è Giolitti, al momento fuori dal governo, però
sempre padrone del Parlamento. Lo sono i cattolici perché lo è il Vaticano, che punta
ad una conferenza di pace da tenersi a Roma sotto l’egida del Papa come nel
Medioevo. E lo sono i socialisti, nonostante la scissione di Mussolini, maturata
sull’onda di un articolo intitolato Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva e
operante, al cui confronto le «convergenze parallele» di Moro appaiono un esempio
di nitida prosa.
Gli interventisti, invece, sono una minoranza. Ma una minoranza decisa e
chiassosa. Dalla loro hanno i grandi giornali (tranne «La Stampa» di Alfredo Frassati,
giolittiana), il convertito Mussolini, l’irredentista Cesare Battisti e l’immaginifico
d’Annunzio, che in un discorso orribile ed applauditissimo aizza le squadracce
guerrafondaie contro «il Mestatore di Dronero», alias Giolitti. «Codesto servidorame
ha spavento del castigo corporale. Io ve li raccomando. Vorrei poter dire: io ve li
consegno». Il giorno dopo centinaia di deputati si recano a casa di Giolitti, protetta
dai cavalli di Frisia, per lasciarvi un biglietto di solidarietà.
Il Mestatore ringrazia, poi va dal Re e dal presidente del Consiglio Antonio
Salandra per convincerli a non entrare in guerra. Ricorda che l’esercito versa in
condizioni penose: «Ho sempre dovuto falsificare i bollettini della campagna di Libia
per non far vedere che si vinceva solo quando si era dieci contro uno». Suggerisce di
riprendere i negoziati con l’Austria, che si è rifatta sotto con promesse allettanti,
contro le quali tuona il solito d’Annunzio: «Vogliamo un’Italia più grande non per
acquisto ma per conquisto».
Salandra riconosce che la Camera è in maggioranza neutralista e si dimette. Ma
Giolitti fiuta l’aria delle piazze, a lui contraria, e non se la sente di sostituirlo. Alla
fine decide Vittorio Emanuele, respingendo le dimissioni del governo, che torna in
Parlamento per farsi votare i pieni poteri, cioè il potere di dichiarare la guerra agli
austriaci.
È il «maggio radioso». Una minoranza determinata e manesca è stata capace di
imporsi al Re ed ai deputati. Il caporale Mussolini prende nota: sta partendo per le
trincee dell’Isonzo, ma di fatto la sua marcia su Roma è già cominciata.
17 agosto 1916
Zang Tumb Tumb!
A Chievo, sobborgo di Verona, un camion fa imbizzarrire un cavallo, che
disarciona il soldato che lo monta. La caduta è mortale. La vittima Umberto
Boccioni, giovane volontario e massimo esponente della pittura futurista. Il
clamoroso movimento è stato fin dall’inizio accesamente nazionalista, favorevole a
qualsiasi guerra («sola igiene del mondo»), e tutti i suoi adepti sono partiti per il
fronte.
Il Futurismo è nato belligerante, il Manifesto pubblicato sul «Figaro» di Parigi nel
1909 è tutto un programma di demolizioni: abolizione della sintassi, della
punteggiatura, soppressione del chiaro di luna, modernizzazione di Venezia, Firenze,
Roma, le tele dei grandi artisti del passato gettate nelle acque di fiumi e canali. Nasce
la categoria del «passatismo», in cui si ammucchiano alla rinfusa secoli di glorie
ormai stantìe.
Promotore di tale rivoluzione è Filippo Tommaso Marinetti, poeta e intellettuale
italo-francese-egiziano, che si è fatto un certo nome con versi romantici e simbolisti,
per lanciarsi infine in un progetto scandalosamente utopistico e tuttavia
rappresentativo del clima di subbuglio culturale che sta prendendo piede in Europa. Il
nuovo mito comprende la modernità, il movimento, la simultaneità, la macchina, la
velocità, l’azione, lo sberleffo irriverente.
Boccioni, Balla, Carrà, Severini, Sironi aderiscono con entusiasmo e ci lasciano
opere che diventeranno memorabili. Mentre in letteratura i risultati restano soprattutto
slogan, parole in libertà, trovate grafiche. E anche nell’arte culinaria i menu del
ristorante futurista «Il sollazzo gastrico», (fra i piatti forti «il porco eccitato», fette di
salame con caffè e acqua di colonia) non producono, oggi, acquolina. Si tengono
provocatorie serate in vari teatri d’Italia e d’Europa, scontri, risse, lanci di ortaggi,
sfide di ogni genere alla borghesia, al buonsenso, al quieto vivere. Si succedono
«manifesti» su ogni attività: architettura, libero amore, musica, arredamento, in una
visione di totalitarismo futuristico.
Numerosi i contatti e le reciproche influenze con gli altri movimenti d’avanguardia
dell’epoca - Cubismo, Dadaismo, Costruttivismo russo - e quando scoppia la Grande
Guerra i futuristi sono immediatamente per l’intervento italiano e dopo il conflitto
aderiscono con qualche perplessità al Partito fascista, dando vita a singolari
formazioni di arditi futuristi in fez e camicia nera.
Mussolini se ne servirà prendendoli un po’ con le molle ed adottando una parte del
loro linguaggio esagitato. Marinetti si batte però con tutte le forze contro le leggi
razziali del 1938 e muore nel suo letto, da buon borghese, nel 1944.
24 ottobre 1917
Una caporetto
Il maresciallo Erwin Rommel, che nella seconda guerra mondiale sarà la «Volpe
del deserto», nella prima è il giovane capitano di un battaglione di alpini tedeschi
incaricato di attraversare la linea del fronte e penetrare il più possibile nelle retrovie
nemiche. I suoi uomini affondano per trenta chilometri in territorio italiano e si
ritrovano a Caporetto, alle spalle di un esercito in fuga. Il nostro.
Sono testimoni di uno spettacolo imbarazzante persino per loro: soldati che
intasano le strade, che gettano le armi, che si arrendono al primo tedesco di
passaggio. Lo stesso Rommel viene portato in trionfo da chi avrebbe dovuto sparargli
addosso, al grido di «Viva l’Austria e la Germania!». Più che una ritirata, sembra una
sfilata pacifista.
Il fascismo se ne servirà per avvalorare una delle dietrologie in cui siamo maestri:
Caporetto andrebbe imputata ai «disfattisti» cattolici e socialisti, che hanno
contaminato il morale delle truppe, altrimenti eroiche fino al fanatismo. Secondo
questa teoria assai ardita, lo spirito della trincea sarebbe fedelmente illustrato dalle
gesta di Enrico Toti, il bersagliere ciclista che nella patria degli imboscati è riuscito a
farsi mandare in guerra nonostante avesse una gamba sola ed è morto in un assalto al
monte Sei Busi, lanciando la sua stampella contro il nemico.
Per fortuna il tempo farà giustizia di certe ricostruzioni di comodo. Se Caporetto è
una caporetto, lo si deve anzitutto ai comandi militari, che non credono a
un’offensiva austro-tedesca nemmeno quando ne vengono a conoscenza dagli
interrogatori di alcuni prigionieri. E non vi credono perché l’idea di uno sfondamento
concentrico in uno spazio ristretto cozza con la loro visione elefantiaca della guerra,
fatta di trincee disseminate lungo un fronte sterminato (settecento chilometri dalle
Dolomiti alla foce dell’Isonzo!) e di assedi estenuanti alle cime dei monti, quelle
pietraie che ricopriamo per anni con centinaia di migliaia di cadaveri.
La breccia in cui si infilano gli alpini di Rommel è anche e soprattutto una breccia
morale. Ma a crearla non è il «disfattismo» della politica, bensì quello della trincea.
Con l’eccezione degli alpini, i soldati italiani non sono abituati ai ritmi sfiancanti
della guerra di posizione. L’unico generale capace di portarli alla vittoria era stato
Garibaldi, che andava all’assalto di slancio come un pirata.
Il fante della prima guerra mondiale ha visto spegnere il suo entusiasmo iniziale
nei lunghi inverni di guerra e nelle dodici inutili carneficine dell’Isonzo (dal Carso a
Sabotino, fino all’ultima sulla Bainsizza, costata centomila vite) in cui lo ha
scaraventato il generalissimo Cadorna, piemontese tutto d’un pezzo col culto della
disciplina e l’elasticità di un obelisco.
È, il nostro, un soldato-contadino, annoiato dalla vita di trincea e gonfio di rancore
verso l’operaio rimasto in fabbrica per produrre armi, che a lui sembra più che altro
un imboscato. Quando arriva Caporetto, non pensa sia una caporetto, ma una licenzapremio per tornare finalmente a casa.
20 settembre 1918
Da imbroglione a santo
Mentre prega nella chiesa del suo convento a San Giovanni Rotondo, un frate
cappuccino si sente invadere da un indicibile senso di felicità. Ma un attimo dopo è a
terra e un dolore fortissimo alle mani, ai piedi e al costato lo trafigge. Si trascina fino
alla sua cella, lasciando dietro di sé una striscia di sangue. Si fascia le mani e i piedi,
tampona alla meglio la ferita al petto, ma ai confratelli e ai fedeli non può nascondere
del tutto il fenomeno. Scrive al suo superiore, che accorre a constatare le piaghe.
Appare così sulla scena del mondo padre Pio da Pietrelcina, umile fraticello prima,
poi beato, poi santo.
Chi dei cappuccini si è fatto un’idea dai Promessi Sposi, dovrà dimenticare la
grande figura di Fra Cristoforo, omicida pentito, ma rimasto uomo d’azione. Questo
frate del Sud è tutt’altra cosa: è un mistico, ha avuto la visione di un misterioso
personaggio che gli infliggeva le ferite che continuano a non cicatrizzarsi, gettano
sangue, gli provocano dolori intollerabili. Sono le stigmate di Cristo che già hanno
segnato nei secoli nobili figure come san Francesco e santa Teresa d’Avila mentre, in
piena epoca giansenista, Gesù stesso è apparso alla francese Maria Alacoque, per
esortarla a celebrare la festa del suo corpo martoriato: il Sacro Cuore di Gesù.
La notizia non può restare segreta e in breve una folla crescente di fedeli circonda
il frate, assiste alle sue celebrazioni della messa e chiede di essere confessata da lui.
Un gruppo di giovani donne si forma attorno al religioso che ne diventa il padre
spirituale, ma la Chiesa procede con molta cautela. Il Sant’Uffizio manda diversi
ispettori a controllare le stigmate e tra questi c’è padre Gemelli, illustre genetista che
padre Pio rifiuta di ricevere.
«Psicopatico, autolesionista e imbroglione» scriverà lo scienziato nel suo rapporto.
E la condanna peserà poi sempre sul frate, che è visitato e venerato da milioni di
fedeli d’ogni paese e ceto sociale, dai principi ai contadini, ma che è anche oggetto di
campagne calunniose: commercio delle sue pezzuoline imbrattate di sangue di
gallina, peccaminosi contatti con le sue Figlie spirituali, uso di unguenti e profumi
griffati.
La Chiesa gli toglie la facoltà di dir messa in pubblico e di confessare, riducendolo
quasi in stato di prigionia, ma numerosi sono i suoi difensori e dopo anni di dispute
più o meno segrete padre Pio riacquista la sua dignità. Finché, sulla base di centinaia
di testimonianze, i «miracoli» vengono riconosciuti: dal profumo di violetta e
gelsomino che emana dal suo corpo ai cosiddetti «viaggi in bilocazione», ossia il
dono dell’ubiquità.
Muore nel 1968. Là dove ricevette le stigmate, oggi sorge la chiesa di San Pio.
Chissà se gli piacerebbe: sembra uno stadio.
4 novembre 1918
La vittoria mutilata
Mentre l’ufficio stampa delle Forze armate compone il celebre Bollettino della
Vittoria, l’uomo che fra qualche istante lo firmerà è piegato su una carta topografica e
sta bofonchiando in napoletano: «Ma ‘sto Vittorio Veneto, addo’ cacchio sta?». È
Armando Diaz, il generalissimo che ha preso il posto di Cadorna dopo Caporetto e ne
rappresenta l’antitesi: estroverso e pacioso, quanto l’altro era rigido e negato per le
pubbliche relazioni. Anche Vittorio Veneto è una caporetto all’incontrario: nel senso
che a sfaldarsi, stavolta, è l’esercito austriaco.
Nell’ultimo anno molte cose sono cambiate. Nasce allora il mito dell’Italia che
nelle emergenze dà il meglio di sé. Il Re al fronte offre uno spettacolo di dignità. I
soldati-contadini vengono motivati con la promessa, poi disattesa, di terre da
assegnare ai reduci. Il ministro Nitti rilancia l’economia stimolando la produzione. E
il generale Badoglio, uscito indenne da Caporetto nonostante lo sfondamento sia
avvenuto nella zona da lui presidiata, si riscatta come assistente di Diaz, assumendo
la direzione effettiva delle operazioni per infondervi la tattica a noi più congeniale:
non l’ottuso assalto alle cime delle Dolomiti, propugnato per anni da Cadorna, ma
un’accorta difesa sul Piave, da cui i nostri escono solo per compiere delle sortite.
Il «contropiede» si rivela la vera essenza dell’anima italiana lo applicano anche le
motosiluranti di Rizzo nella guerra navale. Con questa tecnica sul monte Grappa
cogliamo una vittoria decisiva per il morale delle truppe. Ma la fine della guerra si
avvicina e il governo, ora presieduto da Orlando, pretende che Diaz e Badoglio
vadano all’attacco per conquistare sul campo i territori che i diplomatici
reclameranno al tavolo della pace. Il crollo degli austriaci facilita il compito. I numeri
della vittoria sono comunque terribili 600 mila morti, 500 mila mutilati, 23 miliardi di
debiti.
Orlando e Sonnino partono da trionfatori per la conferenza di pace di Versailles,
dove il presidente americano Wilson sta mettendo insieme il puzzle della Jugoslavia e
prospetta all’Italia di rinunciare alla Dalmazia in cambio di Fiume. I nostri
abbandonano sdegnati il congresso e arrivano a Roma accolti dagli applausi della
folla, sicuri di essere richiamati a Parigi con un telegramma di scuse. Ma poiché il
telegramma non arriva, ci tornano di loro iniziativa con la coda fra le gambe.
Adesso si accontenterebbero di Fiume, ma Wilson non ci vuol più dare nemmeno
quella. E Orlando si dispera. «Ah, se potessi pisciare come lui piange» mormora con
invidia il primo ministro francese Georges Clemenceau, sofferente di prostata.
D’Annunzio tuona contro «la vittoria mutilata» e l’Italia intera si lascia contagiare dal
proprio virus preferito, il vittimismo, che fra non molto farà rima con fascismo.
23 marzo 1919
Antemarcia
«Io non ho creato il fascismo, l’ho tratto dall’inconscio degli italiani» dirà
Mussolini nell’ultima intervista della sua vita. Alla prima adunata milanese di piazza
San Sepolcro, a cui durante il Ventennio affermeranno di aver partecipato un po’
tutti, si presentano in poco meno di trecento. Reduci avviliti dal fronte e piccoli
borghesi imbestialiti: contro i socialisti e i loro scioperi, ma anche contro «i
pescecani» (oggi si direbbe «i poteri forti») arricchitisi grazie alle commesse di
guerra. Il fascismo delle origini è un miscuglio di perdenti, tenuti insieme dal
vittimismo e dal rancore.
Lo stesso Mussolini, chiamato a spiegare ai suoi seguaci in che cosa consista,
proclama: «Noi siamo degli antipregiudizialisti, degli antidottrinari e dei
problemisti». Mah. Comunque si sente sempre un uomo di sinistra: vuole il diritto di
voto per le donne e la pensione obbligatoria a 55 anni.
Alle elezioni i Fasci di combattimento non raccattano nemmeno un seggio. Per
sfregio i socialisti organizzano un finto funerale di Mussolini. Ma è proprio il loro
massimalismo condito di violenza a farlo risorgere: il primo scontro fra rossi e neri
avviene nell’aprile 1920, davanti all’Arena di Milano, anche se la svolta arriva dai
proprietari terrieri della pianura padana, che confluiscono nel fascismo per
contrastare le leghe socialiste e cattoliche.
I contadini tornati dal fronte pretendono la consegna delle terre promesse alle
truppe dopo Caporetto. Non ottenendo soddisfazione, cominciano a prendersele da
soli. E gli agrari, per difendere i loro beni minacciati di esproprio proletario,
organizzano le squadre delle camicie nere e spostano definitivamente a destra il cuore
del movimento, inventando le spedizioni punitive che laureano sul campo i ras di
provincia: Balbo, Arpinati, Farinacci.
Mussolini non li ama, ma li usa: aizzandoli, per poi presentarsi all’opinione
pubblica impaurita come l’unico in grado di domarli. Il gioco gli riesce persino con
una vecchia volpe come Giolitti, che punta ad imbrigliare i fascisti nel meccanismo
parlamentare per rinvigorire i suoi ranghi con forze fresche. Perciò propone
un’alleanza elettorale che Mussolini accetta, salvo disconoscerla un minuto dopo la
vittoria, precludendo a Giolitti l’ennesima presidenza del Consiglio.
Il tribuno di Predappio vuole il potere tutto per sé, e lo vuole attraverso la minaccia
della rivoluzione. Ma solo la minaccia, perché, da arci-italiano qual è, la rivoluzione
pretende di farla d’accordo con i carabinieri, cioè col Re. Invece i suoi ras detestano
la politica e, appena lui tenta di costringerveli, provano addirittura a togliergli la
guida del partito.
Succede quando il futuro Duce, per ragioni tattiche, tende la mano al governo in
carica e agli odiati rossi, contro i quali le sue squadre vanno picchiandosi nelle
piazze. A salvargli il posto è l’assenza di figure carismatiche fra gli oppositori interni.
Dino Grandi tenta invano di mandarlo in minoranza. Ci riuscirà solo il 25 luglio, ma
del ‘43.
12 settembre 1919
Il Comandante
Il poeta Gabriele d’Annunzio giunge nella città dalmata di Fiume accolto in trionfo
dalla maggioranza dei suoi abitanti e da numerosi volontari che pretendono
l’annessione alla Patria. Il Comandante, come d’ora in poi sarà chiamato, si presenta
al balcone e proclama che Fiume è ormai a ogni titolo una città italiana. Ma le cose
sono molto più complicate.
A Versailles i capi di Stato, riuniti per decidere le sorti dell’Europa stremata dalla
guerra, non intendono concedercela. Fiume è presidiata da soldati francesi, inglesi,
americani e italiani che tuttavia non si oppongono all’ingresso dei «legionari», ai
quali ben presto si uniscono diverse unità delle nostre truppe.
D’Annunzio insedia una giunta e rifiuta, con veementi proclami, ogni trattativa con
il commissario generale Badoglio, nominato dal governo Nitti (che il poeta per
spregio chiama «Cagoia»). La confusione è massima. Gramsci e Lenin elogiano il
Comandante come vero rivoluzionario, mentre Mussolini temporeggia, ma alla fine
d’Annunzio lo costringe a lanciare una sottoscrizione in suo favore che raccoglie tre
milioni di lire.
Così si va avanti per mesi e mesi. Nitti mette il blocco alla città, ma si tratta di un
blocco all’italiana: entra ed esce chiunque. A Fiume accorrono reduci di guerra, ex
arditi, avventurieri, prostitute ed adolescenti entusiasti. Badoglio si dimette ed è
sostituito dal generale Caviglia, ma nulla cambia. Qualsiasi apertura offerta dal
disprezzato governo liberale incontra i fulmini del Comandante.
Si tenta la via del plebiscito, ma d’Annunzio, visti i primi risultati, preferisce
bloccare tutto. Per mancanza di viveri quattromila bambini devono essere sfollati e
frattanto a Rapallo Italia e Jugoslavia si accordano per un compromesso ragionevole.
Fiume sarà città libera. Gli annessionisti più fanatici stilano con d’Annunzio la Carta
del Carnaro, sorta di costituzione di un libero Stato che come primo atto ufficiale
riconosce l’Unione Sovietica. Ma la popolazione comincia ad essere stanca di un
confronto che si fa ogni giorno più convulso, tra appelli, dimissioni, defezioni,
rimpalli.
Arriva l’ultimatum del governo: l’esercito di volontari dovrà deporre le armi per
evitare l’intervento armato e il conseguente bagno di sangue. La risposta
naturalmente è negativa e l’indomani una corazzata comincia il bombardamento della
città, mentre le truppe regolari entrano in azione.
La resa è inevitabile. D’Annunzio se ne va, amareggiato e consapevole che la sua
parabola di poeta-guerriero è alla fine. I legionari tornano alla cosiddetta vita civile,
che in questo caso significa unirsi alle due estreme: anarchici e bolscevichi da una
parte, nazionalisti e squadristi dall’altra. La roboante magniloquenza di quei giorni
(«A chi Fiume? A noi!») segnerà per vent’anni il clima politico del nostro Paese.
Settanta
Un ex tribuno di sinistra diventa dittatore di destra. E un ex mangiapreti (sempre lui,
anzi Lui) fa la pace col Papa. Ma l’Italia è piena di smemorati, non solo a Collegno.
22 marzo 1920
Lo sciopero delle lancette
Un operaio della FIAT Brevetti si ferma davanti al grande orologio della fabbrica e,
tra gli applausi dei compagni, sposta le lancette indietro di un’ora. Sembra la bravata
di un goliardo, è l’inizio di una lotta che farà sognare (o temere) la rivoluzione e
sfocerà nella nascita del Partito comunista.
Il casus belli è l’introduzione dell’ora legale, contestata dai metallurgici, come si
chiamano allora, che non vogliono recarsi al lavoro col buio. Ma la vera posta in
gioco è il ruolo dei consigli di fabbrica. Osteggiati dal sindacato, che ne teme la
concorrenza, ma sostenuti da Ordine nuovo, la corrente socialista di Gramsci che li
considera l’equivalente italiano dei soviet.
La rivoluzione russa del 1917 è la moda del momento: mito o spauracchio, a
seconda delle inclinazioni. Qualcuno arriva a sostenere seriamente che sia stato Lenin
a spargere il bacillo della «spagnola», l’influenza che nelle nazioni capitalistiche sta
mietendo più morti della prima guerra mondiale. Ma i bolscevichi diffondono un altro
genere di virus, che attecchisce facilmente in un Paese uscito a pezzi da una guerra
pur vittoriosa, dove il costo della vita è triplicato, l’industria fatica a riconvertirsi
all’economia di pace e le donne che avevano sostituito i parenti maschi spediti al
fronte si ritrovano di colpo disoccupate. Lo sciopero delle lancette paralizza il
Piemonte per un mese e Gramsci vagheggia di estenderlo alle altre regioni a tempo
indeterminato. La Confederazione generale del lavoro (cgdl) lo riporta alla realtà e
raggiunge un accordo con i «padroni». Ma a settembre si ricomincia con
l’occupazione delle fabbriche, stavolta in tutta Italia. Operai armati presidiano gli
ingressi, sui pennoni sventolano le bandiere rosse e le commissioni interne
organizzano la produzione, stipulando un mutuo con la banca delle cooperative per
pagare gli stipendi. Gramsci esulta: «La rivoluzione accende i suoi bivacchi!». Il
vecchio Giolitti, tornato capo del governo, non interviene. Quando Agnelli lo
sollecita a fare qualcosa, risponde beffardo: «Domani darò ordine all’artiglieria di
bombardare la FIAT. È contento?». È di nuovo la CGDL a far defluire l’ondata
rivoluzionaria verso il lago del riformismo, in cambio di miglioramenti salariali.
Gramsci incassa la sconfitta e medita di dotarsi dello strumento che finora gli è
mancato: il partito. Al congresso socialista di Livorno detta le condizioni: cacciare i
riformisti, scomunicare il sindacato e cambiare nome. Insomma, suicidarsi per
risorgere.
Nonostante in sala ci siano più poliziotti che delegati, succede di tutto, anche che
dal podio Nicola Bombacci punti una rivoltella addosso a un «compagno» che lo
accusa di essere «un rivoluzionario da temperino». Il segretario Serrati tenta un
compromesso, ma Gramsci vuole la rottura. «Lasciamo il circo Barnum» annuncia,
mentre i suoi abbandonano la sala cantando L’Internazionale e si trasferiscono, sotto
la pioggia, in un teatro col tetto bucato a fondare tra gli ombrelli il Partito comunista
d’Italia.
9 maggio 1921
Manicomio!
Il pubblico del teatro Valle di Roma assiste tranquillo alla prima di una nuova
commedia di Luigi Pirandello. L’autore è notissimo per i suoi romanzi, le sue
numerose novelle e i testi teatrali spesso paradossali, amarognoli, ma sempre con una
soddisfacente vena di umorismo. La scena si apre sulla compagnia di attori che sta
provando una commedia (dello stesso Pirandello). Il capocomico e gli attori
discutono, chiacchierano, bisticciano, finché l’usciere viene ad annunciare l’arrivo di
alcuni estranei. E dalla platea, attraversando il corridoio centrale, salgono in scena sei
individui.
Un cinquantenne, che si qualifica come il Padre, spiega all’interdetto capocomico
che lui e il suo gruppo sono personaggi concepiti da un autore che non ha poi saputo
o potuto farli entrare nel mondo dell’arte. Ma la loro storia è commovente,
drammatica, bruciante, ed essi chiedono ai teatranti di metterla in scena con la loro
collaborazione.
Comincia il racconto, inverosimile, che gli attori dovranno rendere «vero»,
smussando, adattando, limando la vergognosa realtà. E partono le precisazioni, i
battibecchi, le dispute tra i Sei e tra chi li deve «recitare», in un gioco che si fa
sempre più acceso e ingarbugliato.
Dopo il secondo atto, il pubblico del Valle si ribella: fischi, lancio di monetine,
grida di «Manicomio! Manicomio!» cui cercano di opporsi i sostenitori di Pirandello,
il quale è costretto a uscire da una porta laterale. Ma tre mesi dopo, al Manzoni di
Milano, un’altra compagnia mette in scena i Sei personaggi in cerca d’autore ed il
successo è immediato, definitivo: quei romani non avevano capito niente. O sono
invece proprio loro ad aver colto l’eccezionalità rivoluzionaria dell’evento?
Da quel momento infatti il teatro non potrà più essere la stessa cosa e in tutto il
mondo, nelle mani dei più grandi registi, i Sei personaggi diventano il punto di svolta
tra la finzione ideata dall’autore e la sua messa in scena da parte dei professionisti. Di
cui Pirandello ha dubitato per anni, vedendoli come «traditori» dei suoi testi e
sciogliendo infine il dilemma col geniale espediente di portarlo direttamente in scena.
La sua influenza nel mondo dello spettacolo è stata incalcolabile, sia da un lato per
le avanguardie più temerarie, sia dall’altro per il peggiore «trash» televisivo dei nostri
giorni. Che cosa è vero? Che cosa è combinato? Che cosa è totalmente falso? Sono
domande che tuttora, e anzi sempre più, ci assillano. Ma è dalla fantasia sarcastica del
grande siciliano che tutto è cominciato a Roma, in quel 9 maggio di quasi cent’anni
fa.
24 luglio 1921
Terror dei comunisti
Alle tre del mattino si radunano a Grosseto una cinquantina di giovani: salgono su
due camion, bastonano sette cittadini incrociati per strada, sfasciano il bar gestito da
un anarchico e procedono verso il grosso borgo maremmano di Roccastrada (2600
abitanti). Tre mesi prima hanno ingiunto al sindaco socialista di dimettersi, ma costui
non ha obbedito e merita una lezione.
Quando i camion arrivano nei pressi del paese, una fucilata parte da dietro una
siepe ed uccide uno degli squadristi. La vendetta è immediata. Tutti i casolari della
zona vengono saccheggiati e incendiati: alla fine della rappresaglia si conteranno
dieci morti, persone inermi e per lo più estranee alla faziosità politica. I carabinieri
arrivano in ritardo e minimizzano il più possibile i fatti. I fascisti forniscono una
versione in cui figurano come vittime della violenza rossa. Tutti spariscono in attesa
che le acque si calmino e soltanto otto abitanti di Roccastrada vengono arrestati.
Episodi come questo si ripetono in ogni regione d’Italia, non solo nei capoluoghi,
ma nei più sperduti villaggi. Gli squadristi si muovono su camion militari, a gruppi di
trenta, cinquanta elementi. In origine sono stati assoldati dai proprietari terrieri come
piccoli eserciti a difesa delle proprietà minacciate dalle leghe rosse. Ma via via le loro
spedizioni diventano offensive.
Si tratta in massima parte di reduci dalla guerra, vestono camicia nera e fez, hanno
scorte inesauribili di olio di ricino con cui purgare i rivali. Sono armati di nodosi
bastoni e dispongono di pistole e fucili racimolati qua e là, ma spesso forniti
dall’esercito regolare. Carabinieri e polizia li vedono di buon occhio, raramente si
oppongono alle loro gesta. Molti sono ceffi da galera, molti invece convinti idealisti,
intenti a ripulire il Paese dai tentacoli bolscevichi.
I vari ras locali se li prestano a vicenda, anche se l’anonimato dei picchiatori non è
indispensabile. Ogni squadra ha un suo truce nome di battaglia, «la Disperata»,
«l’Asso di bastoni», «Me ne frego», e si scatena mettendo a fuoco sedi di giornali, di
partiti, di sindacati e soprattutto le abitazioni dei «nemici», di cui hanno precisi
indirizzi e che considerano insetti da schiacciare. Talvolta si limitano a dar loro il
bando, intimandogli di abbandonare il Paese. E i minacciati molto spesso
obbediscono, perché non trovano difesa nelle strutture dello Stato e neppure nelle
organizzazioni proletarie, sempre più sfilacciate.
È la guerra civile. Tra gli squadristi i morti, ossia i «martiri», saranno ufficialmente
tremila, ma una fonte fascista attendibile li riduce a ottocento, forse quattrocento.
Saranno proprio loro a mobilitarsi per la marcia su Roma. Sfileranno senza
combattere per le vie della città e verranno poi assorbiti nella milizia volontaria
istituita dal Duce.
28 ottobre 1922
Colpetto di Stato
Lo sciopero generale indetto ad agosto dai rossi si rivela un fallimento: le camicie
nere sostituiscono gli spazzini, fra gli applausi di una cittadinanza che vede in loro
l’unica forza in grado di rimpiazzare lo Stato. Servirebbe una coalizione antifascista
con vent’anni d’anticipo. Invece i notabili di Giolitti non si sopportano l’un l’altro, i
popolari di don Sturzo non sopportano Giolitti e i socialisti non sopportano nessuno,
nemmeno se stessi, continuando a dividersi fra loro anche dopo l’uscita dei
comunisti.
Le liti partoriscono un governicchio affidato al solito giolittiano di complemento,
Luigi Facta. Proprio a lui, che ne sarà la prima vittima, viene l’idea della Marcia su
Roma: propone a d’Annunzio di organizzarne una per il 4 novembre, quarto
anniversario della Vittoria.
Mussolini gioca d’anticipo, convocando i ras della milizia. Ormai il fascismo ha un
apparato militare vero e proprio, ma l’unico a scandalizzarsene sembra essere il suo
capo: «Se in Italia esistesse un governo degno di questo nome, manderebbe i
carabinieri a scioglierci». Quel governo è deciso a farlo lui.
Il piano prevede un’adunata a Napoli, il 24 ottobre. Da lì le camicie nere
marceranno su Roma, dove i partiti fanno e disfano organigrammi nell’illusione di
coinvolgervi Mussolini, che il potere lo vuole tutto per sé. La sera del 27 il Re
rassicura Facta: non cederà al ricatto della violenza. Nella notte trentamila squadristi
si mettono in marcia verso la capitale, vestiti e armati nei modi più assurdi.
All’alba del 28 Facta proclama lo stato d’assedio, ma quando porta il decreto al
Quirinale per la firma, Vittorio Emanuele glielo strappa di mano e lo chiude in un
cassetto. Cosa gli ha fatto cambiare idea? Dirà poi di essere stato tratto in inganno:
pensava che i «marciatori» fossero molti di più. Allora perché non ha chiesto
informazioni all’esercito, intenzionato a resistere?
Mussolini si trova ancora a Milano, nel suo ufficio di direttore del «Popolo
d’Italia». Sa che la marcia è una burletta e che, se fosse dichiarato lo stato d’assedio,
gli resterebbe solo la fuga in Svizzera. Arriva invece la telefonata dal Quirinale: il Re
intende affidargli il governo. «Lo voglio nero su bianco» risponde. Quando ha il
telegramma fra le mani, mormora in dialetto romagnolo al fratello: «S’i foss a bà», se
ci fosse il babbo. Prima di salire sul treno che lo conduce al potere, legge al telefono
la lista dei ministri al direttore del «Corriere della Sera» Luigi Albertini. Di fascisti ce
ne sono soltanto tre, e dei più timidi. Tanto, basta Lui.
Il giorno dopo gli squadristi sfilano per le strade di Roma: in poche ore sono già
diventati settantamila. Nessuno sa saltare più in fretta degli italiani sul carro del
vincitore, il cui discorso alla Camera è tutto un programma: «Potevo fare di
quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli». E i sordo-grigi, con il masochismo
che è tipico dei deboli, gli votano la fiducia.
10 giugno 1924
Il buco nero
Il socialista Giacomo Matteotti, detto Tempesta per il caratterino, viene aggredito
sotto casa, sul Lungotevere. Loschi figuri lo trascinano verso una Lancia Lambda in
sosta da troppo tempo perché un portinaio incuriosito non ne prenda la targa. Così si
risalirà al guidatore: Amerigo Dumini capo della polizia fascista addetta ai bassi
servizi.
A bordo dell’auto Matteotti si difende come un leone: tira un calcio nei testicoli a
un camerata, che per la rabbia lo colpisce a morte con un pugnale. Oramai in
macchina c’è un cadavere ed i criminali vagano all’ansiosa ricerca di un posto dove
farlo scomparire. A sera si fermano in un boschetto e scavano la fossa, forse con la
stessa lima che poi per sfregio gli piantano nel cuore.
L’arresto di Dumini e il ritrovamento del corpo a Ferragosto scatenano il putiferio.
La stampa, ancora libera, mette in fila i fatti. Nell’ultima seduta della Camera,
Matteotti ha denunciato brogli elettorali mentre i fascisti battevano i pugni sui banchi
per mettergli paura. E alla fine del discorso Mussolini è uscito dall’aula livido in
volto. Dal memoriale del portavoce si scoprirà che ha intimato ai suoi sgherri:
«Quell’uomo non deve più circolare!». Matteotti si oppone al tentativo di assorbire i
socialisti nel listone di governo e soprattutto ha le prove delle tangenti pagate al
fascismo da una multinazionale del petrolio, la Sinclair Oil.
Mussolini è abbastanza cinico da ordire un assassinio, ma non così stupido da
organizzarlo tanto male. Probabile si sia trattato di eccesso di zelo da parte di servi
sciocchi, oppure di un’iniziativa di De Bono, il gerarca più coinvolto nelle tangenti.
Fatto sta che Mussolini sembra politicamente spacciato: un usciere di Palazzo Chigi
lo sorprende in ufficio a battere la testa contro il muro.
Invece al Senato gli vota la fiducia persino Croce: per uno di quegli strani
incantamenti collettivi, gli italiani si sono persuasi che il capo del fascismo sia
l’unico freno contro gli squadristi. I quali, in effetti, gli rimproverano di aver fatto
abortire la rivoluzione, riducendo la Marcia su Roma ad una parata innocua. La svolta
a Capodanno, quando i capi della milizia fanno visita al Duce con la scusa degli
auguri e lo minacciano: o ti carichi sulle spalle i nostri delitti oppure la rivoluzione la
finiamo noi, stavolta contro di te.
Mussolini non teme l’opposizione parlamentare, che da mesi diserta per protesta le
sedute e si fa chiamare Aventino, dal nome del colle su cui si ritirarono le plebi
dell’antica Roma per decretare la caduta dei decemviri allora al potere. E non teme
neppure il Re, a cui invano gli «aventiniani» di Giovanni Amendola chiedono di
delegittimare il fascismo. Ma gli squadristi sì, quelli gli fanno paura. Ed è per tacitarli
che il 3 gennaio 1925, alla Camera, inghiotte gli ultimi scrupoli legalitari e si toglie la
maschera: «Assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di quanto
accaduto. Gli italiani chiedono calma laboriosa e noi gliela daremo, con l’amore o
con la forza».
I prefetti sono inondati di circolari liberticide. È l’inizio della dittatura e al dittatore
viene subito l’ulcera: per mesi andrà avanti a nutrirsi soltanto di latte.
1° gennaio 1926
Sceriffo antimafia
Di ritorno da un viaggio in Sicilia dove ha dovuto subire l’abbraccio appiccicoso
dei padrini, Mussolini convoca un vertice al ministero degli Interni. «Per estirpare la
mafia mi occorre un uomo nuovo, capace, inflessibile, esperto di cose siciliane senza
essere siciliano».
Gli suggeriscono il prefetto Cesare Mori, un pavese «figlio di nn» che ha lavorato
bene a Trapani. «Ha un solo difetto, non capisce niente di politica» interviene
Bocchini, il quale, al contrario, la capisce così bene che resterà capo della polizia per
quasi tutto il Ventennio. Mussolini alza le spalle: «Mi basta che sia duro con i mafiosi
quanto lo è stato con i miei squadristi quand’era prefetto a Bologna». Gli lascia carta
bianca e Mori dimostra di saperla usare, concependo la lotta alla mafia come
un’operazione militare o, forse, come un assalto agli indiani.
La mattina di Capodanno del 1926, al comando di ottocento guardie a cavallo,
cinge d’assedio Gangi, la capitale dei mafiosi. Poi procede al rastrellamento casa per
casa, sequestrando mogli e figli dei criminali per indurli alla resa. Concede un
ultimatum di dodici ore e non sapremo mai cosa avrebbe fatto di quei bambini perché
all’undicesima ora Gaetano Ferrarello, il «capo dei capi», esce dal suo nascondiglio,
che manco a farlo apposta era nel sottotetto della stazione dei carabinieri. Umiliato, si
suiciderà buttandosi dalla tromba delle scale.
La fuga di un altro «mammasantissima», Carmelo Andaloro, consente a Mori di
sperimentare la sua teoria: per battere la mafia, dice, bisogna che i siciliani abbiano
più paura dello Stato che dei padrini. E così, con lo schioppo in spalla, proclama:
«Sappiate che io sono il mafioso più forte di tutti». Di slancio i contadini chiedono di
essere impiegati nella caccia al fuggitivo, il quale viene subito catturato.
Sostenuto dalle sentenze rapide ed esemplari del giudice Giampietro, Mori
ripulisce l’isola palmo a palmo, incitando i contadini alla rivolta contro gli sfruttatori
e costringendo i mafiosi più in vista a scappare in America, dove impiantano la filiale
Cosa Nostra: torneranno nel 1943 nella scia dei marines. Finché, come chiunque
combatta la mafia, anche il Prefetto di ferro si imbatte negli intrecci con la politica.
«La mafia» annota in un quaderno «è una vecchia puttana che ama strofinarsi
cerimoniosamente alle autorità per adularle, circuirle ed incastrarle». Nei guai finisce
il capo dei fascisti locali Alfredo Cucco, detto il Ducine. A comprometterlo sono le
lettere anonime dei rivali di partito, che in tal modo si liberano di lui e ne prendono il
posto nei rapporti con quel che resta della Piovra (qualcosa resta sempre).
Il tempo di Mori è finito. Mussolini non vuole noie: lo riempie di complimenti e lo
rimuove, promuovendolo senatore.
6 febbraio 1927
Il ladro professore
«La Domenica del Corriere» pubblica la foto di un uomo ricoverato al manicomio
torinese di Collegno. È stato arrestato dai carabinieri mentre vagava per Torino
urlando e minacciando il suicidio. Dimostra circa 45 anni, porta una lunga barba
grigia, non ha documenti e non ricorda nulla di sé. La guerra è finita da un pezzo ma
l’Europa è piena di madri, vedove, fratelli che si ostinano a ritenere vivo un loro
congiunto dato per disperso.
Si mette in contatto col manicomio il signor Renzo Canella che ha l’impressione di
poter riconoscere il fratello Giulio, capitano di fanteria, scomparso in azione sul
fronte macedone nel 1916. C’è un primo incontro con esito dubbio. Giulio Canella
era un uomo coltissimo, professore di Teologia, fondatore con padre Agostino
Gemelli di una dotta rivista cattolica.
Lo smemorato ha alcuni tratti fisici che potrebbero coincidere con quelli del
professore, ma per il resto il fratello è molto esitante. Si organizza un incontro con la
moglie, senza ovviamente informare lo smemorato. I due si vedono per quattro volte
ed alla fine la vedova mette da parte ogni dubbio e «riconosce» il professore.
Le autorità decidono di rilasciare il paziente e la coppia riunita torna a Verona. Ma
pochi giorni dopo la polizia riporta l’uomo a Torino con un pretesto burocratico: nel
frattempo una lettera anonima afferma che il sedicente Canella è in realtà il tipografo
torinese Mario Bruneri, latitante da anni, truffatore sotto varie identità e arrestato di
notte nel cimitero ebraico di Torino, il 10 marzo 1926, mentre rubava un vaso di
rame.
Da quel momento la storia prende l’andamento di un romanzo d’appendice, seguito
in tutta Italia e all’estero da un pubblico affascinato. Non si parla d’altro. In ogni
famiglia ci si divide tra canelliani e bruneriani. Arrivano decine di testimoni, vecchi
compagni del tipografo, ex commilitoni del capitano, ex colleghi del professore ed un
turbine di scienziati, psichiatri, avvocati e, beninteso, giornalisti molto fantasiosi.
Viene anche la moglie del Bruneri e c’è la scena madre delle due donne che si
contendono lo stesso marito.
La Canella si dice sempre più convinta dell’identità dello smemorato, la Bruneri è
anche lei ostinatissima. Seguono ben cinque processi con colpi di scena clamorosi: lo
smemorato è Bruneri. No, le prove non bastano. Sì, è proprio lui. No, non è lui. Infine
la corte di Firenze nel 1931 decide, con un solo voto di scarto, che si tratta di Bruneri
e lo condanna a scontare il breve residuo di pena per furto e truffa. C’erano fin
dall’inizio le impronte digitali sul vaso di rame, come osserverà molti anni dopo
Leonardo Sciascia, ma nessuno le ha prese sul serio.
La famiglia Canella, compreso il falso professore, emigrerà compatta in Brasile,
convinta fino in fondo della propria pirandelliana verità.
23 giugno 1928
La Tenda Rossa
Un piccolo aereo svedese atterra sui ghiacci nei pressi della Tenda Rossa, dove si
ammucchiano i superstiti del dirigibile Italia. L’aeromobile si è schiantato ventinove
giorni prima ed è poi scomparso nel nulla trascinato dai venti. Il comandante però si è
salvato. È il generale Umberto Nobile, progettista di fama internazionale, che ha già
sorvolato il Polo Nord nel 1926 con l’esploratore norvegese Amundsen, il primo a
mettere piede al Polo Sud. Ma questa seconda spedizione di Nobile è tutta italiana:
suo il modello semirigido del dirigibile, italiani l’equipaggio, gli scienziati, la scorta
di alpini.
Quando raggiunge il Polo Nord, Nobile lascia cadere una croce benedetta dal Papa
e la bandiera nazionale, e riprende la rotta verso la base. Ma il tempo cambia
drammaticamente, una violentissima tempesta costringe il pilota a disperati saliscendi
tra ghiaccio, sole, nubi, che forse danneggiano il mezzo. Poi la caduta, con la gondola
di comando che si salva, mentre l’altra metà, con sei uomini a bordo, scompare per
sempre. I superstiti riescono a recuperare viveri, strumenti, una radio e una tenda,
sulla quale vengono dipinte delle strisce rosse per renderla più visibile agli aeroplani
da ricognizione.
In tutto il mondo si pensa che l’impresa sia finita in tragedia, ma c’è chi non si
arrende. Amundsen sorvola i ghiacci e, in un’altra tempesta, perde la vita. Infine,
nove giorni dopo, un radioamatore russo capta deboli segnali e in breve tempo c’è la
certezza che gli esploratori sono in parte salvi.
Comincia la ricerca della Tenda Rossa fino all’arrivo del piccolo aereo svedese
pilotato da un asso dei cieli, Lundborg. Questi sostiene di avere l’ordine di portare in
salvo il generale, che è ferito a un braccio e ha una gamba fratturata. In realtà mente:
l’idea è sua, per ricavare dall’impresa il massimo di pubblicità. Nobile rifiuta,
Lundborg insiste e promette: tornerà ogni giorno con viveri e medicinali e caricherà
uno per uno i naufraghi, mentre dalla base il generale organizzerà al meglio i
soccorsi.
Nobile, spinto anche dai suoi, alla fine cede. Errore fatale, perché l’indomani il
tempo peggiora, il piccolo aereo atterra con gravi danni e il pilota diventa a sua volta
uno dei naufraghi. Intanto, preso a bordo dalla nave-appoggio Città di Milano, Nobile
viene in pratica messo agli arresti, destituito, accusato ufficialmente di aver
abbandonato i suoi uomini. Il comandante deve sempre essere l’ultimo a salvarsi,
questa l’idea di Mussolini e delle autorità militari.
Anche quando una nave rompighiaccio russa arriva alla Tenda Rossa e recupera gli
stremati superstiti, Nobile non esce dal cono d’ombra del flop e della supposta
codardia. Si batterà per anni perché gli venga restituito l’onore, ma ci riuscirà soltanto
dopo la seconda guerra mondiale, in una revisione definitiva ma, certo, tardiva.
11 febbraio 1929
Provvidenza e dintorni
Nel giorno in cui si commemora la prima apparizione della Madonna di Lourdes,
un impacciato signore in redingote varca i cancelli del Palazzo Apostolico di San
Giovanni in Laterano. È il cavalier Benito Mussolini, vecchio mangiapreti e giovane
dittatore in procinto di assurgere definitivamente a Duce.
Evirati i giornali, dichiarata fuorilegge l’opposizione, asservita la Camera che
arriva a convalidare 2376 decreti governativi in una sola seduta, esautorati i sindacati
non fascisti. Al regime, per diventare tale, non manca che un ultimo tocco: la
benedizione del Papa. Difficile immaginarla, dopo che le camicie nere hanno
ammazzato il coraggioso don Minzoni e costretto all’espatrio il segretario dei
popolari don Sturzo. E invece Pio XI scopre in Mussolini «l’uomo che la
Provvidenza ci ha fatto incontrare». L’affossamento dei partiti risorgimentali e il
ruolo di diga contro il comunismo ateo sono meriti che consentono di sorvolare sul
resto.
Quanto all’Uomo della Provvidenza, l’opportunità di passare alla storia come lo
statista che ha chiuso per sempre la breccia di Porta Pia sembra fargli dimenticare i
peccati di gioventù, quando scriveva romanzi sulle amanti di un cardinale e nei
comizi sfidava Dio a fulminarlo. Anche se, secondo la testimonianza di Dino Grandi,
appena uscito dal Laterano si riconcilierà col suo passato sparando una bestemmia.
Il programma originale dei Fasci, stilato a piazza San Sepolcro dieci anni prima,
prevedeva il sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose, ma nessuno se ne
ricorda più, tranne forse qualche pedante che comunque preferisce tenerlo per sé. Il
momento è storico: Mussolini e il segretario di Stato (pontificio) Gasparri firmano i
Patti lateranensi con la stilografica d’oro donata dal Papa.
Il Trattato riconosce alla Chiesa la sovranità sulla Città del Vaticano. La
Convenzione le attribuisce un indennizzo miliardario e una serie cospicua di
esenzioni fiscali. Il Concordato le assicura una posizione privilegiata sul territorio
italiano, tranne che per l’educazione dei giovani. Lì il fascismo non vuole concorrenti
e i boyscout dovranno cedere il campo ai balilla. Anche l’Azione cattolica, dopo un
lungo tira e molla, sarà costretta a limitare il proprio campo d’interessi alle «attività
religiose e ricreative».
Pio XI si scaglia contro la «statolatria pagana» e le minigonne delle Piccole
italiane, ma digerisce tutto. Quasi tutto. La preghiera blasfema dei bambini fascisti «Io credo nel sommo Duce, creatore delle Camicie nere, e in Gesù Cristo suo unico
protettore» - proprio non gli va giù e Mussolini la farà cambiare.
La Conciliazione viene ratificata dal Parlamento (2 voti contrari alla Camera e 6 al
Senato, fra cui quello di Croce) e benedetta dal Santo Padre. Il 29 luglio si riapre il
Portone di Bronzo e dopo cinquantanove anni un Papa esce di nuovo incontro alla
folla osannante di piazza San Pietro, sancendo la fine della sua autoimposta prigionia.
Gli eredi di Cavour sono muti o al confino: non corre il rischio di incontrarli.
6 luglio 1929
Cervello in fuga
A due passi dal Colosseo si discute la tesi di laurea di uno studente catanese con i
capelli di bragia e la faccia olivastra da saraceno. La tesi s’intitola «La meccanica dei
nuclei radioattivi» e porta la firma di Ettore Majorana. Il relatore è Enrico Fermi. Il
voto, 110 e lode. In prima fila applaudono i compagni di corso: Segrè, Arnaldi,
Rasetti, Pontecorvo. Li chiameranno «i ragazzi di via Panisperna», dalla strada che
ospita l’istituto di Fisica in cui avviene quell’incrocio irripetibile di cervelli.
Fermi capisce subito con chi ha a che fare: «Al mondo ci sono varie categorie di
scienziati. Gente di secondo rango che fa del suo meglio. Gente di primo rango che
arriva a scoperte fondamentali {qui probabilmente allude anche a se stesso}. E poi ci
sono i geni, come Galileo e Newton. Majorana è uno di loro. Ha quel che nessuno ha.
Però gli manca quel che tutti hanno: il buon senso».
Si sono conosciuti un paio d’anni prima. Majorana è prossimo alla laurea in
Ingegneria, ma un giorno l’amico Emilio Segrè lo trascina in via Panisperna. Fermi
sta lavorando al modello statistico dell’atomo e mostra al visitatore la tabella dei suoi
studi. Majorana se ne va senza dire nulla. La mattina dopo ricompare con un foglio
stropicciato fra le mani. Lo confronta con quello di Fermi: sono identici. «Prosegua
pure, professore: è sulla strada giusta» lo rassicura, in una clamorosa inversione di
ruoli. Però nelle settimane seguenti lascia Ingegneria ed entra a far parte del gruppo.
Che spasso le lezioni in cui Fermi riempie di numeri la lavagna, poi dice «sono
pronto» e Majorana, girato di spalle, dà la soluzione.
Come tutti i geni, Ettore è scostante e solitario. Forse intuisce prima degli altri che
via Panisperna finirà inesorabilmente a Hiroshima. Ma il suo è anche un problema di
carattere: dissemina il talento su pezzi di carta che poi butta nel cestino. Fermi lo
scongiura di pubblicare le sue scoperte. Lui minimizza, sostiene che si tratta di
banalità. Fra queste «banalità», la famosa equazione di Majorana, che fungerà da base
alla matematica quantistica. I rapporti con gli altri «ragazzi» diventano sempre più
radi. Finché il genio prende un piroscafo per Palermo e scompare. Pochi credono al
suicidio: prima di sparire ha svuotato il conto corrente.
Le leggi razziali scompaginano via Panisperna. Fermi e Segrè devono riparare in
America. Ma il mistero di Majorana sopravvive alla guerra. C’è chi lo ha visto in
Argentina a séguito di un gerarca nazista e chi pensa di riconoscerlo in un barbone di
Mazara del Vallo che risolve a memoria i problemi d’aritmetica degli scolari, anche
se l’ipotesi viene smontata dal procuratore di Marsala, Paolo Borsellino.
Sciascia, lui, è convinto che Majorana si sia ritirato in un monastero. E anche a noi
piace immaginare che prima o poi, nell’anfratto di un chiostro, qualcuno troverà un
foglio stropicciato con gli appunti della scoperta che salverà il mondo.
Ottanta
Dai languori dei telefoni bianchi agli orrori delle leggi razziali: la parabola di un
regime che fonda città, sorvola oceani, sopprime oppositori e si allea col diavolo.
24 aprile 1932
Telefoni bianchi (e rosa)
Nell’estate del 1942 al cinema Barberini di Roma si proietta la prima di un film
appena presentato al Festival di Venezia. C’è tutta la Roma elegante ed un buon
numero di agenti in borghese. Qualcuno getta nella sala due bombolette puzzolenti e
subito si levano dalla platea voci tranquillizzanti: niente paura, non sono peti, sono
petacci!
La volgare bravata non proviene certo dall’antifascismo, ma dall’ambiente dei
gerarchi mussoliniani che intendono deridere l’attrice principale del film, nome d’arte
Miriam di San Servolo, all’anagrafe Maria Petacci sorella di Claretta, l’amante del
Duce.
Il film è intitolato Le vie del cuore. Diretto da un regista di buon nome, Camillo
Mastrocinque, possiamo considerarlo la tomba della scuola dei «telefoni bianchi» o
«ungherese», che si afferma nel cinema italiano a partire dal 1932. Due giovani di
modesto ceto s’incontrano, si piacciono, s’innamorano, si fidanzano, superando
equivoci, contrattempi, interferenze di donne fascinose e ricchi gentiluomini, e alla
fine si sposano con un bell’avvenire davanti a sé. Quasi sempre in Ungheria, dove
allora si pensava che potesse accadere di tutto, chissà perché.
Pochi gli esterni, molti gli arredamenti art déco carichi di vetrate, grandi scale
ricurve, colonne, divani di raso, sotto il dominio di un telefono bianco, ben altra cosa
del triste strumento nero appeso in corridoio nelle case dei piccoli borghesi.
Su quel telefono fantasticano tutte le ragazze d’Italia, il che non toglie che da
questo materiale di bocche a cuore, riccioli, fossette, mossette, un regista come Mario
Camerini riesca a mettere insieme piccoli gioielli come Gli uomini, che mascalzoni!,
Grandi magazzini, Il signor Max. E in fondo di Camerini potrebbe essere la regia
dell’incontro tra Mussolini e Claretta, che risale all’aprile del 1932 (anche se altre
fonti lo spostano al settembre dell’anno successivo).
La famiglia Petacci, sei persone, si dirige verso Ostia stipata in una Balilla. È
superata da una rossa auto sportiva in cui viene riconosciuto Mussolini. Saluti e
sbracciamenti. Il dittatore si ferma e scende a far conoscenza. Una settimana dopo
cerca al telefono la bella Claretta, che da anni lo venera e gli manda poesie.
Comincia una relazione segreta, però seguita passo passo dalla polizia, che indigna
e preoccupa i collaboratori del Duce. Ma il clan Petacci non ha nessuna influenza
politica. Cospicue mensilità passano nelle mani di Claretta, che dovrebbe usarle per
beneficenza, ma forse finiscono in una villa a Monte Mario, la Camilluccia, dove tutti
i Petacci si insediano felici. In camera di Claretta c’è un telefono con un lunghissimo
filo, linea diretta con Palazzo Venezia. Il telefono è rosa.
19 dicembre 1932
Littoria e altre paludi
Mentre un balilla emozionato gli consegna le chiavi della nuova città di Littoria
(l’attuale Latina), Mussolini dà fiato a una di quelle sue massime che poi finiscono
sui muri: «È l’aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende». Nel soldatocontadino vede il proprio autoritratto, nonché l’essenza del fascismo. La bonifica
delle paludi pontine fra Roma e Terracina è iniziata da appena un anno, con la
deportazione di trentamila veneti ai quali viene garantito un podere munito di casa,
stalla e pozzo. Gli obiettivi sono gli stessi della «Battaglia del grano»: ridurre la
dipendenza dall’estero ed evitare che i poveri sciamino verso le metropoli.
Littoria è stata costruita in pochi mesi: seguiranno Pontinia, Aprilia, Pomezia e
prima ancora Sabaudia, dove si esalta il razionalismo architettonico degli allievi di
Piacentini, i trentenni Montuori e Cancellotti. Nei loro progetti la torre del municipio
è alta 42 metri, 10 più di quella di Littoria, il cui podestà mette fieramente il veto. In
democrazia una bega simile bloccherebbe i lavori. Ma le dittature vanno per le
spicce: gli architetti scrivono al Duce che l’abbassamento della torre di Sabaudia
guasterebbe l’armonia della piazza, Mussolini ordina di procedere ed al podestà di
Littoria non resta che abbozzare.
Gli inviati della stampa anglosassone sono entusiasti. Mettono a confronto
l’economia dei due regimi autoritari - fascismo romano e comunismo sovietico mostrando una spiccata preferenza per il «Duce trebbiatore». Così lo chiamano, con
un tocco di humour che lui finge di non cogliere. Più delle paludi vorrebbe bonificare
i caratteri, creando l’italiano nuovo. Fioccano decreti per multare chi suona il clacson,
tassare gli scapoli che non fanno figli, perseguire l’assenteismo negli uffici pubblici.
Resteranno lettera morta. Al pari delle corporazioni, dove padroni e dipendenti
dovrebbero tenersi per mano sotto lo sguardo paterno dello Stato. Presentate come il
superamento del dualismo fra lavoro e capitale, si riducono a un’ingessatura
burocratica che soffoca i conflitti sociali e consente di abbassare i salari del 20%, fra i
peana dei giornali di regime per «la squisita sensibilità delle classi lavoratrici».
Lavori pubblici e sostegni statali (pensioni, colonie estive) alleviano solo in parte i
sacrifici causati dalla rivalutazione della lira («quota 90» cioè 90 lire per una sterlina)
e dagli effetti del crollo di Wall Street. Alla fine del Ventennio fascista «avere mille
lire al mese» sarà ancora un miraggio da canzonetta. Come l’italiano nuovo,
affondato in una palude caratteriale che sembra impermeabile a qualsiasi bonifica. Lo
riconosce persino lo sconsolato dittatore:
«Governare gli italiani non è difficile. È inutile».
19 luglio 1933
L’altro fascista
Lo stormo di idrovolanti sorvola i grattacieli di Manhattan e atterra sulle acque del
fiume Hudson, prima di concedersi un bagno di folla davvero oceanica. Un milione di
newyorchesi si riversano lungo le strade per osannare Italo Balbo, il ministroaviatore. Con particolare trasporto quelli di Little Italy, guidati per l’occasione dal
nuovo campione del mondo dei pesi massimi, Primo Carnera.
Decollata da Orbetello per celebrare con una crociera aerea il decimo compleanno
del regime, la spedizione dei «camerati atlantici» ha consumato la sua prima apoteosi
a Chicago, dove il sindaco intesta a Balbo la Settima Strada e i Sioux gli impongono
il nome di Capo Aquila Volante. Il coraggio e l’aspetto del gerarca ferrarese
sembrano fatti apposta per colpire la fantasia degli americani, che ancora oggi
chiamano «balbo» il pizzetto coi baffi.
Al ritorno in patria il fascismo lo tratta come un console vittorioso dell’antica
Roma, decretandogli il trionfo sotto l’Arco di Costantino. È lì che Mussolini
consegna a Balbo il bastone di Maresciallo dell’Aria. Ed è lì, probabilmente, che
decide di toglierselo dai piedi.
Il Maresciallo sta diventando più popolare di lui. È giovane, bello e le sue imprese
aviatorie hanno fatto dimenticare il periodo fosco delle manganellate, di cui Balbo era
stato prodigo dispensatore nell’Emilia dei primi anni Venti. Stratega della Marcia su
Roma, ha rivoluzionato l’Aeronautica (ma senza investire nelle portaerei, errore che
l’Italia pagherà caro) e ora tutti sono convinti che Mussolini gli affiderà il comando
delle Forze armate. Invece, a fine anno, la mazzata, ovvero la nomina a governatore
della Libia.
«Come l’ha presa?» chiede Mussolini allo spione che intercetta le telefonate dei
gerarchi (usava già allora). «Ha detto a un amico di avere avuto da Voi l’alto onore di
essere destinato alla Libia». E Mussolini: «Se ha detto “alto onore”, significa che
sapeva di avere il telefono sotto controllo...». Infatti Balbo in privato ne parla così:
«Capito il padrone? Mi ha fatto dire che ho bisogno di riposarmi. Cose da pazzi. Ah,
ma io in Libia non ci vado...».
Poi naturalmente ci va, ma senza mai smettere di fare la fronda: è contrario alle
leggi razziali, contrarissimo a Hitler. Lui, che ci è stato, intuisce che il futuro è
l’America. Ma agli occhi di Mussolini il fatto che Balbo disprezzi i nazisti diventa un
motivo di più per allearsi con loro.
Lo scoppio della seconda guerra mondiale lo troverà al suo posto, in Africa. Solo
per pochi giorni, però: mentre sorvola l’Egitto in volo di ricognizione viene abbattuto
dal fuoco amico. La moglie è convinta che ci sia dietro la manona del Duce, ma il
capo della contraerea liquida l’allusione come «una stupidaggine». Se Mussolini
avesse voluto ucciderlo, lo avrebbe fatto prima. In guerra quelli come Balbo servono
vivi.
16 agosto 1933
Nastro Azzurro
In una notte di tarda estate, una piccola flotta si raduna lungo la costa romagnola.
Sono barche, mosconi, pescherecci, gozzi, qualche cabinato. Richiami nel buio,
risate, canti, lunghi silenzi d’attesa e infine un battito sicuro, potente e le luci sempre
più vicine di una nave enorme. «È il Rex, è il Rex!» Tutti gridano sbracciandosi e
piangendo. 1268 metri della fiancata passano davanti agli entusiasti.
Così Federico Fellini nel suo Amarcord, capolavoro sulla vita degli italiani di
provincia sotto il fascismo, celebrerà l’evento che segna uno dei momenti più alti di
consenso popolare al regime: il transatlantico Rex conquista il Nastro Azzurro. Che è
davvero un nastro di seta azzurra, lungo ventinove metri, assegnato alla nave che ha
percorso in minor tempo il tragitto Gibilterra-New York.
Era del tedesco Bremen, ma il Rex l’ha superato: 4 giorni, 13 ore e 58 minuti alla
velocità di 29 nodi, sotto la guida del comandante Francesco Tarabotto, un marinaio
di Lerici che nel corso della traversata ha perso cinque chili e rosicchiato decine di
matite per la tensione.
Il Rex è una bella nave, costruita in un anno nei cantieri Ansaldo di Sestri Ponente
e varata nel 1932 da Vittorio Emanuele III (Rex) e dalla regina Elena. Ha due motori
potentissimi con quattro turbine, dodici piani collegati tra loro con ascensori e scale.
Può accogliere oltre duemila passeggeri che hanno a disposizione ogni genere di
negozi e ristoranti, due piscine, la palestra, un teatro, una banca e perfino una chiesa.
Un vero gioiello, che non è però uno scafo da crociera come quelli di oggi, bensì una
nave commerciale, costruita per dimostrare l’eccellenza dell’Italia fascista anche nel
campo delle costruzioni navali, dell’eleganza e del gusto.
Nel maggio 1940 compie l’ultima traversata, viene poi trasferita nel porto di
Genova e di lì in quello più sicuro di Trieste. Trasformata in nave-ospedale della
Croce rossa, trasporta i feriti dall’Africa alle coste italiane. L’8 settembre 1944 si
incaglia nei pressi di Capodistria e i bombardieri alleati la colpiscono con
centoventitré razzi incendiari. La nave brucia per quattro giorni prima di affondare.
Da questo momento inizia il grande saccheggio. Tonnellate di acciaio spariscono
verso l’Italia del Nord, tutti gli arredi saranno trafugati e nascerà la leggenda del
«tesoro del Rex». Si racconta che alcuni ufficiali della Wehrmacht abbiano nascosto
nell’immenso rottame oro e preziosi rubati agli ebrei. Sommozzatori autorizzati e
abusivi frugano per anni nello scheletro della grande nave.
Dicerie, fantasiosi racconti, confessioni più o meno autentiche in punto di morte
vengono ripresi da vari giornali senza mai nessuna conferma. Il tesoro era
probabilmente la nave stessa, finita pezzo a pezzo nelle mani di molti predoni. Per
noi resta un nome glorioso, come oggi la Ferrari, perché l’ha saputo poeticamente
evocare, nella sua imponenza notturna, un grande regista.
18 ottobre 1934
Il Feroce Saladino
Sono le 13,05 di un giovedì, giorno di vacanza nelle scuole, e dagli studi EIAR di
Torino va in onda la prima puntata dei Quattro Moschettieri. La radio è ancora un
passatempo per pochi, ma la rilettura satirica dell’epopea di Dumas la trasforma di
colpo in fenomeno di massa: gli abbonati schizzano a un milione. Merito degli autori,
i giornalisti torinesi Angelo Nizza e Riccardo Morbelli. È loro l’idea di mescolare
D’Artagnan con i personaggi più improbabili, da Tarzan a Greta Garbo, mentre
Nunzio Filogamo presta la voce a un Aramis gagà con l’erre moscia.
Come accade spesso con le storie pensate per i bambini, la serie dilaga fra gli
adulti e viene spostata a furor di popolo alla domenica, sempre alle 13,05: è tale il
successo che il campionato di calcio deve ritardare di mezz’ora l’inizio delle partite.
Il fenomeno radiofonico ne innesca un altro di proporzioni anche maggiori. La
Perugina commissiona al disegnatore satirico della «Stampa», Angelo Bioletto, un
centinaio di figurine ispirate ai personaggi della trasmissione da allegare ai suoi
prodotti: Buffalo Bill, Marlene Dietrich, Sandokan, il giovane Vittorio De Sica in
cappotto bianco. Chi completerà un album riceverà cioccolato e racchette da tennis.
Succedeva già con le figurine delle imprese aviatorie di Italo Balbo. Ma ecco la
novità destinata ad entrare nei manuali del marketing: chi di album ne completerà
centocinquanta, potrà realizzare il sogno dell’italiano medio, la FIAT Topolino, il cui
prezzo di listino sfiora le novemila lire.
Per rendere più difficile l’impresa, si stampano alcune figurine in numero minore.
Una su tutte, il Feroce Saladino. La sua ricerca diventa un’ossessione nazionale. A
Milano i ladri che svaligiano la casa di un imprenditore lasciano i quadri e portano
via le figurine. Sempre a Milano, sotto i portici di Santa Radegonda, nasce un
mercato di scambi così affollato che si è costretti a spostarlo dietro l’abside del
Duomo. I bagarini vanno in Sardegna a fare incetta di figurine del Saladino (lì ce ne
sono in abbondanza, chissà perché) per poi rivenderle in continente a cento lire l’una.
Ma bisogna guardarsi dai falsi: la polizia arresta un tizio con una valigia piena di
Saladino taroccati.
Il fenomeno ormai è fuori controllo e preoccupa il fascismo, che come tutte le
dittature è moralista. Nonostante il padrone della Perugina, Giovanni Buitoni, sia il
podestà di Perugia e perori la sua causa davanti al Duce, una legge abolisce i superpremi e obbliga a stampare tutte le figurine dei concorsi in numero uguale. Per il
Feroce Saladino è la fine. Ma suo nipote, l’introvabile portiere Pizzaballa, ne
continuerà fieramente la missione.
18 dicembre 1935
«Noi tireremo diritto»
In una mattina gelida e piovosa, la regina Elena sale i gradini dell’Altare della
Patria e depone nel tripode due anelli d’oro legati da un nastro azzurro. Sono le fedi
nuziali, sua e del Re. Una vedova della Grande Guerra le porge due cerchietti di
ferro. La sovrana se ne infila uno all’anulare sinistro, poi solleva il braccio nel saluto
romano.
L’Italia in camicia nera, affamata di terre e di avventure che ne comprovino la
presunta metamorfosi guerriera, ha invaso l’Etiopia per vendicare l’onta di Adua. E la
comunità internazionale, su iniziativa inglese, ha deciso di castigarla con le «inique
sanzioni».
Il blocco non si estende al petrolio e danneggia scarsamente l’economia, ma
consente agli italiani di indossare i loro panni preferiti, quelli della vittima, e a
Mussolini di dare sfogo alla vocazione teatrale del regime. La «Giornata della fede»,
in cui tutti sono chiamati a consegnare l’oro alla Patria, contagia anche gli
antifascisti: Benedetto Croce offre la medaglia da senatore e Cesare Pavese, in
mancanza d’altro, cinquanta lire.
Nell’impero dei furbi c’è chi corre a comprare una fede d’oro scadente e la
consegna, con grande trasporto, al posto di quella buona. Qualcun altro si accorge che
l’anello di metallo annerisce il dito e di nascosto lo fa dorare all’interno. Durante la
seconda guerra mondiale si passerà al rame delle pentole, per la disperazione di una
matrona veneta col figlio al fronte: «Prima i gh’ha porta via l’oro, poi el fiol, adeso le
pignate. Ghe fa più dolore el fiol, ma ghe fa più rabia le pignate».
L’entusiasmo è spesso sincero. Ma anche quando non lo è, il controllo dei capicaseggiato impedisce di sottrarsi all’obbligo morale. Si tratta di una cerimonia
religiosa basata sul sacrificio, con la Patria al posto di Dio. E c’è naturalmente anche
il diavolo. L’Inghilterra, la «perfida Albione» che vuole impedirci di fare ciò che lei
fa da secoli: invadere e colonizzare le terre altrui.
Vietati gli scrittori inglesi, tranne Shakespeare perché è Shakespeare e George
Bernard Shaw perché ha criticato le sanzioni. Chiuso a Roma l’albergo Eden, che ha
il grave torto di chiamarsi come il ministro degli Esteri britannico. La furia anglofoba
si abbatte sul vocabolario: pullover diventa farsetto, flirt amoretto. E la chiave
inglese? Chiave e basta. L’austerità autarchica colpisce anche a tavola. «La merenda
italiana ha da essere merenda di frutta. Italiani, mangiate pane e frutta!» intima la
propaganda.
Nonostante certe contromisure grottesche, le sanzioni rafforzano il regime,
identificandolo con la nazione. Quando di lì a poco il Duce spalancherà il balcone per
annunciare la presa di Addis Abeba e il ritorno dell’Impero sui «colli fatali», persino
qualche antifascista metterà il tricolore alle finestre.
27 aprile - 9 giugno 1937
Compagni d’Italia
Gramsci e Rosselli: una dopo l’altra scompaiono le coscienze dell’antifascismo,
eredi ideali dei Gobetti e degli Amendola morti in Francia negli anni Venti per le
conseguenze dei pestaggi squadristi.
Il 27 aprile 1937 Antonio Gramsci si spegne alla clinica Quisisana di Roma,
stremato da dieci anni di prigionia. Il 9 giugno Carlo Rosselli viene ucciso in Bassa
Normandia da una banda di fascisti francesi, i cagoulards (gli incappucciati), su
commissione del governo italiano. Entrambi sono isolati: invisi al regime, ma anche a
molti compagni di lotta che mal ne sopportano la libertà di pensiero e la diffidenza
nei confronti dello stalinismo.
Gramsci muore in solitudine, dopo aver perso ogni contatto con la moglie e coi
figli emigrati in URSS, emarginato dallo stesso Partito comunista che ha contribuito a
fondare e che solo dopo la morte si approprierà del suo mito e delle sue idee. Una su
tutte, l’egemonia culturale come premessa di quella politica.
Nulla gli viene risparmiato. In carcere l’ostracismo degli stalinisti (una volta,
durante l’ora d’aria, gli tirano addosso una palla di neve con una pietra dentro) e, a
cadavere ancora caldo, il necrologio sprezzante di Mussolini: «Era un avido taccagno
che si nutriva di pasticcini mentre gli altri crepavano».
Negli stessi giorni i servizi segreti del Duce, quasi sicuramente su ordine del
ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, organizzano l’assassinio di Rosselli, uomo da
tavolino cui è toccata in sorte una vita avventurosa. Arrestato per aver fatto scappare
all’estero il leader socialista Turati, evade dal confino di Lipari e ripara in Francia. Lì
fonda il movimento Giustizia e Libertà e pubblica Socialismo liberale, bibbia della
sinistra anticomunista che gli procura la scomunica di Togliatti.
Rosselli è il primo a dire che il nazifascismo va combattuto con le armi e allo
scoppio della guerra civile spagnola mobilita gli antifascisti italiani dai microfoni di
Radio Barcellona. Egli stesso organizza una brigata socialista e liberale, forse persino
troppo: «Ho visto Rosselli fare la fila per il rancio in mezzo ai suoi soldati» annota
con stupore il capo partigiano Pacciardi, persuaso che anche negli eserciti
democratici occorra un po’ di gerarchia.
Ferito a una gamba, Rosselli va a curarsi alle terme di Bagnoles de l’Orne, dove lo
raggiunge il fratello Nello. Durante uno spostamento in auto, una macchina inchioda
davanti alla loro. Nello scende per vedere di cosa si tratta e una sventagliata di mitra
abbatte prima lui e poi Carlo, seduto al volante. I giornali italiani accusano del delitto
la massoneria e i comunisti, ma in Francia la verità viene a galla e, nonostante la
censura, riesce a oltrepassare il confine. La fronda al regime da parte dei giovani
fascisti delusi come Montanelli comincia allora.
15 gennaio 1938
Ha vinto Lei
Dietro la testa dell’esercente è appeso al muro un cartello picchiettato di nero con
la scritta «Guerra alle mosche». Il cliente, scacciando con la mano un nugolo di
insetti, domanda al bottegaio: «Ma la guerra?». E l’altro: «L’hanno vinta le mosche».
Sono anni in cui si affollano molte iniziative del regime stimolatrici di barzellette:
l’oro alla Patria, il passo romano per l’esercito copiato dal passo dell’oca prussiano,
la «Battaglia del grano» con Mussolini trebbiatore a torso nudo, l’uso del ruvido
orbace sardo per le divise fasciste, stoffe prodotte con caseina o ginestre, l’abolizione
della stretta di mano in quanto saluto scarsamente igienico e bellicoso, e una pioggia
di decreti contro il ricorso a vocaboli stranieri. Dietro molte di queste trovate c’è la
fervida mente di Achille Starace, segretario del partito detestato dai massimi gerarchi,
che costringe a saltare nel cerchio di fuoco a prova del loro «fegato». Ma non è
Starace a proporre l’abolizione del «lei».
Uno scrittore fiorentino, piuttosto prolifico e di medio valore, Bruno Cicognani, sul
«Corriere della Sera» scrive un articolo contro l’uso della terza persona femminile
quando parliamo a un compatriota o riportiamo dialoghi in un giornale o in un
romanzo. Cosa c’entra quella «lei»? Non solo è un giro tortuoso, barocco,
spagnolesco, ma crea confusione. Sarebbe meglio se gli italiani, ormai tutti camerati
fascisti, tornassero al semplice «tu» ovvero, a segnare rispetto e distanze sociali, al
«voi».
L’autore non immagina di aver gettato un sasso nello stagno.
Benedetto Croce, guru indiscusso dell’antifascismo che per tutta la vita a Napoli si
è servito appunto del «voi», lo abbandona immediatamente a favore del «lei», l’uso
del quale diventa così un gesto politico. E il fascismo reagisce con una grande
campagna per l’abolizione del servile «lei» e impone ai suoi innumerevoli enti, a
partire dalla scuola, un maschio ritorno al «voi».
La rivoluzione non è agevole. Gli italiani, come ogni altro popolo, sono abitudinari
e continuano a stringersi la mano con un sorrisetto e a chiedersi l’un l’altro: «E lei
come sta?». Finito il fascismo tutti tornano tranquillamente al «lei» con un senso
quasi di liberazione. Ma a rileggere oggi l’articolo di Cicognani si vede che le sue
argomentazioni non erano tutte da buttare. Verri, Annibal Caro, Baretti, Leopardi non
sopportavano il «lei», goffo, ridicolo, assurdamente inchinevole, oltre che
imbarazzante eredità della dominazione spagnola.
Hanno vinto le mosche, d’accordo, ma non è che quei neri insetti siano proprio il
massimo.
3 maggio 1938
Due dittatori e un intruso
Altro che apoteosi del nazifascismo. La visita ufficiale di Adolf Hitler in Italia si
rivela la parodia di un film dì Charlie Chaplin. Il Führer scende dal treno alla stazione
Ostiense, scambia saluti romani col suo Duce adorato e sta per salire in auto accanto
a lui quando, con sua enorme sorpresa, viene dirottato sulla carrozza reale. In base al
cerimoniale, il capo dello Stato tedesco deve viaggiare con l’omologo italiano, che
non è Mussolini ma il Re.
I cinque chilometri di tragitto notturno dalla stazione al Quirinale, fra due ali di
folla inesorabilmente «festante» e i fuochi che illuminano i monumenti della Roma
imperiale, si rivelano una sofferenza per tutti. Per il Duce, che vorrebbe essere sulla
carrozza e invidia l’allievo tedesco, capo dello Stato e delle Forze armate, mentre lui
è solo Primo Maresciallo dell’Impero e anche lì bisognava aver visto la faccia del Re
quando ha saputo della nomina. Per Vittorio Emanuele, che nei confronti del Führer
prova una ripugnanza quasi fisica («È una specie di degenerato» dirà). Ma soprattutto
per Hitler: non capisce come mai Mussolini non abbia ancora internato in un ospizio
quel vecchietto insulso, che per rompere il ghiaccio gli ha chiesto quanti chiodi
abbiano le scarpe dei soldati della Wehrmacht.
Arrivati al Quirinale, il Führer si congeda con un sospiro di sollievo, ma a
mezzanotte lo si sente strillare in tedesco nei corridoi: «Voglio una donna!».
Momenti di panico fra i corazzieri. In realtà chiede una donna delle pulizie che gli
rifaccia il letto un po’ meglio.
Il giorno dopo Hitler si vendica del sovrano sperticandosi in elogi per Mussolini.
«Conservate pure quel mobile di velluto e oro, ma metteteci sopra il Duce!» sbotta il
gerarca nazista Goebbels in visita alla Sala del Trono. «Quello lì» e indica il Re «è
troppo piccolo». Vittorio Emanuele si morde la lingua in pubblico, ma in privato
sparla senza ritegno degli ospiti: «I tedeschi sono mentitori costanti. Come i preti e le
donne: gli dai un dito e si prendono il braccio».
E Mussolini? È in imbarazzo. Non ricambia l’adorazione di Hitler, però ne ammira
l’energia vitale (che lui non ha più) e ne subisce il fascino, sorbendosi in silenzio i
suoi terrificanti monologhi. La verità è che si vergogna nel farsi vedere dai nazisti
così poco risoluto nei confronti del Re. Il quale si permette persino di sfotterlo:
«Sapete, caro Duce, che i tedeschi vi chiamano il Gauleiter {governatore regionale}
d’Italia?».
Mussolini si sfoga con Galeazzo Ciano, genero e ministro degli Esteri: «Basta, ne
ho le scatole piene. Io lavoro e lui firma. Aspetto ancora, perché ha settant’anni e
spero che la natura mi aiuti». Forse ha in mente di seppellire, col Re, anche la
Monarchia. Ma il suo amico Hitler non gliene lascerà il tempo.
15 luglio 1938
La grande vergogna
I giornali pubblicano il Manifesto della razza, firmato da un gruppo di «studiosi»
fascisti, dove si afferma che esiste una razza italiana, che questa razza è ariana e
risale a un migliaio di anni prima, dai Longobardi in su. Praticamente nessuno in
Italia ci ha mai pensato, l’idea di questo purissimo sangue nazionale non abita nelle
nostre menti, ma tutti capiscono che è suonata l’ora dell’antisemitismo alla nazista.
Gli ebrei in Italia sono circa quarantamila e sono perfettamente integrati. Molti
hanno combattuto con onore nella Grande Guerra, molti hanno aderito al fascismo.
Ma le disposizioni che li riguardano si succedono di mese in mese, accumulando
divieti: gli ebrei non potranno insegnare nelle nostre scuole, né sposarsi con noi
purissimi ariani, né possedere fondi, case, attività commerciali, né ricoprire cariche
pubbliche. Ognuno di questi decreti è firmato da Mussolini e promulgato dal Re.
Sono le leggi razziali.
Gli ebrei più pessimisti o lungimiranti non credono alle poche scappatoie concesse
dal regime. Chi può se ne va all’estero come Fermi e Segrè (e Einstein si dimette
dall’Accademia dei Lincei). Altri fanno finte vendite dei loro averi a prestanome, altri
rivendicano invano i loro meriti di patrioti. La Chiesa non prende una posizione
ufficiale. Da sempre ha perseguitato, accolto, sfruttato, talvolta torturato quelli che
considera i «deicidi», ma è indifferente alla questione del purissimo sangue. Del resto
la parola «ghetto» è pur sempre italiana, «fonderia» in veneziano. Alcuni vescovi si
espongono dal pulpito, altri tacciono, uno prova ad intercedere, invano, presso
Mussolini. I soccorsi non mancano, ma sempre sotto traccia, senza compromettere le
massime gerarchie.
Si fa intanto largo la figura di Giovanni Preziosi, l’unico autentico antisemita.
Preziosi ripubblica nel ‘38 i Protocolli dei Savi di Sion, un documento fabbricato
dalla polizia segreta zarista, e fonda e dirige diversi «fogli» con ammirati riferimenti
alla politica razziale di Hitler. Dopo l’8 settembre si installa nei dintorni di Salò dove
continua la sua battaglia contro la «congiura giudaico-massonica». Il Duce lo riceve
spesso e mal gliene incoglie perché Preziosi è temutissimo dai suoi stessi camerati
come iettatore. Morirà spiaccicato nell’aprile del ‘45 buttandosi da una finestra di
corso Venezia a Milano.
Quando le leggi razziali vengono abrogate, comincia una serie interminabile di
contenziosi sui beni trafugati degli ebrei in fuga, di cui gli eredi reclamano la
restituzione. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scordiamoci il passato, dice
la canzone; ma è impossibile scordarsi di quella che per molti è la più ributtante
vergogna del fascismo e della Monarchia.
Novanta
Guerra mondiale e civile, macerie visibili e altre nei cuori. Poi la Liberazione, la
Repubblica, la ricostruzione. Un’attrice urla, un ebreo ricorda e un sogno si
schianta.
1940-1945
La Tragedia (in cinque atti)
Atto I
Vincere! E perderemo. La tragedia comincia con un uomo affacciato al balcone,
sospeso su una folla plaudente. Finirà con lo stesso uomo appeso a testa in giù e preso
a sputi da tutti.
L’uomo al balcone è la caricatura di se stesso: imbolsito, grottesco, l’aria di chi
non crede più a quello che dice. Quando, nel settembre del 1938, si è mostrato allo
stesso balcone per annunciare gli accordi di Monaco che ritardavano l’inizio delle
ostilità, l’ovazione pacifista della piazza lo ha sconvolto. Il suo tentativo di
trasformare in vent’anni un popolo che non coltiva virtù militari da venti secoli è
miseramente fallito. Ha egualmente firmato il Patto d’Acciaio. È consapevole che un
Hitler vittorioso non tollererà alleati ma solo satelliti, però è anche così provinciale e
soggiogato dall’energia del nazismo da sottovalutare gli inglesi e soprattutto gli
americani.
Dopo aver assistito ai blitz della Wehrmacht sotto l’ombrello di cartone della non
belligeranza, il 10 giugno 1940 si decide a pugnalare alle spalle la Francia già uccisa
da Hitler. «A settembre tutto sarà finito e io ho bisogno di qualche migliaio di morti
da mettere sul tavolo della pace». Ma la pace non arriva. Arriva invece l’ordine di
«spezzare le reni» alla Grecia - il cui dittatore è un potenziale alleato - per pura
smania di un successo da contrapporre a quelli tedeschi. L’offensiva scatta a fine
ottobre, quando i sentieri dell’Epiro sono trappole di fango. Nell’inverno in cui
l’industria laniera lancia la moda dei calzettoni per signora, gli unici a non averli in
dotazione sono gli alpini, che moriranno congelati. In compenso ricevono un
impressionante stock di scarponi, tutti sinistri. Il generale Visconti Prasca non chiede
rinforzi perché, se il corpo di spedizione venisse allargato, dovrebbe cedere il
comando a un militare più anziano. Garantisce per iscritto che i greci non hanno
alcuna voglia di combattere ed infatti in meno di un mese ci hanno già ricacciato in
Albania, nonostante l’arrivo di un nuovo comandante, Soddu, rimosso quando si
viene a sapere che la sera, invece dei piani di battaglia, compone musica da film. Un
Hitler furibondo è costretto ad accorrere in soccorso.
Salta la testa del capo di Stato maggiore, l’immarcescibile Badoglio: «fisicamente
distrutto e intellettualmente intorpidito», certifica il Re, che tre anni dopo gli darà in
mano il Paese. Prima ci saranno altri sfaceli, nonostante le imprese del Savoia
Cavalleria in Russia, di Luigi Durand de la Penne in Egitto, degli alpini della Julia
ovunque: i soliti eroismi di singoli o di piccoli gruppi che non riescono a nascondere
il fallimento dell’insieme.
Chissà se l’uomo al balcone avrà mai riflettuto che l’«Italietta liberale», da lui
tanto disprezzata, fu capace di resistere sul Piave. Mentre la sua, «romanamente
forgiata», è talmente gonfia di retorica da squagliarsi senza dignità. Durante lo sbarco
alleato a Pantelleria, che nel giugno 1943 vìola «il sacro suolo della Patria», l’unico
morto italiano sarà un soldato preso a calci da un mulo.
Atto II
L’uomo al balcone è a tavola con la moglie, ma non tocca cibo. «Li hai almeno
fatti arrestare tutti?» chiede donna Rachele. No, non l’ha fatto. È sicuro che Dino
Grandi e gli altri gerarchi che la notte prima lo hanno messo in minoranza nel Gran
Consiglio del fascismo si pentiranno dell’errore. «Vado a Villa Savoia. Il Re mi vuole
vedere». «Prima falli arrestare tutti» insiste lei. Invano.
Alle 5 della sera del 26 luglio 1943, l’Alfa del dittatore attraversa una Roma
intontita dall’afa e dallo choc per le bombe americane cadute a San Lorenzo nei
giorni precedenti. Intanto a Villa Savoia si danno gli ultimi ritocchi al colpo di Stato.
Esercito, carabinieri e polizia sono in mani fidate. E il successore designato,
Badoglio, ha già controfirmato la lettera di licenziamento del Duce. I fascisti
dissidenti si illudono ancora che Vittorio Emanuele affiderà a loro il governo. Hanno
votato contro il capo per prenderne il posto e non si sono resi conto che con lui
stavano seppellendo il regime.
Mussolini, l’uomo più sospettoso del mondo, non sospetta alcunché. Il Re lo saluta
con faccia di circostanza: «Caro Duce, l’Italia va in tocchi... La guerra è perduta e il
voto del Gran Consiglio tremendo». «Possiamo ancora farcela». «Gli alpini non
vogliono più battersi per voi». «Si batteranno per voi, Maestà». «Le mie decisioni
sono state già prese. Il nuovo capo del governo è il maresciallo Badoglio». «Ma io
resto il capo del fascismo!» urla un Mussolini invecchiato di colpo. Il Re cerca di
calmarlo e intanto lo accompagna verso l’uscita con piccole spinte. Mussolini,
attonito, muove qualche passo in giardino, dove un ufficiale dei carabinieri lo prega
di seguirlo «per la sua incolumità».
Lo fanno salire su un’ambulanza lercia che parte sgommando. L’ex dittatore si
spaventa: «Qui andiamo a sbattere contro un muro!». È convinto che alla notizia del
suo arresto l’Italia fascista insorgerà. Invece si assiste al più colossale spogliarello
politico della Storia: tutti i funzionari dello Stato, persino i fascistissimi della Milizia,
buttano la camicia nera e ne indossano un’altra immacolata, professando fedeltà al
Re. I dissidenti del Gran Consiglio scappano per paura di essere arrestati: non più da
Mussolini, adesso, ma da Badoglio.
«È fatta» sussurra Vittorio Emanuele all’orecchio della regina Elena, l’unica in
questa storia a conservare un po’ di dignità: «Far arrestare il primo ministro in casa
propria non è un gesto da sovrano» sbotta. Il marito cerca di prenderla sottobraccio,
ma la figlia del pastore montenegrino si ritrae e corre a chiudersi in camera sua, non
prima di avergli urlato: «Mio padre non lo avrebbe mai fatto!».
Atto III
L’uomo che fu il Duce è condotto in morbide catene sul Gran Sasso, dove
apprende dalla radio il nuovo colpo di scena: la resa incondizionata spacciata per
armistizio, con una clausola che prevede la sua consegna agli Alleati. Chiede lumi ai
carcerieri, ma i soldati di Badoglio ne sanno quanto lui. Nel loro sguardo
interrogativo c’è il dramma di un esercito e di un popolo abbandonati a se stessi.
La mattina dell’8 settembre 1943 il Re ha tenuto buono l’ambasciatore tedesco
spergiurando che l’Italia è legata ad Hitler «per la vita e per la morte». In Sicilia il
generale Castellano ha firmato l’armistizio da giorni, però si spera ancora che i
paracadutisti anglo-americani calino su Roma prima che la notizia del ribaltone
giunga all’orecchio dei nazisti. Invece dei parà, arriva un messaggio cifrato di
Eisenhower e il nostro Stato maggiore non ha ancora finito di decrittarlo che Radio
Algeri lo sta già diffondendo in tutto il mondo: è l’annuncio della resa.
Hitler urla al tradimento e ordina l’invasione. In casi simili è già successo che i
capi abbandonino la capitale, ma non che lascino soldati e funzionari senza
comunicazioni. Mentre la famiglia reale ed il maresciallo Badoglio fuggono in auto
lungo la Tiburtina, seguiti da un codazzo di cortigiani e alti ufficiali in borghese,
Roma viene occupata dai tedeschi e al fronte due milioni di militari si ritrovano alla
mercé degli ex alleati. I reduci dalla Russia vengono deportati in Germania. Chi non
consegna le armi finisce contro un muro, come a Cefalonia, o fra i partigiani. Ma
quasi ovunque il soldato italiano butta la divisa e fugge. L’esempio non è forse
venuto dall’alto?
Nella fretta Badoglio ha smarrito la valigia con i soldi incamerati durante il regime
ed ha lasciato nelle mani dei nazisti la riserva aurea della Banca d’Italia. Sul molo di
Pescara c’è gran ressa: colonnelli e generali fanno a gomitate per salire sulla
Baionetta, l’imbarcazione che porterà a Brindisi quel niente che resta dello Stato.
Non si trova più Badoglio: sarà rientrato a Roma per difendere la città? Macché, sta
già in barca, era andato avanti per prendere il posto.
Il Re si sistema a poppa con la Regina e il principe Umberto, l’unico che vorrebbe
tornare indietro: i figli e la moglie sono in Val d’Aosta e Hitler ha dato ordine di
catturarli. Ripareranno in Svizzera. La sorella di Umberto, Mafalda, avrà minor
fortuna e finirà nel lager di Buchenwald.
Sul Gran Sasso, intanto, sta scendendo uno stormo di alianti. «Inglesi?» domanda
rassegnato Mussolini ai suoi carcerieri. «No, Eccellenza, tedeschi». «Questa non ci
voleva proprio». Può darsi che menta, ma anche che sia sincero: certe liberazioni non
cambiano il destino, lo ritardano soltanto.
Atto IV
Siede nell’ufficio di Gargnano sul Garda a far finta di comandare, attorniato dalle
SS che lo controllano con la scusa di proteggerlo. La figlia non gli parla più, dopo che
il marito Galeazzo Ciano, uno dei congiurati del Gran Consiglio, è stato fucilato per
alto tradimento e lui non ha mosso un dito per salvarlo. Lo riscuote un brusio stentato
di voci che urlano il suo nome dal cortile. «Sentite?» commenta amaro col suo
assistente. «Piazza Venezia è già piena...»
L’uomo affacciato al balconcino è ormai lo spettatore di se stesso. Hitler lo ha
issato alla guida formale del Nord Italia, i cui abitanti vivono giorni terribili. In cielo
le bombe alleate, in terra le squadracce nere ed i mitra nazisti. A Marzabotto entrano
persino in chiesa, uccidono il prete sull’altare e poi al cimitero tutti gli abitanti,
neonati compresi. Un intero paese sconta gli aiuti prestati alle bande partigiane, che la
leva obbligatoria della Repubblica di Salò sta rimpinguando di disertori. Gli angloamericani ritardano la risalita della penisola e si limitano a farsi vivi dall’alto: il 20
ottobre 1944 le bombe destinate alla Pirelli di Milano finiscono su una scuola di
Gorla, uccidendo duecento bambini: da Abbondanti Ernesta a Zucchetti Giovanni.
Mussolini manda una corona di fiori.
In teoria anche Roma appartiene al suo regno di cartapesta. In pratica vi
comandano Kesselring e le SS di Kappler e Priebke, un tandem di assassini che
trasforma il centro culturale di via Tasso in un anticipo di lager. Pio XII fa quel che
può, ma dice meno di quel che dovrebbe, nel timore che una presa di posizione
ufficiale possa portare lutti peggiori. Il 23 marzo 1944, venticinquesimo onomastico
del fascismo, i GAP comunisti fanno saltare per aria un battaglione di soldati
altoatesini in via Rasella. I morti sono 33 ed Hitler ordina lo sterminio di 50 italiani
per ogni tedesco ucciso. Kesselring lo convince ad accontentarsi di una percentuale di
10 a 1.
Se gli attentatori si costituissero, verrebbe meno la rappresaglia? No, stavolta i
nazisti non hanno posto la classica condizione: se i colpevoli si consegnano, gli
innocenti non li ammazziamo più. I loro corpi, quindi, andrebbero solo ad
aggiungersi al mucchio. La colpa dei GAP, semmai, è di aver agito nel cuore della
capitale secondo logiche di guerra, quando era scontato che a pagare il conto
sarebbero stati dei civili inermi. La mano sinistra di Kappler accarezza un cane
malato mentre la destra compila la lista di ebrei e partigiani. Alla fine, con l’aiuto di
due boia del peggior fascismo, ne scoverà cinque più del dovuto: 335, da Agnini
Ferdinando a Zironi Augusto.
Il comandante del battaglione di via Rasella si rifiuta di guidare il plotone
d’esecuzione. Sono le ss di Kappler, ubriache di cognac per vincere il disgusto, che
accolgono le vittime all’ingresso delle Fosse Ardeatine, sparando a ciascuna un colpo
alla nuca. L’uomo affacciato al balconcino non viene neppure avvertito.
Ultimo atto
È il 25 aprile 1945, apoteosi di libertà e di violenza. Basta essere additati come
fascisti e si finisce alla gogna, quando non al muro. Quel che resta di Mussolini è un
animale braccato: rifiuta l’aereo che potrebbe portarlo in Spagna e scappa da Milano
per raggiungere una Svizzera che di ora in ora diventa sempre più improbabile.
I partigiani lo scovano a Dongo su un camion di tedeschi in ritirata, travestito da
caporale della Wehrmacht. La scena è grottesca, il séguito un enigma. Chi lo uccide,
insieme con l’incolpevole Claretta, contro il muretto di una villa a Giulino di
Mezzegra? Chi s’impossessa della cartella che contiene il suo carteggio con
Churchill? E le sterline e i lingotti, il famoso oro di Dongo?
L’esecutore materiale (su ordine del CLN, il Comitato di liberazione nazionale) è un
comunista, ma non è detto sia quel Walter Audisio che se ne assume orgogliosamente
la paternità. Il carteggio è probabile che finisca nelle mani più interessate a farlo
sparire: mani inglesi. Quanto ai lingotti, chiunque li abbia presi non ha lasciato
testimoni. Tutti i partigiani che entrano in contatto con l’oro di Dongo troveranno la
morte in circostanze misteriose.
L’epilogo ha un sapore tribale. Quei cadaveri scaricati all’alba in piazzale Loreto,
dove i fascisti milanesi hanno compiuto una delle loro ultime carneficine. Il popolo si
accanisce con sputi, calci, schizzi d’urina e cinque rivoltellate al cuore di Mussolini
(«una per ogni figlio che mi hai mandato a morire in guerra» urla la pistolera). I corpi
vengono appesi al traliccio di un distributore di benzina, a testa in giù. C’è anche
Bombacci, che lasciammo a Livorno tra i fondatori del Partito comunista, poi
evidentemente ha cambiato idea. Al gruppo si è aggiunto l’atletico ma non
astutissimo Starace, ucciso per le vie di Milano mentre faceva jogging come se niente
fosse. Un prete, mosso a pietà, chiude la gonna di Claretta con una spilla da balia.
Nei giorni successivi la mattanza continua in tutta la pianura padana, mentre i
partigiani di Tito rastrellano Trieste e gettano vivi nelle foibe di Basovizza
quattrocentocinquanta metri cubi di esseri umani.
Ogni tragedia prevede una catarsi, anche questa che continua a dividere gli animi
dopo oltre sessant’anni. Nella guerra civile si scontrarono due Italie che
comprendevano di tutto: idealisti e profittatori, aguzzini ed eroi, talvolta confusi nella
stessa persona. Ma nel giudizio politico le due Italie non possono venir messe sul
medesimo piano. Neppure se si accetta la tesi che entrambe combatterono, più o
meno consapevolmente, alle dipendenze di una potenza straniera. Perché la vittoria
dell’America capitalista (da noi i sovietici erano fuori gioco, con buona pace di quei
comunisti che sognavano la rivoluzione) garantì un benessere diffuso e le libertà
fondamentali. Mentre il Reich nazista avrebbe trasformato la Penisola nell’appendice
mediterranea di un lager.
15 aprile 1944
Professor Gentile?
Alle 13,30 una macchina si ferma davanti al cancello di una lussuosa villa sulle
colline di Firenze, ma prima che l’autista scenda ad aprire, due giovani ciclisti si
avvicinano. Dentro c’è un passeggero massiccio, canuto, sorridente. «È lei il
professor Giovanni Gentile?» gli chiedono. Alla risposta affermativa estraggono le
pistole, sparano e fuggono in sella alle loro biciclette. Hanno «giustiziato» il più
illustre filosofo fascista, un atto terroristico su cui ancora si discute. Era proprio
indispensabile?
Ovviamente lo studioso non si è mai macchiato le mani in modo diretto e anzi i
suoi ultimi discorsi implorano una fraterna riconciliazione tra gli italiani schierati su
fronti opposti. Ma proprio questo indigna gli antifascisti. Gentile è l’autore della
riforma fascista della scuola, ha occupato posti chiave nella cultura del Ventennio, ha
aderito alla Repubblica di Salò, ha accettato di presiedere l’Accademia d’Italia ed è
visto come un cinico opportunista, corruttore delle giovani generazioni. Per di più è
molto metodico e si muove senza scorta. La condanna è inevitabile ed una brigata
comunista si incarica di eseguirla.
Per tutta la vita Gentile di fronte a sé ha visto crescere l’ombra di un grande
antagonista, Benedetto Croce. Entrambi «idealisti», entrambi hegeliani, entrambi
ostili al positivismo ottocentesco, i due hanno per qualche tempo collaborato,
lasciandosi poi dividere da sottili divergenze filosofiche e soprattutto dal fascismo
che Croce, come molti, considera dapprima un male passeggero e inevitabile. Ma, col
delitto Matteotti e la dittatura, le strade di Croce e Gentile si divideranno per sempre.
Il filosofo napoletano si ritira nel suo vasto appartamento e si dedica interamente
agli studi di estetica, storia, etica e critica letteraria. Non costruisce un vero «sistema»
ma la sua cultura è sterminata, il suo prestigio altissimo in tutto il mondo. Mussolini
lo giudica inoffensivo. In realtà sa di non poterlo toccare. Croce diventa un autentico
mito per le varie anime dell’antifascismo. Tutti vanno a trovarlo per discutere con lui
degli eventi in corso, sempre più tragici. All’arrivo degli Alleati entra nel governo.
Rifonda il Partito liberale e torna ad occuparsi di politica attiva a tempo pieno, fino
alla morte nel 1952.
Quanto all’uomo che ha ucciso Gentile, è Bruno Fanciullacci, operaio comunista
che trova rifugio nello studio dell’ignaro Ottone Rosai, illustre pittore di Firenze, e
viene catturato per caso dai fascisti in una retata e torturato per due giorni. Per non
parlare si butta dalla finestra della stanza degli interrogatori e muore sul colpo.
26 settembre 1945
L’urlo della Magnani
A pochi mesi dalla fine della guerra, gli italiani che vanno al cinema sono piuttosto
scontenti. Con l’arrivo degli americani si aspettavano nuove meraviglie di Hollywood
e invece si devono sorbire film di propaganda patriottica usa, mentre le commedie
leggère dei bei tempi sembrano scomparse.
Si rispolverano Fred Astaire e Ginger Rogers, Clark Gable e la biondissima Jean
Harlow, ma alla fine è più attraente una coppia amatissima del varietà italiano, il
grosso Aldo Fabrizi e la pirotecnica Anna Magnani, da anni operanti sulle passerelle
della rivista tradizionale. Sono interpreti di un nuovo film, Roma città aperta, del
giovane regista Roberto Rossellini e promettono sano divertimento popolare.
Ma quando le luci si spengono i due comici romani non sono più gli stessi. Lui è
un prete impegnato a proteggere quanti combattono l’occupazione tedesca e finisce
fucilato, lei è una popolana coinvolta nella lotta clandestina, che verrà abbattuta dai
nazisti sotto gli occhi del figlioletto mentre insegue urlando una camionetta che le
porta via il suo uomo.
«Francescooo!» Quell’urlo segna l’inizio del cosiddetto neorealismo, termine come
sempre difficile da definire ma che porta il cinema italiano al più alto livello mai
raggiunto. La Magnani, da stellina del varietà, diventa di colpo la più grande attrice
tragica del Paese ed è richiesta da tutti i produttori del mondo. Tre anni dopo, con
Ladri di biciclette, De Sica meriterà l’Oscar, Rossellini proseguirà con Paisà e
Germania anno zero. È una scuola ma senza un manifesto, senza un teorico. C’è
piuttosto quella presa sulla realtà, sfuggita o proibita per vent’anni, che accomuna De
Santis, Lattuada, Germi, Visconti, Lizzani, registi di valore diverso, ma tutti in certo
modo costretti a una visione infallibile di ciò che li circonda.
Macerie ancora vere, cappotti rivoltati, fame, freddo, paura, disperati espedienti per
sopravvivere. Molti degli interpreti non sono attori ma vengono presi dalla strada e
tuttavia da quel crudo, cupo bianco e nero non traspare il minimo ammicco di cinema
verità, di docu-fiction, di reality. Non c’è, per un magico momento, nessuna distanza
tra lo schermo e lo spettatore.
Così il neorealismo viene accolto e ammirato nel mondo. Un po’ meno in Italia,
dove di lì a poco il boom economico metterà fine a tanta fulminea creatività,
facendola scivolare nel genere «leggero» e talvolta geniale della commedia
all’italiana, che avrà in Risi, Monicelli e Scola i suoi maestri e in Gassman, Tognazzi
e Sordi le maschere indimenticabili.
2 giugno 1946
L’ostetrica Palmiro
Monarchia o Repubblica? L’Italia si mette in coda sotto il sole e per la prima volta
ci sono anche le donne: qualcuna esagera e tenta di votare due volte come la
marchesa Nunziante, nipote di Benedetto Croce, che viene arrestata. Ai seggi si
presenta l’89,1% degli elettori. Dopo vent’anni di digiuno c’è un certo appetito di
democrazia: i fascisti la chiamavano «elezionismo» e se ne consideravano il vaccino.
La regina Maria José, anticonformista fino in fondo, infila nell’urna una scheda
bianca. Il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi rispetta la fila, ma lo
riconoscono e lo lasciano passare: «Tanto faccio presto, so già per chi votare». Forse
sa già anche chi vincerà. Il socialista Giuseppe Romita e il comunista Palmiro
Togliatti, arbitri di parte dislocati ai ministeri degli Interni e della Giustizia,
vigileranno affinché la Repubblica trionfi. Ma i Savoia hanno giocato sporco per
primi, quando Vittorio Emanuele ha abdicato a un mese dal referendum, così da
consentire al figlio Umberto di arrivarci con la corona in testa.
A metà dello spoglio la Monarchia è in vantaggio. Una nota riservata dei
carabinieri le assegna il 58%. Poi nella notte la situazione si rovescia. Brogli?
Chiamiamolo Vento del Nord: giungono in massa le schede delle regioni
settentrionali che hanno nutrito la Resistenza e sperimentato sulla propria pelle il
comportamento ambiguo dell’ex Re. Persino il Piemonte sabaudo si esprime in
prevalenza contro la «sua» dinastia. La Corte di Cassazione certifica il verdetto, 54%
a 46% per la Repubblica, ma rinvia al 18 giugno la proclamazione.
C’è infatti un problema da risolvere. La legge prevede che il referendum sia
efficace se una delle due opzioni ottiene la maggioranza dei votanti. Mentre il 54%
raccolto dalla Repubblica si riferisce solo ai voti validi, escluse cioè le schede
bianche e nulle. Re Umberto punta i piedi e i suoi seguàci manifestano a Napoli e
Bari, lasciando morti e feriti sul selciato. L’incertezza eccita gli animi e, per
scongiurare altre follie, il Consiglio dei ministri pone il sovrano davanti al fatto
compiuto: nella notte fra l’11 e 12 giugno dichiara che la semplice promulgazione dei
risultati basta a detronizzare il Re e nomina De Gasperi capo provvisorio dello Stato
(la carica passerà poi all’integerrimo e bizzoso Enrico De Nicola).
Il giorno dopo, Umberto II esce dal Quirinale sbattendo la porta. Prima di
imbarcarsi per l’esilio di Oporto lancia un proclama in cui accusa il governo di golpe:
«Sono stato messo nell’alternativa fra provocare spargimento di sangue o subire
violenza». Preferisce subire, specie dopo che il generale Lush gli ha spiegato che gli
anglo-americani non muoveranno un dito per salvargli il posto.
Arriva il 18 giugno, giorno della proclamazione ufficiale. La Cassazione si spacca
- 12 giudici contro 7 - ma decide a maggioranza che per «votanti» vanno intesi
soltanto i voti validi. È nata la Repubblica italiana e il ministro Palmiro Togliatti può
confidare al suo segretario: «I parti difficili vanno aiutati».
1° maggio 1947
Turiddu di Stato
«Compagni, siamo qui riuniti per la Festa del Lavoro...» Nella spianata di Portella
della Ginestra, in provincia di Palermo, il calzolaio socialista Giacomo Schirò ha
appena iniziato a parlare davanti alla folla di contadini quando viene interrotto da una
serie di detonazioni. I bambini pensano che si tratti di mortaretti e corrono gioiosi in
direzione degli spari. Ma in pochi secondi la scena cambia. I mortaretti sono scariche
di mitra e sull’erba rimangono 11 morti e 56 feriti.
A far fuoco, dalla cima del monte Pizzuta, è stata la banda di Salvatore Giuliano,
detto Turiddu. Il bandito ha abbracciato la causa del separatismo siciliano e si è
avvicinato ai servizi segreti statunitensi, che nell’isola (e altrove) hanno cambiato
nemico: non più il fascismo sconfitto, ma il comunismo trionfante.
La vittoria delle sinistre alle elezioni amministrative siciliane di aprile non è
piaciuta al blocco di interessi che comprende proprietari terrieri, mafiosi e notabili già
fascisti e ora democristiani. Giuliano diventa il loro braccio armato, e forse non il
solo: i superstiti della strage insistono nel sostenere che gli spari provenivano anche
da un altro monte, la Cometa. Ma il ministro degli Interni, Mario Scelba, respinge
ogni dietrologia e riduce Portella della Ginestra a «fatto di delinquenza». Ci sono tutti
gli ingredienti per il primo mistero irrisolto dell’Italia repubblicana.
Turiddu pretende la contropartita promessa, l’impunità. Non ottenendola, finisce
per scagliarsi contro i suoi mandanti. Tenta di rapire il padrino della mafia, don Calò
Vizzini, e massacra decine di rappresentanti dello Stato, portando il totale dei suoi
delitti a quattrocentoundici.
Finalmente, nel luglio 1950, il colonnello Ugo Luca può annunciare al mondo che
Salvatore Giuliano è stato ucciso a Castelvetrano durante un conflitto a fuoco con i
carabinieri nel cortile della casa di un mafioso. Ma la versione ufficiale è smontata
dal miglior giornalista-segugio dell’epoca, Tommaso Besozzi. Possibile che Turiddu
sia caduto in una trappola così grossolana? E come mai la sua canottiera presenta una
macchia di sangue sulla schiena, in un punto dove non vi sono ferite? Di sicuro c’è
solo che è morto è il titolo dell’articolo uscito sull’«Europeo».
La verità viene faticosamente a galla. A tradire Giuliano è stato l’amico d’infanzia
Gaspare Pisciotta, che lo ha ucciso nel sonno con due pistolettate, prima che i
carabinieri sparassero al cadavere ed allestissero la messa in scena. Pisciotta dichiara
di essere stato imbeccato da un mafioso che lo ha messo in contatto con le forze
dell’ordine e gli ha garantito la ricompensa dello Stato. E la ricompensa arriverà,
quattro anni più tardi: un caffè allungato con stricnina, offertogli da mani amorevoli
nel carcere palermitano dell’Ucciardone.
2 luglio 1947
Le belle del reame
«Signorina Grandi Firme, con le gonne sempre al vento, ti faremo un monumento
tutto d’or». Così alla radio cantava il trio olandese delle sorelle Lescano. È il 1938 e
il settimanale «Le grandi firme» stampato da Mondadori conosce un successo
straordinario: duecentocinquantamila copie per un florilegio di novellette di autori
più o meno grandi e parecchie rubriche di quello che oggi si chiama gossip e
all’epoca è ancora pettegolezzo.
Ma il vero motivo del successo sta nella copertina interamente dedicata ad una
bella ragazza disegnata da Gino Boccasile: un vento birichino solleva la gonna della
giovane, impegnata a saltare verso un avvenire felice, i capelli fluttuano, il sorriso
non lascia mai le sue labbra perfette. È una forte immagine di spensieratezza, di gioia
di vivere, di libertà.
Dirige il settimanale uno scrittore assai noto che diventerà uno dei maggiori
esponenti del cinema italiano: Cesare Zavattini. Ma «Le grandi firme» ha visto la
luce molti anni prima e ha vivacchiato alla meglio sotto la guida di Pitigrilli,
romanziere scandaloso, poi sospettato di essere un informatore dell’OVRA, la polizia
politica del regime. Pitigrilli è ebreo e deve lasciare la testata, che nella nuova
versione va subito a ruba. Si pensa di eleggere una «miss» Grandi Firme, ma
naturalmente la parola è vietata perché straniera e si ripiega sulla «signorina» che
vola con quelle lunghe gambe perfette.
Le autorità non gradiscono, il modello proposto da Boccasile non è consono ai
tempi, quando ormai i tuoni di guerra si fanno sempre più vicini. Il settimanale viene
chiuso, la donna italiana deve prepararsi a ben altro che svolazzare. E così purtroppo
avviene. Ma non appena il macello finisce, le belle ragazze d’Italia non tardano a
farsi avanti. Possibile che da noi non ci siano creature capaci di tener testa alle pin-up
americane?
Nel 1947 si svolge a Stresa la seconda edizione del concorso di Miss Italia. Le
selezionate provengono da ceti sociali modesti, sono timide, piuttosto mal vestite,
non prive di goffaggini. Una di loro si presenta con un occhio pesto per un pugno del
fratello che voleva impedirle di partecipare. Si tratta di Lucia Bosè, la vincitrice, che
fa la commessa in una pasticceria di Milano. Diventerà una delle muse di
Michelangelo Antonioni.
È un’annata straordinaria per il cinema italiano che su quella passerella scova le
sue stelle maggiori: Gina Lollobrigida, Eleonora Rossi Drago, Gianna Maria Canale,
la pigra «miss Lazio» Silvana Mangano (che rinuncia alla finale perché non vuole
sobbarcarsi il viaggio in treno) e, tre estati dopo, Sofia Loren. Belle, ma poi anche
brave, quelle ragazze hanno fatto la loro parte nel «miracolo» italiano. Le veline di
oggi sono tutta un’altra cosa...
22 dicembre 1947
Fondata sul lavoro
La Costituzione nasce alla vigilia di Natale: sulle tribune di Montecitorio una
delegazione di garibaldini intona Fratelli d’Italia e i padri costituenti si accodano,
stonando un po’. Approvata dai nove decimi dell’Assemblea, la Carta è il frutto
dell’incontro fra le due culture di massa, la democristiana e la socialcomunista.
All’antifascismo liberale ed azionista, minoritario dentro le urne, toccano i panni
scomodi del testimone.
Emblematico il percorso del primo comma dell’articolo 1. I socialcomunisti
propongono: «L’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori», sinistramente
simile alla dizione sovietica. Il laico Ugo La Malfa trasecola e rilancia: «... una
Repubblica democratica fondata sulla libertà e sul lavoro». Ma alla fine la libertà
resta nella penna e passa il compromesso democristiano di Fanfani: «... fondata sul
lavoro».
La ferita ancora fresca del fascismo orienta le scelte di fondo. La facilità con cui
Mussolini calpestò la Costituzione precedente (lo Statuto Albertino) induce ad alzare
gli argini e a indebolire il governo, a tutto vantaggio del Parlamento e dei partiti,
contro i quali si batte l’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini.
È costui un giornalista napoletano che col suo stile brillante e volgare (il «vento del
Nord» trasformato in «rutto del Nord», Calamandrei in «Caccamandrei») dà voce ai
piccoli borghesi meridionali che non hanno conosciuto la Resistenza e, fra il partito
unico del Ventennio e la partitocrazia dei partigiani, vagheggiano l’impossibile terza
via di uno Stato senza partiti, affidato a un «buon ragioniere» in carica per un anno e
non rieleggibile.
Compilata da uomini come Einaudi, Ruini, Mortati, Dossetti, Basso e Calamandrei
- la cui preparazione e levatura morale rendono imbarazzante il confronto con coloro
che in séguito hanno cercato di modificarla - la Costituzione repubblicana è la prova
vivente che la politica, persino quella buona, ha ritmi molto più lenti della realtà.
L’Assemblea nomina una commissione di 75 membri (per la Costituzione
americana ne bastarono 45), che si divide in tre sottocommissioni e poi affida la
stesura del testo a un comitato dei 18 che lo invia in assemblea, dove viene discusso
punto per punto, con il colpo di scena dell’alleanza DC-PCI sull’articolo 7 che
riconosce i patti fra Mussolini e il Vaticano. «Questo voto ci assicura un posto al
governo per i prossimi vent’anni» commenta il leader comunista Togliatti,
instaurando la tradizione dei Migliori che non la imbroccano mai, proseguita fino a
D’Alema.
Infatti nel corso dei lavori il quadro politico cambia: il collante dell’antifascismo
smette di funzionare, adesso è il comunismo a dividere il mondo. De Gasperi schiera
l’Italia con gli USA, i socialisti filo-occidentali di Saragat si staccano da quelli di
Nenni ancora ammaliati da Stalin e la sinistra viene estromessa dal governo. Quando
votano insieme la Costituzione, Togliatti e De Gasperi già non si salutano più.
18 aprile 1948
Dio ti vede, Stalin no
O di qua o di là. Di qua la Chiesa cattolica, il piano Marshall, il sogno del
benessere economico. Di là la Chiesa sovietica, il piano quinquennale, il sogno
dell’uguaglianza sociale.
Di qua il democristiano De Gasperi, cattolico ma non baciapile, un italiano di
confine come Cavour, costretto a gestire i disastri dell’arci-italiano Mussolini: al
congresso delle potenze vincitrici ha dato prova di dignità, «sento che tutto, tranne la
vostra personale cortesia, è contro di me», riuscendo a salvare almeno l’Alto Adige.
Di là il comunista Togliatti, stalinista ma non fanatico, costretto a frenare gli spiriti
rivoluzionari della base: quando Giancarlo Pajetta lo ha chiamato da Milano per
dirgli che i compagni avevano occupato la prefettura, gli ha risposto, gelido: «Bravi,
e cosa intendete farne?».
Di qua la Democrazia cristiana e il governo di Scelba, ministro di Polizia, e di
Einaudi, grande economista liberale. Di là il Fronte popolare: con i socialisti di Nenni
- che in questa fase sembra più sovietico di Togliatti - e Garibaldi nel simbolo (ma
Guareschi sostiene che radendogli la barba spunterebbe la faccia del segretario del
PCI).
Ecco, di qua c’è anche il papà di don Camillo, che davanti agli elettori moderati
agita lo spettro della fame e persino dell’inferno, «nella cabina elettorale Dio ti vede,
Stalin no», mentre i Comitati civici fondati da Luigi Gedda e benedetti dal Papa
portano il verbo anticomunista in ogni parrocchia. Di là manifesti di artisti e
intellettuali, da Guttuso a Bassani, per sdoganare il Fronte agli occhi della borghesia
colta. Di qua e di là, armi nascoste e rifugi segreti, qualora il vincitore mettesse
fuorilegge lo sconfitto.
Ultimi comizi. O di qua: «Togliatti ha il piede forcuto come il diavolo». O di là:
«Ho messo i chiodi alle scarpe per applicarli a De Gasperi in una parte del corpo che
non voglio nominare». Poi, se Dio vuole (e anche Stalin) si vota. DC 48,5%, Fronte
popolare 31%. Sommando il 13% dei laici, l’Italia moderata ha la maggioranza
assoluta. «Credevo piovesse, non che grandinasse» gioisce De Gasperi.
È la stagione più bella della sua vita e non riesce a rovinargliela neanche Antonio
Pallante, lo studente di destra che in un pomeriggio di luglio spara a bruciapelo su
Togliatti, uscito dalla Camera con la compagna Nilde Jotti per andare a mangiare un
gelato. Gli operai comunisti occupano le fabbriche, mentre la CGIL proclama lo
sciopero generale, provocando l’uscita dal sindacato rosso dei fondatori di CISL e UIL.
Si dice che a calmare le acque contribuisca la vittoria del democristiano Bartali al
Tour de France. Di sicuro aiutano la calma e la pronta guarigione di Togliatti.
«Eccole il saldo, ma è denaro rubato» sbotta il capo comunista nel pagare il conto al
professor Valdoni che lo ha operato. «Grazie per l’assegno» risponde il chirurgo. «La
provenienza non mi interessa».
6 maggio 1948
L’indicibile
Uno scrittore promettente ma non ancora famoso recensisce il libro di uno scrittore
totalmente ignoto. Il recensore si chiama Italo Calvino e parla di un libro pubblicato
da un piccolo editore torinese, De Silva, che ne ha stampate 2500 copie e ne venderà
meno di 2000. Si tratta di Se questo è un uomo di Primo Levi, sopravvissuto al campo
di sterminio di Auschwitz, dove è rimasto prigioniero per un anno, fino all’arrivo dei
russi nel 1945.
Tornato avventurosamente in patria, Levi si rende conto che ciò che ha visto e
sofferto nel lager non è dicibile, non è raccontabile. E tuttavia capisce che è suo
dovere tentare di dare la propria testimonianza su quell’orrore inaudito. Ma non è
solo una testimonianza, scrive Calvino, «ha delle pagine di autentica potenza
narrativa che rimarranno nella nostra memoria tra le più belle della letteratura sulla
seconda guerra mondiale».
Lo stile sobrio, si potrebbe dire constatativo, fa emergere senza doverle
commentare, le nefandezze perpetrate sugli ebrei prigionieri. Non c’è retorica, non ci
sono invettive, in un certo senso non ci sono neppure i tedeschi e non manca, in
questo distacco, una vena di ironia cui Levi resterà fedele anche nei libri successivi.
Tuttavia bisognerà attendere il 1956 perché Se questo è un uomo cominci il suo
grande volo per il mondo.
Intanto sulla scena letteraria appare un altro testimone, stavolta della guerra
guerreggiata. È Mario Rigoni Stern, che pubblica il suo umile e memorabile
resoconto della ritirata di Russia, Il sergente nella neve. La terribile marcia nella
steppa russa dove chi cade non si rialzerà più, dove gli alpini sono continuamente
accerchiati e continuamente devono battersi, è un’altra pagina altissima venuta dalla
guerra.
Ma c’è un terzo testimone, Beppe Fenoglio, che racconta la guerra partigiana nelle
Langhe e lo fa scegliendo i toni e il linguaggio dell’epica. Fughe, agguati, pioggia,
tradimenti, rastrellamenti e quelle vaste cascine sui crinali, tra le vigne, scorrono con
fulminanti coloriture. Smembrata da vari editori, l’epopea del Partigiano Johnny si
trova oggi riunita in un volume einaudiano a cura di Dante Isella, che ha ricostruito
tutto l’arco dell’avventura.
Tre testimoni così diversi bastano a fare una scuola? Critici e giornalisti sono
sempre a caccia di etichette e questi tre libri, insieme a pochi altri, tra cui il trascurato
gioiello di Calvino L’entrata in guerra, dovrebbero dar corpo a una sorta di
movimento sbrigativamente chiamato neorealismo. Se vale nel cinema, perché non in
letteratura? Ma l’enfasi nominalistica brilla per breve tempo e poi si spegne. Tre
grandi libri restano con noi.
4 maggio 1949
I Campionissimi
Nuvole basse su Torino. La squadra di calcio che porta il suo nome sta tornando in
aereo da Lisbona, dove ha partecipato alla partita d’addio di un asso del Benfica
senza immaginare che sarebbe stata anche la propria. Tradito dagli strumenti di
bordo, il comandante Meroni non si accorge di volare contro la scarpata della basilica
di Superga che sovrasta la città. Nell’urto immane muoiono tutti: calciatori, tecnici,
giornalisti. Si salva solo il presidente Novo, rimasto a casa: l’artefice del capolavoro è
condannato a sopravvivergli.
La tragedia produce un’ondata di dolore collettivo che replica i lutti non ancora
smaltiti della guerra. Mezzo milione di persone assistono ai funerali in un silenzio
che annichilisce l’inviato del governo, il giovane Andreotti. Ma è l’Italia intera che
piange lacrime per una volta sincere.
Negli anni della ricostruzione, le gesta del Grande Torino il suo calcio spettacolare
e così poco italiano, la semplicità dei suoi campioni allergici al divismo - hanno
distratto milioni di poveracci curvi sulle macerie di una vita e li hanno riabituati a
credere nei sogni. Perché sono un sogno quelle maglie granata che in campo
sembrano il doppio. E un sogno nel sogno è Valentino Mazzola: quando i compagni
battono la fiacca (ogni tanto succede), il capitano si rimbocca le maniche, sugli spalti
dello stadio Filadelfia il trombettiere suona la carica e... cinque scudetti consecutivi,
cento partite in casa, zero sconfitte. Cosa dire di più?
Niente. Il favorito del Giro d’Italia che comincia dopo Superga non vuole dire
niente. Appena qualcuno allude alla tragedia, cambia discorso. Affida il suo dolore di
tifoso al linguaggio muto dei simboli, facendosi cucire lo scudetto del Toro
all’altezza del cuore. Lo porta con sé anche la mattina del 10 giugno, quando scatta
sulle prime rampe del colle della Maddalena per poi inanellare, uno dopo l’altro,
l’Izoard, il Monginevro e il Sestriere. «Un uomo solo è al comando» annuncia il
radiocronista Mario Ferretti. «La sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto
Coppi».
Il duello sportivo con Gino Bartali è l’altra favola in cui si immergono gli italiani
del dopoguerra. Per adeguare il mito alla realtà viene inventato un improbabile
dualismo politico fra il cattolico Bartali e il laico Coppi, anche se poi tutti e due
votano Democrazia cristiana. Ma nel calcio stanno effettivamente agli antipodi:
Fausto del Toro e Gino della Juve, benché i loro caratteri suggeriscano l’opposto.
Torniamo alla corsa: dopo 192 (centonovantadue!) chilometri di fuga solitaria,
Coppi taglia il traguardo di Pinerolo con 12 minuti di vantaggio sul rivale. Come
sempre non solleva le braccia al cielo, però non può fare a meno di guardarsi intorno.
E i suoi occhi affogano in un mare di bandiere granata listate a lutto.
Cento
Dolce la vita: con il boom si sogna, con Mike si gioca, con Modugno e Berruti si
vola. Ma cosa è davvero successo sulla spiaggia di Torvajanica e sulla vetta del K2?
11 aprile 1953
Il pediluvio
Presso la spiaggia di Torvajanica, vicino a Roma, un manovale scopre sulla
battigia il corpo supino di una donna parzialmente vestita, senza scarpe, gonna, calze
e reggicalze. Si chiama Wilma Montesi, è figlia di un portinaio e manca da casa da
due giorni. L’autopsia stabilisce che è morta per annegamento, che non ha subìto
violenze di alcun genere (è vergine) e avanza l’ipotesi che sia stata stroncata da un
malore improvviso mentre faceva un pediluvio in mare per curare un eczema. Ma
come è arrivata fin lì?
Due testimoni poco attendibili dicono di averla vista sul trenino di Ostia, ma da
Ostia a Torvajanica ci sono nove chilometri. È stato un gioco di correnti, spiega la
polizia, ma nessuno ci crede perché nel frattempo un giornale di estrema destra, «Il
becco giallo», pubblica una vignetta allusiva: un piccione che vola in questura
portando nel becco un reggicalze.
A quel punto si capisce che si tratta di un caso politico poiché nel piccione si vuole
senza dubbio indicare Piero Piccioni, giovane musicista, amante dell’attrice Alida
Valli ma soprattutto figlio di Attilio Piccioni, ministro democristiano degli Esteri,
indicato da molti come il delfino di De Gasperi.
Scoppia così il primo grande scandalo sessual-politico, genere cui oggi siamo
avvezzi. Saltano fuori ogni giorno personaggi più o meno discutibili, un certo
marchese Montagna che è stato informatore delle ss e che organizza festini nella
tenuta di Capocotta per i suoi potenti amici. Si fa anche uso di droga e la Montesi
potrebbe essere stata vittima di un’overdose. Poi compaiono due ragazze che
presentano lunghi memoriali e si fanno intervistare da chiunque. Volano ricatti,
minacce più o meno velate, rivelazioni inconsistenti, piste false, querele, ritrattazioni.
Piccioni senior si dimette da ministro. Otto anni appena e la Repubblica è già nel
fango.
I comunisti sono i soli felici alla vista di tanta corruzione. I democristiani sono
divisi tra la vecchia guardia (Piccioni, Scelba, Gonella) e la generazione che vuole
prenderne il posto (Moro, Fanfani, Colombo). Ma anche queste sono solo congetture,
non c’è nessuna prova che dimostri l’esistenza di un regista occulto, né si trova alcun
nesso tra la ragazza e quella bella gente.
Il processo che si apre a Venezia nel ‘57 è seguito dai giornali e dal pubblico come
una finale dei mondiali di calcio. Ma tutto si sgonfia, nulla in realtà è stato accertato
seriamente, nulla si può imputare agli accusati Piccioni e Montagna, entrambi in
carcere preventivo, che vengono assolti con formula piena. Nessuno saprà mai perché
la Montesi sia morta su quella spiaggia. E alla fine, tutto essendo possibile, anche la
tesi del pediluvio magari...
7 giugno 1953
Destino cinico e baro
Scatterà, non scatterà? L’Italia politica aspetta il responso delle urne col fiato
sospeso. Consapevoli di non poter bissare il plebiscito del ‘48, i partiti di centro
hanno previsto un premio di maggioranza per la coalizione che supererà il 50% dei
voti.
La sinistra, con Piero Calamandrei, l’ha subito battezzata legge-truffa. La stabilità
dei governi non è ancora percepita come un bene prezioso, mentre il ricordo dei
«listoni» fascisti getta sulla DC un’ombra liberticida che non merita. Altre sono le sue
colpe. Una riforma agraria che è già vecchia prima di nascere. I carrozzoni
mangiasoldi della Cassa del Mezzogiorno e delle Partecipazioni statali. E la riforma
fiscale di Vanoni: nata col nobile intento di far pagare le tasse ai ricchi, ottiene il
prevedibile risultato di tartassare i lavoratori dipendenti, gli unici impossibilitati
all’evasione.
Minato dal male che lo ucciderà (sclerosi renale con alto tasso di azotemia), De
Gasperi assiste alla deriva clericale di un partito che aveva voluto laico e
interclassista. Rompe col Papa, che si rifiuta di riceverlo da quando il leader
democristiano ha posto il veto a un’alleanza coi postfascisti del Movimento sociale. E
ottiene l’approvazione della legge-truffa solo dopo scontri inauditi in Parlamento e
nelle piazze, dove le gincane dei celerini di Scelba vengono messe sul suo conto. Né
lo aiuta la tracotanza con cui l’ambasciatrice Clare Boothe Luce dichiara che
l’America non accetterà una sconfitta della coalizione moderata.
Scatterà, non scatterà? Il quorum non scatta per cinquantamila voti e Saragat,
principale ispiratore del marchingegno, parla di «destino cinico e baro». Un destino
chiamato Achille Lauro, l’armatore monarchico che agli elettori di Napoli regala una
scarpa prima del voto e l’altra eventualmente dopo, e che quando alla radio non
funziona il microfono invoca l’intervento di un radiologo. I voti che mancano li ha
presi lui.
La nuova Camera nega a De Gasperi la fiducia. Persino Guareschi gli volta le
spalle, pubblicando una lettera del periodo di guerra in cui il capo della DC chiedeva
agli Alleati di bombardare la periferia di Roma. De Gasperi ne smentisce la paternità
e lo scrittore va in carcere per diffamazione, rifiutandosi per protesta di appellarsi
contro una sentenza che non ha voluto tener conto delle perizie calligrafiche. Ha i
suoi guai anche il PCI: Nino Seniga, factotum del vicesegretario Pietro Secchia,
scappa con la cassa e Togliatti si guarda bene dal denunciarlo: dovrebbe dichiarare da
dove provengono i soldi.
Estromesso dal nuovo governo, De Gasperi rimane segretario di una Democrazia
cristiana che non gli assomiglia più, frantumata in correnti concordi solo nel farsi la
guerra e nel farla a lui. L’ultima amarezza gliela danno i francesi, affossando il suo
sogno di un esercito europeo. Ai funerali in Valsugana, inondati da lacrime di
coccodrillo, un elettore liberale si insinua sotto la bara, gridando: «De Gasperi è
nostro». Nessuno se la sente di contraddirlo.
31 luglio 1954
La donna del K2
Otto chilometri e mezzo sopra il livello del mare, sull’inviolata piramide di
cristallo del K2, si intravedono dei puntini in movimento. Sono Compagnoni e
Lacedelli, i due scalatori che il geologo Ardito Desio, capo della spedizione italiana,
ha designato per l’assalto alla vetta.
L’ossigeno delle bombole viene di colpo a mancare, ma i rocciatori decidono di
proseguire, anche se a quelle altitudini l’ozono brucia la gola e altera le percezioni.
All’improvviso avvertono uno strattone alla corda di nylon: c’è un essere invisibile
accanto a loro. Una donna, ne sono sicuri, che li scorta fino alla cima e poi scompare.
Ma non hanno tempo di rimpiangerla, devono ammirare il panorama. Sotto, un abisso
di inchiostro. Sopra, una luce totale.
Compagnoni è in crisi estatica: lasciami qui, urla a Lacedelli, che in qualche modo
riesce a convincerlo a intraprendere la discesa. Prima però va documentata la storica
conquista. La cinepresa è inceppata, Compagnoni si toglie un guanto per sistemarla e
il freddo gli deforma per sempre due dita. È il prezzo da pagare per l’apoteosi che lo
aspetta in Italia. L’impresa del K2 diventa il simbolo della rinascita postbellica di un
intero Paese. Evviva, evviva.
Evviva un corno. Le cose non stanno come sembrano. Con la classica logica dei
capi che privilegiano l’affidabilità rispetto al talento, Ardito Desio ha concesso
l’onore della vetta al fedele Compagnoni, discriminando il vero fuoriclasse della
spedizione, Walter Bonatti, che si è dovuto accontentare del compito gregario di
portare le bombole d’ossigeno all’ultimo campo, oltre quota ottomila.
Verso sera Bonatti si presenta puntuale all’appuntamento, ma Compagnoni non
c’è. Senza avvertirlo, ha spostato il campo centocinquanta metri più in alto. Bonatti
non può più raggiungerlo e neanche tornare indietro. Sopravvivrà a una notte da
incubo: quaranta gradi sotto zero, senza tenda né sacco a pelo. La guida pakistana che
è con lui ci rimette mani e piedi.
All’alba Compagnoni scende a prendere le bombole, che però, secondo lui, si
esauriscono prima della cima. Come mai? Un giornalista accusa Bonatti di avervi
attinto durante la nottataccia. Scattano le querele ed in tribunale la verità viene a
galla: Bonatti non può aver utilizzato l’ossigeno perché gli mancava la maschera per
respirarlo. E Compagnoni, con la decisione scriteriata di spostare l’ultimo campo, ha
messo a repentaglio la vita del collega-rivale.
Soltanto Desio difende ancora il proprio pupillo, forse per difendere se stesso.
Restano gli interrogativi: perché Compagnoni ha commesso un’imprudenza simile?
Temeva forse che Bonatti volesse passargli sopra la testa e arrivare da solo in cima?
E se le bombole erano piene di ossigeno fino all’orlo, perché Compagnoni e Lacedelli
hanno sempre dichiarato che si esaurirono prima della vetta?
L’unica che conosce tutte le risposte è la donna del K2.
9 marzo 1955
Bum bum
Il PIL cresce ogni anno a ritmi vertiginosi, la manodopera costa poco, i sindacati
non disturbano, le campagne si svuotano, le città si allargano, il benessere si diffonde.
Stiamo parlando della Cina di oggi, o dell’India, o del Brasile? No, siamo nell’Italia
degli anni Cinquanta, un periodo che sarà poi chiamato «miracolo italiano», «boom»,
«seconda rivoluzione industriale».
La catastrofe della guerra è ancora vicina, ma gli italiani riescono a convincere
grandi banche straniere, enti governativi, potentissime multinazionali che vale ancora
la pena di scommettere sulla loro capacità di ripresa. A capo della FIAT c’è il
genovese Vittorio Valletta, il Professore, un uomo duro, geniale, gran lavoratore. Va
continuamente negli Stati Uniti dove strappa commesse per motori d’ogni tipo, aerei
militari, prestiti cospicui.
La fabbrica torinese di Mirafiori diventa una sorta di calamita urbanistica. I
contadini preferiscono lavorare lì piuttosto che spaccarsi la schiena nei campi e da
tutta Italia, specie dal Mezzogiorno, arrivano masse di uomini e donne che sognano la
tuta blu.
È una migrazione quasi biblica con molti risvolti penosi e umilianti, ma non ci
sono morti e feriti. Le grandi fabbriche creano interi quartieri operai per dare un
minimo di sollievo alle nuove famiglie. L’industriale utopista Adriano Olivetti, che
sogna un’Italia fatta di tante piccole comunità solidali, costruisce a Ivrea per le sue
macchine da scrivere una fabbrica tutta vetrate e cespugli di rose ed attira intorno a sé
letterati e intellettuali di alto rango.
Entrano in scena i vespisti e i lambrettisti, in sella a motorini che fanno i sessanta
chilometri all’ora e che in breve inondano l’intera penisola con raduni, feste, cortei. E
infine la FIAT, al Salone di Ginevra del 9 marzo 1955, mette sul mercato la 600,
vetturetta quasi alla portata di uno stipendio medio, e due anni dopo la 500, cui,
secondo certi sondaggi, si deve un gran balzo demografico del Paese. Entrambe le
utilitarie sono state disegnate dal precursore del «made in Italy», l’ingegner Dante
Giacosa.
Ma tutte queste ruote che girano su e giù per il paesaggio italiano hanno bisogno di
strade e comincia allora la costruzione più o meno incontrollata dei nuovi percorsi, a
due, quattro corsie. Tutti si spostano dappertutto, tutti fanno di tutto e le industrie
straniere accorrono perché lavoriamo di più, costiamo poco, siamo più bravi.
L’oggettistica italiana è presente in ogni vetrina, spesso anche nei musei.
Bei tempi! rimembra qualcuno. Tempi amari, ricordano altri. Ma una situazione
del genere è ovviamente destinata a durare poco, e oggi sembra impossibile credere
che per una breve parentesi la Cina, l’India, il Brasile siamo stati noi.
26 novembre 1955
Controfagotto
Chissà se a Mike Bongiorno piacerebbe essere visto come un grande
rivoluzionario, sia pure a suo modo. Direbbe di sì, poi direbbe di no, sorridente ed
intangibile nella sua modestia autentica. Certo, non ha la parrucca di Robespierre, né
il berretto di Lenin, né la camicia nera del Duce. I suoi gesti sono misurati, la voce
incoraggiante, affabile. Il successo non gli ha dato minimamente alla testa, eppure
dopo di lui non tanto la TV, quanto il nostro Paese non poteva più essere lo stesso.
Viene in mente Gutenberg che inventa la stampa o Marconi la radio, e che prevedono
le conseguenze della loro scoperta. Mike invece non le prevede, va per la sua strada
senza badare a sociologi, filosofi, intellettuali di varia importanza.
Che cosa ha inventato quest’uomo in cravatta e giacca a tre bottoni? Da un
programma radiofonico negli USA, dove abita, si fa venire l’idea di quello che oggi
chiameremmo un format e lo propone alla TV italiana. Questa è appena nata (1954),
ha un solo canale in bianco e nero, e accetta il rischio. Così quel sabato sera di
novembre parte «Lascia o raddoppia?».
Il gioco è abbastanza semplice: i concorrenti devono superare diversi gruppi di
domande, via via più difficili, e dopo ogni «La risposta è esatta!», si sentono chiedere
dal presentatore: «Lei lascia o raddoppia?». Chi si ritira avrà un premio di
consolazione e chi resta si giocherà il gruzzoletto il sabato successivo.
L’Italia impazzisce. I ristoranti sono deserti perché la clientela è rimasta a casa a
guardare il quiz, che anche molti bar e cinema trasmettono nelle loro sale. Per salvare
dal fallimento i locali, si è costretti a spostare il programma dal sabato sera al giovedì.
È una spinta strepitosa ad acquistare il televisore e la RAI può andare fiera di quel
passatempo che pur sempre un po’ di istruzione alle masse la distribuisce. Ogni
«esperto» si presenta infatti su un tema tutt’altro che frivolo: storia d’Italia, teatro di
prosa, scienze fisiche, economia.
Si tocca il massimo con la musica e con un professore di matematica di Carpi,
Lando Degoli, che concorre come esperto di lirica. Alla terza seduta Mike gli chiede:
«In quale opera Verdi ha usato per la prima volta il controfagotto?». «Nel Falstaff»
risponde Degoli. «No, la risposta esatta è Don Carlos». Ma anche questa risposta è
sbagliata: i musicologi infatti scoprono che l’ha usato nel Macbeth. Degoli fa ricorso
e viene riammesso, entusiasticamente supportato dall’intera nazione. Non
raddoppierà e se ne tornerà a Carpi sulla sua 600 nuova di zecca, omaggio della ditta.
Dopo un paio d’anni e molti personaggi più o meno curiosi, «Lascia o raddoppia?»
finisce. Ma ormai il più è fatto. Gli italiani al séguito di Mike, ex allievo dei
rosminiani di Torino, hanno finalmente trovato un modo apparentemente innocuo di
entrare nella modernità. Allegria!
31 gennaio 1958
Sanremo, oh oh
Nel Salone delle Feste, che è anche un ristorante, hanno appena applaudito Nilla
Pizzi «avvinta come l’edera». Vincerà ancora lei, mormorano i veri esperti, i
camerieri. Quand’ecco che un giovanotto pugliese con il farfallino storto sale sul
palco, avvicina i baffi tristi al microfono, spalanca le braccia dello smoking e...
«Volareeeee...». In platea si agitano i fazzoletti e di colpo cambia tutto: la musica, il
costume, persino Sanremo.
Il Festival della canzone italiana è nato agli inizi del decennio. Il direttore del
Casinò ligure è in cerca di un evento che faccia parlare della sua sala da gioco e la
gara musicale si presta subito all’uso, grazie all’apporto della RAI e a un’influenza
che mette a letto la metà degli italiani, inducendoli ad accendere la radio per farsi
cullare dalla voce del presentatore Nunzio Filogamo: «Cari amici vicini e lontani...».
I giornali si schierano all’opposizione e nei rari articoli dedicati allo spettacolo
bollano come «orgia di musica negroide» le melodie soporifere che i cantanti
gorgheggiano fra rumori di posate e vocio di commensali.
Nilla Pizzi vince la prima edizione con Grazie dei fior, ma soprattutto vende
quarantamila copie, trasformando Sanremo nella missione esistenziale di ogni
discografico. Per anni si va avanti fra colombe che volano e casette in Canada. Poi
arriva la televisione e dà un volto ai nuovi divi: il più amato è Claudio Villa, il
Reuccio, che ha centosessanta «fan club» disseminati nella penisola e minaccia di
farli marciare compatti su Sanremo per difendere il suo primato dalla minaccia di
quell’usurpatore coi baffi. Nel blu dipinto di blu è passato anche sopra di lui come un
trattore.
Il testo, intanto. Uno dei due autori, Migliacci, sostiene di essersi ispirato a un
quadro di Chagall. L’altro, lo stesso Modugno, rivela che il primo «volareeeee» gli è
esploso dai polmoni una mattina, mentre apriva le finestre di casa. Ma poi entrambi si
contraddicono, affermando che la canzone è nata durante una passeggiata a Ponte
Milvio. Migliacci offre l’ultima versione. Un pomeriggio si è addormentato sul
divano e ha avuto un incubo: si dipingeva le mani e la faccia di blu.
La musica, quella è di Modugno e non si discute. Risuona da più di mezzo secolo
in tutto il mondo, vero inno-ombra d’Italia, anche se sul palco di Sanremo il direttore
d’orchestra Gorni Kramer storce la bocca: «Ma che razza di pazzia senza stile è
questa?». La rivoluzione, maestro.
Modugno è il primo urlatore ed il primo cantautore. Da Celentano a Vasco, tutti gli
devono qualcosa. Dopo di lui il Festival comincia a precipitare, ma nonostante mezzo
secolo di scandali e baracconi televisivi non ha ancora toccato il fondo. Forse volava
davvero alto, quella sera.
20 febbraio 1958
Un bel casino
Ci sarebbe da ricamare a lungo sulla parola «casino», che oggi per noi conserva un
unico senso: chiassoso disordine, somma confusione. Possono essere «un casino» i
rapporti in famiglia, una guerra, un complicato inghippo burocratico o bancario, una
coda di automobili, una spiaggia affollata. Nei secoli passati «casino» è stato anche
altro, casino di caccia, casino di lettura, casino di nobili, casino di spiriti, casino di
gioco. Tuttavia, nel 1948, quando la senatrice socialista Lina Merlin presenta alla
Camera un disegno di legge per l’abolizione dei casini, la parola ha un solo
significato per gli italiani: postribolo, bordello, casa di tolleranza.
Un coro sarcastico, furibondo, sghignazzante si leva da mezza Italia: vogliono
chiudere i casini! L’argomento fondamentale della Merlin è che lo Stato ricava soldi
dalle prestazioni delle prostitute ospitate in quei luoghi ed è quindi uno Stato
«pappone». In quasi tutti gli altri Paesi europei leggi simili sono state approvate da
tempo e l’Italia non deve più tollerare una tale vergogna.
Obiezione: ma anche sul gioco, sul fumo, sull’alcol lo Stato incassa le sue
percentuali. Contro-obiezione: ma qui ci sono di mezzo almeno tremila schiave del
sesso schedate, non si può speculare ancora sulle loro vite di abiezione e
disperazione.
Va detto che non tutti i casini sono uguali, c’è una categoria infima dove si fanno
sconti a soldati e sottufficiali, una categoria media per impiegati e professionisti e una
categoria di lusso dove si danno convegno, ridendo e scherzando con le inquiline,
illustri professori, industrialotti, raffinati filosofi, editori. È uno stile di vita che gli
italiani considerano del tutto normale. C’è anche il fatto delle visite mediche
obbligatorie alle ragazze, che con la legge Merlin sarebbero abolite, con gravi
conseguenze sulla salute del popolo.
La senatrice non si lascia scoraggiare, anche se, di legislatura in legislatura, la sua
proposta viene sistematicamente fatta slittare a quella successiva. E alla fine vince lei.
Dieci anni dopo, con il voto contrario di monarchici e missini, il progetto diventa
legge. Le circa ottocento case chiuse si aprono, si trasformano in normali
appartamenti e le ex si riversano sui marciapiedi. Pochissime approvano il
cambiamento, molte sono spaventate, smarrite, riprendono la loro attività, vanno a far
casini sotto i portici, nei bar, intorno alle stazioni.
La Merlin non ha risolto il problema della prostituzione, né poteva. È una legge
esclusivamente di dignità nazionale. E comunque con le migrazioni dal Terzo
Mondo, e i pedofili, i minori, le escort, i trans, i viados, i bi, i tri... Insomma, un bel
casino!
5 febbraio 1960
La dolce vita
Un gruppo di persone tiene d’occhio l’ingresso del cinema Capitol a Milano. Tra
loro spicca l’alta e massiccia figura di un uomo con un cappello a larghe tese. È
Federico Fellini, regista del film che si sta proiettando per la prima volta in una sala
pubblica: La dolce vita, tre parole italiane che presto saranno insostituibili in tutte le
lingue del mondo occidentale.
Fellini non sa davvero come il pubblico prenderà la sua ultima opera, che ha avuto
un percorso molto travagliato. Sebbene sia già un regista da Oscar e abbia trovato
subito un produttore disposto a credere nella nuova impresa, le cose si sono poi
complicate. La sceneggiatura di Flaiano e Pinelli, con i quali ha trascorse le notti in
via Veneto per studiare la fauna riprodotta nel film, è troppo approssimativa per
convincere i finanziatori, che si ritirano facendosi restituire il cospicuo anticipo. Alla
fine subentra Rizzoli, che dà piena fiducia all’estroso cineasta.
Fellini non sa bene lui stesso che film farà. Tutto succederà a Roma e il
protagonista sarà un giornalista di mezza tacca sempre impegnato a rincorrere le
notizie mondane. Gossiparo, diremmo oggi, e già questa scelta è profetica. L’attore
che Fellini impone a tutti è Marcello Mastroianni, bello, simpatico, elegante,
proprietario di un’auto sportiva forse di seconda mano, con una fidanzata gelosa e
depressa che lui tradisce senza il minimo scrupolo. È per il tramite di questo
ficcanaso professionista che passeremo da episodio a episodio, da ambiente ad
ambiente, dalla frivolezza allo squallore, dall’assurdità alla pena di vivere.
La dolce vita è in realtà amara, ma Fellini non è un moralista, non fa prediche,
segue una sua poetica sbadata e casuale, cambiando a capriccio luoghi e scene,
itinerari e attori, costruendo in mesi e mesi di lavorazione la sua allegoria di frivola
grandiosità. Gli serve la cupola di San Pietro e se la fa costruire a Cinecittà. Gli serve
un tratto di via Veneto e anche quello sarà finto. Vera resta la fontana di Trevi, dove
fa immergere per ore, in pieno inverno, Anita Ekberg e Marcello Mastroianni. Sono
veri anche il castello della festa dei nobili e i nobili stessi.
Un film difficile, che il pubblico della prima non gradisce: Fellini lascia il Capitol
sballottato fra spettatori inferociti. E tuttavia La dolce vita avrà un successo
istantaneo in tutto il mondo. In pochi mesi i soldi spesi nella produzione vengono
recuperati, poi raddoppiati, triplicati.
Diventa modo di dire, simbolo di Roma e dell’Italia. Osteggiato dal giornalismo
cattolico, trova anche da quella parte chi lo vede come un’opera altamente religiosa e
nessuno rinuncia, sugli altri giornali, a dire la sua personale sciocchezza in merito.
Vince la Palma d’oro a Cannes, in America diventa per molti cineasti un modello cui
ispirarsi. E Fellini diventa Fellini.
30 giugno 1960
Magliette a strisce
Contestazioni, pestaggi, morti ammazzati: un aperitivo degli anni che verranno.
Succede che Fernando Tambroni, democristiano di sinistra, formi un governo con i
voti decisivi dell’estrema destra e che subito dopo il Movimento sociale convochi il
suo congresso a Genova. I partigiani liguri insorgono e Sandro Pertini infiamma la
città con un discorso sui martiri oltraggiati della Resistenza. Una manifestazione
antifascista viene indetta per il 30 giugno. Studenti, operai e portuali sfilano
indossando le magliette a strisce che diventeranno il simbolo della rivolta.
In piazza De Ferrari si va allo scontro con le camionette della celere, sollevate e
rovesciate dai ganci degli scaricatori del porto, i forzutissimi camalli. I poliziotti
hanno le pistole scariche, quindi ci si picchia con grande enfasi ma senza
conseguenze letali: ganci (diversi agenti avranno la faccia sfregiata), pietre,
lacrimogeni, tavolini dei bar, pitali d’acqua bollente in caduta libera dalle finestre. Un
ufficiale di polizia finisce a mollo nella fontana e viene circondato da magliette a
strisce. Per metterlo in salvo, scrive «l’Unità». Per mettergli la testa sott’acqua,
replicano i giornali di destra. Benvenuti nell’epoca della doppia verità.
Quando torna la quiete è chiaro che il congresso del MSI non si farà più. Furibondo,
il segretario del partito Arturo Michelini toglie l’appoggio al governo. «Caro
Arturo...» cerca di rabbonirlo Tambroni al telefono. «Ma che Arturo e Arturo! Mi
chiami onorevole e mi dia del lei».
Il peggio deve ancora venire. A Roma, in una manifestazione a Porta San Paolo, la
polizia manganella i deputati comunisti che aprono il corteo, fra i quali Walter
Audisio, il presunto giustiziere del Duce. E il giorno dopo arrivano i morti: tre
manifestanti in Sicilia e cinque a Reggio Emilia, durante una battaglia in cui i sassi di
operai e studenti si contrappongono ai lacrimogeni della celere. Alcuni agenti,
probabilmente ubriachi, sparano raffiche di mitra nel mucchio e stavolta nei caricatori
ci sono i proiettili.
Nella DC comincia una partita opaca a colpi di dossier, di cui Tambroni è un goloso
collezionista. Il segretario Moro ne è talmente preoccupato che ogni notte dorme in
un posto diverso: diciotto anni dopo si rivelerà un presentimento. Fra un trasloco e
l’altro, prepara la ricetta per liberarsi di Tambroni, costruendo il governo Fanfani
delle «convergenze parallele», anteprima del centrosinistra. Il voto missino è ormai
inservibile, d’ora in poi per avere una maggioranza in Parlamento bisognerà
rivolgersi a quello socialista. Così ha voluto la piazza. E qualcuno, a cui la svolta e la
piazza non stanno bene, comincia ad attrezzarsi per la prossima crisi, quando
bisognerà anticipare le mosse del nemico. Magari con un colpo di Stato.
3 settembre 1960
L’arcangelo frigido
Nonostante le convulsioni e i contorsionismi della politica, l’Italia è una potenza
economica e Roma è la sede delle Olimpiadi estive. Che organizzerà benissimo,
nonostante la pioggia di soldi abbia partorito il padre di tutti gli appalti, l’aeroporto di
Fiumicino, costato cinque volte più del dovuto: già pochi mesi dopo l’inaugurazione,
la pista si squaglia come un gelato perché è stata costruita con materiali scadenti su
un terreno paludoso.
Sono Giochi splendidi, nonostante. Abebe Bikila vince la maratona, nonostante
corra a piedi nudi. Cassius Clay incanta sul ring, nonostante saltelli più che picchiare.
Wilma Rudolph diventa la donna più veloce del mondo, nonostante sia stata una
bimba affetta da poliomielite. E uno studente torinese diventa un mito, nonostante
corra con gli occhiali da vista e i calzini bianchi.
Quando, alle quattro del pomeriggio, Livio Berruti esplode dai blocchi dei 200
metri piani, pochi scommetterebbero di rivederlo in pista due ore più tardi nella
finalissima. Gli è capitata la batteria peggiore, quella dei tre primatisti mondiali. Li
supera in curva con una corsa talmente fluida che può concedersi il lusso di una
frenata sul rettilineo per non sprecare energie.
È questo, adesso, il problema. Quanta benzina gli sarà rimasta? Le due ore di attesa
sono, per gli italiani, le più emozionanti dei Giochi. Sugli spalti dell’Olimpico i
venditori di bibite scandiscono «Coca-Cola, acqua minerale, Berruti» e nei tinelli
d’Italia, dove per la prima volta la televisione porta le emozioni del grande sport, si
intrecciano previsioni e scommesse. Tutti si chiedono cosa starà facendo Berruti. E
nessuno immagina la verità: è sdraiato su una panca degli spogliatoi con un libro fra
le mani, l’esame di chimica organica.
Eccolo in pista, finalmente. Con un lembo della tuta pulisce gli occhiali neri che
diventeranno una moda, ma per lui miope - sono ancora un’esigenza. Sembra calmo,
invece compie una falsa partenza. Poi, però, arriva quella buona: Berruti affronta la
curva senza sbandamenti, insensibile alla forza centrifuga, e sul rettilineo è davanti a
tutti, preceduto solo da un volo di colombi.
Nella sua ombra spunta Les Carney, «demoniaco negro da saga medioevale», lo
bolla senza scrupoli la cronaca di Gianni Brera. Ma il cavaliere di questa saga è
Berruti, «l’arcangelo frigido» (sempre Brera). Sarà lui a spezzare il filo di lana,
sporgendosi in avanti con il busto fino a perdere l’equilibrio. Mentre il pubblico in
delirio dà fuoco ai giornali e li agita come torce nel buio della sera, «l’arcangelo
frigido» si pianta in mezzo alla pista, immobile. Dirà: ero così felice che non sapevo
cosa fare.
Centodieci
Mattei precipita col suo aereo, Pinelli da una finestra della questura.
Fra un precipizio e l’altro, un generale sogna di fare il golpe ed una generazione di
cambiare il mondo.
11 ottobre 1962
Un prete conciliante
Si alza a notte fonda e scruta il cielo di Roma con preoccupazione: se continua a
piovere, la processione salterà. Come all’inizio del Concilio precedente, il Vaticano I,
che nel 1869, coi bersaglieri quasi alle porte, stabilì il dogma dell’infallibilità del
Papa. Adesso l’Infallibile è lui. Ma quando ha chiamato a raccolta i vescovi da ogni
angolo della terra per adeguare il messaggio della Chiesa ai tempi nuovi, un suo
collaboratore ha confidato a un gesuita: «Il Papa è temporaneamente impazzito». In
effetti i cardinali lo avevano eletto perché facesse, e durasse, il minimo
indispensabile. Invece il bergamasco Angelo Roncalli, Giovanni XXIII, ha spiazzato
la Curia e i luoghi comuni, dimostrando che si può essere moderni e anticonformisti
anche a 77 anni.
La Chiesa si dibatte fra due anime inconciliabili. Da una parte la scuola per poveri
di don Milani, il quale anticipa il Sessantotto affermando che «l’ubbidienza non è più
una virtù». Dall’altra le campane a morto fatte suonare in tutta la diocesi dal cardinal
Lercaro contro la giustizia italiana che ha condannato un prete per aver definito
«pubblici peccatori e concubini» una coppia sposatasi in comune.
Il successore Paolo VI vivrà queste contraddizioni in modo alto e tormentato.
Giovanni XXIII è altrettanto profondo, ma più semplice. Perciò piace ai fedeli e ai
parroci dei paesi, che grazie alla tv vedono per la prima volta un Papa in azione e si
rallegrano nel riconoscerlo così simile a loro.
Alle sette in punto smette di piovere e spunta il sole. «Procedamus!» Dal Portone
di Bronzo prende le mosse il corteo di guardie nobili, guardie svizzere, cappellani e
avvocati concistoriali, camerieri d’onore, camerieri segreti. Dietro di loro, sotto mitre
e mantelli di ogni foggia e colore, incedono i 2498 padri conciliari. Infine il
Pontefice, in sedia gestatoria, tra due flabelli di piume di struzzo. Il Concilio scioglie
finalmente le vele.
Papa Giovanni sa che non potrà vederne l’approdo: il tumore allo stomaco gli
concede poco tempo. Però l’impronta è stata data. Il suo lascito non sarà
un’ideologia, ma un metodo: l’apertura verso tutti, credenti e non credenti. Ha
ricevuto la figlia di Chruščëv in Vaticano e, ancora da cardinale di Venezia, ha
inviato un messaggio al congresso del Partito socialista. Il giornalismo interpreta le
sue mosse come una benedizione al centrosinistra nascente. Nella sostanza le
encicliche di Roncalli non si spostano dal solco tradizionale della Chiesa. Ma lo stile,
certo, è cambiato. Dopo lo scomunicatore di comunisti Pio XII, fa effetto un Papa che
distingue fra «l’errore» e «l’errante», nei cui confronti si deve essere disposti alla
comprensione ed al perdono.
È sera, adesso, la sua sera. Il cielo sereno si è riempito di stelle ed in un angolo
brilla la luna. Giovanni XXIII si affaccia alla finestra dello studio per benedire la
folla che dall’alba gremisce piazza San Pietro: «Ritornando a casa, date una carezza
ai vostri bambini e dite loro che questa è la carezza del Papa». Il buonismo dei cinici
non è stato ancora inventato.
27 ottobre 1962
Petrolio!
L’arte della dietrologia ci fa intuire come vivessero gli antichi, per i quali ogni
minimo evento - una vespa che faceva tre giri intorno a un otre, un cane che scivolava
in una pozzanghera - era un segnale che nascondeva qualche altra verità. Per questo
la storia italiana appare talvolta noiosa. Ogni due, cinque, sette anni, riemergono le
stesse domande, le stesse risposte insoddisfacenti, fino al prossimo ripescaggio. E
tuttavia l’intera vita di Enrico Mattei è romanzesca.
Studente mediocre, buon piazzista, piccolo imprenditore, si rivela uno straordinario
manovratore d’uomini. Sono gli anni in cui si formano le amicizie di una vita e gli
amici di Mattei si chiamano La Pira, Dossetti e altri futuri esponenti dell’etica sociale
democristiana. Entra nella Resistenza, si procura finanziamenti, viene arrestato ma
evade, riprende il suo posto e alla Liberazione è uomo di spicco del CLN. Lo
incaricano di liquidare un carrozzone fascista, l’AGIP (Azienda gerarchi in
pensione...) che doveva cercare il petrolio e non l’ha mai trovato. Mattei esamina i
libri e scopre che però è stato trovato qua e là del metano.
Comincia una guerra, tipicamente nazionale, di rinvii, dilazioni, ingiunzioni
disattese, decreti dimenticati in un cassetto, falsi in bilancio. Del tutto indifferente al
lucro personale, proprio questo gli dà spregiudicatezza nel gestire la sua azienda,
continuando surrettiziamente a cercare, e alla fine ha il suo colpo di fortuna: a
Cortemaggiore un getto di petrolio schizza dal sottosuolo.
È solo una piccola bolla, ma Mattei ne fa un evento strepitoso. Da tutto il mondo
piovono richieste di concessioni in Val Padana. L’uomo del petrolio italiano riesce a
bloccare con una legge le compagnie petrolifere straniere, da lui definite le «sette
sorelle». Inventa il logo del cane a sei zampe, costruisce di notte, abusivamente,
chilometri di metanodotto, avvia una sua personale politica estera con i Paesi del
Nord Africa che il petrolio ce l’hanno davvero. Fonda con successo il quotidiano «Il
Giorno» e usa il denaro dell’ENI per finanziare le correnti di sinistra della DC e
manipolare ministri, giornalisti, ambasciatori, servizi più o meno segreti.
È una potenza, ammirato, temuto, odiato. Quando il suo aereo, in una notte
tempestosa, di ritorno da un viaggio in Sicilia precipita vicino a Pavia, tutti pensano a
un attentato. Due sconosciuti sono stati visti armeggiare intorno all’apparecchio
prima del decollo, ma mancano le prove ed il caso viene archiviato come incidente.
Solo nel 1997 nuovi mezzi di indagine rivelano che l’aereo è esploso durante
l’atterraggio. L’ordigno era collegato al meccanismo di apertura del carrello.
Omicidio, dunque. Ma ad opera di chi? Per ordine di chi? A vantaggio di chi?
Non lo si saprà mai, anche se un uomo sembra disegnato apposta per rivestire i
panni dell’anima nera: il suo braccio destro Eugenio Cefis, ex partigiano cattolico
anche lui, ma amico dei suoi nemici: le «sette sorelle» e la corrente DC di Fanfani. Ha
lasciato l’ENI pochi mesi prima, sorpreso da Mattei a rovistare nei cassetti del suo
ufficio. E ci torna dopo la sua morte, diventando il simbolo di quei manager di Stato
che Eugenio Scalfari chiamerà «Razza padrona».
9 ottobre 1963
Morte per acqua
Se il bicchiere fosse pieno a metà o anche a tre quarti... Ma l’acqua arriva fino
all’orlo e quando mezza montagna frana dentro l’invaso della diga del Vajont non c’è
scampo. Una massa liquida alta oltre duecentocinquanta metri, e larga quanto la diga
stessa, la scavalca e precipita a valle, a una velocità stimata in più di cento chilometri
l’ora. L’onda d’urto è pari a quella prodotta dalla bomba di Hiroshima e in pochissimi
minuti travolge tutto ciò che incontra: Erto e Casso, due paesini in fondovalle,
vengono spianati.
L’onda prosegue lungo il torrente Vajont che sfocia nel Piave. Il fiume a sua volta
si gonfia all’istante, la piena velocissima scende su Longarone e la mattina dopo,
quando arrivano i primi soccorritori, la scena, sotto il sole, è placidissima: una distesa
scintillante di fango, da cui emergono pochi massi e spuntoni di roccia. Non si vede
un solo morto per il semplice motivo che sono rimasti tutti sepolti sotto uno strato di
due metri: le vittime saranno quasi duemila.
Arrivano gli alpini, i mobilifici della zona apprestano in due giorni le bare, ma
poche salme sono identificabili, le altre vengono calate in lunghe fosse anonime.
Partono le inchieste: è infatti chiarissimo che non si tratta di un disastro naturale. Il
monte Toc era noto a tutti per la sua friabilità e nel corso degli anni diversi geologi
avevano compiuto simulazioni minacciosissime, specie in quella zona ad alto rischio
sismico. Ma il progetto, che risale ai primi anni Quaranta, va avanti comunque. I
dubbiosi vengono ignorati o zittiti, la società costruttrice, la SADE, vuole vendere
all’ENEL il suo bel bicchiere colmo di ghiotte ricadute economiche. Inutile dire che il
processo si trascinerà per anni, che le pene per il «disastro colposo plurimo» saranno
in definitiva lievi, che i paesi distrutti verranno ricostruiti con criteri molto discussi,
che i pochi superstiti saranno risarciti più o meno adeguatamente.
Il Vajont non è però l’unica sciagura acquatica dell’epoca. A Firenze, il 4
novembre 1966, la pioggia - molta, imprevedibile pioggia - fa tracimare l’Arno, che
invade la città spazzando via, oltre ai mobili del tinello, insostituibili tesori conservati
nelle chiese e nelle biblioteche della capitale del Rinascimento. Incunaboli e papiri,
pale d’altare, affreschi, preziosi reperti lignei, sete antichissime finiscono a
galleggiare sull’acqua marrone all’altezza del secondo piano.
Giovani italiani e di ogni parte d’Europa accorrono per cercare di salvare il
salvabile e molto viene infatti recuperato. I giornali rendono onore ai «capelloni». La
retorica che sempre ne circonderà il contributo rischia di guastarne il ricordo, ma in
quei giorni gli adulti scoprono che la sensibilità dei figli non è affatto incompatibile
con la lunghezza delle loro chiome.
I soccorsi cedono poi il posto alle inchieste, che sono approfondite anche qui, ma
alla fine la rassegnata conclusione: chi poteva prevedere tutta quella pioggia? Per
fortuna il tradizionale sarcasmo toscano regge degnamente alla prova. Sulla porta di
una trattoria viene affisso questo cartello: «Oggi niente arrosto. Tutto in umido».
15 luglio 1964
Tu vuo’ fa’ il sudamericano
Il governo di centrosinistra è caduto sui soldi alla scuola cattolica e Aldo Moro sta
cercando con tecniche da fachiro di metterne in piedi un altro. Le trattative sono
estenuanti. Dopo sessantatré ore di discussioni, a Villa Madama il leader socialista
Pietro Nenni si addormenta di schianto su una panchina. Giuseppe Saragat lo addita
ai democristiani: «Guardate quel pover’uomo. Ecco come lo avete ridotto». E pone
un ultimatum, che essendo rivolto ai democristiani diventa subito un penultimatum,
perché quelli vogliono continuare a discutere su tutto: riforma scolastica, regioni,
legge urbanistica.
Al Quirinale il presidente Antonio Segni non ne può più. Delle consultazioni, del
caldo afoso e del centrosinistra, a cui imputa la crisi che ha spezzato il miracolo
italiano. La Confindustria la pensa come lui e anche il ministro del Tesoro, Emilio
Colombo, in una lettera spedita al presidente del Consiglio ma pubblicata dal
«Messaggero», ha preconizzato il collasso imminente dell’economia. Scioperi,
disoccupati, fuga di capitali. Segni teme la nazionalizzazione delle case, dopo quella
dell’energia elettrica, e ha dato tempo a Moro fino a sabato per formare un governo
più moderato. Altrimenti...
Qui entra in scena il comandante generale dei carabinieri Giovanni De Lorenzo.
Proviene dai servizi segreti, dove ha selezionato i «patrioti» di Gladio («in sonno»,
ma pronti ad agire in caso di invasione sovietica) e si è costruito un tesoretto di
dossier e rapporti ambigui. Ha un piano in tasca per le emergenze. Il piano Solo - nel
senso che sa di poterlo realizzare solo con i carabinieri - prevede di «enucleare», cioè
deportare, in Sardegna una serie di personalità scomode e di occupare le prefetture e
la RAI TV. Il tutto con un pugno di generali e una brigata meccanizzata di fresca
costituzione.
Segni non dimentica le reazioni popolari al governo Tambroni. Secondo
«L’Espresso», che tre anni dopo svelerà l’intrigo, il presidente convoca De Lorenzo
al Quirinale per chiedergli se sarebbe in grado di garantire l’ordine pubblico qualora
si formasse una maggioranza di centrodestra o si tornasse alle urne. Da qui a farne un
alleato dei golpisti, il passo è lungo. Ma De Lorenzo preferisce pensare che sia
arrivata l’ora X e avverte i suoi di tenersi pronti, perché se Moro non formerà il
governo entro sabato...
Invece Moro in extremis ce la fa, simulando persino un malore per ammorbidire i
socialisti e la corrente moderata del suo partito (i gommosi ma coriacei dorotei) e
farli convergere su un programma che non spaventi troppo il capo dello Stato.
Il 7 agosto va a trovarlo insieme con Saragat e durante il colloquio si sentono urla,
riferimenti minacciosi. Segni si accascia, colpito da trombosi: non si riprenderà più e
al suo posto, a Natale, sarà eletto proprio Saragat. Quanto a De Lorenzo, viene
nominato capo di Stato maggiore dagli stessi uomini che avrebbe dovuto
«enucleare». Ma l’esplosione dello scandalo lo costringerà alle dimissioni e il
generale che sognava almeno un ministero dovrà rassegnarsi a concludere la carriera
da semplice deputato del Movimento sociale.
30 marzo 1966
Non capisco più niente
«Non capisco più niente» ripete più volte Oscar Lanzi, il pubblico ministero al
processo della «Zanzara». Si tratta del giornalino interno del liceo Giuseppe Parini di
Milano, un istituto di lunga tradizione conservatrice, che tuttavia ha pubblicato
un’inchiesta sulla posizione della donna riguardo al matrimonio e al sesso. Nove
ragazze, tutte minorenni, rispondono ai quesiti suscitando un incredibile putiferio.
Insorge il gruppo cattolico di Gioventù studentesca e via via la questione diventa di
rilevanza nazionale. I tre giovanissimi responsabili (il direttore della «Zanzara»
Marco De Poli e i suoi compagni Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi) vengono
invitati in questura e richiesti di sottoporsi a una visita medica, in base a una legge
fascista del 1933 atta ad accertare la loro capacità di intendere e volere. La ragazza si
rifiuta.
L’incriminazione è però seria: i tre avrebbero violato diversi articoli del Codice
penale relativi alla pubblica morale, all’oscenità, ai limiti della libertà di stampa ecc.
Ma il vero punto in questione riguarda i cosiddetti «rapporti prematrimoniali». Se
cioè, come sostengono le nove minorenni intervistate, le donne abbiano il diritto di
fare esperienze sessuali prima del matrimonio.
Il processo, che si tiene a Milano, è un evento politico di prima grandezza.
Quattrocento giornalisti si contendono i posti in aula, mentre fuori si formano lunghe
code dove si discute accanitamente su quella che è ormai percepita come una svolta
epocale nella morale pubblica.
«Non capisco più niente» ripete il pubblico ministero nel suo lungo atto d’accusa,
ma in realtà ha capito benissimo. Il mondo cui egli appartiene è quello dei cavoli e
delle cicogne, dove il sesso non emerge mai esplicitamente, dove l’eufemismo, la
mezza verità, l’allusione appena velata hanno accompagnato alla maturità
generazioni di italiani. Certe cose s’imparano dai compagni e dalle compagne di
scuola, non vengono trattate apertamente come avviene nel Congo o nei Paesi
nordici. E la giovane sposa arriverà all’altare illibata.
Contro queste perorazioni di patetica veemenza, i grandi avvocati della difesa
hanno buon gioco. Dall’Ora, Pisapia, Delitala smontano punto per punto tutte le
argomentazioni dell’accusa, portano testimonianze inconfutabili di come ormai il
sesso venga affrontato seriamente a livello didattico perfino nelle scuole cristiane,
confutano le citazioni e i discutibili precedenti chiamati in causa, e chiedono per i
loro assistiti la piena assoluzione da tutti i reati di cui sono imputati. E così appunto
avviene in camera di consiglio.
I tre scandalosi ragazzini se ne tornano a casa in trionfo e si può pensare che
abbiano partecipato entusiasticamente a quello che due anni dopo si chiamerà il
Sessantotto. Una grande vittoria progressista, senza dubbio, un segnale decisivo che
l’Italia è cambiata. Se in bene o in male ancora oggi non si capisce.
30 aprile 1966
Nome d’arte
Quando nel 1991 il presidente della FIAT Giovanni Agnelli accetta, non senza
perplessità, la nomina a senatore a vita, si affretta a precisare: «Non chiamatemi
senatore. Per me e per tutta la famiglia “il” Senatore è mio nonno, il fondatore. Il mio
nome d’arte è l’Avvocato».
Ha partecipato alla seconda guerra mondiale come ufficiale carrista in Russia e in
Africa occidentale. Appena rientra a Torino il nonno muore e Vittorio Valletta,
manager dal pugno di ferro, è sotto accusa di collaborazionismo. Ma viene reinserito
e offre il comando supremo al giovane erede, che rifiuta. Si renderà utile come
ambasciatore muovendosi vivacemente tra i circoli mondani, finanziari, politici di
tutto il mondo e stabilendo rapporti di amicizia con capi di Stato, banchieri e altissimi
burocrati.
Sono anni in apparenza, e anche in sostanza, frivoli ma utilissimi a lungo termine.
Nel 1966 Valletta decide che la dorata gavetta è finita e il 30 aprile gli consegna,
dice, una FIAT in eccellenti condizioni. Ma non è affatto così. Il celebrato miracolo
economico italiano è al tramonto, i sindacati fanno richieste sempre più pressanti, la
concorrenza straniera comincia ad erodere quote di mercato, le grandi banche
tentennano coi prestiti.
Sopravviene l’autunno caldo, che durerà per anni col blocco della produzione,
scioperi selvaggi, gravi perdite per l’azienda. E negli anni Settanta il terrorismo rosso
si infiltra in fabbrica. L’Avvocato e Luciano Lama, capo della CGIL, si stimano e
tentano compromessi di vario tipo, che tuttavia non danno grandi risultati. Ma, con il
nuovo amministratore delegato Cesare Romiti, Agnelli non perde mai di vista quella
che oggi chiamiamo «globalizzazione». Dopo lo stabilimento in Russia, tenta di
acquistare la Citroen in cattive acque, punta sul Brasile e sull’India.
Sono decenni difficilissimi e l’Avvocato, che è stato anche presidente di
Confindustria, ha usato a fondo tutte le sue doti di conciliatore, consapevole che in
queste incessanti tempeste la faccia feroce non è praticabile. Non lascia Torino, guida
lui stesso perigliosamente la sua automobile, scendendo dalla collina (e facendo
impazzire la scorta) e si rassegnerà poi all’elicottero. Ogni tanto si concede una breve
vacanza nelle stazioni sciistiche svizzere, praticando uno dei suoi sport preferiti.
Lavora moltissimo, mantenendo però sempre quel distacco elegante che gli vale la
nomea di vero «Re d’Italia».
Gli offrono più volte una poltrona nel governo, ma Agnelli non ama la politica, si
consola coi successi della sua Juve e con la coscienza di essere ammirato, ossequiato
e imitato fino al grottesco. Quando allo stadio, una domenica d’inverno, decide di
togliersi il cappotto, di colpo l’intera tribuna se lo leva. Sotto, però, l’Avvocato
indossa un pullover pesantissimo: il giorno dopo tutta la Torino che conta è a letto
con l’influenza. Tutta, tranne lui.
25 settembre 1967
Anonima Rapine
Stridore di gomme, la porta della banca spalancata con violenza, due uomini
mascherati da sciarpe e berretti entrano pistole in pugno: «Tutti a terra, è una
rapina!». Uno dei due scavalca il bancone, infila in un sacco il denaro, esce di corsa,
risale in macchina e quando polizia e carabinieri arrivano a sirene spiegate i banditi
sono già scomparsi. La scena si ripete a cadenze sempre più ravvicinate a Torino e
comuni limitrofi, e a Milano.
Ogni colpo dura al massimo tre minuti e frutta dai cinque ai dieci milioni di lire.
L’esecuzione è sempre perfetta e gli inquirenti pensano a una banda di professionisti
espertissimi, mentre i giornali citano la parigina «bande à Bonnot» e più ancora
Dillinger, il celeberrimo «bank robber» dell’America degli anni Trenta. Ma dagli
informatori della malavita non filtra nessuna informazione, i banditi appaiono
totalmente sconosciuti.
La loro audacia spavalda fa paura e il terrore cresce quando i rapinatori cominciano
a prendere ostaggi e quando infine sparano e uccidono. Quasi a voler deridere gli
avversari, portano a termine due, anche tre assalti al giorno, a breve distanza uno
dall’altro, e mandano lettere beffarde alla «Stampa», firmandosi Anonima Rapine.
Poi vanno a Milano in pullman di linea, rubano una macchina e tentano una
temeraria tripletta. Ma stavolta (la diciottesima) falliscono. Un poliziotto ferisce a un
braccio il più grosso di loro, che viene catturato, mentre gli altri fuggono sparando in
tutte le direzioni. Una gincana di sangue che provoca quattro morti e decine di feriti
tra i passanti. Alla fine i banditi abbandonano la macchina e spariscono nelle
campagne.
Il ferito confessa subito, dà indicazioni che portano alla cattura di un diciassettenne
appena affiliato e rivela i nomi degli altri due. È gente qualunque, nessuno ha
precedenti penali. Il capo è Pietro Cavallero ex bigliettaio del tram, che a Torino
opera dietro la facciata di rappresentante di penne a sfera. È lui che prepara
minuziosamente i colpi, studia le vie di fuga e divide il bottino.
Centinaia di agenti lo cercano fra Torino e Milano e infine un giovane carabiniere
lo scova mentre dorme con il suo complice Sante Notarnicola in un casello
abbandonato della ferrovia, vicino a Valenza. «La guerra è finita» dice. E tenta di
dare un qualche valore ideologico alle sue gesta da megalomane, sostenendo che
svaligia le banche per colpire al cuore il capitalismo.
In più di due anni di rapine la banda Cavallero ha racimolato ottanta milioni di lire,
in gran parte persi al gioco. Notarnicola recita la parte del debole traviato, ma
inutilmente: per tutti, tranne il diciassettenne, sarà l’ergastolo. Poi in carcere le parti
si ribaltano. Cavallero chiede perdono e chiude la sua vita assistendo i bisognosi
all’Arsenale della Pace di Torino, mentre Notarnicola diventa un contestatore del
sistema carcerario e si dichiara detenuto politico. Scontata la pena, aprirà un’osteria.
31 dicembre 1968
Il botto
«Ai grassi padroni e alle loro donne impellicciate vogliamo porgere personalmente
i nostri auguri con un simbolico omaggio ortofrutticolo». Non esistono ancora le email, ma l’invito del giovane Adriano Sofri porta cinquecento contestatori e qualche
chilo di arance davanti alla Bussola, il famoso locale della Versilia dove per il
veglione di San Silvestro è in programma un concerto di Fred Bongusto e Shirley
Bassey.
È l’atto finale di un anno che ha fatto la storia: il Sessantotto, la ribellione dei
giovani contro ogni autorità costituita. Era cominciato con l’occupazione delle
università per chiedere meno nozionismo e la cacciata (sacrosanta) di quei «baroni»
che stanno in cattedra senza alcun interesse per i loro allievi. Si concluderà con il
rifiuto (autolesionista) di qualsiasi forma di meritocrazia, complice la lettura un po’
forzata dei «testi sacri» di don Milani.
Arrivano le assemblee, i cortei, purtroppo le chiavi inglesi: volano botte fra rossi e
neri, fra studenti e polizia, e crea scalpore Pasolini, che nel commentare gli scontri
romani di Valle Giulia attribuisce agli agenti la patente di figli del popolo e ai
contestatori quella di figli di papà.
La critica dei ragazzi al sistema scolastico si allarga alla società capitalistica: il
lusso, le multinazionali. Più o meno i temi di oggi, ma il contesto è diverso: l’utopia
comunista esercita ancora fascino, almeno nella versione antisovietica di Mao, Che
Guevara e Ho Chi Minh.
I sessantottini sono una generazione numerosa (sei milioni, il doppio dei loro figli)
e si sentono padroni del futuro. Vogliono tutto e subito, l’immaginazione al potere,
anche se i più cinici, da grandi, si accontenteranno di portarvi l’immagine. Ma per il
momento sono insofferenti verso qualsiasi adulto, compresi quelli che si schierano
con loro per mero opportunismo come Moravia: lo scrittore viene addirittura
«processato» alla Sapienza di Roma da una giuria di ragazzi presieduta da Oreste
Scalzone, uno dei fondatori di Potere operaio.
A dicembre la contestazione vira sul goliardico: i milanesi di Mario Capanna tirano
cachi alla prima della Scala e i pisani di Sofri accolgono con arance marce gli ospiti
della Bussola. «È una vergogna, quella ragazza ha un vestito da trecentomila lire!»
s’infiamma un lanciatore d’agrumi. «Come faccio a saperlo? È mia cugina...»
Dopo le arance, spuntano le palline di metallo e le pistole finte. Anche quelle vere:
c’è una carica di «carruba», i carabinieri, un accenno di barricate ed un proiettile
vagante che colpisce alla schiena il sedicenne Soriano Ceccanti. Costretto per sempre
su una sedia a rotelle, farà incetta di medaglie alle Paralimpiadi di scherma.
Il suo ferimento è un brusco risveglio per tutti. I carabinieri giurano di aver sparato
a salve, ma forse non si può dire lo stesso degli agenti della Stradale. La sinistra
chiede il disarmo della polizia. Sofri si oppone, auspicando scontri sempre più duri,
premessa dell’inevitabile rivoluzione. A mezzanotte il Sessantotto finisce in tutto il
mondo tranne che in Italia, dove continuerà per altri dieci anni.
4 settembre 1969
Potere operaio
«Prevedo che l’autunno sarà molto caldo». Quando scrive questo telegramma al
suo amico Mariano Rumor, il segretario socialista Francesco De Martino non sa
ancora di aver dato il titolo a un’epoca. La contestazione è uscita dalle scuole ed ha
invaso le fabbriche, nelle quali il vecchio manovale specializzato, quello che con la
lima sa fare «i barbis a le musche» (i baffi alle mosche), è ormai sovrastato
dall’operaio-massa giunto dal Meridione, alienato da un lavoro ripetitivo e ribelle alla
disciplina di fabbrica.
La FIAT sospende migliaia di metalmeccanici, accusati di aver sabotato la catena di
montaggio di Mirafiori. Gli operai rispondono bruciando auto e macchinari. Gli
scioperi a singhiozzo mettono in ginocchio l’azienda e negli stabilimenti
furoreggiano i cortei interni: capi e capetti sono costretti a sfilare davanti ai
dipendenti, che urlano loro i peggiori improperi con la consapevolezza dell’impunità.
La FIAT ritira i provvedimenti che hanno innescato la rivolta, ma l’autunno caldo
divampa in tutto il Nord: la Pirelli è occupata e alla Marzotto, come nei cambi di
regime, gli scioperanti abbattono la statua del fondatore. Le agitazioni, culminate in
un corteo di centomila operai per le strade di Roma, si concludono a dicembre con il
successo delle tute blu. Il contratto dei metalmeccanici negoziato dal sindacalista
Bruno Trentin contiene grandi conquiste, come i delegati di fabbrica e la riduzione
dell’orario a quaranta ore settimanali. Presto arriverà anche lo Statuto dei Lavoratori.
Ma non manca qualche bizzarria sessantottina: l’aumento di stipendio uguale per tutti
e l’affermazione che il salario è una «variabile indipendente», sostenuta dal ministro
del Lavoro (lui dice: dei lavoratori) Carlo Donat-Cattin.
La marea di studenti e operai si ritrae appagata, ma rimangono attive le minoranze
estremiste. Per gli intellettuali di Lotta continua e Potere operaio le conquiste del
riformismo sindacale rallentano la marcia della rivoluzione. I «cattivi maestri»
predicano l’avvento imminente del comunismo, per il quale esisterebbero finalmente
le condizioni oggettive. Quanto si sbagliano, e i giornalisti e i politici con loro.
La provincia italiana sta infatti andando da tutt’altra parte. È proprio in questi mesi
bollenti che, lontano dai sussulti del triangolo industriale, sorgono i primi capannoni
di quello che sarà poi chiamato il «sommerso». Famiglie di contadini, artigiani e
cassintegrati si riciclano in piccoli imprenditori. Producono qualsiasi cosa: agnolotti,
sedie, scarponi. E ad animarli non è l’utopia comunista, né il desiderio di una
restaurazione reazionaria e bigotta. È il demone del consumismo. Le stesse grandi
aziende, che a Torino e Milano devono chinare la testa di fronte ai propri operai,
cominciano a spostare servizi e produzioni all’esterno, dove il costo del lavoro è
minore, i sindacati assenti e l’evasione fiscale celebrata come una necessità salvifica.
Negli anni Settanta anche il «sommerso» sfiderà lo Stato. Ma, a differenza del
terrorismo, lo sconfiggerà.
12 dicembre 1969
Il rosso e il nero
Nonostante il portone di piazza Fontana 4 sia chiuso da più di mezz’ora, all’interno
della Banca nazionale dell’Agricoltura di Milano ci sono ancora parecchi correntisti
da servire. Forse chi ha messo una borsa di tritolo sotto il tavolo degli impiegati,
piazzando il timer alle 16,37, immaginava degli uffici vuoti. Invece l’esplosione
provoca sedici morti e un centinaio di feriti.
In piazza della Scala, il direttore della Commerciale apprende la notizia e sbianca.
Ha appena chiuso in cassaforte una borsa, convinto che qualche cliente l’abbia
dimenticata. È piena di tritolo e gli artificieri la faranno brillare, privando le indagini
di un corpo del reato. Nello stesso momento a Roma si odono altri boati: nei
sotterranei della Banca del Lavoro, al Museo del Risorgimento, sull’Altare della
Patria. Piazza Fontana fa dunque parte di un piano più vasto. Sono giorni particolari:
l’autunno caldo si è riversato per le strade ed un poliziotto, l’agente Antonio
Annarumma, è stato ucciso durante una manifestazione. Qualcuno auspica una
sterzata reazionaria.
Il presidente del Consiglio Rumor è a letto con la febbre a quaranta, ma
all’annuncio di piazza Fontana corre in televisione. I mandanti delle bombe si
aspettano che dichiari lo stato di emergenza. Invece Rumor chiede agli italiani di non
credere nel terrorismo, ma nella legge. Nel 1973 rischierà la vita in uno strano
attentato anarchico e da allora si tramuterà in una sfinge, a costo di lasciarsi
incriminare per reticenza al processo di Catanzaro.
Su piazza Fontana il commissario Luigi Calabresi si fa subito un’idea chiara:
«menti di destra e manovali di sinistra». In cerca di un incidente che giustifichi la
svolta autoritaria, neofascisti e agenti dei servizi segreti avrebbero fornito l’esplosivo
a un gruppo anarchico che voleva compiere un gesto dimostrativo. Sono
sorprendentemente le stesse conclusioni a cui giungerà la controinchiesta delle
Brigate rosse.
Fra gli anarchici fermati da Calabresi c’è Giuseppe Pinelli, ferroviere pacifico e
idealista. Da lui il commissario spera di ottenere informazioni sul conto di ben altro
soggetto, il ballerino Pietro Valpreda, che un tassista sostiene di aver lasciato quel
pomeriggio davanti alla banca con una borsa in mano. Dopo tre giorni di
interrogatori, nel cuore della notte Pinelli precipita dalla finestra al quarto piano della
questura. Nella stanza ci sono quattro poliziotti e un carabiniere. Non Calabresi, che
di quella morte diventerà il capro espiatorio.
Valpreda, lui è difeso dagli intellettuali progressisti, benché il suo circolo
anarchico presenti contorni foschi: ne fa parte un certo Merlino che nel maggio del
1965, in un albergo di Roma, ha partecipato al convegno in cui agenti dei servizi,
politici e giornalisti di estrema destra hanno teorizzato l’uso della forza per fermare
l’avanzata dei comunisti.
Fra omissis e ritrattazioni, su piazza Fontana passano i processi e i decenni. Ma se
non la verità giudiziaria, quella storica è infine raggiunta: Franco Freda e Giovanni
Ventura, neonazisti padovani di Ordine nuovo, assolti irrevocabilmente in appello per
insufficienze di prove, vengono dichiarati dalla Cassazione responsabili della strage.
Centoventi
I sogni del Sessantotto si tramutano in piombo: terrorismo, stragi e veleni non solo
metaforici. Impaurito e impoverito, l’italiano medio trova il suo eroe: Fantozzi.
1972-1978
Shot river (Fiume di piombo)
Negli anni Settanta in Italia furono uccise centinaia di persone per ragioni
ideologiche. In questa nostra «Spoon River» abbiamo dato la parola a cinque di esse:
un poliziotto, una terrorista, una studentessa, un giornalista e un politico.
Gigi
Non ero nella mia stanza, non gli ho tirato un colpo di karaté alla nuca, non l’ho
buttato dalla finestra. Mi hanno condannato a morte per un delitto che non ho
commesso. Io e Pinelli ci fidavamo l’uno dell’altro: dopo le bombe di piazza Fontana
ero andato a prenderlo con la 850 di servizio, ma avevo lasciato che mi seguisse col
suo motorino fino alla questura. A Natale gli avevo regalato il libro di un giornalista,
Emanuelli, che parlava di Russia e Cina. E lui aveva ricambiato con l’Antologia di
Spoon River. Dormiamo entrambi sulla collina, adesso. Legati da uno stesso destino.
Sono sempre stato cattolico, di quelli che ci credono davvero. Non ci avessi
creduto, sarei impazzito. Qualcuno sostiene che sarei un santo. Ma allora pensavano
che fossi il diavolo. Dicevano: è un agente della CIA, la guardia del corpo di un
generale americano. Io, che non ho mai saputo una parola d’inglese...
Quando querelai «Lotta continua» vennero al processo a gridarmi: assassino! Lo
scrivevano sui loro giornali, intellettuali famosi firmavano manifesti contro di me,
mentre sui muri le mie mani grondavano sangue e io ero «il commissario Finestra».
So che molti di loro se ne vergognano, adesso. Erano tempi allucinanti, ricordo
bambini sfilare in corteo col Libretto Rosso di Mao.
Non sono un diavolo e nemmeno un santo. Sono stato un uomo. Un commissario
di polizia. Ho diretto le cariche contro gli studenti che avevano occupato la Cattolica.
Ho protetto col mio corpo il loro leader Mario Capanna, quando si presentò ai
funerali dell’agente Annarumma e i miei lo volevano linciare. Ho indagato su piazza
Fontana e continuo a pensare che i manovali fossero di sinistra e le menti di destra.
Pinelli era un anarchico all’antica, un galantuomo. Quando capì di essere stato
usato, anche da qualche compagno meno galantuomo di lui, non resse la vergogna.
Morì e per me la vita divenne un inferno. Scoprii che il rivoluzionario esploso su un
traliccio di Segrate mentre preparava un attentato era Giangiacomo Feltrinelli,
l’editore del Dottor Zivago: bastava aggiungergli i baffi. Ma la Cederna scrisse che
non si era ucciso, che lo avevamo ammazzato noi.
Amavo leggere, sul comodino ho lasciato una biografia di Chruščëv. I colleghi mi
sfottevano per i libri. E per i capelli: appena vedevo uno specchio, correvo a
pettinarmeli. L’ultima volta prima di uscire di casa, la mattina in cui nell’androne ho
sfiorato un tizio con la faccia nascosta dalla «Gazzetta dello Sport». Ho messo la
chiave nella serratura del mio bolide, una 500 blu. E poi.
Mi chiamo Luigi Calabresi, Gigi per gli amici, e sono stato ucciso a 34 anni con
due rivoltellate alla schiena, il 17 maggio 1972. Secondo la giustizia umana, l’uomo
nell’androne era Ovidio Bompressi e i suoi mandanti Pietrostefani e Sofri. Non
portavo mai la pistola con me: sapevo che sarei morto senza la possibilità di
difendermi. Colpito alle spalle, perché il mio assassino non avrebbe avuto il coraggio
di guardarmi negli occhi.
Mara
Vi starete chiedendo perché. Perché una ragazza trentina di buona famiglia, figlia
del proprietario della profumeria «La casa del sapone» - una brava figlia cattolica che
tiene concerti di chitarra classica e fa assistenza agli anziani - un giorno decide di
mettersi a sparare.
Non sopporto si dica che sono diventata terrorista per amore. Renato Curcio è stato
l’uomo della mia vita, ma non mi ha plagiato. Il nostro era un rapporto paritario, fra
compagni. Lui era al mio fianco sul sagrato del duomo di Trento, quando leggevamo
a voce alta le lettere di don Milani e i benpensanti ci tiravano le mele addosso. E
quando mi sono laureata in Sociologia col professor Alberoni, sì, quello che poi
scriverà Innamoramento e amore, e al momento del 110 e lode ho sventolato il pugno
chiuso.
Sapete che la tecnologia consentirebbe a dieci miliardi di persone di vivere come
un americano medio? Invece il mondo muore di fame, è intollerabile! Certo, chi spara
ha sempre torto perché la violenza chiama violenza e prepara le ingiustizie di domani.
Ma io allora vi avrei risposto: è la guerra che dà la libertà, non la scheda elettorale, un
trucco delle multinazionali per farci giocare alla democrazia e intanto tutto resta
com’è.
Ho sposato il mio René in abito bianco e la luna di miele l’abbiamo passata alla
Pirelli. Milano mi ha mostrato la faccia vera del consumismo. Gli sperperi, le
disuguaglianze. Ho perso il nostro bambino in uno scontro con la polizia, durante
un’occupazione di case a Quarto Oggiaro. Fu allora che decidemmo di passare alla
lotta armata. Un giorno, a piazzale Loreto, Renato mi disse: «Qui una brigata
partigiana appese Mussolini a testa in giù. Chiamiamoci Brigata anche noi». «Rossa»
aggiunsi io. Poi arrivarono altri compagni e la Brigata rossa divenne plurale.
La prima azione fu l’incendio dell’auto di un sorvegliante della Pirelli: sistemai io
la tanica di benzina, mentre Renato faceva da palo. Poi i rapimenti: un dirigente della
Sit-Siemens, il giudice Sossi. Ci sentivamo i nuovi partigiani, in guerra coi fascisti
delle stragi di Brescia e dell’Italicus.
Non ero un’invasata. Mi piaceva ridere e suonare Dylan. Però prendevo la vita sul
serio, come tutte le donne. E come tutte le donne avevo un sesto senso. Non fidarti di
frate Mitra, dissi a Renato, che si era infatuato di quel sedicente rivoluzionario.
Avevo ragione, era una spia del generale Dalla Chiesa. Renato fu rinchiuso nel
carcere di Casale Monferrato. Per liberarlo mi presentai all’ingresso con un pacco:
dentro c’era una mitraglietta.
Servivano soldi, così rapimmo il Gancia degli spumanti e lo nascondemmo in una
cascina vicino ad Acqui Terme. Si chiamava la Spiotta e qualcuno fece la spia,
perché la mattina dopo un carabiniere bussò alla porta. Misi mitra e borsetta a tracolla
e corsi fuori.
Mi chiamo Margherita Cagol, nome di battaglia Mara, e sono morta a 30 anni in
combattimento, il 5 giugno 1975. Nel luogo in cui fui uccisa alcuni compagni
gettarono dei fiori rossi.
Giorgiana
Povera mamma, l’ho perfino rassicurata: non succederà niente, canteremo e
festeggeremo, e se poi le cose prendessero una brutta piega mi metterò al sicuro, non
sono una stupida.
Così io e il mio ragazzo usciamo di casa, un palazzone scrostato sulla via
Trionfale, e ci dirigiamo verso piazza Navona, dov’è in programma la manifestazione
dei radicali per il terzo anniversario del referendum sul divorzio. Il mio ragazzo è un
tipo normale. Anch’io. Sono una liceale timida e impegnata, ma quest’anno lo siamo
un po’ tutti. La domenica distribuisco «Lotta continua» e faccio parte di un collettivo
femminista che si batte per l’apertura di un consultorio nel quartiere.
A piazza Navona non siamo mai arrivati. Poliziotti ovunque, alcuni vestiti da
autonomi: impossibile distinguere i falsi dai veri. A me piacciono gli Indiani
metropolitani e Radio Alice. Non gli espropri proletari (che di proletario hanno ben
poco: quando entrano in un supermercato, anziché pane e salame rubano champagne)
e la violenza dell’Autonomia, con quegli slogan cupi: «Le spranghe nel ‘68, nel ‘77
le P38».
C’è stato uno scontro col servizio d’ordine comunista durante un comizio di Lama
all’università di Roma. Poi a marzo la morte di quel ragazzo a Bologna, Francesco
Lorusso, ha innescato la spirale d’odio, un poliziotto ci ha rimesso la pelle e Cossiga,
d’accordo col PCI, ha proibito le manifestazioni non organizzate dai partiti dell’arco
costituzionale: «Deve finire il tempo dei figli dei contadini meridionali uccisi dai figli
della borghesia romana» ha detto alla Camera, facendo il verso a Pasolini.
Pannella se ne è infischiato e ha confermato la nostra festa, ma si è capito subito
che autonomi e poliziotti l’avrebbero utilizzata per regolare i loro conti. In corteo
giungono notizie di pestaggi: studenti, fotografi, giornalisti, anche un parlamentare.
Nelle scritte lungo la strada, la prima lettera del ministro è già cambiata: «Kossiga
boia».
Ci ritroviamo su ponte Garibaldi. Al tramonto parte la carica della polizia.
Cominciamo a correre verso viale Trastevere, coi poliziotti dietro - quelli in divisa
sulle autoblindo, quelli in borghese appoggiati alle ringhiere del ponte - e le barricate
degli autonomi davanti a noi. Si sente uno sparo e io cado di faccia sul selciato.
Qualcuno mi prende per i piedi e le ascelle. «Oddio che male» mormoro. L’ultima
cosa che ricordo è la faccia del mio ragazzo china su di me: «Sarà stata la botta, non
ti preoccupare».
Mi chiamo Giorgiana Masi e sono stata uccisa alle 8 di sera del 12 maggio 1977 da
un proiettile calibro 22 sparatomi alle spalle. Avevo 18 anni e il mese dopo avrei
dovuto sostenere la maturità. Mentre ero all’obitorio, il mio ragazzo ha tentato di
suicidarsi con il gas: i suoi genitori lo hanno salvato, prendendolo per i capelli. Al
mio funerale le femministe hanno intonato canzoni partigiane. Dove sono caduta,
qualcuno ha lasciato questo biglietto: «Forse Giorgiana sei più fortunata di noi perché
non devi più vedere questo mondo schifoso».
Carlo
Il rimbombo, i lampi... Quel rimbombo sotto l’androne e subito il dolore,
fortissimo, alla faccia, alla testa, che ancora persiste dopo giorni e giorni di agonia.
Mi hanno «giustiziato» e sono il primo giornalista a morire per il mestiere che faccio,
altri prima di me sono stati soltanto «gambizzati». Del resto l’avevano detto:
«Alzeremo il tiro», e mi hanno scelto come esempio per tutti.
Mal di denti. Così sono uscito dall’ufficio e sono andato dal dentista senza la
scorta, che avevo da pochi giorni. E loro mi hanno seguito fino a casa, hanno
aspettato che parcheggiassi l’auto in corso Re Umberto e quando poi sono entrato nel
portone, in due, forse in tre, mi hanno puntato le pistole. Il rimbombo in quella casa
borghese, in quel quartiere borghese. Eliminato «un servo dello Stato» con quattro
colpi.
Tutti sono venuti, tutti hanno sperato, ma io sapevo che non c’era speranza, il
dolore era troppo forte. Avrebbero potuto essere pallottole fasciste o naziste, quando
ero nella lotta partigiana con Giustizia e Libertà, e invece muoio a più di sessant’anni
per mano di questi idioti, sì, degli idioti ignoranti. È così che li giudico, alla fine.
Certo, lo Stato di cui sono un servo non è uno Stato ideale, ma è in grado di
difendersi senza leggi speciali, con le armi legali che già possiede e che noi gli
abbiamo dato in anni lontani. «Né con lo Stato né con le br» dicono alcuni personaggi
eminenti e improvvidi, ma è una neutralità impossibile: lo Stato, per quanto debole,
zoppicante, carente, talvolta iniquo, non si può mettere sullo stesso piano di gente che
non ha un’idea dietro l’assassinio.
Vogliono impedire che si faccia il primo processo alle BR e uccidono, in un altro
androne uguale al mio, l’avvocato Fulvio Croce, nominato loro difensore d’ufficio, e
i giurati si ritirano uno dopo l’altro con ogni genere di giustificazione. Si arrendono,
fuggono, non vedono che questa è appunto la forza del terrorismo.
Ho preso troppo sul serio i miei «giustizieri»? Sì, ho polemizzato con loro alla pari,
ho «ragionato». Ma sapevo che le mie argomentazioni erano vane con simili esaltati.
Ora si alzeranno voci di altri «servi dello Stato» come me ed anche tra gli ignavi e i
pavidi si diffonderà un moto di rigetto. Non ci sarà nessuna rivoluzione, non ci
saranno spallate che valgano ad abbattere questo Stato che a quei folli sembra
sull’orlo del baratro.
Di me diranno che sono un eroe, anche se ho vissuto tutta la mia vita lontano da
ogni enfasi. Ho fatto il giornalista, ho commentato i fatti politici che mi passavano
davanti, non ho mai auspicato la morte di nessuno. Una vita tutto sommato
abitudinaria, moderata, passata a lavorare, leggere, studiare, scrivere, giorno dopo
giorno. Ma non è bastato a salvarmi da quel rimbombo nell’androne, da quegli idioti
ignoranti. Il 29 novembre 1977 è arrivata la fine, dopo tredici giorni di agonia.
Sono stato Carlo Casalegno, vicedirettore della «Stampa» di Torino.
Aldo
È finita. Mi uccideranno, stanno per uccidermi. Lo faranno con un solo colpo alla
nuca o con una raffica di mitra? Ma dal momento di quell’agguato in via Fani,
quando mi hanno tirato fuori dalla macchina, ho capito che sarebbe finita così,
avevano ucciso cinque uomini per prendere me, presidente della Democrazia cristiana
(una carica che non volevo). Capivo che dopo un così orrendo massacro non
avrebbero potuto lasciarmi libero.
Per cinquantacinque giorni sono vissuto non nelle loro mani, ma in quelle ben più
misteriose della morte. Pregavo, parlavo, scrivevo, chiedevo disperatamente aiuto,
perché la morte non la volevo. Pensavo alla mia famiglia e l’idea di abbandonarli era
insopportabile. Quella era la vita, per me. Ho scongiurato tutti gli amici che credevo
di avere nel mio partito perché accettassero lo scambio di prigionieri: i brigatisti in
carcere liberati e mandati in Algeria e dall’altra il presidente della DC. Ma non hanno
voluto, tirando in ballo la ragion di Stato. Lo Stato che io ho servito per decenni non
può venire a patti con degli assassini.
Ho scritto anche al Papa, che conosco bene da tanti anni. E il Papa ha cercato
canali nelle carceri, ha offerto enormi somme di denaro come riscatto. Un’ingenuità
incredibile, a dir poco. C’è stato qualche altro contatto, ma sempre lontano dai veri
responsabili, che mi hanno nascosto benissimo: nessuno mi ha trovato. Da un po’
giravano voci che mi volevano rapire, addirittura in chiesa, ma i miei non sono stati
capaci di proteggermi.
Se esco vivo da questo carcere cosiddetto «del popolo», lascerò tutte le cariche,
tutti gli impegni politici, non vedrò più Andreotti, Zaccagnini, Cossiga, mi ritirerò a
studiare sui miei libri di Diritto. Insegnerò, starò lontano da Roma, vivrò in mezzo ai
sorrisi e ai pianti dei miei nipotini adorati. Lascerò che i comunisti entrino nel
governo, oppure che ne restino fuori. Non siederò più per ore su poltroncine
damascate a cercare il consenso dei massimi dirigenti americani o sovietici, starò
fuori da tutti i giochi. Ma penso a questa vita con un sentimento di nostalgia, come se
l’avessi già vissuta e già perduta.
Tra poco mi uccideranno, lo so, non ci può essere nessuna trattativa e a me restano
soltanto la preghiera e la dolcezza infinita della mia famiglia. Mi uccideranno e poi
mi vestiranno, mi annoderanno la cravatta, mi nasconderanno sotto una coperta
qualunque e su una macchina qualunque mi porteranno in qualche strada di Roma.
Tutto cambierà dopo la mia morte, oppure tutto continuerà in modi diversi, con altre
vittime, altri moventi, in questo Paese dai mille aculei.
Sarò stato Aldo Moro, rapito in via Fani il 16 marzo 1978, assassinato il 9 maggio
dello stesso anno da Mario Moretti delle Brigate rosse.
31 agosto 1971
«Venghi ragioniere!»
Nelle più antiche civiltà e culture, anche primitive, non è mai mancato il
personaggio dello sbruffone, del miles gloriosus, del matamoros, del Tartarino che si
vanta di trionfi immaginari. Ma così su due piedi non viene in mente nessuna figura
di segno opposto, un eroe della sconfitta, dell’umiliazione, dell’abiezione remissiva.
Fantozzi sembrerebbe il primo, a memoria d’uomo.
Il suo creatore è un genovese, Paolo Villaggio, che lavora in una grande azienda
della sua città e poi intraprende una carriera cabarettistica in diversi teatri, inventa
diversi personaggi: il professor Kranz, tetesco di Cermania, Fracchia e altre figure di
piccola ma esilarante statura. Una di queste, il ragionier Ugo Fantozzi, appare in una
serie di racconti sull’«Europeo», che nel 1971 sono raccolti in un libro di successo,
scritto con una originale vena eroicomica in negativo. E così, quattro anni più tardi,
Fantozzi viene abilmente sceneggiato e cucinato dal regista Luciano Salce e diventa
istantaneamente una nuova, inaspettata, grande maschera italiana.
Il ragioniere è dipendente di una mega-azienda capeggiata da uno spietato megadirettore ed in questo ambiente l’ometto è vittima delle peggiori vessazioni, spesso
provocate dalla sua totale goffaggine ed inettitudine. È innamorato di un’acida
collega e tartassato da un pari grado attivissimo e deleterio. I disastri d’ufficio non si
contano, ma anche nella vita familiare Fantozzi non trova pace, con una moglie
remissiva e piagnucolosa e una figlia di orribile aspetto.
Ogni possibile incidente, equivoco, banalissimo sbaglio, ogni disfunzione, guasto,
intoppo circondano il ragioniere nei suoi sfortunati movimenti. Cadrà in terra
innumerevoli volte, precipiterà da tutte le scale, tutte le pentole gli scoppieranno in
faccia, non smetterà mai di scottarsi, ferirsi, spiaccicarsi in un pantano. Nei giorni
liberi dovrà sopportare la «nuvola dell’impiegato», che manda giù pioggia soltanto su
di lui e i suoi svaghi: assurde partite di calcio, folli incontri di tennis, picnic funestati
da disastrosi inconvenienti.
Quando un dirigente della mega-società impedisce ai sottoposti di assistere a una
partita di calcio dell’Italia e li costringe a vedere per l’ennesima volta il film La
corazzata Potëmkin, Fantozzi infine si ribella e urla la celebre frase: «La corazzata
Potëmkin è una cagata pazzesca!».
È la rivolta di Sancho Panza contro il suo illustre cavaliere. E in quel grido si
identificano milioni di italiani che si sentono esclusi o vogliono escludersi dal mondo
più alto della cultura. Fantozzi diventa una saga, la parola «fantozziano» entra nella
nostra lingua, insieme con l’uso errato del congiuntivo («venghi ragioniere»). Ogni
impiegato sa che Paolo Villaggio sta esagerando, che sta portando all’iperbole le
spicciole frustrazioni della giornata, ma lo elegge comunque a proprio eroe, umiliato
e offeso colpo su colpo.
2 dicembre 1973
Appiedati
La colpa è degli sceicchi che hanno chiuso i rubinetti del petrolio per ritorsione
verso gli amici di Israele. Così almeno dice il telegiornale nel comunicare al pregiato
popolo bue la decisione del governo Rumor: da questa domenica si va a piedi. Ma
non è che gli altri giorni si faccia festa. Negozi chiusi entro le 7 di sera, cinema e
ristoranti entro le 23, fine delle trasmissioni televisive alle 22,45, spente le insegne
natalizie ed in casa il riscaldamento non può superare i venti gradi.
Nuovi mostri mediatici irrompono nell’immaginario collettivo. Il Serpente
monetario, dalle cui spire ci avrebbe liberato Andreotti svalutando la lira. E la
Stagflazione, terribile incrocio fra la stagnazione dell’economia e l’inflazione a due
cifre che fa salire i prezzi dei beni di prima necessità. I quali, con un atto d’imperio,
vengono bloccati. Il risultato è che sparisce lo zucchero sfuso e si trovano soltanto le
zollette, che ovviamente costano il doppio.
Quanto è amaro il caffè, quella mattina. A renderlo più insopportabile sono i
giulivi che esaltano la nuova parolina magica, au-ste-ri-tà, declinata rigorosamente in
inglese: austerity. I telegiornali mostrano famigliole festanti in bicicletta e lanciano
appelli allo spirito di sacrificio. È la formula della felicità, o almeno della
sopravvivenza, e la ripetono a gran voce i politici più seri e tenebrosi, da Berlinguer a
La Malfa, che ha minacciato di uscire dal governo se verranno autorizzate le
trasmissioni televisive a colori.
Probabilmente quei due vedono lontano. Però l’italiano del 1973 non pensa ancora
all’ecologia e alla sobrietà come antidoto alla deriva turboconsumista. Pensa alla
guerra e alle privazioni che credeva di essersi lasciato alle spalle per sempre. Invece
si vocifera di una imminente, ancor più terrificante «fase due» e Gianni Agnelli, che
pure non passa per un pessimista, dichiara: «Prepariamoci, durerà a lungo».
Affiora l’incubo dei razionamenti, delle restrizioni valutarie e di nuove tasse, che si
materializzano in un’altra stirpe di creature mitologiche, le «una tantum»: sull’auto,
sulla casa, su tutto. Gli italiani evadono come possono e riorganizzano l’economia
all’insaputa dei politici, che incrementano anch’essi un secondo lavoro: il furto. A
beneficio del partito, s’intende. Tangenti dall’ENEL per non fare le centrali nucleari e
dall’Unione petrolifera per speculare sul prezzo della benzina. Ma non era colpa degli
sceicchi?
L’austerity si rilassa un po’: arrivano le domeniche a targhe alterne. Il suo colpo di
coda sarà la scomparsa degli spiccioli, sostituiti dai miniassegni di carta. Con quello
da 300 lire si comprano due quotidiani o un litro di benzina. Ma ormai è il settembre
del 1975 e l’Italia di provincia si è rimessa in moto. La sua capitale è Maranello, dove
Enzo Ferrari, l’ingegner Mauro Forghieri e un giovanissimo Luca Cordero di
Montezemolo creano la Rossa delle meraviglie, che a Monza con Niki Lauda
conquista dopo undici anni il titolo mondiale di Formula Uno, senza lesinare sulla
benzina. Alla faccia dell’austerity.
12 maggio 1974
Dissolubili
Il primo divorzio registrato in Italia risale al 1808, a Napoli, sotto il breve regno di
Gioacchino Murat e grazie al codice napoleonico. Poi tutto si chiude fino alla fine del
secolo, quando due proposte di legge vengono presentate in Parlamento e bocciate da
maggioranze schiaccianti.
Col fascismo e il Concordato la parola «divorzio» scompare di scena e fino agli
anni Sessanta gli italiani devono arrangiarsi. C’è l’annullamento da parte della Chiesa
dove un tribunale apposito, la Sacra Rota, vaglia le richieste e dà parere favorevole in
casi più o meno accertabili: la non consumazione, il rifiuto di procreare, il dissidio
sull’educazione religiosa dei figli eccetera. Poi c’è una serie di Paesi che consente un
secondo matrimonio aggirando il reato di bigamia, come il Messico e la Scozia. Si
forma una singolare categoria di avvocati detti «divorzisti» che cavillano attorno a
minimi spunti. Ma la legge proposta nel 1968 dai deputati Fortuna e Baslini, un
socialista e un liberale, finisce per prevalere sulla accanita opposizione di
democristiani e missini.
È una vittoria di breve durata perché subito gli oppositori, capeggiati
dall’onorevole Fanfani, ricorrono per la prima volta al referendum abrogativo, un
meccanismo costituzionale che consente soltanto di chiedere la cancellazione di una
legge che già esiste. La Chiesa si mobilita con tutte le notevoli forze di cui dispone,
non solo la DC, ma le associazioni parrocchiali, gli enti religiosi, le processioni. Il
matrimonio deve restare indissolubile ed il divorzio viene dipinto come uno
strumento che porterà alla rovina le basi stesse della società, l’unità della famiglia e
avrà conseguenze traumatiche per i figli delle coppie divorziate. Dalla parte opposta
si ribatte che la convivenza obbligata tra coniugi ostili è ancor più intollerabile per i
figli che crescono in un’atmosfera di odio, disprezzo, spesso violenza.
Grande tribuno divorzista diventa Marco Pannella, che impegna il suo Partito
radicale in una battaglia in cui si trova coinvolto l’intero Paese. Alla fine il
referendum abrogativo non passa: il 40% degli italiani lo approva, ma il 60% lo
respinge. La società (la donna) italiana è cambiata ed è molto diversa da come la
immaginano nelle sacrestie. Le cose poi si equilibrano e, dopo un primo periodo di
euforia separatista, le statistiche offrono cifre medie che non hanno nulla di
catastrofico.
Le coppie continuano a litigare fino alla decisione finale, i bambini passano a turno
da madre a padre, tutta una serie di provvedimenti fanno più o meno funzionare la
macchina che regola l’infelicità coniugale. La società non crolla, la famiglia si
complica e si sdoppia nelle cosiddette «famiglie allargate», ma resta all’incirca quella
di sempre. Lacrime e dolore, risate e festeggiamenti non cambiano la routine della
vita.
29 settembre 1975
Libero killer
Un metronotte che fa il suo giro nel quartiere Parioli a Roma sente gemiti e colpi
provenire dal bagagliaio di una 127. Quando alza lo sportello vede due sacchi neri,
uno dei quali contiene evidentemente un corpo vivo: è di una ragazza diciassettenne,
Donatella Colasanti, insanguinata, tumefatta e nuda. Accanto a lei la sua amica Maria
Grazia Lopez, ormai cadavere.
Vengono da una villa del Circeo dove hanno festeggiato il compleanno di tre
ragazzi conosciuti pochi giorni prima. Ma i tre si sono rivelati torturatori, stupratori e
infine assassini. La Colasanti si è salvata solo perché si è finta morta e da
quell’incubo non uscirà per tutta la vita: morirà di tumore senza poter vedere il suo
torturatore condannato definitivamente. Quando i tre vengono fermati, uno di essi, il
Ghira, non è indiziato e non sarà mai preso. Ma la polizia conosce bene Angelo Izzo,
un giovane di ottima famiglia, noto come violento, megalomane, praticante di sport
estremi e associato a un circolo di destra (che lo ha poi cacciato).
Durante il processo non apre bocca. Ma fin dai primi anni dell’ergastolo comincia
ad esercitare le sue doti di manipolatore. Ottiene un permesso premio, evade in
Francia, viene ripreso, ma tenterà altre evasioni tutte fallite. Psichiatri e psicologi lo
giudicano narcisista, psicopatico, schizofrenico, asociale, amorale e con tutte le
possibili etichette del gergo specialistico. Ma ora l’uno ora l’altro concordano nel
ritenerlo bene avviato sulla via del recupero: Izzo è pentito, pentitissimo. Tornano i
permessi premio per la buona condotta del detenuto, che s’impegna nel sostegno
morale e psicologico dei suoi compagni.
Arriva la semilibertà e Izzo diventa assistente sociale in una comunità religiosa che
soccorre giovani disadattati. Il «neo-adattatore» se ne sceglie due e con loro si affretta
ad organizzare un altro assassinio: la moglie e la figlia di un ergastolano conosciuto
nel carcere di Campobasso. Le porta in un casolare isolato, probabilmente le tortura,
le seppellisce ancora vive, compra due sacchi di calce e ricopre il tutto con mezzo
metro di terra. Viene presto scoperto e segue un secondo processo dove il
pluriassassino parla senza freni di sé, delle sue pulsioni, dei suoi disturbi, del suo
incoercibile sadismo. Un delirio sputato da un uomo grasso con due occhi da folle.
Gli italiani assistono allo sproloquio televisivo, ma si chiedono se la giustizia abbia
davvero fatto quanto poteva. Perizie, pareri, permessi e facilitazioni, concessi nel
corso degli anni da tanti luminari e da tanti magistrati, gettano un’ombra poco
rassicurante sull’intero sistema. E di tutti quegli esperti che si sono così
clamorosamente sbagliati, non risulta che uno solo abbia perso il posto.
2 novembre 1975
Ragazzo di vita
Pierpaolo Pasolini - intellettuale disorganico e poliedrico che si esprime in versi, in
prosa e attraverso i film e gli articoli di giornale - è a cena con l’amico Ninetta
Davoli. È di pessimo umore e si lancia in una delle sue preveggenti intemerate contro
il consumismo e il conformismo sociale. «La gente è odiosa» conclude. Forse è per
questo che la ama.
Anziché frequentare gli omosessuali colti come lui, preferisce mescolarsi col
popolo più violento e ignorante. «Vado a dare un’occhiata a delle sceneggiature» dice
a Ninetta. Invece sale sulla sua Alfa GT metallizzata e gira intorno alla stazione
Termini finché non rimorchia un adolescente di borgata, Pino Pelosi, chiamato la
Rana per gli occhi sporgenti, e lo porta all’Idroscalo di Ostia, in uno spiazzo
circondato dalle baracche che per molti romani hanno sostituito le case chiuse.
Pasolini ne ha una in affitto e offre ventimila lire alla Rana in cambio di un rapporto
orale. Da qui in poi la verità si riempie di buio.
La versione di Pelosi, che otterrà il timbro della Cassazione, racconta di una sua
ribellione ai giochi erotici dell’artista e di una colluttazione conclusasi con
l’investimento involontario di Pasolini da parte del ragazzo in fuga. Ma, a meno che
si voglia avvalorare la tesi masochista di una «morte sacrificale», l’idea che la Rana
abbia fatto tutto da solo è smentita dal buon senso: Pasolini era un esperto di arti
marziali, mai si sarebbe lasciato sopraffare da uno scricciolo come Pelosi. Infatti la
sentenza di primo grado del giudice Moro (fratello del politico DC) parla di «concorso
di ignoti». La giornalista Oriana Fallaci raccoglie le testimonianze anonime di vari
«ospiti» dell’Idroscalo: nella baracca c’erano almeno altri due ragazzi arrivati in
moto. Sono stati loro a pestare Pasolini e poi a passargli sopra con la sua auto, mentre
Pelosi gridava: «E mo’ me lasciate solo?». Trent’anni dopo smentirà se stesso, dando
ragione alla Fallaci.
Ma chi erano i misteriosi assassini? I fratelli Borsellino (morti nel frattempo, e
questo spiegherebbe il voltafaccia di Pelosi) e altri fascisti, smaniosi di «dargli una
lezione» poi degenerata in omicidio, sostengono gli amici della vittima. Secondo
loro, Pasolini si accingeva a rivelare la verità sulle stragi del ‘74, opera di
manovalanza di destra arrabbiata con quegli ambienti politici che dopo le bombe di
piazza Fontana avevano rinunciato al golpe. E stava ultimando Petrolio, «un romanzo
scritto come un saggio», diceva lui, in cui dietro il nome fittizio di Troya raccontava
di Eugenio Cefis, presidente dell’ENI e poi della Montedison comprata con soldi
pubblici, accusandolo di essere il mandante dell’assassinio di Mattei.
Nuove indagini ci daranno, si spera, la verità. Ma nulla potrà lenire il rimpianto per
una parabola umana incompiuta. Come egli stesso riconobbe più volte con amarezza,
Pasolini riversò all’esterno - nelle esperienze di vita e nelle invettive sociali - le
energie che non trovò la forza di indirizzare dentro di sé per sciogliere i propri
grovigli emotivi, riassunti da quella tomba di famiglia in cui riposa trionfalmente
accanto alla mamma, mentre il padre è relegato in un angolo.
6 maggio 1976 - 23 novembre 1980
Terrenord e Terresud
Certamente molti di noi conservano degli anni Settanta teneri ricordi privati, ma se
si sta alle cronache il decennio appare come uno dei più tormentati e funesti della
nostra storia. Quasi a simboleggiare il sentimento generale di catastrofe, la notte del 6
maggio 1976 la terra trema con violenza nel Friuli. Le primissime notizie parlano di
un solo morto, un carabiniere, ma poi via via, sempre più rapidamente, le proporzioni
del disastro crescono fino a comprendere gran parte della regione e la stessa Udine.
Dopo la prima scossa, molti hanno capito e si sono precipitati così com’erano, nelle
strade. Ma molti altri non hanno avuto uguale prontezza e la seconda scossa li ha
travolti.
Le macerie si accumulano, i campanili crollano, antichi affreschi diventano
polvere, i superstiti si aggirano smarriti e bisognosi di tutto. Si montano tendopoli,
arrivano alpini, autobotti, volontari, medici, roulotte, coperte. E naturalmente
fotoelettriche, ruspe, scavatrici, giganteschi caterpillar e molti badili, perché chi si è
salvato non perde un attimo, si butta a scavare tra i cumuli, l’orecchio teso ai lamenti
dei possibili sepolti vivi.
L’indomani mattina un carico di tegole va subito a ruba, tutti già pensano a
rimettere le cose a posto là dove si può. Molti dei friulani emigrati in Germania, in
Svizzera, a Torino e Milano tornano a casa per ricostruire ciò che il terremoto ha
cancellato, senza aspettare le sovvenzioni di Roma. Faranno da soli e in pochi anni
riusciranno ad avere la meglio sulla scala Mercalli o Richter che sia.
Più di mille i morti, cinquecento i dispersi. E un bilancio non dissimile deve essere
stilato per il terremoto dell’Irpinia, quattro anni dopo. Anche qui decine di villaggi
distrutti, episodi di straordinario eroismo, di abnegazione paterna e filiale, di
sacrificio di sé, di straziante pietà e dolore. Anche qui i soccorsi sono abbastanza
tempestivi, anche qui l’esercito interviene. Ma c’è un altro esercito, senza divisa, che
s’intrufola immediatamente nell’operazione. Perché far sgombrare le macerie ai
militari che non costano niente? Meglio che lo sgombero diventi un appalto
(venticinquemila lire a tonnellata) e che venga affidato ad aziende ed aziendine di
amici, parenti, referenti, non proprio impeccabili.
Il terremoto diventa un affare colossale dove ogni comune, anche se non è stato
toccato, ricava la sua fettina dallo Stato che stanzia una favolosa quantità di miliardi.
Ben poco può fare l’onestissimo Giuseppe Zamberletti, coordinatore degli
investimenti, per fermare la speculazione. L’esempio del Friuli qui non fa testo. I
baraccati resteranno nelle baracche all’infinito in condizioni di disagio permanente.
Ci saranno inchieste, come sempre lunghissime ed inconcludenti, e solo una minima
parte dell’Irpinia devastata verrà davvero ricostruita.
10 luglio 1976
La fabbrica dei profumi
Turatevi il naso, ha appena scritto Montanelli sul suo «Giornale», invitando gli
anticomunisti a votare DC nonostante la DC. Ma in Brianza quell’appello metaforico si
rivela una concretissima profezia.
È l’ora di pranzo e il piccolo Massimiliano Fratter sta ancora giocando a pallone
con il cugino quando le sue orecchie vengono offese da un fischio lancinante.
Proviene dal capannone dell’ICMESA, che produce componenti per cosmetici: gli
abitanti di Seveso la chiamano «la fabbrica dei profumi». Eppure non è un profumo
quello che Massimiliano sente nell’aria. Piuttosto un fetore di uova marce mescolate
a disinfettante. Anche l’aria è cambiata, sembra lattiginosa, e procura un bruciore
terribile agli occhi.
L’esplosione di una valvola del reattore ha provocato la fuoriuscita di una nuvola
di diossina. L’indomani, domenica, due tecnici dell’ICMESA si recano dal sindaco
Rocca per rassicurarlo: tutto sotto controllo. Ma il mercoledì cominciano a morire le
galline, il giovedì le foglie ingialliscono, il venerdì le piante si seccano e il sabato, a
una settimana dallo scoppio, sulla faccia di Massimiliano e di altri bambini spuntano
delle macchie rosse che evolvono in bubboni giallastri. Le pustole irrompono nei
telegiornali, insieme con le tute bianche dei bonificatori, e l’Italia angosciata dagli
anni di piombo scopre una nuova emergenza: l’ambiente.
Finora non interessava quasi a nessuno. Nella stessa Seveso, chi ha mai dato peso
ai liquami del torrente omonimo? In assenza di norme e controlli, le aziende
scaricano le loro schifezze dove vogliono e la sicurezza degli impianti obbedisce
soltanto alla legge del profitto. Alla «fabbrica dei profumi» si sapeva che l’aumento
di temperatura del reattore avrebbe creato la diossina. Ma si sapeva anche che quel
surriscaldamento avrebbe quintuplicato la produzione.
Il direttore e il vicedirettore vanno in carcere e la multinazionale svizzera
proprietaria dell’ICMESA paga duecento miliardi di danni. Gli abitanti di Seveso si
trasformano in cavie. Negli anni si scoprirà che i bambini nati dopo l’esplosione
hanno sei volte più probabilità degli altri di disfunzioni alla tiroide. E che sono quasi
tutte bambine, perché la diossina àltera lo sviluppo dell’apparato riproduttivo
maschile.
Al momento dei fatti queste cose si ignorano. Ma molte donne temono
malformazioni al feto. Poiché l’aborto è ancora tabù, tocca al premier Andreotti
autorizzare l’interruzione delle gravidanze. La Chiesa non ci sta e il cardinale di
Milano lancia un appello alle mamme brianzole: «Non uccidete i vostri figli, le
famiglie cattoliche sono pronte a prendersi cura di eventuali bambini handicappati».
La polemica esplode in tutto il Paese, innescando il dibattito che nel giro di due anni
porterà alla legge 194.
A Seveso, intanto, i decenni passano. Massimiliano è diventato adulto, le cause con
la multinazionale non finiscono mai e dagli ultimi carotaggi risulta che il terreno è
ancora imbevuto di diossina, tranne che nell’unica area bonificata sul serio: quella
dove sorgeva la «fabbrica dei profumi» e ora invece svettano centinaia di querce. Lì
si sente soltanto l’odore del bosco.
15 giugno 1978
Il Leone e l’Antilope
In una sera di lampi, tuoni e pioggia scrosciante, esce dal portone del Quirinale una
macchina che ha a bordo il presidente della Repubblica Giovanni Leone. Ma è la sua
ultima uscita, perché poco prima sugli schermi televisivi a colori (appena arrivati in
Italia) il presidente ha annunciato le sue dimissioni, pallido e molto teso. È stato
eletto nel 1971 al posto di Moro, cui dovrebbe toccare il prossimo settennato. Ma la
DC, ancora onnipotente, sceglie Leone, avvocato di grido a Napoli, eccellente giurista,
tre volte presidente della Camera, due volte capo di brevi governi «di tregua», che
tuttavia è un isolato, non ha una corrente ed è considerato dai suoi colleghi non tanto
super partes, quanto al di fuori di esse.
Leone è un napoletano tipico, spiritoso, superstizioso, scandalizza l’Italia facendo
le corna scaramantiche in pubblico. Ha una moglie bellissima e diversi figli installati
a palazzo con lui. Sembra profilarsi una presidenza tranquilla con un capo che non ci
tiene a intervenire, lontano da ogni protagonismo. Ma subito arriva il terrorismo e ben
presto scoppia lo scandalo Lockheed, società di costruzioni aeree americana, che
rivela di aver pagato cospicue tangenti per far acquistare all’Italia aerei militari da
trasporto, corrompendo un misterioso Antelope Cobbler, che nel gergo dei giornali
diventa subito «l’Antilope».
Ma chi sarà mai? Già da qualche tempo la famiglia Leone è oggetto di
pettegolezzi, insinuazioni, sospetti di traffici edilizi e di valuta. Non si è mai saputo
come o perché, si forma un’onda che va dall’estrema destra, ai radicali, ai comunisti e
agli stessi democristiani e quest’onda lambisce e infine allaga il Quirinale.
La più celebre giornalista del tempo, Camilla Cederna, scrive un libro al vetriolo
contro il presidente e la sua «banda», che va a ruba edizione dopo edizione. Leone
querela e vincerà in tutti e tre i gradi di giudizio: erano solo calunnie senza prove. Ma
sul momento, a caldo, nessuno lo difende. Quando poi Moro viene assassinato dalle
Brigate rosse, la DC si sfrangia, barcolla, annaspa in una crisi che è generale.
Non si sa bene ancora oggi di chi sia stata l’idea di trasformare Leone in un capro
espiatorio. Dei comunisti? Forse. Ma anche molti democristiani concordano, per non
parlare di tutti gli altri partiti e forse dei soliti «servizi», più o meno deviati. Leone sa
di non avere difensori e si rassegna alla cacciata, unica nella storia repubblicana
italiana, con l’animo esacerbato e la ferma volontà di recuperare l’onore. Ci riuscirà,
ma dovrà aspettare più di trent’anni, prima che il suo ultimo successore Giorgio
Napolitano gli riconosca di essere stato, se non un grande presidente, almeno un
onesto cittadino. E chi fosse l’Antilope non si è mai saputo.
11 luglio 1979
Controcorrente
Mogli e figli sono al mare, così un gruppo di vecchi amici milanesi si ritrova per
guardare alla tele l’incontro di boxe fra Zanon e Righetti, campionato europeo dei
pesi massimi.
il padrone di casa, l’avvocato Giorgio Ambrosoli, spegne l’ennesima sigaretta nel
portacenere e pensa che in fondo quei due connazionali che si picchiano in
eurovisione sono la metafora della sua vita. Da cinque anni combatte contro Michele
Sindona e non ha ancora capito da che parte stia l’arbitro. Anzi, l’ha capito
benissimo, e l’ha anche scritto alla moglie: «Pagherò a molto caro prezzo questo
incarico, ma non me ne lamento perché è stata un’occasione di fare qualcosa per il
mio Paese».
L’incarico è la liquidazione della banca di Sindona, un affarista svelto e senza
scrupoli arrivato a Milano dalla Sicilia, che all’inizio degli anni Settanta era l’uomo
più potente d’Italia, omaggiato a Wall Street e in Vaticano, e salutato da Andreotti
come «il salvatore della lira». Solo Cuccia da Mediobanca scuoteva la testa
indignato: «È un falsificatore di bilanci». E un riciclatore di denaro mafioso. Ma
questo lo avrebbe scoperto proprio Ambrosoli, dopo che «il salvatore della lira»
aveva fatto crac e la Banca d’Italia si era rivolta a lui per mettere il naso in quel
dedalo di scatole cinesi.
Sindona ha provato a sedurlo, poi è passato alle pressioni. Due italoamericani
introdotti da un certo Licio Gelli si sono recati da Andreotti per chiedergli di
soccorrere il povero Sindona «accusato dai comunisti», cioè da Ambrosoli, cattolico
liberale e monarchico che non ha mai votato a sinistra in vita sua. Il «comunista» ha
resistito, abbandonato da tutti tranne che dai vertici della Banca d’Italia, che hanno
dovuto subire la ritorsione della cosca: avvalorando una montatura, due magistrati
romani hanno incriminato il governatore Baffi e arrestato il suo vice Sarcinelli. Un
avvertimento, ma Ambrosoli ha presentato egualmente la sua relazione sulle
malefatte di Sindona. Per dirla con Andreotti, se l’è andata a cercare.
Sono cominciate le telefonate strafottenti di un «picciotto» che lo invitava a
soprassedere. Fino al messaggio definitivo: «Lei è degno di morire ammazzato come
un cornuto». Poi un silenzio gravido di minaccia e l’assassinio di Mino Pecorelli,
giornalista vicino ai servizi segreti, azzittito alla vigilia di rivelazioni su Andreotti,
Sindona e Calvi.
L’incontro di boxe fra i due italiani è finito in parità. Ambrosoli sta per perdere il
suo. Squilla il telefono, ma dall’altra parte del filo non parla nessuno. L’avvocato
accompagna a casa gli amici con la sua macchina e al ritorno trova davanti al portone
William Joseph Aricò, il killer che Sindona ha pagato centoquindicimila dollari per
farlo fuori. «Scusi, dottor Ambrosoli» e gli scarica addosso quattro proiettili.
Sette anni dopo, Sindona viene condannato come mandante del delitto e si suicida
in cella con un caffè corretto al cianuro, gridando: «Mi hanno assassinato!». Una
messa in scena per morire da vittima, secondo i giudici Turone e Colombo. Infatti il
cianuro ha un odore troppo rivoltante perché si possa berne più di una goccia senza
accorgersene. E Sindona ha svuotato la tazzina.
Centotrenta
Dopo tanto morire, torna la voglia di vivere. Persino troppa: Milano è da bere,
l’Italia da rubare. Fra un mistero e l’altro, la tv cade in un pozzo e il Muro addosso
al PCI.
1980-1983
Misteri...
...di Stato.
L’Italia di quegli anni è un posto di frontiera: fra Ovest ed Est, fra Europa e Medio
Oriente. Crocevia di terroristi internazionali, militari, spioni e mestatori. Tutti armati
fino ai denti e dediti a ricatti, avvertimenti, doppi giochi. Noi ci aggiungiamo del
nostro: estremisti con licenza di uccidere, faccendieri, monsignori ma non troppo.
L’estate delle stragi è il 1980 e ha il suo epicentro a Bologna. Da lì parte l’aereo
che si inabissa nel mare di Ustica la sera del 27 giugno. E da lì non partiranno i
vacanzieri che affollano la stazione dei treni quando, alle 10,25 del 2 agosto, una
valigia deflagra nella sala d’aspetto della seconda classe. La scena dei cadaveri
caricati su un autobus di linea rimarrà per sempre nella memoria collettiva. Ancora
una cifra: 166. È il numero complessivo dei morti nelle due carneficine.
Su Ustica i pinocchi di Stato si affrettano a parlare di cedimento strutturale, ma i
resti sbriciolati del DC-9 rivelano tracce di esplosivo. Le autorità alzano un «muro di
gomma»: depistaggi, ritrattazioni, morti sospette. Le indagini accumulano un milione
e mezzo di pagine (record mondiale, tuttora imbattuto) e svelano che quella sera nei
cieli italiani c’era un traffico da ora di punta. Caccia francesi, americani, libici. Questi
ultimi sono MIG di fabbricazione sovietica che devono volare periodicamente in
Jugoslavia per la manutenzione, attraversando il nostro spazio aereo. L’Italia lo
tollera, gli Stati Uniti assai meno. L’ordinanza del giudice Rosario Priore ritiene che
un missile destinato all’incursore libico abbia sfiorato il DC-9, provocandone la
distruzione. Ma Cossiga, all’epoca primo ministro, sosterrà ancora in punto di morte
che il missile era francese ed aveva come bersaglio l’aereo personale di Gheddafi.
Anche per la bomba della stazione comincia un valzer di fango che coinvolge tutto
ciò che di torbido si agita in Italia, dalla loggia P2 alla banda della Magliana. La
sentenza definitiva di condanna per i neofascisti Francesca Mambro e Giusva
Fioravanti (che si proclamano innocenti) fa pensare a un bis di piazza Fontana, ma il
solito Cossiga alimenta la tesi di una bomba in transito esplosa per errore.
In quegli anni vige un patto non scritto fra il governo italiano e i terroristi
palestinesi, che possono usarci come garage a patto di compiere poi i loro attentati
altrove. I palestinesi smentiscono, sostenendo si tratti di una strage ordita dalla CIA
proprio per punire l’ambiguità italiana in Medio Oriente. Il dissidio con gli USA
emergerà plasticamente cinque anni più tardi nella base militare di Sigonella, quando
Craxi si rifiuterà di consegnare agli americani il commando palestinese che ha
assassinato uno statunitense disabile di religione ebraica a bordo della motonave
Achille Lauro.
Ma i familiari delle vittime della stazione non credono alla pista internazionale e la
targa commemorativa che attesta la «matrice fascista» della strage diventa spunto per
divisioni politiche che si perpetuano a ogni ricorrenza.
...di loggia
Nessuna carta riuscirà mai a svelare il mistero più impenetrabile della loggia
massonica «coperta» Propaganda Due (P2): per quale motivo centinaia di politici,
generali, imprenditori e giornalisti di successo decidano di legare i loro destini a
quello di Licio Gelli. La ricerca spasmodica di un burattinaio alternativo - il Grande
Vecchio, di volta in volta identificato in Cefis o in Andreotti - nasce dal rifiuto di
credere che questa organizzazione segreta di mutuo soccorso, che condiziona
pesantemente le cronache politiche, economiche e giudiziarie del nostro Paese, sia
veramente guidata da un materassaio toscano.
La biografia di Gelli racconta di un uomo rotto a tutti i giochi, capace di
barcamenarsi fra nazisti e partigiani, ma pur sempre un pesce piccolo privo di cultura
e mezzi economici adeguati al ruolo. La magistratura si interessa a lui nel 1981, sulla
scia del crac di Sindona. Durante la perquisizione di un’aziendina di Gelli a
Castiglion Fibocchi, la Guardia di Finanza trova un elenco di quasi mille nomi, fra i
quali spicca quello del suo comandante.
Ma ce n’è per tutti i gusti, da Sindona a Calvi, da Noschese a Claudio Villa.
Ministri, militari, servizi segreti e persino due monarchi: Vittorio Emanuele IV e
Silvio I (Berlusconi). Un direttorio della nazione, con tanto di programma
anticomunista e autoritario, il Piano di rinascita democratica, che si propone di
«ripulire il Paese dai teppisti ordinari e pseudopolitici» e di ridimensionare il peso
della magistratura, dei sindacati e della RAI.
Poiché Gelli (e non solo lui) teorizza che nei regimi moderni «il vero potere risiede
nelle mani dei detentori dei media», la combriccola muove alla conquista del
«Corriere della Sera». Indotti a compiere l’incauto acquisto, gli eredi del fondatore
Angelo Rizzoli si indebitano con le banche dei piduisti, che diventano i veri padroni
del giornale. Sarà l’inizio di una serie di guai che trascineranno nella polvere la
Rizzoli e l’Ambrosiano. Ma non c’è trama oscura, omicidio o strage di quegli anni
che non porti alla ribalta la P2, marchio di garanzia per ogni nefandezza.
A distanza di tempo le responsabilità politiche sembrano prevalere su quelle penali
(che pure ci sono: Gelli è stato condannato a dodici anni per la bancarotta
dell’Ambrosiano). Ma nessuna carta, ripetiamo, potrà mai svelare il mistero del
potere di quell’omino. Perché esso è celato nella psiche della classe dirigente che a
lui si affidò, mossa da avidità e spirito gregario.
Gli italiani di successo sono individualisti a parole, ma cercano sempre di legarsi a
un carro, consapevoli che da noi contano più le relazioni che le azioni e che per
diventare ancora più ricchi e influenti non serve conoscere i problemi, ma le persone
giuste. Gelli è l’intermediario di cui i potenti si fidano perché apparentemente non fa
loro ombra.
Eppure, vent’anni dopo lo scoppio dello scandalo, il Venerabile si considererà
soprattutto un precursore: «La giustizia, la tv, l’ordine pubblico. Tutto si realizza
poco a poco, pezzo a pezzo. Forse dovrei chiedere i diritti d’autore...».
...di sagrestia
La vita non assomiglia alla mela di Biancaneve: bene e male sono spesso
intrecciati. Tranne che per qualche nostalgico dello stalinismo, è senz’altro un bene
che il sindacato cattolico dei portuali polacchi Solidarnosch scardini il regime
comunista dall’interno. Però per riuscirci potrebbe essersi servito anche del male,
cioè dei miliardi mafiosi ripassati in lavatrice.
Il tintore occulto è il banchiere della Chiesa, monsignor Paul Marcinkus, tasso di
spiritualità vicino allo zero, amante del golf e della bella vita, «escort» di via Veneto
comprese. Nel Padrino Parte III, Coppola non esita ad accusarlo della morte
improvvisa di papa Luciani. Con Roberto Calvi, presidente dell’Ambrosiano, il
monsignore imbastisce una rete di società fantasma nei paradisi fiscali di mezzo
mondo, dove convergono rivoli di denaro inconfessabile.
Forte della benedizione vaticana, Calvi dà libero sfogo alla sua avidità: allaccia
relazioni pericolose con Sindona e il giro della P2, di cui ovviamente è un affiliato. Il
crollo della loggia lo priva dei suoi garanti e viene arrestato, condannato per reati
valutari e rimesso in libertà provvisoria.
In attesa dell’appello, il suo problema più urgente è restituire una montagna di
dollari ai peggiori strozzini possibili: il mafioso Pippo Calò e i clan della malavita
romana, riuniti nel marchio Banda della Magliana. Chiede quindi allo IOR di
Marcinkus la restituzione del «prestito» fatto a Solidarność, ma invano. Allora fugge
all’estero tampinato dai creditori e la sua corsa finisce il 17 giugno 1982 sotto un
ponte di Londra, appeso a una corda con dei mattoni nelle tasche. Il suicidio di un
disperato o l’omicidio di un ricattato?
Le indagini portano alla sbarra Pippo Calò, il faccendiere Carboni e un bandito
della Magliana dal cognome adeguato alla trama: Diotallevi. Avrebbero ucciso Calvi
per punirlo dello sgarro (non ha restituito i soldi) e dare un segnale ai suoi amici
d’Oltretevere. I tre finiscono assolti per insufficienza di prove, ma la sentenza
conferma che si trattò d’assassinio.
Marcinkus reagisce con durezza: lo IOR, dichiara nel giugno del 1983, non risponde
dei debiti dell’Ambrosiano. Una settimana dopo Emanuela Orlandi, figlia
quindicenne di un dipendente del Vaticano, scompare all’uscita da una lezione di
musica. Sembra il classico avvertimento. E qui entra in scena Enrico De Pedis, detto
Renatino, il boss più intraprendente della Magliana.
C’è chi sostiene sia stato lui a far sparire la ragazza, mentre altri indizi lasciano
credere che possa essersi posto come mediatore fra le parti, favorendo un
compromesso economico soddisfacente (anche se nel frattempo Emanuela era
probabilmente già stata eliminata).
Quando Renatino rimane ucciso in un regolamento di conti interno alla banda, il
Vaticano dà il nulla osta perché il suo corpo sia sepolto nella cripta di
Sant’Apollinare, a pochi passi da dove fu rapita la ragazza. La motivazione: «È stato
un benefattore». Se qualcuno se ne stupisce, ecco la chiosa dell’immancabile
Andreotti: «Magari non era proprio un benefattore per tutti. Ma per Sant’Apollinare
sì».
14 ottobre 1980
Flusso e riflusso
Quando a settembre l’amministratore unico Cesare Romiti annuncia il
licenziamento di quindicimila operai della FIAT, la reazione del sindacato è durissima.
Blocco della produzione, picchetti ai cancelli: al numero 5 di Mirafiori si presenta
Enrico Berlinguer, che fa il verso a Gramsci e si schiera con gli operai in lotta. «Non
gli ho detto di occupare la fabbrica, ma che il PCI sarà al loro fianco se lo faranno»
spiega a Luciano Lama. «Pensi che abbiano colto la differenza?» replica il
sindacalista, preoccupato.
Il pendolo dell’umanità sta cambiando direzione. Stato sociale, voti e stipendi
uguali per tutti, disprezzo (a parole) per il consumismo: i totem degli anni Settanta
cadono come le foglie in questo autunno caldo all’incontrario, che ne crea subito di
nuovi. Il liberismo senza regole. Il disimpegno politico ed esistenziale, con la disco
music al posto dei cantautori e le giacche Armani di American Gigolò invece
dell’eskimo. La voglia di divertirsi e di arricchirsi dopo tanto lottare.
Le nuove idee si fermano, per ora, ai cancelli delle fabbriche in sfacelo. Mirafiori,
il simbolo, è ridotta ad un suk: barbieri, banchi di frutta e verdura, operaie ed operai
che si accoppiano dietro i cassoni. Lavorano in pochi, guardati malissimo. Se un
caporeparto prova ad eccepire qualcosa, si prende un bullone in testa. Se poi ha
l’ardire di lamentarsi, il sindacato lo ignora e i superiori allargano le braccia. Ma i
nuovi manager Romiti e Ghidella sono di un’altra pasta: grano duro. L’anno prima,
hanno reagito all’assassinio del dirigente Carlo Ghiglieno con il licenziamento di
sessantun operai in odore di terrorismo. Poi hanno imposto il cambiamento
dell’orario di lavoro agli addetti alla verniciatura. E ora, con il licenziamento dei
quindicimila «esuberi», si è arrivati allo scontro finale.
Il trentacinquesimo giorno di sciopero è quello della svolta. Davanti ai cancelli
girano da settimane bollettini ciclostilati dal titolo inequivocabile: «Giù la testa,
Capo». Contengono nomi, indirizzi e targhe automobilistiche dei quadri aziendali:
quasi una segnalazione ai terroristi in cerca di bersagli. La paura e la rabbia
prevalgono sulla proverbiale prudenza sabauda e per iniziativa di uno di loro, Luigi
Ansio, i «capetti» della FIAT decidono di uscire allo scoperto, autoconvocandosi al
Teatro Nuovo e da lì mettendosi poi in marcia verso il centro della città.
Partono in qualche migliaio, ma il corteo si ingrossa lungo il cammino: impiegati,
dirigenti, anche operai. Pochi cartelli, nessuno slogan e una sola richiesta: tornare a
lavorare. I negozianti chiudono le saracinesche e si uniscono alla fiumana di cappotti
scuri. È la maggioranza silenziosa, che in Italia non si era mai manifestata prima.
Passerà alla storia come la Marcia dei quarantamila: forse erano la metà, ma pesano il
doppio. Romiti gongola e i sindacati si arrendono, firmando un compromesso che
trasforma i licenziati in cassintegrati.
Non è la fine del mondo, ma è la fine di un mondo. Vedendo marciare i «colletti
bianchi» per le strade di Torino, un operaio sospira profetico: «Sembra il nostro
funerale».
13 maggio 1981
La filiera
Biancovestito e sorridente, ritto nella sua «papamobile» scoperta, Giovanni Paolo
II fa lentamente il giro di piazza San Pietro tra la folla (non numerosissima)
plaudente. Impartisce benedizioni, prende in braccio una bambina e pochi momenti
dopo si accascia sul sedile mentre sul petto gli si allarga una macchia di sangue. Il
giovane che gli ha sparato due rivoltellate si dà alla fuga nel colonnato del Bernini.
Il Papa polacco, trasportato alla massima velocità al Policlinico Gemelli, viene
sottoposto a un lungo intervento, cinque ore e mezza: una delle pallottole l’ha
centrato al ventre dopo avergli spezzato l’indice della mano sinistra. L’operazione
riesce ed il Santo Padre sarà in grado già l’indomani di ascoltare la Messa in
ospedale.
L’attentatore viene fermato. È un turco, Mehmet Alì Agca, appartenente a un
gruppo eversivo di destra del suo Paese denominato Lupi grigi. Abita in un albergo
vicino al Vaticano, ha con sé una cospicua somma di denaro e si trova già da qualche
tempo in Italia. Processato per direttissima, viene condannato all’ergastolo. Poiché
non presenta appello, la sentenza è subito esecutiva.
Qui comincia una lunga catena di misteri, ipotesi, sospetti, rivelazioni più o meno
attendibili. La tesi più verosimile è che l’ordine per l’attentato sia partito dal
Cremlino per eliminare un nemico del comunismo che finanzia il sindacato
Solidarnosch e minaccia di far traballare tutti gli Stati satelliti dell’URSS. Il KGB si
sarebbe appoggiato alla stasi, il servizio segreto della Germania Est, che avrebbe a
sua volta incaricato i servizi bulgari di trovare un esecutore mentalmente instabile,
non riconducibile ai capi sovietici.
È una filiera classica, già sperimentata varie volte contro altri nemici dell’URSS.
Qualche conferma verrà dall’archivio Mitrokhin, emerso dopo la caduta del Muro;
ma c’è chi privilegia la pista della mafia siciliana, la pista di un complotto interno al
Vaticano, la pista massonica. I processi a carico del giovane turco complicano ancora
di più le cose. L’attentatore, che il Papa è andato a trovare in carcere ed ha perdonato,
dà versioni differenti, nega, smentisce se stesso, recita o finge di recitare la parte del
mentecatto.
Di documenti e prove definitive non ne verranno mai fuori. Dal canto suo
Giovanni Paolo nota che l’attentato è avvenuto lo stesso giorno della prima
apparizione della Madonna a Fatima, il 13 maggio 1917; si fa quindi consegnare la
busta che contiene il cosiddetto «terzo segreto di Fatima» e si convince che è stata
proprio la Madonna a deviare il proiettile del giovane Lupo grigio. Quando la statua
della Vergine arriverà a Roma, la seguirà in preghiera attorno alla piazza del fallito
attentato. La pallottola colpevole verrà incastonata nella corona di Maria per la
devozione di tanti fedeli.
10 giugno 1981
Bambino pubblico
Quando la piccola bara bianca arriva alla basilica romana di San Lorenzo, stenta a
farsi largo tra una folla fittissima: applausi, pianti, urla, accuse, isterica curiosità.
«Fateci vedere il bambino! Non è lui, è un bambolotto!»
È la stessa folla, tumultuosa e cieca, descritta ineguagliabilmente da Manzoni
nell’assalto ai forni, ma qui per la prima volta viene ripresa dalla TV, che ha tenuto in
sospeso milioni d’italiani, seguendo ora per ora, giorno per giorno, la tragedia di
Alfredino Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di
Frascati. Pozzo naturalmente abusivo, non segnalato, dove il bambino, verso sera, è
scivolato mentre tornava di corsa a casa per la cena.
La famiglia non lo vede rientrare e comincia a cercarlo. Il proprietario del pozzo si
accorge che le due assi in croce sull’imbocco di 50 centimetri sono spezzate e copre
l’apertura con un coperchio metallico, senza capire che il bambino può essere proprio
là sotto. Dopo ore di ricerche, qualcuno sente dei fiochi lamenti e infine il piccolo
viene ritrovato, ma laggiù, a più di venti metri nel terreno argilloso. Chiama la
mamma, ha male (nella caduta si è rotto il femore) e ha problemi respiratori e
cardiaci congeniti. Vengono calate funi, sonde, microfoni, mentre il comandante dei
vigili del fuoco gira tutta la notte inutilmente per Roma, alla ricerca di una scavatrice.
Intorno al pozzo si raduna una folla enorme, sotto gli occhi implacabili delle
telecamere. Arriva il presidente Pertini con il suo séguito e insiste per incoraggiare
Alfredino personalmente. La confusione è totale. Nessuno pensa a transennare la
scena. Sfilano acrobati, nani, ginnasti, mitomani, ciascuno accompagnato dal suo
manager, e tutti pretendono di poter scendere lungo il pozzo e tirar su il bambino.
Si scava finalmente un pozzo parallelo che si ferma però a venti metri di
profondità. Si tenta di aprire una galleria di raccordo, ma intanto il piccolo è pian
piano scivolato a una profondità di sessanta metri. Uno speleologo scende a testa in
giù con una corda che Alfredino non ha più la forza di afferrare. Un pompiere gli
parla in continuazione, i familiari a turno lo tengono sveglio con i loro racconti, ma
infine, dopo sessanta ore, tutto tace. L’Italia intera ha seguito in diretta la terribile
agonia, il primo grande evento mediatico nazionale.
Nel pozzo viene versato molto ghiaccio secco per conservare la salma, e quando,
un mese dopo, viene scavato un passaggio adeguato, con mezzi adeguati, il bambino
è chiuso in un rigido blocco verdastro da cui spunta un esile braccino. L’autopsia dirà
che è morto soffocato dal fango, disidratato, denutrito e terrorizzato. La folla di San
Lorenzo non offre certo un bello spettacolo, ma qualche attenuante ce l’ha.
11 luglio 1982
Patrioti
«Io giocavo terzino e centravanti» confida uno, «una volta ho fatto un gol di tacco
impossibile». «Io ero portiere e ala destra» rievoca l’altro, «una volta ho parato un
rigore».
Sono due vecchi amici, ma hanno avuto infanzie in città diverse, in Liguria e in
Piemonte, e non gli è mai capitato di parlarne fino a oggi. Ma oggi è il gran giorno!
L’Italia si gioca la permanenza nel campionato mondiale di calcio contro l’Argentina
di Maradona.
Le prospettive sono pessime. Fin qui la nostra nazionale ha racimolato a fatica
soltanto pareggi e corre voce che abbia «comprato» quello con i Leoni africani del
Camerun, che tornano a casa imbattuti. Cala il silenzio stampa. Soltanto il capitano
Dino Zoff è autorizzato a parlare con i giornalisti. Ma ci sarà poco da dire dopo la
batosta con l’Argentina... I due ex campioni guarderanno insieme il disastro, a casa
del ligure che ha un televisore nuovo da molti pollici.
Il piemontese arriva puntuale ed i due, con crescente stupore, vedono Maradona
bloccato dai nostri, che vincono 2 a 1. Da quel momento gli amici non pèrdono più
una partita. Non solo dell’Italia, ma di tutte le altre squadre rimaste in gara, di giorno
e di sera, facendo complicati calcoli sulle varie evenienze. Poi arrivano la tripletta di
Paolo Rossi e l’incredibile vittoria contro il Brasile. La moglie del ligure, che è
argentina e del tutto indifferente al football, non crede ai suoi occhi. Porta grandi
bicchieri di tè freddo e contempla indulgente i due esagitati. Battiamo la Polonia
senza difficoltà e siamo in finale contro i tedeschi che hanno sconfitto a fatica i
francesi.
Il presidente Pertini siede in tribuna accanto al Re di Spagna. La partita si gioca a
Madrid, in uno stadio gremito ovviamente in ogni suo centimetro. Ma per l’Italia non
è più un incontro difficilissimo, la squadra si sente ormai sicura, tutti sono in forma,
tutti si passano la palla come a memoria. È un miracolo rarissimo in questo gioco
collettivo interpretato da undici feroci individualisti.
Lo juventino Marco Tardelli segna la seconda rete, capisce che la vittoria è nostra e
attraversa il campo a braccia alzate urlando. Al terzo gol anche Pertini salta in piedi a
braccia alzate sotto lo sguardo affettuoso di re Juan Carlos, che tra poco consegnerà
la coppa al capitano Zoff. E il Camerun? Nessuno ne parla più e il giornalista
guastafeste non farà una gran carriera.
Tutta l’Italia esce in strada a sventolare il tricolore ed anche i due amici, dalla
pineta maremmana in cui sono vicini di casa, sarebbero tentati da un carosello nel
paese di Castiglione della Pescaia. Ma sono avvezzi alla sobrietà, all’autocontrollo,
niente piazzate, e restano sulle loro poltrone a ricordare i tempi in cui uno, Calvino
Italo, segnava i gol di tacco e l’altro, Fruttero Carlo, parava i rigori.
3 settembre 1982
«Non siamo stati noi!»
Una calda sera d’estate un tassì si ferma davanti al palazzo della prefettura a
Palermo e ne scende un giornalista che viene lasciato passare senza difficoltà dai due
agenti che sorvegliano l’ingresso. Dentro non ci sono altri controlli, il giornalista non
vede nessuno, sale le scale, attraversa una serie di sale e salette e, quando arriva in un
vasto salone, ecco finalmente un uomo venirgli incontro. È Carlo Alberto Dalla
Chiesa, generale dei carabinieri, e il giornalista è il più prestigioso inviato della
«Repubblica», Giorgio Bocca. Ma non è stato lui a cercare l’intervista, è il generale
che vuole, attraverso i giornali, tentare un’ultima volta di scuotere i politici romani,
che pure l’hanno voluto alla prefettura della città.
Dalla Chiesa è famoso perché è riuscito in pochi anni a debellare il terrorismo
rosso. Con una squadra di fidatissimi e metodi investigativi pazienti ma sempre più
stringenti, ha ottenuto i primi arresti, le prime ammissioni, le prime confessioni, la
scoperta dei covi e dei documenti. Ma in Sicilia, dall’inizio dell’anno, ci sono state
più di cento vittime della mafia, una guerra di bande che ha toccato anche politici,
giornalisti ed estranei.
A Dalla Chiesa viene offerto l’incarico non certo di eliminare la mafia, ma di
«contenerla», come dirà egli stesso a Bocca. Ma quali poteri ha il prefetto antimafia?
In realtà nessuno. Non gli vengono dati gli strumenti tecnici e documentali per
procedere nelle investigazioni indipendentemente da tutti. Non può richiamare in
servizio il suo gruppo di fedelissimi. Non può trasferire dai suoi uffici diverse
persone sospette. Gli resta soltanto il coraggio personale, farsi vedere in giro, per
esempio al mercato ittico, noto covo mafioso, senza scorta, per dare l’immagine di
uno Stato che non teme le cosche, che non teme nessuno. E protesta con i suoi
referenti politici, ripete a tutti le sue richieste: perché affidargli quel compito senza
poi dargli i mezzi per portarlo a buon fine?
Tutti svicolano, temporeggiano, fanno vaghe promesse. La mafia ha ucciso il
democristiano Piersanti Mattarella, dice a Bocca, quando ha capito che era rimasto
solo. E lo stesso avverrà con me - lascia intendere - se non mi danno quel che mi
serve.
L’intervista non cambia minimamente le cose. E la mafia capisce e colpisce. Su
una vetturetta bianca, guidata da un carabiniere, il generale e la giovane moglie
Emanuela, che da poco l’ha raggiunto a Palermo, escono dal palazzo della prefettura
e si dirigono verso casa. Nessuno conosce i loro programmi per la serata, ma la mafia
arriva con due motociclette e fa una strage.
Ai funerali, nella chiesa di San Domenico, si presenta tutta Roma, dal presidente
Pertini al Consiglio dei ministri al completo. Quando escono, la folla li fischia, li
insulta, li copre di monetine e bottigliette. Una donna del popolo urla singhiozzando
alla figlia del generale: «Non siamo stati noi!».
17 giugno 1983
Giustizia in bancarella
Ventotto milioni di italiani guardano ogni venerdì sera «Portobello», un
programma d’intrattenimento ideato e condotto da un sorridente, elegante,
amabilissimo presentatore: Enzo Tortora.
Tutti più o meno sanno che Portobello è il nome del mercato delle pulci di Londra
e sulle bancarelle di Tortora si esibisce infatti ogni sorta di gente: matti, mitomani,
inventori strambi, vecchiette patetiche, innamorati riconciliati, artisti falliti. È una
giostra divertente, manovrata con disinvoltura e abilità da un uomo che lavora per la
tv da molti anni, con alterne fortune, senza mai perdere la sua ironica bonomia.
Con «Portobello» raggiunge il massimo degli ascolti, ma quegli stessi ventotto
milioni lo vedono uscire dal comando dei carabinieri di Roma, l’aria sbalordita più
che spaventata. Ha le manette ai polsi, è stato arrestato insieme a oltre mille
camorristi su richiesta della procura di Napoli. L’accusa è di spaccio di stupefacenti,
associazione a delinquere, stretta collusione con la NCO (Nuova camorra organizzata)
capeggiata dal famigerato Raffaele Cutolo.
I ventotto milioni si dividono: è inverosimile che quell’uomo così gentile, corretto,
perbene sia un criminale. Ma è altrettanto inconcepibile che la magistratura compia
un atto di queste proporzioni senza avere le prove. Contro Tortora sembrano esserci
serie testimonianze: vengono da due pentiti (uno soprannominato ‘o Animale)
entrambi condannati per vari omicidi, e via via questi pentiti aumentano fino a
ventuno. Tutti hanno saputo per certo, o visto coi propri occhi, il presentatore mentre
spacciava droga a Milano.
Tortora, che ha un’eccellente memoria, contesta le circostanze incriminanti, ma si
fa comunque sette mesi di cella, finché Pannella lo fa eleggere all’Europarlamento e a
presidente del partito. Non basta, al processo di primo grado i giudici napoletani lo
condannano a dieci anni di galera e Tortora, che è rientrato in Italia, rientra anche in
carcere.
In appello, pochi mesi dopo, il castello accusatorio crolla miseramente. Il pentito
che lo accusa risulta essere un paranoico, arrabbiato con la redazione di «Portobello»
che avrebbe smarrito dei centrini da lui spediti per una vendita all’asta. E il nome
ritrovato sull’agendina di un altro camorrista non è «Tortora» ma, a guardar meglio,
«Tortona».
Il presentatore è assolto per non aver commesso il fatto e la RAI gli concede il
ritorno, cui Tortora tiene moltissimo. Rifà il suo «Portobello» («Dove eravamo
rimasti?» esordisce), ma la magia dopo così tragiche traversie è svanita e lui stesso
non può più essere quello di prima. Morirà per un tumore dopo poco tempo e così
l’italica malagiustizia resterà esposta sulla bancarella di Tortora in tutto il suo nero
fulgore.
20 ottobre 1984
La rivolta dei puffi
Bettino Craxi, primo capo del governo socialista, rientra precipitosamente dal
vertice internazionale di Londra per presiedere un Consiglio dei ministri convocato
d’urgenza. Quali terribili sventure ci minacciano? Terremoti, virus, inondazioni?
Peggio. Sono scomparsi i puffi. E il perfido J.R. di «Dallas». Gli eroi delle televisioni
commerciali, che hanno fatto chiassosa irruzione nei tinelli degli italiani abituati da
trent’anni alla messa cantata e un po’ triste della RAI.
Il proprietario delle emittenti non è ancora un volto notissimo al grande pubblico,
ma di lui già si parla come di uno dei quattro condottieri del «nuovo Rinascimento
italiano»: Agnelli, De Benedetti, Gardini e appunto Silvio Berlusconi, figlio del
dipendente di una banca milanese molto chiacchierata, e chiacchierato a sua volta per
la rapidità e la spregiudicatezza della propria ascesa.
Si è legato a doppio filo alla stella di Craxi e quando tre pretori applicano la legge
che impedisce a Canale 5, Retequattro e Italia 1 di trasmettere in contemporanea
sull’intero territorio nazionale, l’amico premier si affretta ad emanare un decreto che
regolarizza il metodo ingegnoso con cui Berlusconi ha fin lì eluso il monopolio RAI.
Si tratta del cosiddetto «pizzone»: una videocassetta riprodotta in molti esemplari,
che viene messa in onda alla stessa ora su tutte le emittenti locali del gruppo, così da
garantire la contemporaneità agli inserzionisti pubblicitari. L’avvocato Bonomo,
padre di tutti i Ghedini che verranno, escogita l’inghippo: la legge non vieta la
diffusione nazionale dei programmi, ma solo i ponti radio che la consentono...
Berlusconi trova un alleato formidabile nel suo pubblico di ragazzini e casalinghe,
che inondano di proteste i centralini della RAI e gli uffici dei magistrati, i cui numeri
di telefono sono gentilmente offerti dal cartello che appare sul video oscurato. Invano
i pretori si sgolano a ripetere che la Fininvest può continuare a trasmettere tutto ciò
che vuole, purché a diffusione regionale. Il Cavaliere sa che gli italiani hanno un
debole per chi fa la vittima e non manda in onda più nulla, convincendoli che sono
stati i giudici a imporgli il blackout totale.
Craxi riaccende i puffi, ma i problemi sono appena all’inizio, perché la sinistra DC
di De Mita boccia il decreto e i pretori tornano a chiedere il rispetto della legge. È
Craxi stesso a zittirli con un duro comunicato. Poi prepara un nuovo decreto e
stavolta si ricorda di dare un contentino anche a De Mita (aumentando i poteri del
direttore generale della RAI suo compaesano) e al PCI (la Terza Rete).
L’ultimo guizzo è degno di Azzeccagarbugli: da «provvisorio», quindi soggetto a
decadenza, il decreto diventa «transitorio». «Una scappatoia che consente a
Berlusconi di fare provvisoriamente i propri comodi» scrive nel 1990 un implacabile
Vittorio Feltri sull’«Europeo», «in attesa che possa farseli definitivamente» Avverrà
proprio quell’anno con la legge Mammì, che assegna in via conclusiva la vittoria ai
puffi.
22 gennaio 1987
Milano da bere
Cosa ci dà il senso di un’epoca? Nell’Ottocento i romanzi, per larga parte del
Novecento i film, nel Duemila probabilmente i blog. Ma di sicuro durante gli anni
Ottanta il ruolo di testimone spetta alla pubblicità. Quella sera, dentro un pacchetto di
spot ad alta gradazione alcolica (in attesa dei telefonini, sono gli aperitivi e gli amari
a fare la parte del leone), irrompono per la prima volta le immagini patinate di piazza
del Duomo e le note raffinate dei Weather Report, mentre la voce fuori campo esalta
«questa Milano da vivere, da sognare, da godere... questa Milano da bere».
L’autore dello slogan è Marco Mignani, capofila di quei «creativi» pubblicitari che
sono parte integrante del bestiario umano che anima i giorni e le notti della Milano da
bere. Fra le vetrine esclusive di via Montenapoleone e le luci stroboscopiche di
discoteche come il Nephenta, si aggirano agenti di Borsa che fanno il verso agli
yuppie americani, stilisti venerati come artisti rinascimentali, aspiranti modelle e
modelle aspiranti cocaina.
Gli odori e i rumori della fabbrica sono un ricordo degli anni di piombo. Persino la
nebbia è cambiata. Per non parlare dello smog: ormai tutto deve essere glamour,
anche lui. Si lavora tantissimo, benché non sia sempre chiaro che cosa si faccia. È
l’epoca del «terziario avanzato», ma non avanza quasi niente: si prendono tutto loro.
Il sommelier di questa Milano ubriaca di vita è Bettino Craxi, erede del riformismo
socialista di Turati e Nenni improntato alla sobrietà. Roba da museo. È Roberto
D’Agostino a coniare la nuova formula esistenziale: «edonismo reaganiano». Belle
macchine, belle donne, molto alcol, molta droga per reggere il ritmo infernale. E
tantissimo denaro per oliare il meccanismo.
Non tutti gli edonisti sono craxiani, ma dovunque ci sia dell’edonismo, lì c’è un
craxiano. Il sindaco è il cognato di Bettino e l’imprenditore di punta il suo migliore
amico, Silvio Berlusconi. L’ufficio di Craxi in piazza del Duomo diventa meta
ininterrotta di un pellegrinaggio di fedeli, conoscenti e riconoscenti, che lasciano ex
voto sotto forma di bustarelle sempre più gonfie.
Oltre lo spot, a immortalare l’epoca è come sempre un delitto. Dopo una notte da
vivere, da sognare, da godere ma soprattutto da bere, una modella americana strafatta
entra in un appartamento della Milano dei ricchi e scarica un revolver addosso al
playboy che la importuna da tempo con parole e gesti volgari. Si chiama Terry
Broome e alla sua storia si ispireranno un romanzo e un film dal titolo emblematico:
Sotto il vestito niente.
Intanto l’inventore della Milano da bere sta già lavorando a un nuovo progetto. La
DC gli ha chiesto uno slogan per le imminenti elezioni e Mignani si inventa «Forza
Italia». Nella sua villa di Arcore comperata a prezzo di saldo, un imprenditore
laureato in Legge con una tesi sulla pubblicità ritaglia la reclame e la infila in una
cartellina. Chissà che non possa tornargli utile, un giorno.
12 novembre 1989
Che Cosa?
A Berlino è appena caduto il Muro. A Roma più modestamente De Mita,
«l’intellettuale della Magna Grecia» (copyright dell’Avvocato), il democristiano antiCraxi fatto fuori dalle correnti del suo stesso partito. Dopo l’implosione dei regimi
comunisti, il mondo dibatte sulla fine della storia, che solo in Italia non ha alcuna
intenzione di andare in pensione: al governo c’è Andreotti, alla segreteria DC Forlani.
Come diciassette anni prima, quando all’estero comandavano ancora Nixon, Breznev
e Pompidou.
Neanche il PCI vuol saperne di cambiare, nonostante lo abbiano già fatto persino i
movimenti fratelli del Patto di Varsavia. «Io non mi vergogno della mia storia, io il
nome non lo cambio per quello che hanno combinato quelli lì» urla il vecchio Pajetta,
interpretando l’umore degli iscritti e perpetuando l’eterno equivoco: i comunisti si
sentono diversi da tutti - socialisti dell’Ovest e comunisti dell’Est - eppure oltre la
metà degli italiani continua ad assimilarli ai filosovietici.
Nel 1984, complice lo choc emotivo per la morte di Berlinguer durante un comizio,
il PCI ha sfiorato il sorpasso elettorale sulla DC. Poi la stinta segreteria Natta e l’onda
lunga (ma lenta) del psi craxiano hanno eroso i consensi. Il nuovo segretario Achille
Occhetto si ritrova alle prese con la crisi di un partito dove l’unico che vorrebbe
davvero cambiare nome è il moderato Napolitano: boccia Partito democratico,
«troppo generico», e propone Partito del lavoro.
La base storce il naso ed è perciò ancora più sorprendente ciò che accade a
Bologna tre giorni dopo la caduta del Muro. Occhetto si presenta in una delle
roccaforti del partito - la sezione della Bolognina - e ispirandosi all’esempio dei
partigiani lì commemorati esorta i compagni ad «abbandonare le vecchie strade ed a
inventarne di nuove». I pochi giornalisti se ne vanno con la pulce nell’orecchio.
Cos’avrà voluto dire? Tornano indietro e glielo chiedono. Dobbiamo dedurne che
cambierete nome? Occhetto abbozza: «Scrivete che tutto è possibile».
Succede il finimondo. Il partito si spacca e il delfino Massimo D’Alema si
barcamena: sta col segretario, ma è anche il direttore dell’«Unità», i cui centralini
sono intasati dalle proteste dei militanti, che il giorno del Comitato centrale fanno
ressa davanti alla sede di via Botteghe Oscure per fischiare i favorevoli alla «svolta»
e prendere a calci la macchina di Lama.
Occhetto li osserva dalla finestra del quinto piano e assicura di condividerne il
tormento: «Prima viene la cosa, poi il nome» dichiara. E da quel momento, un
momento che forse non è mai finito, il PCI si trasforma in un’entità impalpabile: la
Cosa, appunto, che dopo un anno e le lacrime pubbliche del segretario prenderà una
prima forma botanica nel Partito democratico della sinistra (PDS).
La falce ed il martello sono confinati alle radici del nuovo simbolo, la quercia. Ma
la sostanza non cambia, perché non cambia l’allergia (ricambiata) per il socialista
Craxi, che impedisce la nascita di una sinistra maggioritaria in grado di mandare
all’opposizione la DC.
Centoquaranta
I magistrati sono gli eroi. E i cattivi? Oh, c’è l’imbarazzo della scelta: politici
corrotti, mafiosi feroci, killer di genitori e di coppiette. E per qualcuno gli stessi
magistrati...
20 maggio 1990
I picconatori
«Sono quasi le tredici, sotto un cielo minaccioso e gravido di pioggia, quando
davanti a ottomila militanti il patriota padano Umberto Bossi pronuncia le parole
scritte di suo pugno: “Giuro fedeltà alla causa della libertà dei nostri popoli...”».
Così i testi sacri della Lega immortalano il secondo giuramento di Pontida. Il
primo lo avrebbe pronunciato Alberto da Giussano nel 1167 per «legare» i Comuni
lombardi in lotta contro l’imperatore Barbarossa. Ma ora Umberto da Cassano
Magnago indica un nuovo nemico: la partitocrazia romana.
Il condottiero va per i cinquant’anni e fin quasi a quaranta è un simpatico
perdigiorno che gira in jeans e capelli lunghi con un’Alfa GT usata (profeticamente
verde), si spaccia per il figlio del signor Pasta (il padrone della fabbrica dove lavora
suo padre) e millanta una laurea in Medicina. Ogni mattina esce di casa con la
valigetta del dottore e dice alla moglie che va in ospedale. Invece si ferma al bar. Ma
all’università di Pavia qualche volta ci entra davvero ed è lì che nel 1979 si imbatte
nell’autonomista valdostano Bruno Salvadori, a caccia di proseliti lombardi.
L’Umberto comincia ad incollare manifesti sui muri. L’anno successivo Salvadori
muore in un incidente d’auto, lasciandogli un giornale e venti milioni di debiti. E qui
Bossi si rivela, forse anche a se stesso. Ripiana le perdite e porta a spasso per le valli
il verbo federalista, in compagnia di una nuova moglie e dell’amico Bobo Maroni. Il
messaggio è semplice ed efficace: trattenere sul territorio le tasse che il Nord versa a
Roma in cambio di servizi pubblici di pessima qualità. Questo, al netto del folclore
padano, è il nocciolo duro del leghismo, il segreto del suo successo.
I partiti tradizionali pensano che si tratti di un fenomeno passeggero, invece
saranno loro a essere spazzati via. Con la fine della Guerra fredda l’Italia non è più un
Paese strategico e le rendite di posizione della DC sono finite. È quel che cerca di
spiegare ai suoi «amici» il capo dello Stato, Francesco Cossiga, che dopo cinque anni
di presidenza silenziosa impugna il piccone e si mette a menare fendenti
all’impazzata. Giudici, comunisti, democristiani: ha una definizione malevola per
tutti. La più celebre: «Occhetto è uno zombie coi baffi». Insinuano che sia malato di
nervi, ma lui nega: «Non sono matto. Faccio il matto per dire la verità».
Un altro politico sardo si aggira armato di piccone fra i muri pericolanti della
partitocrazia: è Mario Segni, figlio di un predecessore di Cossiga. Sfidando l’ostilità
dei colleghi, raccoglie firme per una serie di referendum che mirano a ridurre il
potere ed il numero dei partiti. La Corte costituzionale li boccia tutti tranne uno, il
meno significativo, sulla preferenza unica. Molti elettori non sanno neppure cosa
voglia dire, ma dalla reazione irridente di Craxi (che consiglia di andare al mare)
intuiscono che il referendum di Segni sia indigesto alla Casta e corrono in massa a
votarlo. I picconatori hanno scheggiato le fondamenta del Palazzo. Per buttarlo giù
adesso ci vogliono i magistrati.
7 luglio 1990
Nessun dorma
Anche se la grande maggioranza di noi se ne serve senza farci caso, la voce umana,
femminile o maschile, è uno strumento potentissimo, versatilissimo e misterioso. Può
essere grido di folla inferocita, potente incitamento di condottiero a cavallo, sussurro
amoroso al chiaro di luna, spietata argomentazione in tribunale. Ma per un cantante di
professione è piuttosto una sorta di «inquilino», un alieno che vive per proprio conto
dentro di lui e ha bisogno di cure ininterrotte, di riguardi e protezioni senza fine. Noi
profani sediamo tranquilli in platea aspettando quella certa aria, quella certa nota,
mentre il cantante fino all’ultimo ha interrogato, vezzeggiato, esortato il suo occulto
alieno. Riuscirà? Non riuscirà?
La voce di Luciano Pavarotti viene scoperta anzitutto da suo padre, buon tenore
amatoriale, e messa a punto giorno per giorno da due professori che resteranno suoi
amici per tutta la vita. Pavarotti nasce a Modena, studia da maestro elementare e nei
due anni di insegnamento non smette di esercitarsi nel canto. La sua prima vera
apparizione in pubblico risale al 1961 nella parte del Rodolfo nella Bohème di
Puccini. Da quel momento i suoi successi, nei ruoli più diversi, non si contano più.
Oltretutto l’uomo è molto simpatico, cordiale, generoso, senza nulla del divo
impettito. È un fenomeno, ma alla portata di tutti. Ben presto la sua fama dilaga oltre
i confini e arrivano i primi trionfi in Inghilterra e in America. Quella melodiosissima
voce, che sembra in grado di scoprire e restituire a chi ascolta ogni emozione,
fulmina milioni di appassionati.
Big Luciano diventa di culto, come la Callas e come Caruso. Ma oggi c’è la tv e
Pavarotti, senza perdere quella sua naturale affabilità, o intima modestia, capisce
bene come sfruttarla. Per la finale dei Mondiali di calcio del 1990 a Roma, organizza
alle Terme di Caracalla un concerto sensazionale: i Tre Tenori, con Placido Domingo
e José Carreras. Il trio canta celebri arie d’opera, ma anche brani di musica popolare:
da ‘O sole mio a Cielito lindo a La vie en rose. Scandalo per i puristi, ma è pur
sempre un modo per avvicinare grandi folle alla grande lirica.
I Tre Tenori verranno chiamati a celebrare molti altri eventi e ogni anno Pavarotti
metterà in piedi, per beneficenza, il concerto Pavarotti & Friends, invitando a cantare
con lui, nella sua Modena, i più popolari esponenti della musica leggera, da Sting a
Zucchero, da Liza Minnelli a Laura Pausini. Inevitabilmente colpito dal gossip si
lascia con la prima moglie e sposa la segretaria che lo accompagna da tempo in giro
per il mondo. Ne nascerà una bambina e ne nasceranno tristissimi dissidi ereditari
quando Pavarotti morirà nel 2007. Ma poi tutto si appiana e del grande cantante ci
resta intatta quella voce così meravigliosamente naturale e così misteriosamente
aliena.
17 aprile 1991
Massacro a Nord-Est
Quattro ragazzi siedono a un tavolo del Bar John di Montecchia di Crosara, vicino
a Verona, e discutono gli ultimi dettagli per mettere in esecuzione un delitto previsto
per quella sera. Entra Michele, un loro amico, e quelli gli spiegano subito il progetto
e lo esortano a partecipare. Michele pensa sia uno scherzo e, quando i quattro escono
per andare a compiere la strage, li segue, viene ancora caldamente invitato a dare una
mano, si mette a ridere e se ne va. Gli altri entrano in casa di Pietro, Pietro Maso, un
ragazzo di vent’anni che ha davvero intenzione di uccidere i genitori.
Ha già tentato tre volte. Due mesi prima, la madre scende nella tavernetta del
villino in cui abitano e trova due bombole di gas, un apparato di luci psichedeliche,
una sveglia fissata sulle 9,30 e la canna fumaria del caminetto ostruita da abiti e
stracci. Il figlio le spiega che si tratta dei preparativi per una festa, però poi
confesserà che l’idea era di far saltare in aria la casa.
Seguono due tentativi affidati all’amico Carbognin con un batticarne, ma il
complice al momento buono non se la sente. Infine, per coprire un prestito bancario
dello stesso Carbognin, Maso stacca un assegno dal blocchetto di sua madre
(venticinque milioni) e lo firma imitandone la grafia. Ma sa benissimo che l’inganno
non potrà reggere a lungo e decide di agire al più presto.
Pietro Maso è un ragazzo normalissimo, ha fatto il chierichetto, ha studiato
malvolentieri, ha trovato e lasciato diversi lavoretti, va d’accordo con i genitori e con
le due sorelle sposate, non ha mai dato segni di squilibrio. Ma ad un certo punto
scopre la bella vita: discoteche, bevute, qualche puntata al casinò di Venezia. Tutte
cose che costano soldi e i soldi sono in quegli anni la grande molla del Nord-Est,
dove migliaia di piccole imprese, i cui padroni accumulano cospicui risparmi ed
esibiscono potenti auto sportive.
Maso (psichiatri, sociologi, moralisti ne faranno, non si sa quanto a ragione, un
caso emblematico) precipita in questo vortice «acquisitorio». I genitori non sono
ricchi, ma moderatamente benestanti. Quando rientrano da una funzione religiosa in
tarda serata, Pietro colpisce il padre con una spranga di ferro e i suoi tre complici lo
aiutano servendosi di pesanti padelle e di un cric. La madre viene soffocata con del
cotone in bocca e un sacchetto di plastica sulla testa.
Dopo 53 minuti di agonia, i coniugi Maso sono morti. Gli assassini si fanno vedere
in due discoteche e Pietro al rientro «scopre» il delitto e chiama i vicini. Ma l’alibi
non regge più di due giorni e allora l’assassino denuncia anche i complici. Prima del
processo insiste per avere la sua parte di eredità e viene condannato a trent’anni.
Freddissimi, quasi spavaldi, i massacratori finiscono in carcere e dopo una non
lunghissima detenzione cominceranno a godere dei privilegi che concede la legge.
Pietro Maso passa al regime di semilibertà, si dice pentito, ma una giornalista che lo
vede nella prigione di Opera nota che le sue preoccupazioni principali sono i profumi,
l’abbronzatura, la forma fisica. Come Erika e Omar, i fidanzatini che a Novi Ligure
di lì a qualche anno ne imiteranno le gesta, riceve lettere da migliaia di fan.
1992-1994
La rivoluzione
La presa della Bastiglia.
Come ogni rivoluzione che si rispetti, anche quella italiana si sviluppa in quattro
stadi: la presa della Bastiglia, il Terrore, il Termidoro (dove le passioni si
stemperano) e il Consolato, cioè l’avvento del Napoleone di turno, il cui cognome
comincia ancora una volta per B.
Ma riavvolgiamo il nastro dall’inizio, da un magistrato quarantenne della procura
di Milano, Antonio Di Pietro, che un pomeriggio di fine febbraio (del 1992) telefona
all’avvocato di un certo Mario Chiesa, presidente socialista della casa di riposo Pio
Albergo Trivulzio, arrestato pochi giorni prima mentre intascava una mazzetta. «Dica
al suo cliente che l’acqua minerale è finita». Si riferisce ai conti Fiuggi e Levissima
che ha appena scoperto in Svizzera con l’aiuto dell’ex moglie dell’indagato in lite col
marito per gli alimenti.
Chiesa è stato colto in flagrante grazie alla collaborazione di un imprenditore stufo
di farsi dissanguare. Prima di consegnarsi, ha gettato nel gabinetto un’ultima busta di
soldi. In carcere ha provato a resistere, confidando nel sostegno del suo partito. Ma
adesso che Di Pietro ha trovato i depositi delle tangenti, il funzionario socialista
crolla e si decide a parlare. Spiega il sistema, fa i nomi, coinvolge DC e PCI-PDS. E il
solito scandaletto all’italiana diventa Mani Pulite, il disvelamento della Tangentopoli
in cui si inabissa la Prima Repubblica.
Bettino Craxi sarà tra i primi a sentire la burrasca, ma ancora la sottovaluta e
definisce Chiesa «un mariuolo». Gli serve a poco: nonostante all’inizio rimanga nei
confini lombardi, l’inchiesta scatena l’opinione pubblica, esasperata da un sistema
bloccato da mezzo secolo.
Politicamente assediato (a Milano sono indagati sindaco ed ex sindaco, Pillitteri e
Tognoli, entrambi socialisti), il 3 luglio 1992 Craxi pronuncia alla Camera uno dei
suoi discorsi più famosi: «I partiti hanno ricorso e ricorrono all’uso di risorse
aggiuntive in forma irregolare o illegale. Non credo ci sia nessuno in quest’aula che
possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario: presto o tardi i fatti si
incaricherebbero di dichiararlo spergiuro». In effetti non si alza nessuno. Tutti zitti.
Anche lui, peraltro, riguardo ai tanti soldi defluiti nei suoi conti esteri, che forse non
sono serviti solo a finanziare il partito.
Il Terrore
La sera del 30 aprile 1993 Bettino Craxi esce dalla sua residenza romana, l’hôtel
Raphael, per andare negli studi di Canale 5, ospite in una trasmissione di Giuliano
Ferrara. All’ingresso lo attendono decine di manifestanti che ritmano «ladro-ladro».
Craxi insiste, vuole l’auto davanti al portone principale. Lì viene accolto da insulti e
da un fitto lancio di monetine. Protetto dalla polizia riesce ad allontanarsi, ma capisce
che la sua avventura politica è finita e poco dopo, in tv, parlerà di se stesso al passato.
Qualche metro più in là, in piazza Navona, si sta tenendo un comizio con il leader
del PDS Achille Occhetto e con Francesco Rutelli, ex radicale convertito all’ecologia,
che sarà il candidato sindaco di Roma per la coalizione di sinistra. Rutelli si è appena
dimesso da ministro del governo Ciampi e dal palco incita la gente alla protesta dura,
augurandosi che Craxi finisca col consumare il rancio «nelle patrie galere». Il giorno
prima la Camera ha negato l’autorizzazione a procedere per l’ormai ex segretario
socialista. I quotidiani scrivono che è il momento più nero della Repubblica
dall’assassinio di Aldo Moro. Roma è travolta dalle manifestazioni, davanti ai palazzi
del potere ed alla sede del PSI. Sono i tempi in cui i deputati della Lega sventolano il
cappio e quelli del Movimento sociale mostrano le manette.
È l’aspetto truce della rivoluzione. Craxi morirà latitante in Tunisia, sette anni
dopo, malato e solo, ma la contabilità più cupa è quella dei suicidi. Una quarantina.
Poi ci sono anche coloro che si ammalano e muoiono di tumore o di infarto in sei
mesi, come Vincenzo Balzamo, responsabile amministrativo del PSI. Il primo a
spararsi è Renato Amorese, segretario socialista di Lodi, una sera di giugno del 1992.
A settembre è la volta di Sergio Moroni (padre di Chiara, futura deputata del
centrodestra), che manda una lettera al presidente della Camera, Giorgio Napolitano,
lamentando che la ferocia e soprattutto il caso assegnino il patibolo o l’impunità.
Dopodiché si spara in bocca con un fucile.
Il 20 luglio muore in carcere l’ex presidente dell’ENI, Gabriele Cagliari: si soffoca
con un sacchetto di cellophane in testa. È reduce da quattro mesi e mezzo di galera
preventiva e dall’ennesimo rifiuto di scarcerazione. Prima di morire scrive alla
moglie: «La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi
magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi,
abbandonandoci alla gogna e al rancore».
È per evitare l’onta del carcere che tre giorni dopo si spara un colpo alla tempia
Raul Gardini, patron del gruppo Ferruzzi ed elargitore della maxi-tangente Enimont.
Ancora l’anno prima era sulle copertine delle riviste patinate, al timone della sua
barca, Il Moro di Venezia, che aveva sfiorato la vittoria all’America’s Cup.
Il Termidoro
È venerdì 17 (dicembre 1993). Craxi e Di Pietro sono finalmente uno di fronte
all’altro in un’aula di tribunale. Nei giorni precedenti, il pubblico ministero a cui gli
italiani perdonano tutto, anche il maltrattamento dei congiuntivi, ha strapazzato i
capi-bastone della partitocrazia: la fotografia della resa è il filo di bava alla bocca di
Forlani, che infila una serie imbarazzata e imbarazzante di «non ricordo». Adesso
l’eccitata tifoseria dipietresca aspetta l’abbattimento del Cinghialone. Invece fra i due
fila tutto liscio, con fair play e rispetto reciproco. Sarà che Craxi, a differenza degli
altri, non nega niente. Sa dei finanziamenti illegali alla politica «sin da quando
portavo i calzoni corti». Di Pietro gli lascia campo, è consapevole di avere già vinto.
Il procedimento è quello a carico di Sergio Cusani, «stralcio» del fascicolo
Enimont, il colosso nato dalla fusione di ENI e Montedison. Per realizzarla Gardini ha
dovuto ungere le ruote di tutti i partiti. Anche Cusani ha un ruolo e il suo processo,
trasmesso in diretta dalla RAI, diventa l’evento televisivo dell’anno. Le sfide
procedurali fra l’avvocato Spazzali e Di Pietro («che c’azzecca?») sono un «cult»,
anche se il vero spettacolo è la sfilata dei politici, testimoni o imputati di reato
connesso. I loro racconti, tecnicamente, servono per incastrare Cusani. In realtà è il
pentapartito al governo che confessa in TV di avere rubato a man bassa,
scientemente, con l’arroganza di chi si sente invulnerabile. E non solo il pentapartito:
c’è anche il nuovo, la Lega, il cui tesoriere Alessandro Patelli confessa di aver preso
duecento milioni di lire, ma si autodefinisce «un pirla» e cerca di addossarsi tutte le
colpe. Invano: il suo capo Umberto Bossi sarà condannato a otto mesi di reclusione.
Chi manca? Il PCI, ora PDS. Molti suoi dirigenti sono stati condannati per le
tangenti milanesi. Soprattutto ex comunisti «miglioristi», cioè fautori del dialogo col
PSI, che a Milano funziona benissimo, anche nella riscossione delle mazzette. Ma nel
caso Enimont, quello decisivo, il PCI-PDS la scampa. «Ho seguito la tangente fin sul
portone di Botteghe Oscure» assicura Di Pietro. Gardini entrò nella sede comunista
con la borsa dei soldi: lo racconta l’autista personale. A chi l’abbia consegnata, visto
che si è suicidato, non si saprà mai. Con la resa della partitocrazia e l’avvento di
Berlusconi, l’onda rivoluzionaria si esaurisce ed il 6 dicembre 1994, alla fine
dell’ultima requisitoria del processo Enimont, Di Pietro si toglie teatralmente la toga
e lascia la magistratura per entrare in politica. È tempo di bilanci. Come evitare in
futuro altre Tangentopoli?, chiedono al suo collega Piercamillo Davigo. «Semplice.
Basterebbe smettere di rubare». E già.
Il Consolato
Di solito gli imprenditori non hanno tempo per occuparsi di politica e delegano
l’incombenza al personale specializzato, limitandosi a sovvenzionarlo. Così ha fatto
anche Berlusconi per anni, ma la rivoluzione ha asfaltato il pentapartito a cui si
appoggiava e quindi, delle due l’una: arrendersi o sostituirlo. Ha troppi debiti per
potersi permettere che il governo nomini banchieri a lui ostili. E il suo business, la
TV, è troppo condizionato dalle leggi per consentirgli di non andare d’accordo con
chi le fa. Dopo qualche timido tentativo di armistizio col nemico (la sinistra), si
scrolla di dosso i dubbi di Fedele Confalonieri e Gianni Letta e decide di «scendere in
campo».
Il suo esordio non può che celebrarsi all’inaugurazione di un ipermercato: il 24
novembre 1993, a Casalecchio di Reno, nel cuore dell’Emilia rossa. Una giornalista
gli chiede: «Se votasse a Roma, chi sceglierebbe?». Per la carica di sindaco della
capitale sono al ballottaggio Rutelli e il post-fascista Fini. Berlusconi, di getto: «Io
voterei Fini». Si innesca il meccanismo che verrà replicato all’infinito negli anni a
venire: la stampa di sinistra grida allo scandalo (il «Cavaliere nero») e lui reagisce
facendo la vittima, un ruolo che in Italia paga sempre.
Litiga con il dissidente Indro Montanelli e lo sostituisce al «Giornale» con Vittorio
Feltri. Trasforma le concessionarie di pubblicità del fido Marcello Dell’Utri nei club
del nuovo movimento, Forza Italia. Infine, in un angolo ingombro di detriti del parco
della villa di Macherio, monta il set televisivo della «discesa in campo»,
presentandosi agli elettori con un videomessaggio in cui parla già da presidente in
carica. C’è il sogno («il nuovo miracolo italiano») e una narrazione avvincente: la
storia di un uomo di successo che viene «dalla trincea del lavoro» come i suoi fan.
Confezionato il prodotto, non resta che lanciarlo e nessuno più di lui ha le capacità
e i mezzi per promuovere una campagna pubblicitaria su larga scala: i manifesti
sovrastati dai cieli azzurri del benessere, le dichiarazioni di voto di Mike Bongiorno e
Raimondo Vianello, l’inno che ricorda i jingle di Canale 5 (l’autore della musica è lo
stesso, Augusto Martelli, mentre le parole - vagamente esoteriche - sono sue).
Durante il duello finale in TV, il pidiessino Occhetto si lamenta perché «Il Giornale»
lo ha accusato di andare in barca coi mafiosi. «Beato lei che può andare in barca con
chi le pare: io non ne ho il tempo, sa, il lavoro...» replica Berlusconi e naturalmente
stravince. Gli dà una mano anche la magistratura, che indaga a tappeto le sue aziende,
arresta il fratello Paolo e alla vigilia del voto perquisisce la sede di Forza Italia,
consentendogli di presentarsi agli italiani come un perseguitato.
La «gioiosa macchina da guerra» del PDS (definizione iettatrice di Occhetto) è colta
alla sprovvista: ironizza, sottovaluta, allude. Ma non riesce a far blocco con gli ex
democristiani e il 27 marzo 1994 va incontro alla sconfitta. Il partito Fininvest,
alleato di Bossi al Nord e di Fini al Sud, sfrutta la nuova legge elettorale e conquista
la maggioranza. La rivoluzione che ha abbattuto Craxi finisce col consegnare il
potere al suo migliore amico.
1992-1993
Cose Nostre
Guerra...
Buoni contro cattivi. Ecco come vorremmo sempre immaginare la guerra fra lo
Stato e la mafia. Ma talvolta i ruoli non sono così chiari. L’espressione livida del
presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, appare la sera del 13 marzo 1992 nei tg
già monopolizzati da Mani Pulite. L’uomo che abita al potere da oltre quarant’anni è
a Palermo per i funerali del proconsole Salvo Lima, ucciso per strada dai Corleonesi
come un cane. Ma Lima non è una vittima. È stato, a lungo, un complice. Il suo
omicidio è un avvertimento per Andreotti, il quale, più che disperato, sembra
spaventato.
I Corleonesi sono stati trascinati alla sbarra dai magistrati Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino: oltre alle indagini sui conti bancari, decisiva la testimonianza di un
pentito d’eccezione, Tommaso Buscetta, boss della cosca perdente. Al maxiprocesso,
il padrino Totò Riina si è preso l’ergastolo, sia pure in contumacia, e ora pretende
l’ammorbidimento della pena. Altrimenti, dopo Lima, salterà in aria qualcun altro.
Falcone è il primo della lista per tanti motivi, non ultimo la sua solitudine: è inviso
ai colleghi, anche di sinistra, che con l’eccezione di Giancarlo Caselli hanno
boicottato la sua nomina a capo della procura di Palermo, al cui interno un «corvo»
scrive lettere anonime per diffamarlo. Subisce un attentato e le critiche di un sindaco
fanatico, Leoluca Orlando, che lo taccia di connivenza col nemico perché ha
incriminato per calunnia un pentito che accusava Lima senza prove. «La cultura del
sospetto non è l’anticamera della verità, ma del khomeinismo» si sfoga Falcone.
Disgustato, accetta un’offerta del ministro della Giustizia, Claudio Martelli, e si
trasferisce a Roma, finché a maggio viene nominato superprocuratore antimafia.
Il giorno successivo (sabato 23 maggio 1992) torna a Palermo per il weekend e
percorre in auto la strada che collega l’aeroporto alla città. Cinque quintali di tritolo
azionati col telecomando da un luogotenente di Riina, Giovanni Brusca, squarciano
l’asfalto all’altezza dello svincolo di Capaci, proprio mentre Falcone sta rallentando
per prendere un oggetto dal cruscotto. Lui e la moglie pérdono la vita andando a
sbattere contro la muraglia di cemento sollevata dall’esplosione.
La notizia giunge a Montecitorio durante le votazioni per il presidente della
Repubblica. La DC, impallinato Forlani, si accinge a candidare Andreotti, ma
l’emozione per la strage rende inopportuna la scelta del capo di Salvo Lima. Così
viene eletto Scalfaro. Il Movimento sociale vota compatto per Borsellino, uomo di
destra, il quale rifiuta sdegnato la candidatura del governo a superprocuratore al posto
dell’amico appena ucciso.
Ai funerali echeggia l’urlo straziante di Rosaria Schifani, vedova ventiduenne di
uno degli agenti della scorta. Nelle stesse ore un’altra donna, un magistrato dai
capelli rossi, inveisce contro l’ipocrisia dei colleghi che piangono Falcone dopo
averlo dileggiato in vita. Si chiama Ilda Boccassini.
... e pace?
Sull’assassinio di Falcone non può che indagare Borsellino, con la consapevolezza
di essere la prossima vittima. Il 19 luglio 1992, una 126 imbottita di tritolo esplode al
suo passaggio sotto casa della madre, in via D’Amelio. Dalla borsa del magistrato
scompare l’agenda rossa degli appunti: il giornalista Marco Travaglio la definirà «la
scatola nera della Seconda Repubblica». Gli stessi mafiosi che non hanno problemi a
rivendicare la mattanza di Capaci definiscono quella di via D’Amelio «una strage di
Stato». Affiora l’ipotesi che Borsellino avesse scoperto l’esistenza di una trattativa
per giungere all’armistizio e sia stato tolto di mezzo come testimone scomodo.
Di questo genere di contatti si torna a parlare dopo l’arresto di Totò Riina,
avvenuto il 15 gennaio 1993. A sorprendere il capo dei capi a un semaforo è la
squadra speciale di un carabiniere fuori dagli schemi e perciò inviso ai burocrati, il
Capitano Ultimo (all’anagrafe Sergio De Caprio), che blocca il Padrino stringendogli
la propria sciarpa intorno al collo.
Ultimo respinge l’insinuazione che a propiziare la cattura sia stata la soffiata di un
altro boss, Bernardo Provenzano. E la sentenza che lo assolve dall’accusa di
favoreggiamento per non aver perquisito la villa di Riina (come se la possibilità di far
scomparire prove compromettenti fosse stato il prezzo da pagare per la consegna del
Padrino) gli riconosce il merito esclusivo dell’operazione. Ma anche lui, come
Falcone, cambierà aria disgustato, andando a occuparsi di reati ambientali.
Dalla sua cella d’isolamento, che tanto isolata non deve essere, Riina scrive
«papelli» allo Stato in cui chiede l’abolizione del carcere duro. Intanto la guerra
continua. Maurizio Costanzo esce indenne da un agguato deciso dal Padrino, che non
gradisce le campagne antimafia del «Costanzo show». Poi si passa ai musei e alle
chiese: l’accademia dei Georgofili a Firenze (5 morti), il Padiglione d’arte
contemporanea a Milano (5 morti), San Giovanni in Laterano e San Giorgio al
Velabro a Roma (forse per «punire» il Papa che ha appena lanciato un anatema
contro la mafia). In autunno fallisce l’attentato allo stadio Olimpico e se ne prepara
uno alla Torre di Pisa.
Il presidente del Consiglio Ciampi teme addirittura un colpo di Stato e invece il
colpo arriverà a colui che lo Stato incarna più di ogni altro: Andreotti, indagato a
Palermo dal nuovo procuratore Giancarlo Caselli per concorso esterno in
associazione mafiosa. Al processo i pentiti intrecciano storie improbabili, come il
bacio a Riina, ad altre più verosimili. La sentenza definitiva assolve l’imputato per i
fatti successivi alla primavera del 1980, ma lo considera responsabile fino a quella
data, anche se il reato è estinto per prescrizione. Nella speranza di vantaggi elettorali,
Andreotti avrebbe avuto rapporti con la cosca dei Bontade, poi soppiantata dai
Corleonesi.
Con l’avvento della cosiddetta Seconda Repubblica e di una nuova generazione di
boss, la guerra guerreggiata fra mafia e Stato si interrompe. Ma, nonostante la cattura
di molti latitanti, la Piovra continua ad avanzare, riciclando i suoi guadagni immensi
nell’economia del Nord Italia. Ai cattivi, adesso, conviene di più fare i buoni.
17 gennaio 1993
Un manto di stelle
«Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle» così cantavano i tenorini degli
anni Trenta. Ma le coppiette che si appartano a contemplare il manto di stelle dalle
colline attorno a Firenze, dal ‘68 in poi, farebbero meglio ad andare a mangiarsi un
gelato in pieno centro. C’è in giro, per la prima volta in Italia, un autentico serial
killer. Il suo metodo è semplice: si avvicina alla coppia chiusa in macchina, spara
diverse revolverate, poi massacra le vittime con un eccesso di coltellate.
Perché serial? Perché i crimini sono quasi tutti uguali e soprattutto l’omicida lascia
sul terreno i bossoli calibro 22 di una stessa pistola Beretta. Quando i diversi casi
vengono collegati, le autorità, con l’aiuto di giornali e TV, mettono in guardia i
giovani. Ma c’è sempre qualcuno che per sventatezza o ignoranza si offre a quello
che è ormai battezzato il Mostro di Firenze.
Il primo duplice delitto risale all’agosto del 1968 e gli fanno séguito altri sette
massacri, per un totale di sedici vittime. Ma a partire dal secondo si deve tener conto
di un nuovo, atroce sviluppo. La ragazza coinvolta viene mutilata con l’asportazione,
di mano chirurgica, del pube e più tardi del seno sinistro. Il profilo del mostro
cambia: non può trattarsi di un «guardone» passato al sadismo omicida, ma di una
versione fiorentina del londinese Jack lo Squartatore.
Si forma una speciale «forza anti mostro» che imbocca la cosiddetta «pista sarda»,
perché sardi sono tutti gli inquisiti. Ma l’inchiesta si aggroviglia sempre più, mentre il
mostro continua a colpire. Infine, dopo una lunga serie di equivoci, errori, certezze di
breve durata, il 17 gennaio 1993 si arriva al nome di un contadino di Mercatale,
Pietro Pacciani, un uomo grosso, rozzo e violento che ha già ucciso in passato e ha
compiuto abusi sessuali sulle figlie. Uno degli inquirenti dirà: «Anche se il mostro
non fosse lui, a tenerlo dentro non si fa comunque una lira di danno».
Lettere anonime, semiammissioni e ripetute perquisizioni portano Pacciani davanti
ai giudici. Gran parte del pubblico non crede alla sua colpevolezza. Le prove
cosiddette «materiali» sono scarse e soprattutto appare inverosimile che un contadino
di 72 anni, ignorante e truce, abbia potuto commettere delitti tanto efferati. Come
poteva asportare così abilmente quei seni, quei triangoli pubici? Li consegnava a
qualcuno e dunque ci sarebbe, dietro il mostro, una setta satanica: s’intravede un più
alto e raffinato livello culturale.
Il Pacciani è condannato a quattordici ergastoli, poi assolto in appello, poi di nuovo
arrestato e scarcerato con tutti i suoi «compagni di merende», secondo la definizione
data in tribunale da uno di loro, il postino Mario Vanni. Pacciani verrà trovato morto
in casa sua qualche tempo dopo. E tutto il sinistro guazzabuglio di mandanti,
complici, esecutori, guardoni e satanisti scompare per sempre sotto il manto di stelle.
22 dicembre 1994
Ribaltoni
L’utopia che lo Stato sia amministrabile come un’azienda evapora alla vigilia di
Natale, quando l’alleato Bossi, in combutta con l’opposizione, presenta una mozione
di sfiducia contro Berlusconi. Ad allarmare la Lega è stato l’esito delle elezioni
europee di giugno, in cui Forza Italia ha moltiplicato i voti a spese dei «lumbard».
Lungo la strada, Bossi trova alleati importanti: Massimo D’Alema, che definisce la
Lega «una costola della sinistra», e il pool milanese di Francesco Saverio Borrelli,
che a novembre invita il premier a comparire al processo per le tangenti Fininvest alla
guardia di finanza. L’atto giudiziario, anticipato dal «Corriere della Sera», viene
recapitato a Berlusconi mentre presiede a Napoli un convegno ONU sulla criminalità
organizzata.
Il Cavaliere la prende malissimo. Alle piazze di sinistra mobilitate contro la
Finanziaria risponde sprezzante: «Ho altro a cui pensare». A Bossi che tresca con
D’Alema dà pubblicamente del Giuda (il leghista restituisce la cortesia, chiamandolo
«mafioso»). E al presidente Scalfaro, che a suo dire lo ha convinto a sgombrare
Palazzo Chigi con promesse poi non mantenute, assegna la patente multipla di
«serpente, traditore e golpista». Quanto ai giudici di Milano, li accusa di voler
togliere di mezzo l’ultimo baluardo dell’anticomunismo: lui. Fa ancora finta di
stimare Di Pietro, assai popolare nei sondaggi, al quale ha ripetutamente offerto un
ministero: «È uomo di centro come me». Ma l’altro si è sempre negato, ricambiando
con un’altra bugia, «Non ho il pallino della politica», salvo assicurare a Borrelli: «Io
quello lo sfascio».
Con la caduta di Berlusconi si consuma il primo dei tanti ribaltoni che
caratterizzano la Seconda Repubblica, in realtà mai nata, perché mai si è proceduto
alla riforma della Costituzione che ne rappresenterebbe il fondamento. La Bicamerale
presieduta da D’Alema raggiunge un accordo sull’elezione diretta del capo dello
Stato, ma si squaglia al momento di definirne i poteri.
Nascono a grappoli i partitini personali, eppure il bipolarismo degli interessi è
sempre lo stesso dal dopoguerra: Cefis contro Mattei, Fanfani contro Moro, Craxi
contro De Mita e ora Silvio Berlusconi contro Romano Prodi. Il manager pubblico
crea l’Ulivo, mettendo insieme (lui dice «assiemeeehh») ex comunisti ed ex DC di
sinistra. Vince le elezioni del 1996 e spinge l’economia dentro i parametri di
Maastricht che garantiscono l’ammissione al club dell’euro. Ma anche Prodi ha il suo
Bossi in seno: Fausto Bertinotti, che lo impallina da sinistra ogni volta che può e
nell’ottobre 1998 gli toglie la fiducia.
Il governo cade per un solo voto e Prodi vi intravede la manina di D’Alema,
smanioso di prendere il suo posto. In effetti così accade e dopo oltre mezzo secolo di
anticamera il primo ex comunista entra a Palazzo Chigi con la benedizione del filoamericano Cossiga. Ma lungi dal fare la rivoluzione, fa la guerra in Kosovo e aiuta un
gruppo di imprenditori ad acquistare la Telecom, meritandosi l’appellativo di «unica
merchant bank che non parla inglese». Cadrà anche lui, ribaltandosi da solo dopo la
sconfitta alle Regionali del 2000.
26 gennaio 1998
Il Grande Piccolo
La guerra è finita da poco e Milano, come molte altre città, è ancora disseminata di
rovine per i bombardamenti. Si usano carbone e legna per riscaldarsi e i muri delle
case sono fuligginosi, neri, cupi. Ma questa tetraggine è compensata da una grande,
generale vitalità e intraprendenza. Due giovani che si sono incontrati a una fermata
del tram diventano in breve amicissimi. Sono Giorgio Strehler e Paolo Grassi, li
unisce una passione totale per il teatro.
Strehler è triestino, si è poi trasferito a Milano dove frequenta il liceo Parini e si
iscrive all’Accademia dei Filodrammatici. Negli anni di guerra si rifugia in Svizzera e
riesce con minime risorse a mettere in scena testi di T.S. Eliot e Camus. Rientrato a
Milano riprende contatto con Grassi, formidabile organizzatore, e allestisce diversi
spettacoli con attori di fama, talvolta recitando lui stesso in piccole parti. È anche
critico teatrale per un giornale milanese e la sua insofferenza per lo stato della scena
italiana del tempo (mattatore al centro, circondato da una compagnia di guitti) cresce
continuamente.
Grassi e Strehler sono entrambi socialisti, non comunisti, amici personali dei
massimi esponenti del partito. Con tali appoggi e con l’aiuto di imprenditori privati, i
due fondano nel 1947 quella che diventerà una vera e propria istituzione dello
spettacolo italiano ed europeo: il Piccolo Teatro della città di Milano, ristrutturando
un vecchio cinema in via Rovello, non lontano dal Castello Sforzesco.
L’attività del Piccolo parte con L’albergo dei poveri di Gorkij, cui seguiranno
negli anni oltre duecento spettacoli, in un crescendo di successi che lasciano il segno.
Molto Shakespeare, molto Cechov, molto Goldoni, soprattutto con Arlecchino
servitore di due padroni che farà il giro del mondo, il filone nazional-popolare di
Bertolazzi, e poi la scoperta di Brecht e le celebri regie legate al nome del
drammaturgo tedesco.
Il Piccolo viaggia molto, si esibisce in tutti i Paesi d’Europa, s’impone come
modello di magiche, spettacolari e tuttavia concretissime finzioni. Il teatro di via
Rovello non tarda ad apparire troppo esiguo per tanta attività. Inizia la solita lunga,
travagliata guerra burocratica per la costruzione di una nuova sede adeguata. Per
protesta Strehler si dimette più volte, diventa parlamentare europeo e poi senatore
della Repubblica, mentre Grassi passa alla direzione della Scala e, anni dopo, della
RAI. Quando Paolo muore, il grande amico gli rivolge una lettera in cui rievoca quella
che per loro è stata una «missione» che tra infinite difficoltà, contrasti, battaglie
politiche ed economiche possono dire con orgoglio di aver portato a termine.
Dopo di loro il teatro italiano non sarà mai più lo stesso. Quando infine la nuova
sala è pronta, si decide di inaugurarla il 26 gennaio 1998 con una delle più belle regie
operistiche di Strehler, Così fan tutte dell’amatissimo Mozart. Ma il Maestro non sarà
presente: è morto il mese prima a Lugano, nella notte di Natale.
9 settembre 1998
Tu chiamale se vuoi, poesie
Lucio Battisti smette di vivere alle otto del mattino e per tutto il giorno non c’è
stazione radio che non trasmetta le sue canzoni, solo le sue canzoni, fino a notte,
quando i canali TV improvvisano concerti in memoria del cantante di Poggio
Bustone, provincia di Rieti. Battisti aveva 55 anni, era malato da tempo. Si è fatto
ricoverare una decina di giorni prima all’ospedale San Paolo di Milano, si è
sottoposto a cure sperimentali e, quando si è accorto che il fisico non rispondeva, ha
rifiutato l’accanimento terapeutico. Si dice abbia pronte le musiche di un altro disco,
che non ha inciso perché Pasquale Panella, l’ultimo paroliere, ha giudicato esaurito il
sodalizio e perché il clamoroso ritorno di Mogol non è ancora stato perfezionato.
Mogol è uno dei primi, a metà degli anni Sessanta, a scoprire che quel ragazzo di
campagna, goffo e grezzo, ha un grande talento. Aiuta Battisti ad affinarsi, i due
cominciano a sfornare i primi pezzi, il successo è subito travolgente. Un’avventura,
Non è Francesca, Emozioni, Per una lira: sono soltanto alcuni dei brani che la coppia
lancia a getto continuo, scalando immancabilmente le classifiche. È una rivoluzione
pop, sia nel linguaggio romantico ma non aulico di Mogol, sia nell’uso di una voce al
limite dello stonato (invece è la sua forza drammatica).
Siamo alla fine degli anni Sessanta. Anche nella musica l’impegno rivoluzionario è
considerato imprescindibile e Battisti, che lo rifiuta, passa per fascista. Ma, nel corso
degli anni, tutti - lottacontinuisti, maoisti, leninisti, e persino i brigatisti nei giorni
della carcerazione di Moro - confesseranno di aver cantato Lucio in segreto.
È la nuova poesia. In musica, come d’altronde quella dei lirici greci. Si sospirava,
una volta, leggendo Baudelaire o Dino Campana. Ora lo si fa su un prodotto magari
non così alto, ma non meno affilato. I suoi sono i versi sentimentali di un’Italia che
sogna distese azzurre e verdi terre, e il grande amore, ben più di un soviet nostrano.
È il miracolo del genio che esplode spontaneo: Mogol e Battisti tardano a una cena
perché il secondo fa sentire al primo la musica composta nel pomeriggio, e il
paroliere accosta la macchina e canticchia: «Io lavoro e penso a te...». In un’ora il
capolavoro è pronto. Poi, però, i due litigano per banali questioni di diritti. Forse è un
bene, perché i pezzi di fine anni Settanta sono belli, ma sempre più di rado
miracolosi. La collaborazione di Battisti con Panella passa quasi inosservata, scansata
con fastidio, ma per i fan più fedeli è un ritorno a una straordinaria freschezza
compositiva.
Ma ciò che nessuno sa, quel 9 settembre, è che mancano solo quattro mesi e due
giorni alla morte dell’altro poeta con la chitarra: Fabrizio De André, genovese come
Eugenio Montale, si congeda a 58 anni per entrare a pieno titolo nelle antologie della
letteratura italiana.
5 giugno 1999
Globulo rosa
Nel tardo pomeriggio del 4 giugno 1999, sulla salita che conduce all’arrivo di
Madonna di Campiglio, il ciclista francese Laurent Jalabert sta cercando l’impresa in
solitaria. Suda, si alza sui pedali, ingobbisce. Finché non gli piomba alle spalle un
ragazzo in maglia rosa. Jalabert si gira appena, sbigottito, ma quell’altro è già avanti
di dieci metri e pochi minuti più tardi taglia il traguardo a braccia alzate. Lo sconfitto
dirà ai giornalisti: «Pensavo fosse una moto. Invece era Pantani».
Quella del giorno dopo, da Madonna di Campiglio all’Aprica, è la ventunesima
tappa del Giro d’Italia. Il romagnolo Marco Pantani - che l’anno prima ha vinto il
Giro e il Tour, accoppiata che in Italia possono vantare solamente Fausto Coppi e
Felice Gimondi - ha la corsa in pugno. I giudici, però, lo fermano. Da un’analisi
risulta che il suo ematocrito è oltre la soglia legale, per il ciclismo, del 50%. Significa
che Pantani ha troppi globuli rossi. Non che è dopato. Potrebbe anche esserlo, ma
quel che conta è che corre rischi per la salute e non può affrontare la gara. Il Giro sarà
vinto dal bergamasco Savoldelli, che al medesimo controllo ha denunciato un
ematocrito del 49 virgola. Al limite. Per rispetto di Pantani, Savoldelli non indossa la
maglia rosa.
Alcuni direttori sportivi racconteranno poi ciò che è successo a Madonna di
Campiglio, quella sera. Dei collaboratori di Pantani che gli consigliavano di bere altra
acqua, e di pernottare più a valle, di modo che il sangue diluisse. E di Pantani
sorridente, sicuro: «Con tutto quel che succede nel ciclismo, cosa volete che mi
facciano?». Ma la mattina dopo, terreo, avrebbe detto: «Mi sono rialzato dopo tanti
infortuni e sono tornato a correre. Questa volta, però, abbiamo toccato il fondo.
Rialzarsi sarà molto difficile».
Si rialzerà. Tornerà a correre. E a vincere. Staccherà in salita l’immenso e non
meno chiacchierato Lance Armstrong. Ma non si rivedrà mai più il grande campione,
lo scalatore ubriacante e leggero che ha stroncato tutti i più forti. Si lascerà inghiottire
dalla depressione, fino a morire per overdose di cocaina in un residence di Rimini a
34 anni.
Pantani è una leggenda. Ma soprattutto l’emblema e il mistero dello sport
moderno. Fu un fuoriclasse? Fu un buon corridore capace di vincere grazie al doping
(anche se non venne mai trovato positivo a un controllo)? Fu il capro espiatorio di un
mondo marcio che cercava di guadagnare credibilità offrendo la vittima più illustre?
Sono domande senza risposta ancora oggi, dopo che tanti altri campioni hanno
visto le loro imprese macchiate da sospetti e squalifiche. Ma la storia di Pantani
racconta una verità in più: quella di un’epoca, ormai lunga, in cui molti ragazzi,
incapaci di risollevarsi e affrontare la vita, hanno trovato rifugio e trappola nella
droga.
Centocinquanta
L’immigrazione ci spaventa, l’euro ci fa sentire poveri e il Grande Fratello ci spia,
rivelando che i furbetti del quartierino credono ancora di vivere nel Paese dei
Balocchi.
18 settembre 2000
Gi Effe
«Tu dici che lo fanno?» «No, impossibile, sarebbe uno scandalo pazzesco».
«Eppure li hai visti, si sono già baciati senza il minimo...» «Vabbe’, ma passare dal
bacio alla...» «E invece guardali lì che si buttano dietro al divano!» Sullo schermo
televisivo il divano e una tenda coprono l’accoppiamento, non si vede niente, ma si
sentono gemiti e sospiri ansimanti inequivocabili.
È l’alba del quinto giorno del nuovo programma «Grande Fratello», che passa
sugli schermi di Canale 5 e finora non ha avuto particolare successo. Si tratta di un
format preso dalla tv olandese ed il suo titolo allude alla cupa utopia dello scrittore
inglese George Orwell, che nel romanzo 1984 ha descritto una società
minuziosamente dittatoriale in cui la tv del salotto serve al governo del Grande
Fratello per controllare ogni gesto dei cittadini. Ma nel format del 2000 il governo
siamo noi spettatori e lì, sotto l’occhio delle telecamere, dieci persone vivono per
novantanove giorni la loro vita, spiate ventiquattr’ore su ventiquattro in ogni angolo
di una villetta costruita appositamente negli studi di Cinecittà.
Chi sono queste cavie? Una bagnina, una studentessa, un cuoco, un pizzaiolo, un
ingegnere. Gente qualsiasi, scelta per l’esperimento proprio perché qualsiasi. Ci sono
stati, negli anni, molti concorsi a premi dove i concorrenti erano tenuti a rispondere a
vari tipi di indovinelli, a esibire competenza in diversi rami del sapere, a dimostrare
comunque un minimo di cultura; ma nel «Grande Fratello» non è richiesta nessuna
speciale attitudine o capacità. I dieci concorrenti parlano, si muovono, litigano,
mangiano, dormono, si baciano, si accoppiano senza nemmeno dover recitare. Gli si
chiede di dimenticare la presenza delle telecamere e di essere semplicemente se stessi
davanti a un pubblico di guardoni. Che infatti, dopo la clamorosa scena dietro al
divano, va in delirio per il programma.
Molte sono le critiche, molti i motivi di protesta, ma via via che passano le
settimane il Gi Effe diventa una specie di culto per milioni e milioni di italiani che,
certo non se ne rendono conto, ma stanno assistendo a una colossale rivoluzione.
Quei dieci protagonisti non sono nessuno, non hanno talenti, non hanno niente che li
distingua dal loro pubblico che, appunto per questo, li adora. È il trionfo dell’égalité
invocata dalla rivoluzione francese? D’ora in avanti ognuno potrà sentirsi a sua volta
«qualcuno» e forse proprio qui si gettano i semi di quella democrazia totale, diretta,
assoluta grazie alla quale chiunque avrà la possibilità di dire la sua su qualsiasi
argomento.
E i due pubblici peccatori? Lei, Pievani Cristina, dopo aver vinto il Gi Effe è
rientrata nelle pieghe del nulla. Lui, Taricone Pietro, ha avuto una breve ed intensa
vita di attore tra cinema e TV, stroncata da un incidente di paracadutismo, sport di cui
era appassionato cultore.
20 luglio 2001
Gli Uomini Neri
Nei giorni in cui a Milano si spegne Indro Montanelli, ecco una storia che avrebbe
meritato la sua penna. L’Italia ospita il G8, passerella annuale dei Potenti della Terra,
ma qualcuno ha deciso di rovinare lo spot. Sono i movimenti no-global, nati due anni
prima a Seattle contro il nuovo corso dell’economia, la globalizzazione, in cui
manager e banchieri assumono decisioni senza controllo politico che condizionano la
vita del mondo intero. Come sempre, fra i contestatori si infiltrano dei violenti. La
stampa li chiama «Black Bloc», dal verbo che descrive la loro «attività»: marciare
compatti e vestiti di nero, distruggendo i simboli del capitalismo (bancomat,
automobili, supermercati) che incontrano lungo il cammino.
La sede del G8 è Genova, che con le sue strade strette sembra particolarmente
adatta agli agguati degli Uomini Neri. Il secondo governo Berlusconi, insediato da
poco, subisce la scelta nefasta dell’amministrazione precedente, però non fa molto
per ridurne gli effetti. I Black Bloc devastano indisturbati la città, ma le forze
dell’ordine si accaniscono contro il corteo dei manifestanti pacifici. Finché in piazza
Alimonda ci scappa sciaguratamente il morto (che tanto pacifico non è).
Carlo Giuliani, il volto coperto da un passamontagna, viene freddato da un colpo di
pistola mentre corre con un estintore in mano verso una camionetta dei carabinieri,
rimasta intrappolata fra i bidoni della spazzatura che i rivoltosi utilizzano come
barricate. A sparargli è un giovane carabiniere terrorizzato: la Land Rover su cui si
trova è bersagliata da una fitta sassaiola e una quindicina di manifestanti la
circondano con pietre e bastoni, gridando agli occupanti: «Bastardi, vi
ammazziamo!». Dopo il delitto, la camionetta sgomma via, passando due volte sopra
Giuliani. Qualcuno cercherà di incolpare i suoi compagni, lasciando una pietra
insanguinata accanto al cadavere.
La notte successiva si sparge la voce che un gruppo di Black Bloc si è rifugiato
nella scuola Diaz, il dormitorio dei No-Global. Polizia e carabinieri vi si recano in
massa per una perquisizione che diventa il pretesto per sfogare su persone incolpevoli
la frustrazione accumulata nei giorni precedenti. Pestaggi e sangue dappertutto: un
giornalista inglese ci rimette otto costole e sedici denti. Decine di ragazzi vengono
portati illegalmente in caserma e sottoposti a torture fisiche e psicologiche. Li si
accusa di detenzione di due bombe molotov, che invece risulteranno essere state
portate nella scuola dai poliziotti. Dei Black Bloc, naturalmente, neanche l’ombra.
La destra difende contro ogni evidenza le forze dell’ordine e la sinistra trasforma il
ragazzo con l’estintore in un martire. Nei processi solo una decina di manifestanti
paga per le devastazioni. Quanto agli orrori della Diaz, la sentenza di primo grado
esclude la premeditazione, ma certifica che i picchiatori in divisa agirono con la
copertura dei loro superiori: in appello verranno anch’essi condannati.
11 settembre 2001
Invasione?
Nel suo tranquillo appartamento al centro di New York, una donna avverte una
inspiegabile sensazione di minaccia, quasi un impulso a buttarsi a terra per evitare un
pericolo, come in guerra; pochi minuti dopo accende il televisore che trasmette, senza
sonoro, l’attacco alle Torri Gemelle. La sbalordita spettatrice non è una donna
qualunque, è Oriana Fallaci, la più letta, la più famosa giornalista d’Italia.
Fiorentina di nascita, ha poi fatto carriera come inviata speciale in tutti i maggiori e
minori teatri di guerra. Durante uno scontro in Messico è stata data per morta e
portata addirittura in obitorio. Ha intervistato un gran numero di celebrità di ogni
genere, cineasti e primi ministri, dittatori e terroristi, premi Nobel e ayatollah. Ha
scritto molti libri, alcuni di grande successo come Lettera ad un bambino mai nato,
ha amato un dissidente greco nemico dei Colonnelli, morto in circostanze non chiare.
Colpita da un tumore, si è stabilita a New York, circondata dall’affetto di molti amici
e dall’astio di moltissimi nemici.
Il crollo delle Torri incendia la sua ben nota virulenza polemica. Nel suo
linguaggio senza sfumature, senza eufemismi, nel suo lessico diretto, brutale,
scorticante, compone una sorta di «manifesto» che è insieme un appello, uno sfogo,
un’invettiva, un disperato addio. Odia e disprezza l’Islam senza mezzi termini, ha
orrore dei terroristi suicidi, del chador, di tutti i riti e le costumanze imposte dal
Corano, e si scaglia contro gli occidentali incapaci di vedere l’invasione ormai già in
corso da anni, che finirà per cancellare tutte le meraviglie create nei secoli dalla
nostra civiltà, anche dalla Chiesa, di cui pure quest’atea mangiapreti (così si
autodefinisce) elenca le colpe. Solo gli smidollati e gli stupidi possono illudersi di
venire a patti con l’Islam moderato, che per la Fallaci non esiste. Non c’erano
moderati tra i giacobini, le SS, i bolscevichi. Pochi fanatici guidano e gli altri
seguono.
Contro questa drastica visione, molte voci si levano anche tra gli amici della
Fallaci. Il suo collega Tiziano Terzani, fiorentino come lei, che ha vissuto per decenni
in Oriente fino a diventare buddista, alza vigorosamente la bandiera della convivenza,
della mediazione e rifiuta l’inevitabilità di una guerra tra religioni. L’integrazione va
tentata, una pacifica osmosi è ancora possibile, il messaggio fondamentale del Corano
è pur sempre la pace. Ricorda ad Oriana le intense conversazioni di tanti anni prima e
la invita a visitare il commovente sacrario dei kamikaze giapponesi, immolatisi per il
loro Imperatore, durante la seconda guerra mondiale.
Poi la Fallaci torna in Italia per morire e viene sepolta nel cimitero evangelico a
Firenze. Anche Terzani morirà poco dopo, ma la loro infuocata polemica non si può
certo dire finita.
1° gennaio 2002
Zero virgola
Il pensionato Rossi incontra sulle scale il pensionato Bianchi e si informa: «Tu li
hai già?». Bianchi risponde di no. «Nemmeno io, vado appunto a prenderne un po’».
Al vicino bancomat c’è una lunga coda, ma su tutte le facce si legge più eccitazione
che impazienza. Finalmente la bocca bancaria partorisce la misteriosa novità:
bellissimi biglietti croccanti che i due clienti stropicciano, guardano controluce,
intascano con la vaga sensazione di essere più ricchi.
È arrivato l’euro, la moneta unica europea che, si può dire, abbia come padrino il
fungo di Hiroshima, la terribile bomba dopo la quale ogni guerra significherebbe la
distruzione del pianeta. E così, finito il secondo conflitto mondiale, nasce un primo e
poi un secondo e poi un terzo accordo comunitario europeo, con una serie di sigle che
si assomigliano tutte e che tutte tendono a stabilire una minima concordia fra Stati
che si sono scannati per secoli.
Un solo governo? Impossibile. Un solo esercito? Infattibile. Leggi penali e fiscali
identiche per tutti? Troppo complicato. Ma forse, partendo più modestamente dalla
moneta, si può salire il primo gradino. Dopo anni di discussioni, ogni Paese accetta di
rinunciare alla propria per sostituirla con la nuova, chiamata appunto euro. È pur
sempre un salto avventuroso e le profezie più nere e più rosee tra gli economisti si
sprecano.
Come reagiranno il pensionato Rossi e il pensionato Bianchi? Il commissario
europeo Prodi è soddisfatto dei primi dati e non meno di lui si rallegrano il premier
Berlusconi e il ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Gli italiani stanno
prendendo bene questo evento rivoluzionario. C’è curiosità, c’è fiducia, i nuovi
biglietti piacciono, vanno addirittura a ruba.
Il pensionato Rossi ne consegna uno alla cassa del suo supermercato abituale e la
cassiera, accanto alla quale siede un assistente, calcola laboriosamente il resto
dovuto. Il cliente studia sul palmo le monete e le monetine ricevute e constata che c’è
stato un arrotondamento a suo favore di zero virgola: quest’euro sembra davvero una
buona cosa. Ma il pensionato Bianchi, alla cassa del suo supermercato, constata
invece un arrotondamento a suo danno di zero virgola: quest’euro ha tutta l’aria di
una fregatura.
Col passare dei giorni, molti italiani si convincono che è proprio così e se ne
lagnano amaramente. Gli esercenti negano, ma continuano ad arrotondare. Quando la
vecchia lira cessa definitivamente di circolare, la maggior parte dei consumatori ha la
sensazione che i prezzi siano raddoppiati o quasi. Come sempre, si dice, sono mancati
i controlli e tuttavia la nuova moneta ci ha messi al riparo da micidiali speculazioni
sulla nostra valuta, come accadeva in passato.
A poco a poco ci si rassegna allo zero virgola e solo alcuni restano a rimpiangere
gli ampi lenzuoli da diecimila lire.
4 marzo 2005
Morire da italiani
Sotto un cielo di tuoni e di fulmini, una Toyota Corolla sta portando all’aeroporto
di Baghdad la giornalista del «manifesto» Giuliana Sgrena, rapita un mese prima dai
resistenti iracheni, e il suo liberatore, l’agente segreto Nicola Calipari. Non è la prima
volta che il brillante funzionario del SISMI riesce a recuperare l’ostaggio dietro
pagamento di un riscatto: ci è già riuscito nel 2004 con Simona Pari e Simona
Torretta.
Da quando l’Occidente ha invaso l’Iraq di Saddam Hussein per esportarvi la
democrazia in cambio del petrolio, molti italiani animati da motivazioni diversissime
si sono trasferiti laggiù: i soldati che presidiano la zona meridionale del Paese, le
guardie private che lavorano a protezione degli oleodotti, i volontari come Simona &
Simona che prestano servizio presso scuole ed ospedali, i giornalisti. Tutte prede
prelibate per i resistenti, che qualcuno definisce «terroristi» e qualcun altro
«partigiani».
I militari sono bersaglio di continui agguati e il 12 novembre 2003 un camion
esplode davanti alla base italiana di Nassiriya uccidendo ventotto uomini e ferendone
oltre cento. L’Italia si stringe intorno alle Forze armate, ma svanita l’emozione
cominciano le polemiche. Anni dopo i familiari delle vittime si chiederanno ancora
perché ai loro cari sia stata negata la medaglia d’oro al valore, concessa invece a
Fabrizio Quattrocchi, la guardia privata rapita e uccisa con tre colpi alla nuca, che un
attimo prima dell’esecuzione ha tentato di togliersi la benda gridando: «Vi faccio
vedere come muore un italiano».
Per quella frase Quattrocchi diventa il martire della destra, mentre a sinistra lo
chiamano mercenario e lo contrappongono alle volontarie Pari e Torretta, le buone
samaritane. I tifosi di Quattrocchi ricambiano, considerando Simona & Simona delle
fanatiche irriconoscenti, che dopo la brutta avventura si rifiutano di parlar male dei
loro rapitori. I neutrali si limitano a riflettere sulla disparità di trattamento mediatico
fra chi compie il suo dovere in Iraq e chi, carabiniere o volontario, lo fa in Italia nel
disinteresse generale.
I più irritati per la liberazione degli ostaggi sono comunque gli americani.
Disapprovano i metodi di Calipari, che anche per la Sgrena ha dovuto pagare un
riscatto sostanzioso. Adesso la giornalista e l’agente segreto si trovano sul sedile
posteriore dell’auto, in viaggio verso l’aeroporto da cui poi prenderanno il volo per
Roma. Ma oltre una curva vengono illuminati da un fascio potente di luce: appena
sente il crepitio della mitragliatrice Calipari si getta sul corpo della donna e le salva la
vita, morendo da eroe.
A sparare è stato un soldato del Bronx di 36 anni, Mario Lozano: sostiene di aver
scambiato la Corolla per la macchina di un kamikaze. Gli USA deplorano il «tragico
incidente», ma si guardano bene dal consegnare il colpevole alla giustizia italiana:
una replica di quanto accaduto pochi anni prima per la strage del Cermis in Val di
Fiemme, quando un aereo militare statunitense ha tranciato le corde di una funivia,
uccidendo venti persone.
Dopo l’11 settembre siamo tutti americani. Ma certo, loro continuano a esserlo un
po’ di più.
27 luglio 2005
I furbetti del telefonino
Si tende spesso a pensare che in passato il male fosse meno diffuso. Invece era solo
meno conoscibile. I bulli nelle scuole esistevano anche prima, ma non c’erano ancora
i telefonini a immortalarli. E qualche parolaccia sarà scappata pure a Garibaldi, però
non lo sapremo mai, dato che mancava la tecnologia per intercettare le sue
conversazioni con Mazzini. Nel nuovo millennio i tabulati telefonici diventano
protagonisti della politica e dell’economia, rivelando all’italiano medio che i potenti
parlano come lui, persino peggio. E hanno i suoi stessi vizi, i suoi stessi gusti, la sua
stessa allergia per le regole, con un’aggiunta di arroganza dettata dallo status.
Sono i «furbetti del quartierino» e prendono il nome dalla battuta intercettata al
telefono dell’odontotecnico romano Stefano Ricucci. Uno che negli anni Sessanta
avrebbe fatto l’attore nei film di Dino Risi e ora invece si ritrova alla testa di un
intreccio di finanzieri che non hanno mai prodotto null’altro che soldi in vita loro.
I furbetti puntano alla conquista della Banca Antonveneta e di tante altre belle
cose, fra cui il «Corriere della Sera». La loro mente è il presidente della Popolare di
Lodi, Gianpiero Fiorani detto Gianpi, che vanta un rapporto privilegiato con Antonio
Fazio e con sua moglie, da lui definita «il nostro aquilone».
Fazio è il governatore della Banca d’Italia, cioè l’arbitro. Ma nel derby di potere
tra i furbetti e un gruppo di banchieri olandesi parteggia nascostamente per i primi.
Pare che allo stesso modo si comportino gli arbitri veri e le intercettazioni di Luciano
Moggi e di altri «mammasantissima» del pallone sfociano in un’inchiesta che
materializza il sogno di mezza Italia e l’incubo dell’altra metà: la Juventus in serie B.
Ma se perfino gli arbitri sono di parte, di chi ci si può ancora fidare? Non di Calisto
Tanzi, il furbetto del latticino, che sfrutta la frenesia finanziaria dei risparmiatori per
incassare soldi in cambio di carta straccia: il crac Parmalat, come lo scoppio della
«bolla» di Internet, è sintomo di un mondo avido e indebitato che vive al di sopra dei
propri mezzi e che il fallimento di Lehman Brothers precipiterà nel caos.
Fra le tante tele(fo)novelas che allietano la crisi economica degli italiani, le più
gettonate sono quelle a sfondo sessuale, in cui le donne prendono il posto delle
mazzette e scaltri faccendieri procurano svago ai potenti in cambio di favori.
Noblesse oblige, ad aprire le danze è il mancato re Vittorio Emanuele, intercettato
mentre chiede garrulo a un certo Bonazza, il cui cognome è già un indizio: «C’ho tre
quarti d’ora e volevo andare a puttane».
Verrà accontentato, come i tanti sgherri del sottobosco politico e del sottoscala RAI
che discorrono al telefono, con piglio da intenditori, di qualche «morta di fama»
pronta a immolarsi sull’altare del maschilismo più retrivo per un’apparizione in TV:
«È piccola, ma carina. Compatta come una Smart».
La morale, si fa per dire, è che nulla sembra più distinguere le classi sociali, se non
la ricchezza. E anche questo spiega perché tutti ormai puntino esclusivamente a
quella.
10 febbraio 2006
Capitale di ritorno
La fiaccola olimpica passa per le strade del centro e ai torinesi viene da piangere.
Piange chi la porta e chi la guarda: senza scrosci da scena madre, ma con sobria
lentezza sabauda, perdendo acqua dagli occhi come un rubinetto chiuso male o forse
riaperto a fatica dopo un lungo congelamento. Torino ha pagato a caro prezzo il
quarto d’ora di giubilo con cui, sette anni prima, salutò l’assegnazione dei Giochi
invernali del 2006. Dall’inizio del millennio è sprofondata in una crisi economica ed
esistenziale, culminata nel declino della FIAT e nella scomparsa degli Agnelli:
l’Avvocato e poi anche il fratello Umberto.
La città che ha unito l’Italia, e non ha mai perso l’occasione di farlo notare, subisce
il destino dei secchioni caduti in disgrazia: essere compatiti col ghigno sulle labbra da
coloro a cui si è sempre fatta la morale. Sono giorni in cui chiunque si sente in dovere
di insegnare ai torinesi come si fa un’automobile. Deplorando di non avere il tempo
per intervenire personalmente, il premier Berlusconi suggerisce di battezzare i nuovi
modelli «Ferrari young» e «Ferrari woman»: per lui è proprio quel nome, Fabbrica
Italiana Automobili Torino, a non funzionare più.
Ma i torinesi sono chiamati bögianen non perché stiano fermi, ma perché non
mollano mai. I cantieri olimpici, pur fra mille sprechi e mugugni, avanzano. Il
mortorio cittadino si rianima e Torino si scopre città del gusto e del buongusto,
mentre i denari dei Giochi mettono in moto la macchina del divertimento e della
cultura. In FIAT Susanna Agnelli e Gianluigi Gabetti, sorella e braccio destro
dell’Avvocato, sventano il piano dell’amministratore delegato Giuseppe Morchio,
che dopo la morte di Umberto prova ad estromettere la famiglia del fondatore ed a
farsi incoronare presidente, e insediano una nuova accoppiata: Luca Cordero di
Montezemolo e Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese e di un’istriana
che ha avuto il padre infoibato da Tito e il fratello ucciso dai nazisti.
I Marchionne si sono trasferiti presso alcuni parenti in Canada, dove Sergio è
cresciuto e ha cominciato a costruirsi quella fama di risanatore d’aziende in difficoltà
che lo ha poi condotto in Svizzera e da lì al timone della FIAT. L’emigrante col
maglione nero e lo scudetto tricolore sul braccio scrosta le burocrazie interne, toglie
dai cassetti il progetto della nuova 500, scioglie il patto con la General Motors,
riportando a casa un bel gruzzolo, e rimette a lucido il marchio aziendale, assistito da
un gruppo di giovani dirigenti, subito ribattezzati i «Marchionne boys».
La conquista della Chrysler e i dissapori con i sindacati sono ancora lontani:
stasera anche lui può godersi l’ingresso nello stadio dell’ultima tedofora, la
campionessa di fondo Stefania Belmondo. Quando in tribuna il presidente Carlo
Azeglio Ciampi dichiara ufficialmente aperti i XX Giochi olimpici invernali, Torino
si sente per un attimo la capitale del mondo ma soprattutto, di nuovo, la capitale
d’Italia. Ogni torinese si scopre felice di essere felice. Ed è tale la sorpresa che gli
viene da piangere.
9 maggio 2006
Il potere della parola
In una vasta piazza di Secondigliano, quartiere alla periferia di Napoli, arriva su
una Vespa scassata un ragazzo «neutro». La piazza, nevralgica per lo spaccio di
stupefacenti, è sorvegliata da numerose vedette appostate ovunque, che segnalano
l’arrivo della polizia o di emissari e spie di clan rivali, lasciano filtrare clienti,
spacciatori, amici di varia importanza, e non si curano minimamente dei cosiddetti
«neutri», cioè casuali sfaccendati ritenuti innocui. Ma il ragazzo sulla Vespa è il più
grande nemico che la camorra abbia mai incontrato: Roberto Saviano, giovane
napoletano senza un vero mestiere, curiosissimo di tutto, pronto a fare amicizia in
qualsiasi ambiente.
Senza saperlo, senza quasi volerlo, accumula una quantità impressionante di dati
sulla malavita che inquina la sua città. Con questo materiale raccolto nei bar, nei
vicoli, sui moli del porto, nelle case sventrate, nei portoni di tutta Napoli, Saviano
compone un libro che esce in sordina nel maggio del 2006. Si intitola Gomorra ed è
non tanto una denuncia o un reportage investigativo, quanto piuttosto
un’autobiografia, una confessione nonché l’affresco avvincente di un mondo
sconosciuto.
L’autore lavora, spaccandosi la schiena, per il boss cinese che muove il grande
commercio delle contraffazioni griffate, dalla Cina verso il porto di Napoli e da lì in
tutta Europa. Possiede una radio che capta i messaggi della polizia, corre giorno e
notte sui luoghi di innumerevoli delitti, ascolta le confidenze di piccoli manovali del
crimine, si aggira tra sicari spericolati, incontra le donne dei camorristi, descrive nei
termini più crudi la ferocia implacabile delle guerre fra i diversi clan.
Non è un giornalista, è uno scrittore che crede ancora nel potere della parola.
Camorra è un termine antiquato per indicare ciò che i moderni camorristi chiamano
«il sistema», una sorta di immane ragnatela che si estende in tutto il mondo e copre
con avidità assoluta, senza curarsi della vita altrui (e nemmeno della propria), ogni
ramo di attività: edilizia, rifiuti, droga, moda, ristoranti, supermercati. I profitti sono
vertiginosi, anche se poi i capi latitanti devono vivere in buchi sotterranei.
È un quadro terrificante che riaccende l’interesse mondiale per l’esotismo italiano.
Siamo al polo opposto della «dolce vita» e il libro di Saviano diventa un bestseller
universale. In Italia la magistratura e le forze dell’ordine prendono infine sul serio la
piaga della camorra, persino più estesa e pericolosa della mafia siciliana.
Il Male non è facilmente eliminabile, ma «il sistema» comincia a soffrire e fa
giungere al ragazzo sulla Vespa precise minacce di morte. Saviano sa che si tratta di
gente dalla memoria lunga: può aspettare dieci, venti, trent’anni. Lui vive sotto scorta
continua, compare ogni tanto qua e là con grande cautela, ma la sua esistenza
«neutra» è finita per sempre. Un eroe, a suo modo.
11 dicembre 2006
L’Erba del vicino
Il grosso paese di Erba, non lontano da Como, non è mai stato protagonista di
eventi madornali e quando i vigili del fuoco lasciano la caserma per una chiamata si
aspettano il solito incidente domestico, la sigaretta dimenticata accesa, la vecchina
che ha rovesciato la pentola dell’acqua calda. Arrivano davanti a una cascina
ristrutturata da poco e suddivisa, attorno al cortile, in piccoli appartamenti. Dalla
finestra di uno di questi vedono uscire un denso fumo nero. Azionano le pompe, poi
entrano. Trovano i corpi di tre donne e di un bambino in un lago di sangue, e quello
di un uomo con la gola tagliata.
È chiaro che il fuoco non c’entra niente: sono stati assassinati. Mentre arrivano i
carabinieri, la folla assiepata nel cortile ha già individuato il colpevole. È un tunisino
con precedenti per spaccio di droga, Azouz Marzouk, marito di una delle donne e
padre del bambino. Un poco di buono che insultava e picchiava la moglie ed era
continuamente visitato da loschi figuri. Non è lì, certamente è fuggito, ma i
carabinieri non tardano a controllare: Azouz, da diversi giorni in Tunisia, è del tutto
estraneo al delitto.
Allora chi? I suoi complici o compari per vendicarsi di uno sgarro? Ma presto
anche questa ipotesi cade e si comincia ad indagare più da vicino. Miracolosamente
l’uomo con il taglio alla gola non è morto, è in coma all’ospedale, ma quando si
riprenderà, proprio da lui verranno le prime indicazioni. Il suo aggressore era un tipo
corpulento, parlava italiano, ma poteva anche essere straniero.
Tutti i condomini sono via via interrogati e viene alla luce uno sfondo coabitativo
molto conflittuale. C’erano liti, insulti, minacce, urla a tutte le ore, soprattutto contro
il tunisino e la moglie. Da parte di chi? Parrebbe per lo più a opera di una coppia di
mezz’età, Olindo Romano, netturbino, e sua moglie Rosa, i cui alibi risultano
alquanto deboli. I due vengono fermati e interrogati a lungo.
È passato un mese, Olindo comincia a cedere e infine confessa. Il movente è il
«rumore», il chiasso insopportabile che il tunisino, la moglie ed il bambino piangente
causavano, portando all’esasperazione i coniugi Romano. Così, per avere infine un
po’ di pace, sono saliti al piano di sopra - lei con un coltello, lui con una spranga - e li
hanno tolti di mezzo, eliminando anche la madre della donna e la vicina uscita sul
pianerottolo, spaventata dalle urla. Poi è toccato a suo marito, Mario Frigerio, che si è
salvato per un soffio e che ora accusa Olindo. Quanto a Rosa, conferma tutto e
aggiunge anzi particolari raccapriccianti. Per distruggere le prove i due hanno pensato
bene di dar fuoco alla casa e hanno gettato gli abiti sporchi di sangue in un
cassonetto.
Al processo, legati da un attaccamento morboso, si tengono per mano, si
abbracciano e si coccolano. Poi però cambiano avvocato e ritrattano tutto: la
confessione è stata estorta. Ma anche al processo d’appello la pena viene confermata:
la pace dell’ergastolo.
25 aprile 2009
Da Orma a donna
Berlusconi ha l’Italia in mano. Il secondo governo Prodi ha tolto rapidamente il
disturbo e la nuova legge elettorale, che persino dal suo ideatore è stata definita «una
porcata», gli ha consegnato una maggioranza senza precedenti.
Il Cavaliere stringe un’alleanza di ferro con Bossi e si fa eleggere con un applauso
alla presidenza del Popolo della Libertà, il partito unico del centrodestra la cui nascita
ha proclamato dal predellino dell’auto. Poi affronta con il fido Bertolaso le
emergenze ambientali: la spazzatura di Napoli e il terremoto d’Abruzzo. Ed è proprio
fra le macerie di Orma, un paesino già piagato dalla ferocia nazista, che celebra il 25
aprile, ricorrenza che in passato ha sempre considerato di sinistra. Ma ora la sinistra è
come Orma - a pezzi - e il suo leader Walter Veltroni ha già fatto rima con
dimissioni.
Il premier parla da statista, loda la Resistenza e la Costituzione, si mette al collo il
fazzoletto dei partigiani. Il giorno dopo i sondaggi registrano un consenso
plebiscitario. Lui si rilassa e corre a festeggiare in un locale di Casoria, vicino a
Napoli, il compleanno di una diciottenne, Noemi Letizia. E di colpo cambia tutto.
La fanciulla, incauta, rivela le sue frequentazioni assidue con il Cavaliere, che lei
chiama «papi». Si spargono voci incontrollabili su qualsiasi bella ragazza faccia parte
del governo e del partito, oppure ambisca ad entrarvi. Spuntano le intercettazioni di
una escort barese in cerca di favori e munita di registratori, Patrizia D’Addario, da cui
si evince che, la notte dell’elezione di Obama, Berlusconi disertò il ricevimento
dell’ambasciata USA perché impegnato in camera da letto. Il dibattito politico emigra
sotto le lenzuola e fra calunnie e scomode verità non risparmia nessuno. Avranno i
loro guai il sottosegretario alla Protezione civile Guido Bertolaso, coinvolto in una
storia di appalti e massaggiatrici, il governatore del Lazio Piero Marrazzo, ricattato
per i suoi amori trans, e il dissidente Gianfranco Fini alle prese con un
appartamentino di Montecarlo donato al suo ex partito e finito nella disponibilità del
giovane cognato.
La moglie Veronica Lario definisce Berlusconi un malato e chiede il divorzio,
sconcertata da un Paese che «per una strana alchimia tutto concede e giustifica al suo
imperatore». Ma la forza del premier sta proprio nel suo essere in simbiosi con le
viscere della nazione. Chiunque sia andato al potere prima di lui ha cercato di
cambiare gli italiani. Il Duce voleva farne dei soldati-contadini come gli antichi
romani, la DC dei cittadini probi e laboriosi. Anche il PCI aveva un fondo moralista.
Berlusconi invece esorta i connazionali ad andare fieri dei loro difetti: sono sintomi di
«libertà». Ne dà egli stesso l’esempio con continue cadute di gusto che indignano gli
stranieri ma confermano nei suoi elettori la convinzione che il miliardario di Arcore
sia «uno di noi».
La sua ideologia è racchiusa nell’esortazione che rivolge agli autori dei programmi
televisivi: «Ricordatevi che il nostro pubblico ha fatto la seconda media e non era
neanche fra i primi della classe». Quel pubblico che la RAI democristiana e comunista
cercava di spingere verso il liceo a furia di romanzi sceneggiati, lui lo trattiene nel
Paese dei Balocchi, ammannendo svago e facilità come l’omino di burro che
trasforma Pinocchio in un ciuchino. Nonostante molti ambiscano alla parte, non si
hanno ancora notizie della Fata Turchina.
Ringraziamenti
Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno pazientemente assistiti nella nostra
compilazione ed in particolare: il direttore de «La Stampa» Mario Calabresi; Mattia
Feltri e Alberto Mattioli; Roberto Gritella e i colleghi del centro documentazione de
«La Stampa»: Patrizia Guidi, Moreno, Claudio, Genserico e Daniele della biblioteca
«Italo Calvino» di Castiglione della Pescaia.