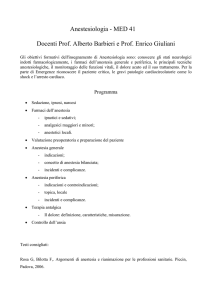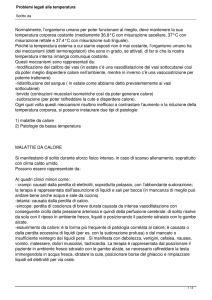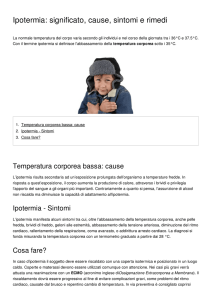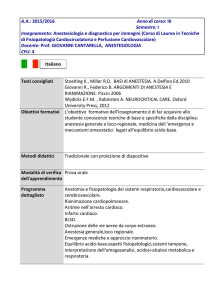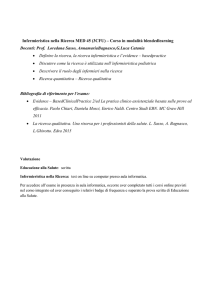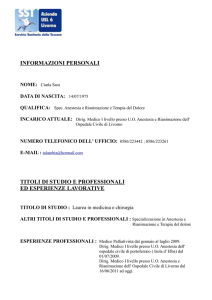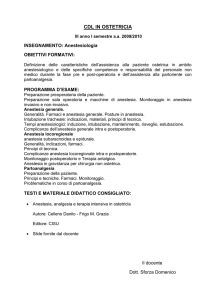CAUSE DI IPOTERMIA ACCIDENTALE
PERIOPERATORIA
Autore Alex Puglierin
Nel contesto perioperatorio, l’ipotermia accidentale è il disturbo della termoregolazione più
frequente. Le cause dell’ipotermia possono essere varie e spesso sono la somma di una
serie di fattori concomitanti.
ANESTETICI
L’anestesia generale, sia inalatoria che endovenosa, altera significativamente la normale
termoregolazione. La regolazione della temperatura corporea tramite la risposta
comportamentale non è possibile, perché i pazienti sono incoscienti, miorilassati e quindi
incapaci di reagire attivamente ad alterazioni della temperatura corporea. Tutti gli
anestetici generali finora testati sul mercato inibiscono il normale controllo della
termoregolazione a livello del sistema neurovegetativo. Queste sostanze aumentano la
soglia di attivazione dei meccanismi di termoregolazione in risposta al caldo (sudorazione)
e diminuiscono la soglia per la risposta al freddo (vasocostrizione). Conseguentemente il
range intersogliare aumenta da un valore normale di 0.3°C a 2°C – 4°C. Una temperatura
corporea all’interno di questo range non attiva una risposta termoregolatoria ed i pazienti
diventano, per definizione, poichilotermi.
Gli anestetici sono inoltre responsabili di una ridistribuzione del calore all’interno del corpo.
Innanzitutto il calore non è distribuito equamente su tutta la superficie del corpo. La
temperatura corporea centrale viene mantenuta soltanto sulla metà della massa corporea
(prevalentemente su tronco e testa), la massa restante è tipicamente più fredda rispetto al
centro di 2°C – 7°C. Questo gradiente di temperatura fra centro e periferia è normalmente
mantenuto
dalla
vasocostrizione
termoregolatoria.
Gli
anestetici
provocano
vasodilatazione, con conseguente ridistribuzione del calore dal centro verso la periferia
(vedi figura I). La ridistribuzione dipende dalla differenza di temperatura tra centro e
periferia al momento dell’induzione dell’anestesia.
Figura I: Illustrazione della ridistribuzione del calore corporeo dopo induzione dell’anestesia.
Gli anestetici riducono inoltre la produzione di calore per via metabolica del 20% – 30%. Si
può quindi affermare, che l’uso degli anestetici è la causa più importante di ipotermia
perioperatoria (Miller et al. 2010).
L’anestesia
regionale,
sia
epidurale
che
subaracnoidea,
altera
anch’essa
la
termoregolazione, inibendo sia la regolazione centrale a livello dell’ipotalamo che la
vasocostrizione periferica (Joris et al. 1994)
L’anestesia integrata è la combinazione di un’anestesia epidurale con un’anestesia
generale. In questo caso le due tecniche agiscono sinergicamente e l’effetto sui centri
regolatori e sugli organi effettori è potenziato, determinando un rapido e progressivo
raffreddamento del paziente. Nell’anestesia integrata, la soglia di attivazione della
vasocostrizione si abbassa ancora di 1°C rispetto all’anestesia generale (Cannone 2006).
Il tourniquet emostatico, applicato agli arti, blocca lo scambio di calore tra il centro e la
periferia. Nell’adulto questo fenomeno riduce la caduta iniziale della temperatura corporea.
Tuttavia, i tessuti a valle del tourniquet diventano ipotermici e nel momento in cui viene
tolto questo dispositivo, si verifica una redistribuzione del calore (Cannone 2006).
TEMPERATURA AMBIENTALE
Un’altra importante causa d’ipotermia accidentale perioperatoria è la temperatura
all’interno del blocco operatorio e della sala operatoria. All’interno della sala operatoria la
temperatura è solitamente mantenuta sotto i 23°C (temperatura minima necessaria a
mantenere il paziente normotermico). Questo è dovuto alla percezione soggettiva di calore
del personale operante con conseguente riduzione della temperatura ambientale
all’interno della sala operatoria. I chirurghi sono particolarmente suscettibili a temperature
troppo elevate a causa dello stress operatorio e dei numerosi strati d’indumenti indossati.
Temperature elevate favorirebbero anche la sudorazione del personale operante sul
campo operatorio. Temperature troppo elevate potrebbero inoltre alterare negativamente
la performance del personale di sala operatoria e diminuirne la vigilanza (Hart S. R.,
Bordes, Hart J., Corsino, Harmon 2011).
TIPO E DURATA DELL’INTERVENTO CHIRURGICO
Il tipo d’intervento chirurgico e la durata dello stesso influenzano significativamente
l’ipotermia perioperatoria, soprattutto in caso d’interventi addominali e toracici. Le tecniche
chirurgiche prevedono interventi in laparoscopia ed in laparotomia (a seconda del sito
chirurgico si distinguono la toracotomia, la craniotomia, etc.) La laparoscopia è un tipo di
chirurgia mini – invasiva, perché praticata tramite delle piccole incisioni cutanee. Vengono
inseriti nell’addome del paziente uno strumento ottico, il cosiddetto laparoscopio e dei
tubicini che permettono la comunicazione tra cavità addominale ed ambiente esterno.
Nella laparotomia invece viene aperto l’addome tramite un incisione chirurgica. Nel caso di
apertura di cavità, gli organi sono a diretto contatto con l’ambiente esterno e la perdita di
calore per via evaporativa è maggiore e più rapida.
Anche
la
durata
dell’intervento
incide
sull’insorgenza
dell’ipotermia
accidentale
perioperatoria.
Durante un intervento in anestesia generale vi è solitamente un repentino abbassamento
della temperatura corporea centrale nella prima ora dall’induzione, seguito da una perdita
di calore più lenta e graduale. A causa della ridistribuzione del calore corporeo dal centro
verso la periferia, si ha un abbassamento della temperatura corporea centrale da 0,5°C a
1,5°C durante la prima ora. In seguito la temperatura centrale diminuisce lentamente e
gradualmente nelle 2 – 4 ore successive. Questa riduzione avviene semplicemente perché
la perdita di calore è maggiore rispetto alla produzione per via metabolica. Dopo 3 – 4 ore
d’anestesia, la temperatura corporea raggiunge solitamente un valore costante (plateau) e
rimane invariata per il resto dell’intervento chirurgico (vedi figura II) (Miller et al. 2010).
Figura II: Illustrazione dell’andamento della temperatura corporea centrale (°C) in relazione al tempo
trascorso dall’induzione dell’anestesia (h).
FLUIDI ED EMODERIVATI
La somministrazione intraoperatoria di grandi quantità di soluzioni infusionali fredde, di
emoderivati freddi e di soluzioni d’irrigazione fredde favoriscono l’ipotermia (Paulikas
2008).
FATTORI DI RISCHIO DEL PAZIENTE
Esiste una serie di fattori legati a caratteristiche del paziente stesso che favoriscono
l’insorgenza dell’ipotermia accidentale perioperatoria (De Mattia et al. 2012).
L’età, il peso (BMI), la temperatura nel periodo preoperatorio, lo stato di salute
preesistente e comorbidità possono incidere sull’evoluzione dell’ipotermia. Da sottolineare
sono le seguenti patologie: il diabete mellito, i disturbi della tiroide, le patologie cardiache e
i disturbi dell’asse corticosteroidea (NICE 2008).
Per permettere una stratificazione e classificazione dei pazienti, si utilizza la
classificazione secondo ASA (The American Society of Anesthesiologists), che suddivide i
pazienti in diverse categorie di rischio anestesiologico. La valutazione prevede cinque
classi (vedi tabella I), che definiscono il rischio anestesiologico (classe I – V).
Tabella I: Classificazione del rischio anestesiologico secondo ASA.
Autore Alex Puglierin