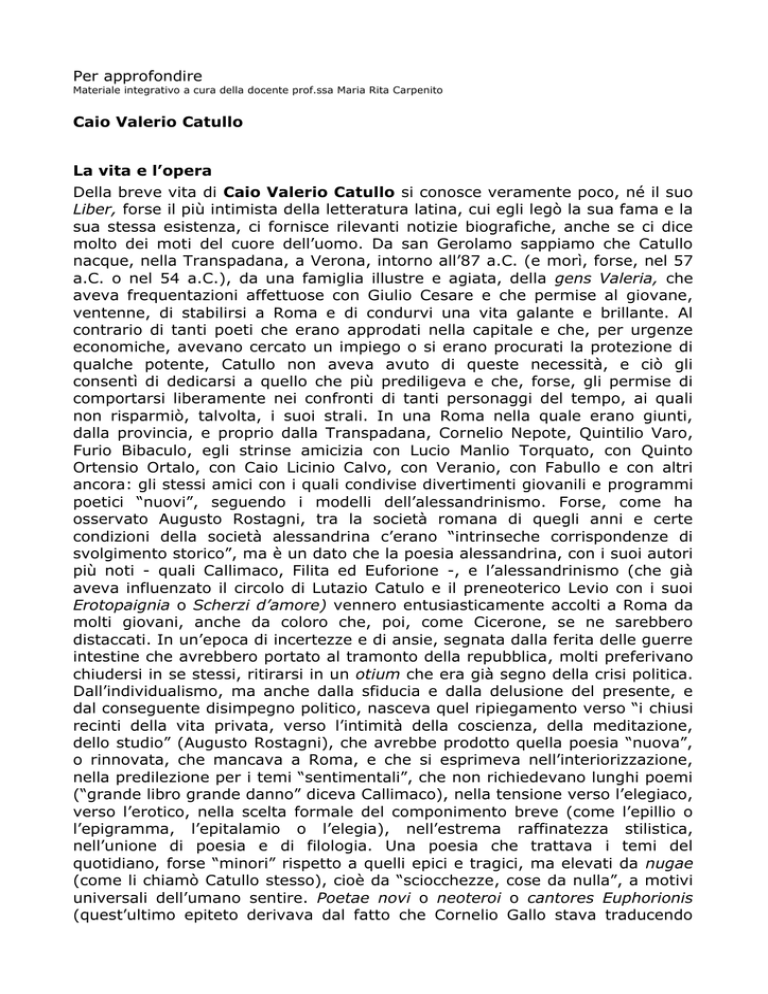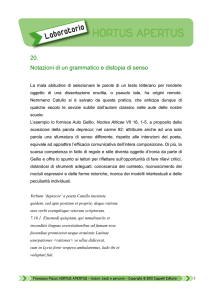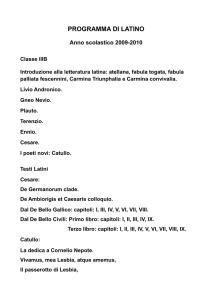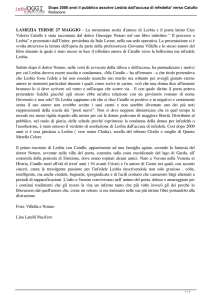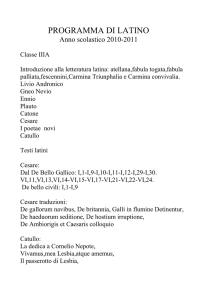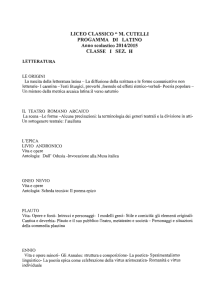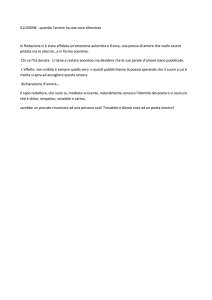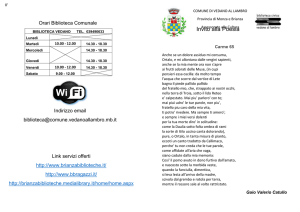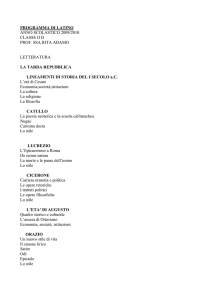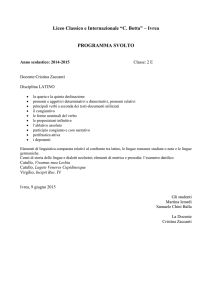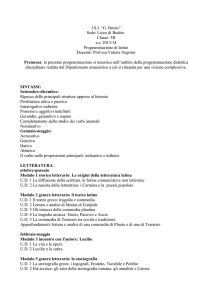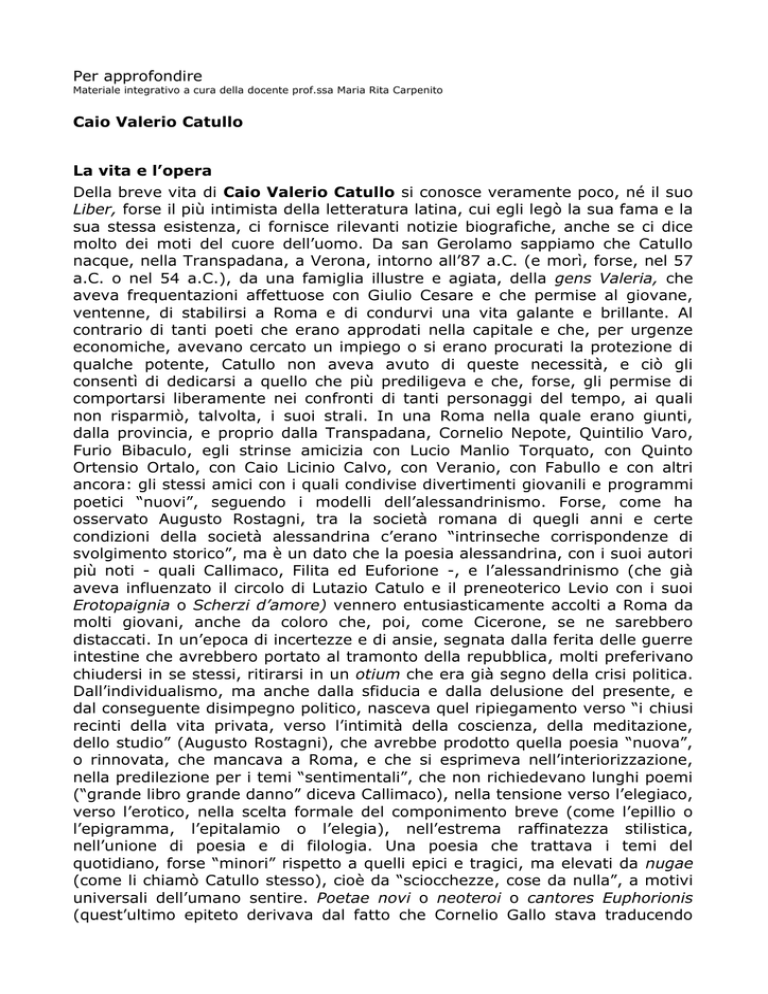
Per approfondire
Materiale integrativo a cura della docente prof.ssa Maria Rita Carpenito
Caio Valerio Catullo
La vita e l’opera
Della breve vita di Caio Valerio Catullo si conosce veramente poco, né il suo
Liber, forse il più intimista della letteratura latina, cui egli legò la sua fama e la
sua stessa esistenza, ci fornisce rilevanti notizie biografiche, anche se ci dice
molto dei moti del cuore dell’uomo. Da san Gerolamo sappiamo che Catullo
nacque, nella Transpadana, a Verona, intorno all’87 a.C. (e morì, forse, nel 57
a.C. o nel 54 a.C.), da una famiglia illustre e agiata, della gens Valeria, che
aveva frequentazioni affettuose con Giulio Cesare e che permise al giovane,
ventenne, di stabilirsi a Roma e di condurvi una vita galante e brillante. Al
contrario di tanti poeti che erano approdati nella capitale e che, per urgenze
economiche, avevano cercato un impiego o si erano procurati la protezione di
qualche potente, Catullo non aveva avuto di queste necessità, e ciò gli
consentì di dedicarsi a quello che più prediligeva e che, forse, gli permise di
comportarsi liberamente nei confronti di tanti personaggi del tempo, ai quali
non risparmiò, talvolta, i suoi strali. In una Roma nella quale erano giunti,
dalla provincia, e proprio dalla Transpadana, Cornelio Nepote, Quintilio Varo,
Furio Bibaculo, egli strinse amicizia con Lucio Manlio Torquato, con Quinto
Ortensio Ortalo, con Caio Licinio Calvo, con Veranio, con Fabullo e con altri
ancora: gli stessi amici con i quali condivise divertimenti giovanili e programmi
poetici “nuovi”, seguendo i modelli dell’alessandrinismo. Forse, come ha
osservato Augusto Rostagni, tra la società romana di quegli anni e certe
condizioni della società alessandrina c’erano “intrinseche corrispondenze di
svolgimento storico”, ma è un dato che la poesia alessandrina, con i suoi autori
più noti - quali Callimaco, Filita ed Euforione -, e l’alessandrinismo (che già
aveva influenzato il circolo di Lutazio Catulo e il preneoterico Levio con i suoi
Erotopaignia o Scherzi d’amore) vennero entusiasticamente accolti a Roma da
molti giovani, anche da coloro che, poi, come Cicerone, se ne sarebbero
distaccati. In un’epoca di incertezze e di ansie, segnata dalla ferita delle guerre
intestine che avrebbero portato al tramonto della repubblica, molti preferivano
chiudersi in se stessi, ritirarsi in un otium che era già segno della crisi politica.
Dall’individualismo, ma anche dalla sfiducia e dalla delusione del presente, e
dal conseguente disimpegno politico, nasceva quel ripiegamento verso “i chiusi
recinti della vita privata, verso l’intimità della coscienza, della meditazione,
dello studio” (Augusto Rostagni), che avrebbe prodotto quella poesia “nuova”,
o rinnovata, che mancava a Roma, e che si esprimeva nell’interiorizzazione,
nella predilezione per i temi “sentimentali”, che non richiedevano lunghi poemi
(“grande libro grande danno” diceva Callimaco), nella tensione verso l’elegiaco,
verso l’erotico, nella scelta formale del componimento breve (come l’epillio o
l’epigramma, l’epitalamio o l’elegia), nell’estrema raffinatezza stilistica,
nell’unione di poesia e di filologia. Una poesia che trattava i temi del
quotidiano, forse “minori” rispetto a quelli epici e tragici, ma elevati da nugae
(come li chiamò Catullo stesso), cioè da “sciocchezze, cose da nulla”, a motivi
universali dell’umano sentire. Poetae novi o neoteroi o cantores Euphorionis
(quest’ultimo epiteto derivava dal fatto che Cornelio Gallo stava traducendo
proprio Euforione) furono detti spregiativamente da Cicerone questi giovani
che, con il rifiuto della trattazione letteraria dei grandi temi epici, con
l’avversione a Ennio (il poeta del III secolo a.C., pater e nome sacro della
poesia latina), con il disimpegno politico, con l’amore per la ricerca filologica ed
erudita, con la concezione della poesia come lusus costituirono un vero e
proprio cenacolo letterario, dal quale derivarono, per la storia letteraria latina,
nuovi fermenti e ancor più nuovi impulsi. Dell’allegra brigata di giovani poeti
che, prendendo le distanze dai poetastri (i pessimi poetae del carme XIV),
volevano svecchiare le forme poetiche, anche con uno stile, quello atticistico,
severo e pulito, Catullo è colui che, per personalità, ma, forse, anche per un
modo di affrontare la vita a volte eccentrico, a volte sopra le righe, emerge a
tutto tondo, divenendone il caposcuola. Probabilmente, fu proprio la sua
tormentata storia d’amore con Lesbia a costituire il dato più appariscente della
sua breve esistenza. Clodia, perché questo è il vero nome di Lesbia, era figlia
di Aulo Claudio Pulcro, sorella di Publio Appio Claudio detto Clodio (fattosi
chiamare così perché, per ottenere il tribunato della plebe, si fece adottare da
un plebeo), moglie del console Metello Celere. Bellissima, colta e affascinante,
era una delle signore più in vista dell’alta società romana e, naturalmente, una
delle più corteggiate, motivo per il quale la sua storia d’amore con Catullo è
anche una delle più travagliate che si conoscano. Come tante probabilmente,
destinate, tuttavia, a rimanere anonime, mentre quella tra Catullo e Lesbia ha
il pregio di essere divenuta un romanzo, un libro, un’opera d’arte.
Il Liber
La storia del Liber catulliano, composto da centosedici carmina, è tutt’altro che
semplice, per genesi, per struttura e per vicende storiche. Quel che è certo è
che esso è il libro di una vita, nel quale confluiscono l’esperienza letteraria, le
affinità artistiche, le scelte stilistiche del poeta, oltre che le voci del suo cuore
e le contraddizioni della sua quotidiana vicenda umana. Il testo, nel suo
impianto narrativo, presenta degli aspetti che hanno generato dei dubbi sulla
sistemazione cronologica e logica dei carmi, cosa che ha alimentato, nel
tempo, la querelle attorno al Liber: in primo luogo, la fisionomia di quello che il
poeta chiama lepidum libellum (Carmina, I) non è proprio quella di “un libretto
leggiadro”, giacché un tal libretto di nugae non avrebbe contenuto circa
tremila versi né i carmina docta, e cioè i componimenti più ricercati e anche
più complessi dell’opera. Essa, infatti, si presenta come un corpus
comprendente, nella prima parte, sessanta carmi che, per temi e per brevità
(di solito non superano i venti versi), rispondono maggiormente a una poetica
del lusus, dunque del “divertimento”, dello “scherzo”, sia che si parli d’amore
sia che si colpisca con l’invettiva. A questa varietà tematica corrisponde anche
una grande libertà metrica che, con lucida disinvoltura, dal falecio passa alla
strofe saffica, dal priapeo trascorre al coliambo. Dal carme LXI in poi, invece,
comincia quella parte centrale del Liber che comprende otto carmina docta,
che i “poeti nuovi” di solito distinguevano dagli altri e che, in effetti, Catullo, o
chi per lui, accomuna nell’ordine di successione. In essi, nei canti, per così
dire, “maggiori”, è il mito a essere trattato, o che prenda spunto da un motivo
occasionale, come le nozze di un amico, o che venga introdotto velocemente,
per cantare di tempi nei quali gli dei non disdegnavano di trattare con i
mortali. Un mito, tuttavia, piegato alle più intime esigenze spirituali,
reinventato, se possibile, come i poetae docti usavano fare, rinnovato e
riscaldato dal fuoco della passione catulliana: persino il metro, composto e
costante, come il distico elegiaco, la tessitura sintattica ricercata, con una
serie di trapassi attentamente sorvegliati, il linguaggio meno incline ai
diminutivi, ai provincialismi, agli arcaismi, elegante e raffinato, se pure preso,
in massima parte, dalla lingua viva, denotano una poetica che aspirava alla
perfezione tipicamente alessandrina. Ma poi, dopo gli otto carmina docta,
quasi come se il poeta avesse voluto mettere al centro del Liber il perno cui
avvitare componimenti più “leggeri”, ritornano i carmi brevi: il carme LXIX, il
primo dopo il LXVIII, costituisce, con i suoi riferimenti coloriti, il contenuto
“forte” e lo stile “basso”, una “discesa agli Inferi”, un rituffarsi, dopo le altezze
del mito, nella quotidianità, con le sue ombre e con le sue debolezze, con le
sue brutture e con i suoi disinganni. Il metro usato è sempre il distico elegiaco,
ma il tono è disincantato, se non disperato. Se il Liber è la storia di un’anima,
è inutile, tuttavia, cercarvi un ordine cronologico o contenutistico; il carme
VIII, uno dei primi, indica inequivocabilmente la disperazione per la fine della
storia d’amore, così come il XLIII manifesta chiaramente l’orgoglio di amare
una donna splendida come Lesbia e il CIX contiene la speranza dell’amante
che sa di essere al momento amato. Chiunque lo abbia sistemato non ha,
però, mutato l’unitarietà fondamentale del testo, che consiste proprio nello
spirito del poeta che domina e assembla la materia trattata, col suo continuo
colloquiare con i sentimenti, che non conoscono la logica temporale. Su tutto e
su tutti svetta Lesbia, la donna amata, così chiamata, forse, pensando a Saffo,
della cui poesia Catullo è debitore, forse volendo far intendere Lesbia la bella,
così come la poetessa di Lesbo era detta. Tutto ruota attorno a lei: persino la
morte di un passerotto a lei caro può essere un avvenimento doloroso. E i suoi
baci? Meglio non contarli, perché occorre guardarsi dagli invidiosi. Meglio
vivere intensamente l’amore e la giovinezza, perché la vita è breve e la morte
attende ineluttabile. Eppure, non sempre l’amore è gioia; più spesso è ansia, è
attesa, è gelosia, è tormento. Perché, anche quando Lesbia dice di amare e
giura la propria fedeltà, non è detto che le sue parole non scorrano via come
l’acqua. Lesbia è bella, è sempre la più bella, ma sa essere anche crudele e i
suoi furta, cioè i suoi tradimenti, mettono a dura prova la fides, la fedeltà,
sacra nel foedus, nel patto d’amore: il poeta si dispera, chiede, implora, tenta
di distrarsi con i viaggi, con gli amici, con altri amori, si sdegna, attacca, come
è spesso evidente dalle sue violenze verbali, ma il pensiero di non essere
amato quanto lui ama, lo conduce quasi alla follia. Il testo dei carmi quale a
noi è pervenuto ha avuto una storia difficile: nel V secolo d. C., Isidoro di
Siviglia citava il testo catulliano, ma di esso non si seppe nulla fino al IX secolo
d. C.. Riapparso e periodicamente scomparso, non ve ne fu notizia fino al
1300, quando il manoscritto venne ritrovato e, poi, successivamente trascritto.
Il buio di tanti secoli, secondo Giovanni Pascoli, si spiega con la bellezza
dell’opera: poiché la sua “eccellenza la fa amare, l’amore la fa imitare,
l’imitazione la rode, la consuma, l’annulla... fino a quando il piccolo libro torna
a splendere e a vivere, e a far rivivere un’anima e un’età” (Giovanni Pascoli,
Lyra, La Nuova Italia).
da Tiziana Cacciola e Patrizia Danzé, Itinerari di civiltà classica, pagg 515-518