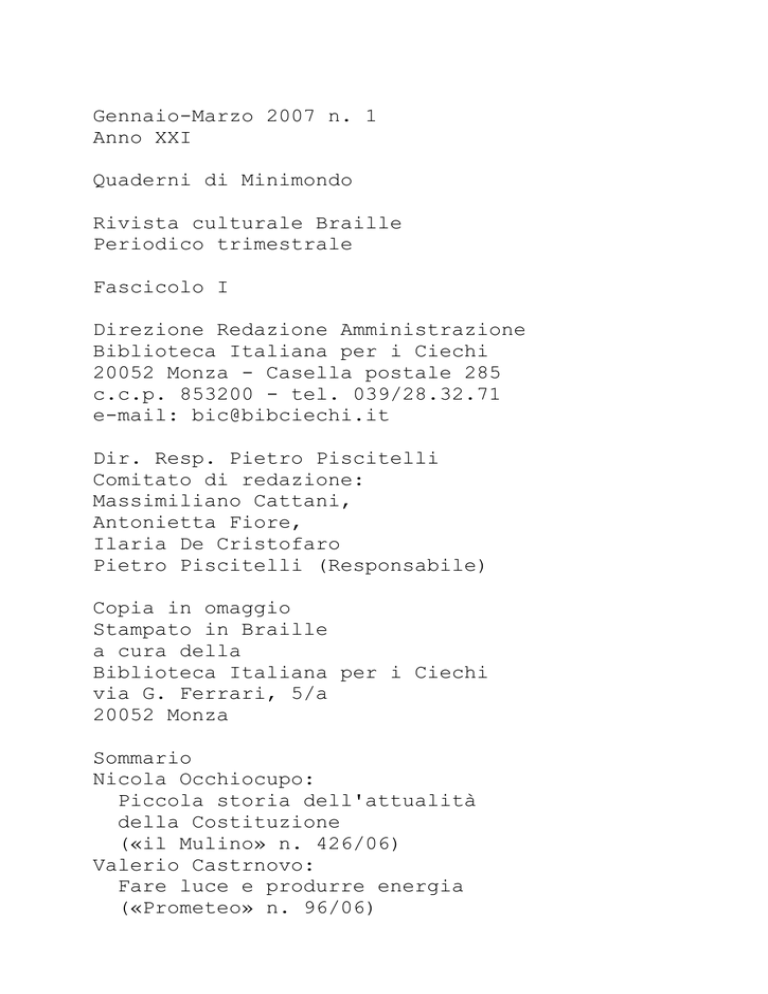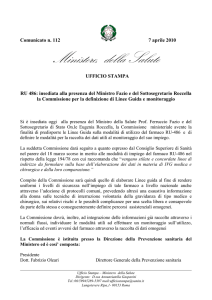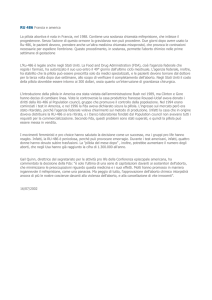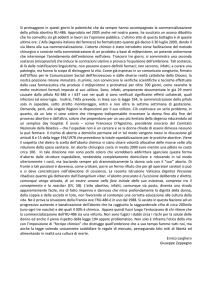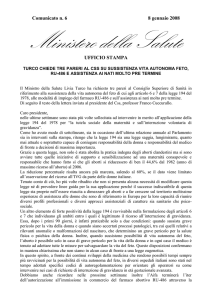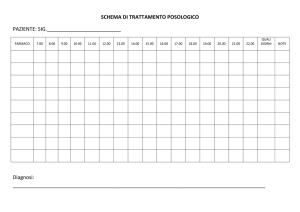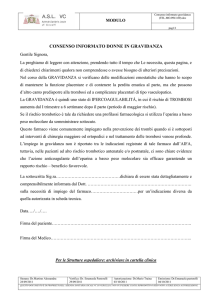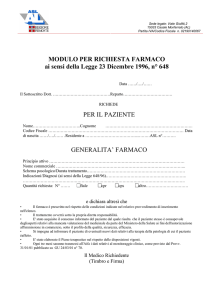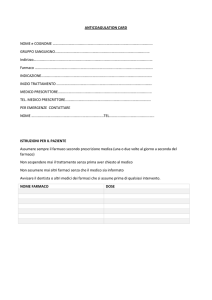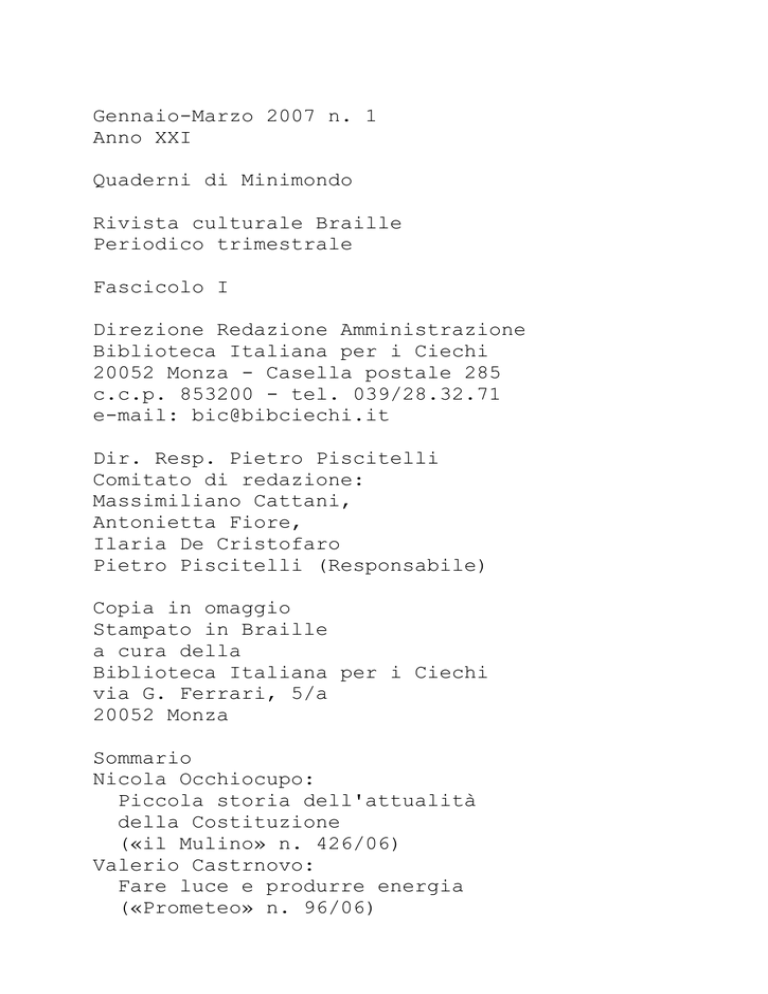
Gennaio-Marzo 2007 n. 1
Anno XXI
Quaderni di Minimondo
Rivista culturale Braille
Periodico trimestrale
Fascicolo I
Direzione Redazione Amministrazione
Biblioteca Italiana per i Ciechi
20052 Monza - Casella postale 285
c.c.p. 853200 - tel. 039/28.32.71
e-mail: [email protected]
Dir. Resp. Pietro Piscitelli
Comitato di redazione:
Massimiliano Cattani,
Antonietta Fiore,
Ilaria De Cristofaro
Pietro Piscitelli (Responsabile)
Copia in omaggio
Stampato in Braille
a cura della
Biblioteca Italiana per i Ciechi
via G. Ferrari, 5/a
20052 Monza
Sommario
Nicola Occhiocupo:
Piccola storia dell'attualità
della Costituzione
(«il Mulino» n. 426/06)
Valerio Castrnovo:
Fare luce e produrre energia
(«Prometeo» n. 96/06)
Stefano Cagliano:
RU-486: la «pillola
della discordia»
(«le Scienze» n. 458/06)
Alessandra Girardi,
Nicoletta Beschin,
Sergio Della Sala:
Fantasmi del corpo
(«Psicologia contemporanea»
n. 197/06)
Fabiana Fusco:
«Messaggiarsi»
(«Prometeo» n. 96/06)
Dario Enrico Baudini:
Amarcord della radio libera
nell'era dei grandi network
(«Vita e pensiero» n. 4/06)
Theodor Kissel:
La regina di Saba
(«le Scienze» n. 460/06)
Arianna Dalzero:
Le mille voci di Trieste
(«Luoghi dell'Infinito» n. 104/07)
Marina Verzoletto:
Béla Bartók: ritorno alla
terra e creazione del suono
(«Letture» n. 625/06)
Comunicati:
Concorso nazionale di poesia e racconti
«Basilio Beltami - Pensieri e Parole»
Nuovo Consiglio di Amministrazione della
Biblioteca
Contenitori dei libri in restituzione
Piccola storia dell'attualità della
Costituzione
Tra le parole d'ordine messe in circolazione
in occasione della campagna referendaria sulla
riforma costituzionale, approvata, nella
passata legislatura, dalla sola maggioranza di
centrodestra, e respinta dai cittadini
italiani con il voto del 25 e 26 giugno 2006,
una delle più diffuse è stata quella relativa
alla presunta vecchiaia della Costituzione. Un
postulato, invero, non nuovo e alla base anche
della fioritura, negli ultimi anni, di
numerosi progetti di riforma.
Sembra di trovarsi nella situazione evocata
da Vincenzo Cuoco, impegnato a esaminare nel
1799 il progetto di Costituzione di Mario
Pagano: «Noi rassomigliamo - scrive lo
studioso molisano - ai filosofi della Grecia
dei tempi di Platone e di Aristotele, quando,
stanchi dei vizi di tutti i popoli e dei
disordini di tutti i governi loro noti, si
occupavano della ricerca di una Costituzione
che fosse senza difetti, da servire a un
popolo, che non avesse vizio alcuno. Allora fu
moda, come lo è oggi, che ognuno il quale
ambisse fama di pensatore formasse un progetto
di Costituzione; e ciascuno spacciava la sua
come l'unica che potesse stabilirsi e durare».
Orbene, senza entrare nel merito delle
diverse proposte di riforma costituzionale, di
cui tanto si parla e si parlerà, sembra utile
richiamare, invece, i principi fondamentali e
l'ispirazione di fondo della nostra
Costituzione, evocati, ma non esaminati in
profondità, che consentono di coglierne la
vitalità e attualità, pur in uno scenario
interno, europeo e internazionale
profondamente diverso da quello esistente, al
momento della sua elaborazione, negli anni
1946-1947.
È indispensabile, infatti, come osservava
Giuseppe Dossetti in una magistrale lezione
tenuta all'Università di Parma, conoscere e
comprendere la Costituzione, più e meglio di
quanto sia stato fatto, anche per rilevare e
sottolineare, sia pure in una necessaria
visione di sintesi, come sussista un
patrimonio costituzionale che può essere,
oggi, comune a tutto il popolo italiano, che
non preclude, tra l'altro, la possibilità di
realizzare, come si vedrà, riforme
costituzionali condivise, anche di tipo
federale, nella salvaguardia della unità e
della indivisibilità della Repubblica.
L'«oggetto particolare» della nostra
Costituzione
Scrive Montesquieu ne Lo spirito delle leggi
(cap. V, libro XI): «Quantunque tutti gli
Stati abbiano generalmente un oggetto
medesimo, che è di conservarsi, nulla di meno
ogni Stato ne ha uno che gli è particolare.
L'ingrandimento era l'oggetto di Roma; la
guerra quello di Sparta; la religione quello
delle leggi giudaiche; il commercio quello di
Marsiglia; vi è altresì nel mondo una nazione,
la quale ha per oggetto diretto della sua
costituzione la politica libertà». Montesquieu
ricorda che ogni Costituzione, in ogni tempo e
in ogni Paese, ha avuto un «oggetto»
peculiare, ovvero un fine supremo che impronta
di sé l'intero ordinamento.
«Oggetto particolare» della Costituzione
italiana è la persona umana, soggetto,
fondamento e fine dell'ordinamento
repubblicano, con i diritti inviolabili, e i
doveri, inderogabili, ad essa consustanziali e
che ad essa si riconnettono nel continuo
fluire della storia, che l'ordinamento
statuale riconosce, non crea.
Una persona umana, concepita non come entità
astratta, ma nella concretezza della sua
esistenza, della sua esperienza di vita, nella
multidimensionalità dei suoi bisogni,
materiali e spirituali, immanenti e
trascendenti, che essa cerca di soddisfare
nella concreta realtà dei gruppi in cui viene
a trovarsi, naturalmente e volontariamente, in
cui nasce, cresce, entra, e si sviluppa, in
rapporto con altre persone, in una relazione
reale di solidarietà. Essenziale e costitutiva
della persona è, dunque, la dimensione
sociale, secondo la ispirazione aristotelica,
ripresa e sviluppata dalla filosofia
tomistica, nel senso che la persona è persona
proprio nella società, nelle sue diverse
articolazioni, portatrice di diritti «innati»,
che «la società non può disconoscere».
Tale concezione trova la sua consacrazione
nell'articolo 2, che «riconosce» e
«garantisce» i diritti che ad essa fanno capo,
ritenuti «inviolabili», e sancisce, con
plastica formulazione, che riecheggia il
motivo fondamentale del pensiero di Giuseppe
Mazzini, la stretta correlazione fra il
«godimento» dei diritti e l'«adempimento» dei
doveri, inderogabili, di solidarietà,
ribadita, in modo esplicito e implicito, in
molti articoli della Costituzione. L'articolo
2 fa espresso riferimento alle «formazioni
sociali», in cui la società si articola e dove
il soggetto plasma la sua personalità, tra le
quali alcune formazioni sono ritenute
«tipiche», quali, ad esempio, la famiglia, la
scuola, le chiese, i partiti, i sindacati, le
comunità di lavoratori, le imprese, le
cooperative ecc. Esse, tuttavia, non
esauriscono i fenomeni organizzativi, che si
manifestano nella società, dal momento che,
essendo molteplici e diversi gli interessi che
fanno capo alla persona umana, molteplici e
diversi possono essere le formazioni in cui
essa cerca di soddisfare i suoi bisogni.
L'articolo 2 racchiude, dunque, il principio
ispiratore della intera Costituzione, la
persona umana nella sua dimensione sociale,
che si trova in una posizione di primato, non
più di sudditanza e/o di soggezione nei
confronti dell'ordinamento statuale nuovo.
Ben può dirsi, che l'articolo 2 è l'articolo
che, secondo la significativa espressione di
Giorgio La Pira, «governa l'architettura di
tutto l'edificio costituzionale».
Dalla concezione di persona e di società
accolta nella Costituzione, discende anche il
principio di sussidiarietà, orizzontale e
verticale, su cui si è aperto un vasto
dibattito, in Europa, e si è formata una
abbondante letteratura, specie con il suo
formale inserimento nel Trattato istitutivo
dell'Unione europea, firmato a Maastricht il 7
febbraio 1992.
Nel nostro Paese, tale principio non era
esplicitato, come noto, nel testo
costituzionale del 1948. Si può dire,
tuttavia, che esso fosse presupposto proprio
per la predetta concezione di persona e
società in esso consacrato. È da rilevare,
comunque, che, ora, con la riforma del Titolo
V del 2001, il principio di sussidiarietà è
espressamente formalizzato.
Uno dei pilastri dell'edificio
costituzionale, secondo la terminologia
lapiriana, proiezione della dimensione sociale
della persona, è dato dal pluralismo sociale,
giuridico, istituzionale.
L'istanza pluralistica consente anche alla
persona di realizzare il suo sviluppo nelle
formazioni sociali a carattere territoriale comuni, province, regioni - che, non a caso,
la Repubblica, come è previsto nell'articolo 5
della Costituzione, riconosce e promuove come
comunità storicamente esistite ed esistenti,
che concorrono a costituire l'ordinamento
della Repubblica medesima, secondo le
disposizioni appunto del Titolo V, parte
seconda, della Costituzione.
Si tratta di un'altra «novità», molto bene
evidenziata dal presidente della Commissione
dei «Settantacinque», Meuccio Ruini, il quale
ricorda come essa riecheggi l'affermazione di
Stuart Mill che nelle autonomie locali si ha
un «ingrandimento della persona umana», e che
«senza istituzioni locali una nazione può
darsi un governo libero, ma non lo spirito
della libertà».
L'esperienza storica dimostra che la
promozione e la tutela del pieno sviluppo
della persona non si ottengono con il mero
riconoscimento di diritti, con la pur solenne
proclamazione della libertà e dell'eguaglianza
per tutti, come era avvenuto, in Europa, con
l'avvento della Rivoluzione francese e la
nascita della forma di Stato moderno, la cui
«monade costitutiva», come sottolineava
Vittorio Emanuele Orlando, era ritenuto, per
l'appunto, l'individuo, nato libero e eguale
nei diritti, naturali e imprescrittibili,
secondo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo
dell''89. Nonostante le solenni proclamazioni,
racchiuse nella Dichiarazione e nelle
Costituzioni successive, la grande maggioranza
dei cittadini veniva, infatti, a trovarsi in
condizioni di profonda e diffusa
disuguaglianza nei diritti politici, civili,
sociali, economici. Assume particolare
significato, ad esempio, la denuncia, fatta da
un noto esponente della destra storica, Sidney
Sonnino, della discrasia esistente, in Italia,
tra enunciazioni di libertà e di eguaglianza,
che, pur teorizzate dallo Statuto Albertino,
«restano affermazioni dottrinarie e gli
istituti di garanzia formale, in esso
previsti, tutelano in effetti gli interessi di
una oligarchia».
E amaramente concludeva che: «Quella
italiana è una libertà da tre soldi, che non
cammina e che, invece di dar vita a tutte le
forze della nazione per farle collaborare al
suo benessere e al suo vigore, li accascia con
tutte le debolezze proprie delle oligarchie
decrepite».
La situazione era destinata a cambiare, come
noto, sia pure in modo lento, travagliato, a
volte drammatico, con la industrializzazione,
la nascita e il diffondersi, in tempi diversi,
del movimento operaio, socialista e cattolico,
dei partiti di massa, dei sindacati, dello
stesso fascismo.
Il Legislatore costituente non poteva non
tener conto della esperienza vissuta, in
Italia e negli altri Paesi, dalla persona
umana nell'ordinamento prefascista e fascista;
non poteva non tener conto della immane
tragedia della seconda guerra mondiale, con la
morte di oltre cinquantacinque milioni di
persone innocenti, il loro annientamento
materiale e spirituale, in forme e misure che
non hanno eguali nella storia recente.
Giuseppe Dossetti ha individuato proprio
nella tragedia della seconda guerra mondiale
«la vera matrice della nostra Costituzione».
Eventi che hanno portato il nostro
Legislatore costituente non solo a porre, come
detto, la persona umana come valore originario
e finale dell'ordinamento nuovo, con i diritti
e doveri ad essa consustanziali, ma anche a
prevedere una serie di norme e di istituti,
diretti a costruire un ordine sociale
proiettato a consentire alla persona, a ogni
persona, di essere veramente tale, libera,
cioè, dai bisogni, dai condizionamenti, dalla
miseria che le impediscono di vivere veramente
la sua vita.
Tra questi, assume valore strategico
l'articolo 3. Dopo aver stabilito la «pari
dignità sociale» e l'eguaglianza davanti alla
legge dei cittadini, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di
condizioni personali e sociali, esso recita:
«È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese».
L'articolo 3 ha posto numerose questioni su
cui non è possibile soffermarsi. Ci limitiamo,
più semplicemente, a ricordare che il
Legislatore costituente, partendo dalla
constatazione, storicamente accertata, che
nella società esistono i suddetti ostacoli,
stabilisce che la Repubblica ovvero tutti gli
enti preposti a esercitare funzioni pubbliche
e i loro organi sono impegnati a rimuoverli
per consentire ad ogni persona il
raggiungimento del suo pieno sviluppo e la
partecipazione effettiva alla vita del Paese,
nelle sue diverse articolazioni.
In questa prospettiva, non esiste
separazione tra primo e secondo comma: l'uno
espressione della forma di Stato liberale,
fondato sull'eguaglianza formale delle
persone; l'altro, espressione della forma di
Stato sociale, proiettato a realizzare
l'eguaglianza in senso sostanziale.
I due commi dell'articolo 3 non sono
inconciliabili, ma interdipendenti, dal
momento che entrambi hanno la finalità di
eliminare le discriminazioni delle e tra le
persone, di diritto e di fatto, esistenti
nelle leggi e nella società, con l'obiettivo
di procedere a una graduale trasformazione
della società, promuovendo, per l'appunto, il
pieno sviluppo di ogni persona e uno Stato
strumento al servizio della persona.
Altra conseguenza che scaturisce dalla
impostazione di fondo richiamata è la
proclamazione, ad apertura del testo
costituzionale, che la «Repubblica è fondata
sul lavoro».
La disposizione è espressione di
accettazione, da parte del Legislatore
costituente, di un valore come denominatore
comune di tutte le persone, essendo il lavoro
elemento di vita e di sviluppo, che, secondo
l'insegnamento di Costantino Mortati
costituisce la sintesi fra il principio
personalistico (che implica la pretesa
all'esercizio di una attività lavorativa) e
quello solidarista (che conferisce a tale
attività carattere doveroso).
La Costituzione, assumendo, quindi, il
lavoro come criterio di qualificazione del
merito, impone alla Repubblica di creare le
condizioni per realizzare, nel rispetto anche
della libertà di iniziativa economica privata
e dell'economia di mercato, una efficace
politica di sviluppo per evitare, tra l'altro,
quella specie di «agonia» per la persona, che
è la disoccupazione, e dare effettività alla
eguaglianza, alla dignità di ogni persona,
alla libertà, che non sia, pertanto, quella
libertà da «tre soldi» di cui parlava Sidney
Sonnino.
La Costituzione vuole coniugare, non
contrapporre, libertà ed eguaglianza, e
realizzare una democrazia sociale, politica,
economica, nella prospettiva storica di una
operante solidarietà.
Strettamente correlata con la richiamata
concezione della persona umana è la
proclamazione, carica di significati giuridici
e politici, contenuta nell'articolo 1 della
Costituzione, che «l'Italia è una repubblica
democratica» e che «la sovranità appartiene al
popolo che la esercita nelle forme e nei
limiti stabiliti dalla Costituzione».
La democrazia non può trovare fondamento che
nella persona umana: «Nessun regime
democratico potrebbe consolidarsi se non fosse
diffusa e compenetrata - scriveva Costantino
Mortati - nella coscienza comune la credenza
ineffabile di ogni persona umana, quale che
sia la sua condizione, credenza che può essere
alimentata non già dal ritenere l'uomo mero
prodotto dell'ambiente, bensì dal risalire
alla sua origine divina, ai diritti congeniti
e inalienabili che da essa derivano».
Vasta e complessa è la problematica che
scaturisce dall'articolo 1, che contiene la
sintesi generalissima dei caratteri della
forma di Stato e i criteri ermeneutici
necessari per svelarne la portata.
In esso, si proclama che la sovranità è
attribuita al popolo in titolarità e in
esercizio, al popolo inteso non quale entità
astratta, mistica o spirituale, ma come
insieme di cittadini, ciascuno individuato
nella sua storica concretezza, ciascuno
titolare di situazioni giuridiche a carattere
costituzionale, che ciascuno esercita in forma
singola e collettiva nella comunità, ripartita
nelle diverse formazioni sociali, in comunità
territoriali, che la stessa Costituzione
individua, come fa, ad esempio, con gli
articoli 114 e 131, in riferimento ai comuni,
alle province, alle regioni e in altre entità
(partiti, sindacati ecc.), ove si svolge la
sua personalità.
Il dato rilevante, dunque, è che il
Costituente non si è limitato a dichiarare la
semplice spettanza della sovranità al popolo,
ma ha voluto stabilire che al popolo
appartiene l'esercizio della sovranità. In
questa scelta, è stata anche vista una svolta
rivoluzionaria, rispetto all'ordinamento
statutario, nato «oligarchico» e rimasto «predemocratico».
Occorre evidenziare, a tal proposito, un
dato esplicitato nella stessa Costituzione:
l'articolo 1, secondo comma, nel dichiarare
che la sovranità appartiene al popolo,
aggiunge che l'esercizio relativo sarà svolto
«nelle forme e nei limiti della Costituzione».
Il che significa, tra l'altro, che l'esercizio
della sovranità non è illimitato, ma è
limitato ed è disciplinato dalla stessa
Costituzione, che, fuori dalla Costituzione e
dal diritto - commentava, già nel 1948, Carlo
Esposito - non c'è sovranità, ma l'arbitrio
popolare, e che la Costituzione viene ad
assumere una posizione di supremazia, rispetto
a tutti gli altri normativi, il cui garante e
promotore è la Corte costituzionale. Si tratta
della consacrazione di uno dei principi del
costituzionalismo contemporaneo derivante
dall'ordinamento degli Stati Uniti d'America.
Tra i corollari più vistosi, derivanti
dall'articolo 1, è che la Costituzione ha dato
formale consacrazione a quella che era già una
tendenza del periodo prefascista, il trapasso,
cioè, della «sovranità» dal Parlamento al
popolo, ovvero a tutti i cittadini, viventi e
operanti in una pluralità di formazioni
sociali. Partiti, sindacati, enti locali
territoriali, altre formazioni sociali in cui
la persona, il cittadino vive e opera, sono
concepiti come strumenti di penetrazione della
società, nella sua multiforme e variegata
realtà, nelle istituzioni, viste anch'esse
come strumenti al servizio della società.
L'obiettivo è, tra l'altro, quello di portare
al superamento della contraddizione tra
società civile e stato, tra Paese reale e
Paese legale, che ha caratterizzato la storia
italiana dopo l'unificazione.
Si può dire che la Costituzione delinei
quella che Giuseppe Capograssi, in una
penetrante e lungimirante analisi delle cause
e degli effetti della trasformazione della
società e del conseguente ruolo dello Stato,
chiama la «nuova democrazia diretta». Nuova
democrazia diretta, fondata sul primato della
società, di palpitante attualità, nei suoi
profili generali, che merita un'attenta
riflessione a parte.
È alla luce dei principi ricordati che
debbono essere interpretati, anche, gli
articoli della Costituzione dedicati ai
«rapporti economici e sociali», che
riconoscono e garantiscono, tra l'altro,
l'iniziativa economica privata, l'impresa, la
proprietà, la cooperazione, come oggetto di un
diritto e di una libertà della persona, come
manifestazione specifica della sua personalità
in formazioni sociali cui è possibile dare
vita. È appena il caso, in questa sede, di
sottolineare che dalle norme costituzionali
emerge chiaramente che l'attività economica,
in ogni sua forma, di gestione della
proprietà, di impresa, di prestazione del
lavoro, è libera e deve essere finalizzata al
perseguimento del «razionale sfruttamento» dei
beni, di «equi rapporti sociali», della
«funzione sociale», della «utilità sociale».
Il fine immediato cui è indirizzata e
coordinata la disciplina costituzionale dei
«rapporti economici» è, per l'appunto, la
«utilità sociale», il progresso economico
della società attraverso cui ogni persona può
trovare sviluppo, sicurezza, libertà, dignità,
per adoperare la stessa terminologia della
Costituzione.
In questo contesto, l'economia, al pari di
ogni altra forma di attività umana, non può
sottrarsi alle norme che la società si è data.
Essa e la sua organizzazione sono al servizio
della persona al cui sviluppo, dunque, i
meccanismi dell'economia di mercato debbono
operare.
Un altro principio fondamentale che concorre
a caratterizzare la forma di stato delineata
nella Costituzione repubblicana è il principio
supernazionale, affermato, in particolare,
negli articoli 10 e 11 della Costituzione
medesima, che stabiliscono, tra l'altro,
l'adattamento automatico delle norme di
diritto internazionale generalmente
riconosciute, ossia la loro immissione diretta
nell'ordinamento; il ripudio della guerra come
strumento di risoluzione delle controversie
internazionali; la promozione e l'adesione,
anche mediante limitazioni della propria
sovranità in condizione di parità con gli
altri Stati, alle organizzazioni
internazionali dirette a realizzare un
ordinamento internazionale che assicuri la
pace e la giustizia fra le nazioni. E si sa
bene che la pace, come non si è stancato di
sottolineare, nel suo lungo pontificato,
Giovanni Paolo II, «si riduce al rispetto dei
diritti inviolabili dell'uomo - opera di
giustizia e di pace - mentre la guerra nasce
dalla violazione di questi diritti e porta con
sé ancor più gravi violazioni di essi». La
Costituzione vuole attuare un sistema di
rapporti tra gli Stati imperniato sul
principio del reciproco rispetto e di
solidarietà.
Alla luce di queste concezioni, Piero
Calamandrei, a chiusura di un lungo saggio
sulle vicende storiche che precedettero
l'elaborazione della Costituzione
repubblicana, notava acutamente, nel 1950,
come, dalle tante «finestre» aperte dalla
Costituzione verso l'avvenire, poteva
intravedersi negli articoli citati, «qualcosa
che potrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa
e del Mondo». È appena il caso di sottolineare
che il processo di creazione dell'unità
economica, politica e sociale dell'Europa è un
processo in atto che dovrà continuare ad
essere perseguito con determinazione.
La forma parlamentare
Nel quadro delineato, debbono operare
istituti e organi della forma di governo
parlamentare, prescelta dal Legislatore
costituente, già all'inizio dei lavori
dell'Assemblea, e qualificata, per gli aspetti
problematici che presenta, che altererebbero
il suo schema «classico», forma di governo
parlamentare «razionalizzata a tendenza
equilibratica», a «multipartitismo estremo».
Ma, al di là delle formule, significative
certo, ma, oggi, tutte in fase di
risistemazione per le riforme in atto,
costituzionali e non, sembra utile ricordare
che la Costituzione ha istituito una pluralità
di organi - Camera, Senato, presidente della
Repubblica, Corte costituzionale, governo,
presidente del Consiglio dei ministri,
Consiglio superiore della magistratura - di
cui ha anche determinato direttamente le
funzioni, il carattere monocratico e
collegiale, il sistema di elezione, i criteri
per la loro formazione e composizione, la
responsabilità e la irresponsabilità, le
prerogative, ciascuno con una propria sfera di
competenza, che non si contrappone né è
separata l'una dall'altra, ma reciprocamente
coordinata, armonizzata, interdipendente,
secondo il principio non della separazione dei
poteri, ma del principio dei checks and
balances, ciascuno istituzionalmente preposto,
secondo le funzioni attribuite, a concorrere,
a dare concretizzazione ai principi e ai
diritti consacrati nella Costituzione, a
soddisfare i bisogni della società, del
popolo, che viene a porsi come la fonte
originaria di ogni potere, a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, per
raggiungere le finalità di cui parla il citato
articolo 3.
Il Legislatore costituente ha dato anche
vita a una serie di istituti di garanzia, di
ordine formale e sostanziale, finalizzati a
evitare la violazione della Costituzione, di
cui ha affermato la supremazia e la
conseguente rigidità, garantita da una
procedura aggravata per l'approvazione delle
leggi di revisione costituzionale e delle
leggi costituzionali, da limiti, espliciti e
impliciti, alla sua revisione, dal controllo
di costituzionalità delle leggi, ad opera di
un organo appositamente creato, la Corte
costituzionale, per l'appunto. È appena il
caso di rilevare che un altro organo supremo è
preposto a garantire la Costituzione, sia pure
in momenti e forme diversi, rispetto al
giudice delle leggi: il presidente della
Repubblica.
Non mancano altri organi istituzionalmente
competenti a garantire, in posizione di
indipendenza e autonomia, diritti e interessi
ai cittadini, come sono naturalmente gli
organi della giurisdizione, ordinaria,
amministrativa, contabile, e, da qualche
decennio, le Autorità indipendenti.
Fra intesa e compromesso
Ho cercato di richiamare, a grandi linee, la
ispirazione di fondo della Costituzione, i
principi fondamentali che la caratterizzano,
nella forma di Stato e nella forma di governo,
intorno a cui gli esponenti più significativi
dei partiti, rappresentati all'Assemblea
costituente, si sforzarono di trovare un
solido e ampio terreno d'intesa, come
attestano i lavori preparatori e la votazione
finale, il 22 dicembre 1947, sul testo
definitivo della Costituzione: deputati
presenti e votanti 515; maggioranza richiesta
258; voti favorevoli 453; voti contrari 62.
Non si ignora, di certo, la critica che la
Costituzione è, nel suo complesso, espressione
di un «compromesso». È così e non avrebbe
potuto essere diversamente in presenza di
un'Assemblea elettiva, costituita non da
rappresentanti di un unico partito, come è
accaduto e accade in Paesi dove la democrazia
non c'è, ma da rappresentanti di tutti gli
orientamenti politici e culturali esistenti
nella società italiana. Si tratta di una
critica facile, ripetuta meccanicamente come
un ritornello, anche nei tanti discorsi in
Assemblea costituente, ignorando e/o volendo
ignorare che il «compromesso» è connaturato a
un ordinamento democratico, come già Kelsen
aveva sottolineato, negli anni venti, e Jürgen
Habermas ha ricordato più recentemente.
Senza poi dire che sulla ispirazione di
fondo, sui principi ricordati non ci fu
neanche il «compromesso», ma una intesa, come
si ricava dai lavori preparatori. Va a merito
dei Costituenti aver messo da parte le
differenti e contrapposte posizioni di cui
erano portatori, al fine di dar vita a una
Costituzione in cui tutti o quasi gli Italiani
potessero riconoscersi.
La maggioranza così ampia raggiunta, tale da
superare largamente i due terzi dei componenti
l'Assemblea, rappresentò, quindi, una «felice
convergenza» di opinioni, secondo Aldo Moro;
l'«espressione concorde» della volontà della
grande maggioranza degli italiani, secondo
Lelio Basso; la «unità necessaria» per fare,
come affermò Palmiro Togliatti, la
Costituzione non dell'uno o dell'altro
partito, non dell'una o dell'altra ideologia,
ma la Costituzione di tutti i lavoratori
italiani e, quindi, di tutta la nazione.
I ricordati principi fondanti della
Costituzione del 1948 non solo non sono
invecchiati, e tanto meno superati, ma sono
vivi e attuali, oggi più che mai.
A differenza di quanto pregiudizi di varia
specie e natura e letture ideologiche o
superficiali hanno potuto e possono far
ritenere, essi sono in grado di soddisfare le
istanze provenienti e presenti nella società
contemporanea complessa e articolata, nel
rispetto dei vincoli, europei e
internazionali, assunti dal Paese.
La persona umana, con i diritti e i doveri,
vecchi e nuovi, ad essa connaturati; la
democraticità dell'ordinamento; la sovranità
popolare; la partecipazione di tutti i
cittadini all'esercizio del potere; il
pluralismo delle e nelle istituzioni e della
società; il lavoro; la famiglia; la religione;
la cultura; l'ambiente; la salute; la pace;
l'eguaglianza formale e sostanziale; la
solidarietà; la giustizia; la identificazione
dell'Italia con la Repubblica, le limitazioni
di sovranità, in condizioni di parità con
altri Stati, necessarie per assicurare la pace
e la giustizia tra le nazioni, ad esempio, non
sono termini mistificatori, usati per coprire
un sistema di potere, propri di una classe o
di un partito, ma sono termini che esprimono
principi, valori, bisogni, aspirazioni di base
della società di oggi, della persona vivente
nel «villaggio globale», nell'epoca della
rivoluzione scientifica e tecnologica, e
intorno a cui ricostituire, pur nella naturale
dialettica delle idee e degli interessi, il
frantumato tessuto connettivo della società
italiana, come recentemente ha sottolineato
anche il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, nel messaggio di insediamento.
Una conferma della loro attualità può anche
trovarsi nei non pochi atti approvati da
organismi internazionali, dal 1948, che non è
possibile richiamare; nelle Costituzioni,
adottate, nel sessantennio, da diversi Stati;
nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, nei Trattati di
Maastricht e di Amsterdam e nello stesso
«Trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa».
Atti tutti che, sia pure con diversa
accentuazione, affermano la centralità della
persona umana, della sua dignità, dei diritti,
di diversa specie, che ad essa fanno capo,
valori, principi, che emergono sempre più come
patrimonio comune dei Paesi operanti nel nuovo
spazio costituzionale europeo.
Si rende indispensabile, tuttavia, che essi
siano tradotti, più e meglio di quanto sia
avvenuto nel sessantennio trascorso, in prassi
operative a tutti i livelli - politico,
economico, sociale, giudiziario,
amministrativo - e penetrino nelle coscienze
dei cittadini, ne diventino patrimonio comune.
Si sa bene che la strada per la loro
affermazione è ancora irta di ostacoli.
Tuttavia, bisogna operare per renderla
effettivamente concreta. Che è poi la
concretizzazione di un «mondo umano», ovvero,
per adoperare le significative parole di
Giuseppe Capograssi, di un «mondo umano cioè
giusto, di una giustizia realizzata con mezzi
giusti, e libero, di una libertà realizzata
per mezzo della libertà. Mondo umano della
storia: mondo fatto dagli uomini, per gli
uomini, ma umanamente, cioè rispettando l'uomo
e le leggi profonde e le profonde esigenze
spirituali dell'umanità».
Il giurista, il costituzionalista, in
particolare, non meno del politico di
professione, hanno il dovere di lottare per la
edificazione di questo mondo umano, nella
consapevolezza che, oggi, la «lotta per il
diritto», per riprendere la efficace locuzione
di Rudolf von Jhering, è lotta per la persona
umana, per l'affermazione dei suoi diritti e
dei suoi doveri, essendo, peraltro, la persona
umana, secondo la plastica espressione di
Antonio Rosmini, «diritto umano sussistente».
Le pur rapide considerazioni svolte
testimoniano, tra l'altro, come scriveva Paolo
Barile, che la «cultura dei costituenti, non
era una cultura del passato, ma anzi,
sorprendentemente, del futuro. Essa li portò a
scrivere una Costituzione che, come Gustav
Mahler diceva della sua musica, «era destinata
non ai contemporanei, che erano sgradevolmente
colpiti dalla sua novità, ma ai posteri».
Conclusioni
In questo sessantennio, il processo di
trasformazione economica, sociale, culturale
del Paese si è realizzato, nell'alveo della
Costituzione, che ha garantito, pur in mezzo a
tante difficoltà e tragedie, libertà, sviluppo
e democrazia, in misura che non trova
riscontro in nessun'altra epoca della nostra
storia.
Nessuno, tuttavia, può negare la esistenza
di gravi disfunzioni delle e nelle
istituzioni, centrali e periferiche; l'enorme
debito del bilancio dello Stato; le mancate
riforme strutturali dell'economia; i ritardi
nei processi di liberalizzazione e di
privatizzazione; la diffusa corruttela; la
persistente illegalità.
Questi e altri fenomeni sono da addebitare a
una Costituzione malfatta o non piuttosto a
una classe politica che, per molteplici
ragioni, non ha saputo o potuto realizzare il
disegno di un ordinamento statuale nuovo,
concepito come strumento al servizio della
persona e della società, delineato nella
Costituzione del 1948? Invero, le cause di
questi fenomeni estremamente negativi per lo
sviluppo del Paese sono da ricercare non nelle
manchevolezze, nelle imperfezioni che nessuno,
peraltro, ha mai negato e nega, della
Costituzione, ma nella crisi che, per diverse
ragioni, ha colpito, per decenni, i partiti, i
rapporti tra i partiti, tra i partiti e la
società civile e nella conseguente incapacità
di dare vita a una maggioranza in grado di
assolvere a quella che è la sua funzione
propria: governare. Era inevitabile che la
crisi si riverberasse anche nelle supreme
istituzioni dello Stato, costituite da uomini
scelti dai partiti, che alla logica di
partito, quando non di corrente, hanno
obbedito e obbediscono. Si è assistito e si
assiste così a una costante inadeguatezza
delle istituzioni investite della funzione di
«direzione» politica, tant'è che si è potuto
parlare del Parlamento «esautorato» dal
governo; del governo «supplito» dai partiti; i
partiti, a loro volta, «suppliti» dai
sindacati. I «vuoti», lasciati liberi dalle
istituzioni inattive, sono stati riempiti in
forma, misura e tempi diversi, dalle
istituzioni «garantistiche» (presidente della
Repubblica, Corte costituzionale, ordine
giudiziario) che hanno cercato, per quanto
possibile, di far valere «l'imperio della
Costituzione» nei confronti di tutti gli
operatori politici.
Il nodo è, dunque, essenzialmente politico e
il problema vero, allora, non sembra quello di
dare al Paese una Costituzione diversa da
quella elaborata e approvata dall'Assemblea
costituente sessant'anni fa.
Le brevi considerazioni svolte non vogliono
però significare che la Costituzione sia
immodificabile. Si sa bene che essa non è il
Vangelo, il Corano o il Talmud, e che la
stessa Costituzione prevede, del resto,
all'articolo 138, la possibilità della propria
revisione, secondo procedure e maggioranze
stabilite, nei limiti, espliciti e impliciti,
che la Corte costituzionale ha individuato,
già nella sentenza n. 1146 del 29 dicembre
1988.
Anche da parte mia, peraltro, nel lontano
1975, è stata proposta una modifica della
Costituzione con la trasformazione del Senato
in «Camera delle Regioni», ispirata
fondamentalmente dall'intento di risolvere i
problemi del sistema bicamerale paritario e
dei rapporti tra Stato e regioni, nel
processo, avviato all'Assemblea costituente e
rimasto incompiuto, di costruzione dello Stato
regionale, come si diceva allora, oggi detto
di tipo federale, nella salvaguardia
dell'unità e della indivisibilità della
Repubblica.
Non si è affatto contrari, dunque, a
riforme, puntuali e ben definite, di
disposizioni della Costituzione, che, alla
luce dell'esperienza, abbiano mostrato di
sentire l'usura del tempo e delle circostanze.
A mio avviso, le riforme debbono essere
dirette non a istituzionalizzare forme di
governo di tipo plebiscitario o cesaristico,
ma a dare rinnovata vitalità, maggiore
funzionalità, sicura stabilità al governo.
Obiettivo che è possibile raggiungere con
meccanismi adeguati e coerenti con una forma
di governo parlamentare razionalizzata, da
inserire nel testo costituzionale e nei
regolamenti parlamentari, e con l'adozione di
una legge elettorale idonea alla formazione di
una maggioranza omogenea, capace di dare
attuazione all'indirizzo politico di cui è
espressione. Mi sembra, altresì, urgente
procedere alla richiamata trasformazione del
Senato in organo di rappresentanza delle
regioni, sul tipo dello Stato federale
tedesco, nel pieno e inequivoco rispetto
dell'unità e dell'indivisibilità della
Repubblica.
Verrebbe così a realizzarsi compiutamente
l'ordinamento statuale, delineato nella
Costituzione del 1948, in grado, nei suoi ben
definiti livelli di governo, nella dimensione
europea, di operare come strumento di
liberazione e di promozione della persona
umana, di ogni persona umana, senza
distinzione alcuna.
Nicola Occhiocupo
(«il Mulino» n. 426/06)
Fare luce e produrre energia
- I prodigi e gli effetti rivoluzionari
dell'elettricità e dei suoi derivati. Un denominatore comune ha collegato come in
una filiera le più importanti innovazioni di
sistema che si sono susseguite negli ultimi
cent'anni. Ossia quelle innovazioni che hanno
determinato un mutamento radicale di scenario
e di prospettiva. È l'elettricità con i suoi
effetti cumulativi e a catena sia sul versante
economico e tecnologico che
nell'organizzazione sociale.
Da un lato l'elettrificazione ha segnato il
compimento della seconda rivoluzione
industriale, la progressiva automazione di
impianti e macchinari, e la comparsa di nuove
forme di comunicazione, per poi dare il via
agli esordi dell'informatica. Dall'altro, ha
contribuito a trasformare modi e stili di
vita, e a alleviare le fatiche entro le pareti
domestiche; e ha assecondato, moltiplicando
risorse e servizi collettivi, la formazione di
una società di massa e di un'economia sempre
più terziarizzata.
Tuttavia si usa definire il Novecento come
«il secolo dell'automobile»; mentre quello che
l'ha preceduto è passato alla storia come il
«secolo del vapore».
Come si spiega che all'elettrificazione
nelle sue diverse valenze non sia stato
riconosciuto il ruolo dominante e pervasivo
che pur ha esercitato nel corso del Novecento?
Il fatto è che l'energia elettrica si
diffuse su larga scala soltanto nel primo
ventennio del Novecento. Dunque, troppo tardi,
per detronizzare la macchina a vapore dal
piedistallo in cui era assisa dall'inizio
dell'Ottocento (da quando l'«acqua che bolle»
di James Watt aveva cominciato a imprimere
cadenze più impetuose alla produzione
industriale e inaugurato l'epoca dei piroscafi
e delle strade ferrate). Ma l'espansione delle
centrali idroelettriche è anche avvenuta
troppo tardi per tenere testa con successo
all'irruzione sulla scena dell'automobile con
cui Henry Ford (da quando comparve nel 1909 il
famoso «modello T») tenne a battesimo l'era
della motorizzazione di massa.
D'altra parte, la macchina a vapore e il
motore a combustione interna avevano dalla
loro un vantaggio che il «carbone bianco» non
possedeva, quello della visibilità, in ragione
della loro intrinseca natura di entità
materiali, immediatamente percepibili tanto
nelle loro concrete fattezze che nel loro modo
di funzionare. Basti pensare, da un lato, alla
poderosa struttura di una rombante locomotiva
con le sue bielle e con le sue grandi ruote;
dall'altro, all'involucro tirato a lucido,
composto per metà da congegni meccanici e per
metà da un abitacolo, piazzato su quattro
ruote e in grado di lanciarsi in corsa per
ogni dove.
In entrambi i casi si trattava di oggetti
tangibili e di cui era relativamente facile
comprendere come e con quali pezzi fossero
stati realizzati. Tutt'altro, quindi, della
scintilla scoccata fra i conduttori della pila
di Alessandro Volta, quale generatrice di una
forza cinetica che, racchiusa poi in un
trasformatore di corrente alternata, veniva
trasmessa a lunghe distanze dalle viscere
delle centrali idroelettriche.
A quanti assistettero nell'ultimo
quindicennio dell'Ottocento all'accensione
delle prime lampade ad arco per
l'illuminazione pubblica, in sostituzione
delle insicure lanterne a gas e dei vecchi
lumi a petrolio, l'elettricità sembrò insomma
una sorta di fluido magico, di fenomeno
sovrannaturale. E Thomas Edison, che per primo
aveva impiantato nel 1882 una centrale nel
cuore di New York, assunse, per alcuni suoi
contemporanei, le sembianze di uno «stregone»,
di un personaggio con capacità altrettanto
mirabolanti che misteriose. E a altri egli
apparve come un novello Prometeo che aveva
sottratto agli dei il fuoco del sapere, di un
sapere benefico e portentoso, per farne dono
agli uomini.
In effetti, quale altro ritrovato avrebbe
potuto eguagliare le virtù innate e le
applicazioni a cascata dell'elettricità? Essa
aveva prodotto, innanzitutto, il miracolo di
annullare la distinzione fra il giorno e la
notte, diradando d'un colpo le tenebre che
fino a allora avevano avvolto d'oscurità quasi
metà dell'esistenza quotidiana dell'uomo.
Dal «Ballo Excelsior» al Manifesto del
futurismo la luce cristallina e affascinante
della lampada a incandescenza di Edison venne
perciò celebrata come si trattasse di una
stupenda Sheherazade o di una «creatura
divina». E assurse così a metafora sublime
della civiltà, della forza creatrice
dell'intelletto, della ragione e della
scienza, in antitesi con i vincoli retrivi
dell'oscurantismo e del misoneismo. D'altra
parte, quale emblema allegorico più pregnante
del fulgore della luce avrebbe potuto
esercitare un impatto più eclatante
nell'immaginario collettivo all'alba di un
secolo che sembrava possedere lo splendore e
le connotazioni elegiache di una Belle Epoque?
Ma l'illuminazione non era che uno dei tanti
prodigi scaturiti dall'avvento
dell'elettricità. Insieme alla luce, essa
produceva all'istante calore, energia, forza
motrice. Nella combinazione di questi vari
elementi stava infatti l'essenza, e, insieme,
il tratto distintivo, della tecnologia
elettrica. Una tecnologia che, grazie alla sua
versatile convertibilità e flessibilità, aveva
la capacità di generare in continuazione nuovi
strumenti utili e campi d'impiego per il
miglioramento delle condizioni di vita
individuali e collettive, nuove soluzioni
organizzative e nuove sinergie in ogni campo
d'attività, nuove opportunità di crescita
economica e di benessere materiale.
Inoltre, l'elettricità si rivelò in tempi
relativamente brevi, rispetto a ogni altra
fonte di energia utilizzata in passato, una
risorsa accessibile a tutti indistintamente,
trasferibile da un luogo all'altro, e
estensibile a ogni latitudine. Di fatto essa
valse a standardizzare e a accelerare i
sistemi di produzione e i procedimenti di
lavoro; a rendere possibile (rispetto alle
vecchie localizzazioni) la diffusione
territoriale a raggiera delle imprese di ogni
genere; a far marciare tramvie, metrò e treni;
a accrescere il patrimonio di equipaggiamenti
e infrastrutture.
Non è poi il caso di spendere troppe parole
sul ruolo che l'elettrificazione ha svolto nel
trasformare molti aspetti della vita sociale
tanto nella sfera pubblica che in quella
privata. È noto come essa abbia corrisposto a
un numero incalcolabile di esigenze, e
influenzato orientamenti e modelli di
comportamento. E ciò, man mano che, dagli anni
Trenta in poi, si propagò dalle principali
città ai centri minori, ai borghi di campagna,
e via via che la gamma poliedrica delle sue
applicazioni divenne alla portata anche delle
classi popolari, dei ceti più minuti.
Di fatto, se nella prima metà del Novecento
si ebbe la sensazione di vivere in un'epoca
animata da continue mutazioni, da cadenze
assai più rapide e intense rispetto al
passato, quest'impressione fu dovuta in misura
rilevante al profluvio di novità introdotte e
sviluppatesi sulla scia dell'elettricità. Dato
che esse valsero a modificare la percezione
dello spazio e del tempo, riducendo le
distanze fra luoghi ancorché assai lontani,
riproducendo voci e suoni in diretta, e
accelerando il movimento di uomini e di mezzi.
Perché questo fu l'effetto che produssero,
ognuno per la sua parte, nuovi strumenti di
comunicazione come il telegrafo, il telefono e
la radio nonché i mezzi di trasporto
collettivi azionati da grandi motori e da
apparati elettrici.
In considerazione delle caratteristiche e
delle dinamiche peculiari di una risorsa come
l'elettricità, si spiega anche come essa sia
stata considerata, al suo apparire, una chiave
di volta per l'espansione dell'economia
capitalistica e, allo stesso tempo, per
l'edificazione di un'economia socialista.
Da un lato, l'elettrificazione accrebbe
infatti nei paesi occidentali le potenzialità
delle più grosse concentrazioni industriali
con tendenze oligopolistiche e le compagnie
elettriche, attraendo sui propri titoli
un'ingente massa di risparmi, contribuirono
allo sviluppo dei mercati finanziari.
Dall'altro, la massimizzazione in tempi
rapidi delle applicazioni elettriche apparve
in Unione Sovietica una sorta di scorciatoia
per il passaggio da una condizione di relativa
arretratezza economica allo stadio di uno
sviluppo avanzato, nell'ambito di un sistema
collettivista. E ciò all'insegna del teorema
di Lenin per cui il comunismo sarebbe stato il
risultato di un binomio fra politica e
tecnologia, fra il potere dei Soviet e il
ruolo propulsivo dell'elettrificazione.
Realtà e mito, risvolti pratici e valori
simbolici, interessi concreti e aspettative
palingenetiche sono andati perciò
intrecciandosi lungo il percorso di quello
che, al suo avvento, appariva del resto ai
contemporanei il prodotto della scienza
positivista e, insieme, di un incantesimo
miracoloso.
Sta di fatto che nella valorizzazione delle
attitudini e delle proiezioni sempre più
estese della tecnologia elettrica, quali sono
andate manifestatesi nella seconda metà del
Novecento, ha finito per avere la meglio
l'economia capitalistica. E ciò per due motivi
fondamentali.
In primo luogo, perché essa ha convertito
alcuni prodotti scaturiti dagli sviluppi
dell'elettrificazione (dagli elettrodomestici,
alla televisione, agli audiovisivi) in
altrettanti beni di consumo durevoli,
destinati da un lato a fare della casa di
ognuno una sorta di terminale a rete della
filiera elettrica, e dall'altro a moltiplicare
le forme di svago e d'intrattenimento, di
fruizione del tempo libero. Così che
quest'insieme di beni e di servizi ha finito
per divenire un emblema per eccellenza di una
società affluente.
In secondo luogo, un'importanza rilevante
hanno avuto i fattori d'ordine strutturale.
Nei paesi dell'Occidente, in quanto
caratterizzati da un assetto economico
competitivo e propenso all'innovazione
rispetto al burocratismo e alla progressiva
sclerosi del «socialismo sociale», si è giunti
nel corso degli anni Ottanta a porre le basi
in anticipo dell'informatica e della
multimedialità. E ciò grazie ai forti
progressi conseguiti nel campo
dell'elettronica e delle telecomunicazioni
che, dopo aver segnato l'irruzione sulla scena
del robot e del computer, hanno visto
l'incorporazione dell'intelligenza artificiale
in nuove apparecchiature sempre più
miniaturizzate e sofisticate.
Giunti a questo punto, c'è da domandarsi se
oggi si deve considerare concluso il ciclo
dell'elettricità, nel suo ruolo di vettore di
tante trasformazioni. O se, invece, c'è da
pensare che quanto ora siamo portati a
ritenere qualcosa di prodigioso non sarà reso
obsoleto da qui a pochi anni da ulteriori
sviluppi, da un nuovo salto di qualità.
Di certo, quel che si può dire è che le
applicazioni dell'elettronica non finiscono di
stupirci. Non solo la microelettronica, per la
sua natura di tecnologia trasversale, ha
modificato i processi decisionali e i sistemi
di produzione convertendoli da verticali in
orizzontali, segnando così il passaggio delle
imprese a un'organizzazione modulare e a rete.
Ma, quel che più colpisce, è il suo ultimo
ritrovato. Il prodotto informatico è infatti
un bene che sfida l'immaginazione, in quanto è
tale da non essere consumato né dal tempo né
dallo spazio, e perciò immagazzinabile e
costantemente recuperabile.
In sostanza l'ultima «rivoluzione
silenziosa» dell'elettricità, quella dei
microchips, ha segnato l'alba di una nuova era
in cui la rilevanza della materia sta
lasciando il posto a quella delle idee e dei
saperi, grazie alla loro elaborazione e
memorizzazione in sistemi computerizzati di
sempre maggior potenza e funzionalità.
Pertanto, si può ben dire che sia ancora
l'elettricità, grazie alle sue più recenti e
mirabili applicazioni, a recitare una parte da
protagonista. Poiché essa ha fatto da
battistrada alla rivoluzione post-industriale
e è un elemento basilare del processo di
globalizzazione sia del mercato sia
dell'economia della conoscenza.
Vorrei fare, in conclusione, una
considerazione di carattere generale. Molti
oggi temono gli effetti prorompenti della
tecnoscienza, ossia il pericolo che essa si
trasformi da mezzo in fine a se stessa. Invece
che il progresso civile e la padronanza
assoluta della natura, che in tal modo pensava
di conseguire, l'uomo si troverebbe sotto il
dominio totalizzante di un'entità anonima e
onnipotente come la tecnologia. In realtà, la
scienza e la tecnica presentano, alla stessa
stregua di una medaglia, due facce, il diritto
e il rovescio. Dipende perciò dal modo con cui
ce ne avvaliamo, il ruolo in positivo o meno
che esse possono esercitare.
Di fatto, quantunque sia giunta a
racchiudere in sé potenzialità sempre più
estese, la tecnoscienza va considerata per
quello che è: non di più di una leva che sta a
noi usare, per quel che ci può dare, in modo
razionale e secondo prospettive corrispondenti
tanto ai bisogni effettivi della collettività
quanto a determinate norme etiche e
compatibilità di carattere ecologico.
A questo riguardo è evidente come spetti
innanzitutto ai leader politici il compito di
effettuare delle scelte responsabili e
confacenti a un buon uso della tecnologia. Ma
anche la comunità scientifica non può
sottrarsi al dovere di valutare e ponderare le
conseguenze in un senso o nell'altro di quel
vasto potenziale di risorse e di cognizioni di
cui essa è l'agente principale e che passa in
primo luogo per le sue mani.
Valerio Castronovo
(«Prometeo» n. 96/06)
RU-486: la «pillola della discordia»
- Storia, vantaggi e rischi del
mifepristone, una scoperta avvenuta quasi per
caso e divenuta uno dei progressi scientifici
più controversi della storia dei farmaci. Dal 1988 a oggi, in Francia sono stati
eseguiti più di 1,2 milioni di aborti non con
un intervento, ma con il ricorso a un farmaco,
il mifepristone, che causa un aborto
spontaneo. Dal 2000 a oggi negli Stati Uniti
vi sono stati 500.000 aborti per via chimica
con lo stesso farmaco, il cui mercato si
estende dalla Cina a diversi paesi europei,
passando per Israele. Non per l'Italia,
tuttavia, dove non è stato ancora registrato,
e pochi mesi fa è stato motivo di contrasto
tra l'ex ministro della salute Storace e
qualche ASL che ne voleva introdurre
l'impiego. Il mifepristone - meglio noto con
la sigla RU-486 con cui fu contrassegnato
dall'azienda che lo scoprì - è il primo di una
nuova generazione di farmaci per il controllo
delle nascite, utile per causare l'aborto
spontaneo (vedremo in quali condizioni), come
contraccettivo d'emergenza e per altri scopi.
Agisce bloccando soprattutto i recettori del
progesterone, ovvero le serrature chimiche che
permettono a questo ormone di sostenere la
gravidanza, e, preso assieme alle
prostaglandine, si è dimostrato utile allo
scopo nelle prime nove settimane di
gestazione.
In sintesi, i vantaggi della tecnica
dell'aborto chimico rispetto a quella
alternativa dell'aspirazione praticata sinora
sono la maggiore praticità, il minor rischio
d'infezione e il maggior rispetto della
privacy della donna durante un'esperienza che
crea un comprensibile disagio psicologico.
D'altra parte, come accade spesso con ogni
altro farmaco, la sua applicazione ha
dimostrato che la RU-486 può essere fonte di
sgradite sorprese. Un fatto, questo,
particolarmente enfatizzato dagli ambienti
religiosi più conservatori, che, non solo in
Italia, portano avanti da anni una forte
opposizione all'uso della RU-486. Come
osservava già nel 1993 Allan Rosenfield, della
Columbia University di New York, sulle colonne
del «New England Journal of Medicine»:
«Raramente un progresso scientifico è stato
oggetto di tante controversie politiche,
ideologiche e sociali come il mifepristone».
Ed è appena del 17 maggio scorso l'intervista
rilasciata dal dottor Ralph P. Miech,
professore emerito alla Brown University di
Providence, nel Rhode Island, al quotidiano
«Avvenire», e intitolata: «Ho studiato la RU486, vi spiego come uccide».
Storia di una scoperta casuale
La ricerca di un metodo chimico per
interrompere la gravidanza è durata decenni.
Le prime molecole impiegate a questo scopo
furono le prostaglandine, sostanze che
inducono contrazioni della parete uterina e la
cui produzione è normalmente inibita dal
progesterone. Ma, come ricordavano oltre 15
anni fa su «le Scienze» André Ulmann, Georges
Teutsch e Daniel Philbert, i tre «padri» del
mifepristone, (si veda La pillola RU-486, un
antiormone, n. 258, febbraio 1990) «le dosi
necessarie erano elevate, con la comparsa di
effetti secondari molto rilevanti che ne
impedivano l'impiego nella pratica corrente».
Bisognava cercare altrove; ma la scoperta
dell'utilità del mifepristone non fu frutto di
un programma di ricerca destinato a quello
scopo. Al risultato contribuì il caso, perché
gli studiosi non stavano cercando una pillola
per l'aborto chimico.
Nei laboratori della casa farmaceutica
Roussel-Uclaf si conducevano ricerche sugli
ormoni steroidi, una famiglia di sostanze che
hanno in comune la parte della molecola detta
steroide. Una famiglia eterogenea dal punto di
vista chimico e funzionale. Per esempio, solo
nella famiglia dei progestinici, ovvero degli
ormoni che preparano la mucosa dell'utero
all'accoglimento di un embrione, si
riconoscono almeno tre gruppi di molecole: uno
con struttura ed effetti simili al
progesterone, uno simile al norgestrel, e il
terzo con effetti analoghi al 19nortestosterone, i cui componenti
rappresentano i primi progestinici di sintesi,
diversi l'uno dall'altro per la presenza di
questo o quel gruppo chimico.
La famiglia ha come denominatore comune
l'azione progestinica, ma i gruppi variano
anche per la diversa attività androgenica o la
diversa facilità a essere metabolizzati dal
fegato. Tutto dipende da come varia la
struttura chimica della molecola base del
progesterone, o per un bricolage chimico
naturale o per le variazioni introdotte con la
ricerca chimico-farmaceutica, che in qualche
caso ha portato a composti molto diffusi.
Nell'articolo di «le Scienze» i padri del
farmaco ricordano che nel 1975, al Centro
ricerche Roussel-Uclaf a Romainville, Georges
Teutsch mise a punto un metodo semplice per la
sintesi di varianti di 19-nor, con gruppi
chimici aggiunti in una specifica posizione.
«Questa serie di molecole fino ad allora di
difficile sintesi - scrivevano i tre studiosi
- si è dimostrata di grande interesse per lo
studio dell'attività biologica degli ormoni
sessuali e quindi del controllo delle
nascite».
Per certi versi, però, sembrò un risultato
inutile. La ricerca scientifica delle case
farmaceutiche, allora come oggi, era
condizionata dall'interesse commerciale di un
farmaco, ovvero dal fatturato potenziale delle
scoperte commisurato al tempo necessario per
passare dallo studio di molecole a un farmaco
vero e proprio. Per sviluppare un
contraccettivo chimico che agisse durante la
fase luteinica, quella che va dal 15o al 28o
giorno del ciclo mestruale, allora si pensava
che occorressero 10-17 anni, mentre i brevetti
che proteggevano una molecola duravano
vent'anni nel migliore dei casi. Così,
l'azienda decise di non procedere oltre.
Ma ci fu una sorpresa. Mentre c'era chi si
dedicava a introdurre variazioni nelle
molecole, altri studiavano il rapporto tra
variazioni ottenute e potenziali effetti, come
faceva Alain Bélanger, un giovane canadese che
tra il 1975 e il 1976 lavorava alla RousselUclaf con Teutsch. Bélanger scopri che alcuni
di questi composti presentavano un'affinità
molto forte per i recettori dei
glucocorticoidi, un fatto che convinse i
ricercatori della Roussel-Uclaf di aver
individuato una serie chimica molto
particolare.
Antiormoni
L'idea iniziale fu proprio di aver scoperto
una molecola con attività antiglucocorticoide,
cioè capace di contrastare molecole come il
cortisone. In pratica, erano stati scoperti
degli antiormoni, che nelle loro interazioni
con i recettori si comportavano esattamente
come composti agonisti, senza tuttavia indurre
risposte biologiche. Entravano nella serratura
molecolare senza aprire la porta, e così
impedivano alla chiave - l'ormone - di fare il
suo effetto. Secondo questa ipotesi, più
elevata era l'affinità per il recettore, più
potente doveva essere l'effetto antagonista,
il che costituiva un buon metodo per la
selezione in vitro delle molecole
sintetizzate.
Le cose andarono avanti più speditamente
solo alla fine del 1979 quando, anche con il
contributo di sir Derek Barton e di EtienneEmile Beaulieu, si decise di iniziare le
ricerche sugli antiglucocorticoidi. «Il
coordinamento di questo progetto fu affidato a
Daniel Philibert - si legge sull'articolo di
«le Scienze» del 1990 - che mise a punto
diversi test biologici destinati a mettere in
evidenza una eventuale attività
antiglucocorticoide. Nell'aprile 1980 furono
sintetizzate in successione tre molecole, e
poi affidate ai biologi: RU-38140, RU-38473 e
RU-38486. Rispetto alla RU-25055 l'attività
antiglucocorticoide di queste nuove molecole
era molto più marcata in vitro, ma soltanto la
RU-38486 (indicata in seguito con la sigla RU486) si dimostrò capace di opporsi a tutti gli
effetti del dexametasone (un potente
glucocorticoide di sintesi)». Nello studio
degli ormoni si era decisamente imboccata una
strada nuova.
A quel punto, tuttavia, ci fu una doppia
considerazione. Primo, la RU-486 si fissava in
maniera altrettanto efficace ai recettori del
progesterone, il che avrebbe potuto provocare
effetti indesiderati nel caso di un eventuale
trattamento antiglucocorticoide nella donna.
Secondo, negli esperimenti sugli animali la
RU-486 si dimostrava priva di attività
agonista nei confronti del progesterone, e
quindi doveva essere un suo antagonista, dato
che ne occupava i recettori senza indurre una
risposta biologica.
In conclusione, fu solo per via indiretta
che si arrivò a una molecola tanto attesa dai
ricercatori e dai medici che lavoravano nel
campo del controllo delle nascite.
Comprendendo l'importanza della scoperta,
Beaulieu convinse la direzione generale della
Roussel-Uclaf della necessità di dare priorità
alle ricerche nella direzione dei composti
antiprogesterone. Nei sei mesi seguenti il
gruppo di farmacologi completò gli studi
biologici sulla RU-486, così che Beaulieu,
nell'ottobre 1981, propose la sperimentazione
di questa molecola sulla donna a Walter
Herrmann, a Ginevra, sperimentazione che
ottenne risultati molto incoraggianti: «La RU486 si dimostrò in grado di interrompere la
gravidanza e di provocare l'espulsione
dell'embrione in 9 donne su 11. Questi
risultati costituirono il punto di partenza
per lo sviluppo clinico della RU-486», ovvero
di ricerche ulteriori su donne intenzionate a
interrompere una gravidanza.
Le ricerche sulla donna
Ma era solo l'inizio. Ricercatori e
industria si convinsero ad ampliare le
ricerche cliniche su un numero più ampio di
donne usando la RU-486 come metodo medico
d'interruzione della gravidanza. I primi studi
iniziarono nel 1985 e permisero di precisare
come andava usato il farmaco, ovvero che una
dose unica di 600 milligrammi dava i risultati
migliori. Tuttavia non si poteva essere del
tutto soddisfatti perché nei casi migliori il
farmaco aveva un'efficacia dell'80 per cento.
Alta per qualsiasi altro farmaco, ma non
soddisfacente considerate le ragioni per cui
si usava il mifepristone. Un'ipotesi per
spiegare il mancato successo in quel 20 per
cento di casi era che occorresse una
contrazione uterina più energica per espellere
l'embrione. E così Marc Bygdeman, del
Karolinska Institut di Stoccolma, propose di
rinforzare l'azione dell'RU-486 con piccole
dosi di prostaglandine della serie E, vale a
dire proprio quei farmaci usati senza successo
in passato per interrompere la gravidanza ma
che stavolta avrebbero potuto essere usati a
dosi più basse.
Furono organizzati studi clinici in Francia,
Gran Bretagna, Scandinavia e Cina per valutare
l'efficacia di una tecnica che prevedeva la
somministrazione di 600 milligrammi di RU-486
seguita da una piccola dose di prostaglandine
da 36 a 48 ore più tardi, intervallo
necessario perché la RU-486 sensibilizzasse la
muscolatura uterina all'azione delle
prostaglandine, e ritenuto non abbreviabile.
L'associazione si rivelò felice. I due farmaci
così combinati mostravano un'efficacia del 96
per cento, paragonabile a quella dell'aborto
tramite aspirazione allo stesso stadio della
gravidanza. Altri studi dimostrarono poi che
l'efficacia restava la stessa anche in uno
stadio più avanzato di ritardo delle
mestruazioni.
Il risultato ottenuto in tutti i casi di
successo era quello di un «aborto spontaneo»,
ovvero di un'interruzione spontanea della
gravidanza quando l'espulsione dei frammenti
ovulari si accompagna da emorragie uterine
che, nel 4-5 per cento dei casi, sono gravi e
possono imporre un intervento chirurgico per
arrestare l'emorragia e in qualche caso
obbligare a una trasfusione sanguigna.
Un'eventualità possibile e in qualche caso
accaduta anche con la somministrazione
combinata di RU-486 e prostaglandine, che
rende necessario usare il metodo in una
struttura sanitaria. A dispetto di quanto a
volte raccontano i suoi detrattori, la RU-486
non può in alcun caso consentire di compiere
un'interruzione di gravidanza a domicilio,
senza controllo medico.
D'altra parte, l'esperienza accumulata era
nel complesso rassicurante, e per questo la
Roussel-Uclaf chiese alle autorità sanitarie
francesi l'autorizzazione per l'immissione sul
mercato dell'RU-486; autorizzazione che venne
accordata il 23 settembre 1988, corredata da
disposizioni destinate a evitare che il
prodotto potesse essere usato al di fuori dei
centri autorizzati a effettuare interruzioni
di gravidanza.
L'approvazione negli Stati Uniti
Da allora, l'interesse verso questo farmaco
e verso la tecnica farmacologica
d'interruzione della gravidanza andò crescendo
un po' in ogni parte del mondo, sia riguardo
alla sua efficacia sia per i suoi possibili
rischi e controindicazioni. La RU-486 ha avuto
tanto sostenitori entusiasti quanto
detrattori. Le riviste mediche se ne sono
occupate ripetutamente. Il quindicinale di
aggiornamento sui farmaci «Medical Letter» ne
parlò per la prima volta nel 1991, e il nome
mifepristone è comparso ripetutamente sulle
pagine dell'autorevole periodico medico
statunitense «New England Journal of
Medicine», la prima volta nel 1993, quando la
rivista dedicò all'argomento quattro articoli
e un editoriale che chiedeva polemicamente:
«Mifepristone (RU-486) negli Stati Uniti cosa ci riserva il futuro?».
Negli Stati Uniti, tuttavia, il farmaco fu
proposto per la registrazione solo il 14 marzo
1996, otto anni dopo l'inizio della sua
circolazione in Francia. In quel momento, il
corredo scientifico della proposta erano due
studi su 4600 donne, ma nei quattro anni
successivi si arricchì di un articolo di
revisione dei dati disponibili basato su 14
studi diversi. Nell'autunno 2000, l'esperienza
complessiva e controllata del farmaco era
quella raccolta in studi diversi su un totale
di 26.000 donne. E non si limitava solo a
questo, perché a quel punto il farmaco era in
commercio in più di 12 paesi, dove era stato
usato da circa mezzo milione di donne. Fu su
queste basi che il 28 settembre 2000 la Food
and Drug Administration (FDA), l'autorità
responsabile dell'approvazione dei farmaci,
diede il via libera al suo impiego negli Stati
Uniti.
L'esperienza accumulata negli anni
successivi all'approvazione ha portato la FDA
a rivedere di continuo le sue informazioni ai
medici sui rischi possibili e le
controindicazioni del mifepristone. Nel
novembre 2005 sulle confezioni statunitensi è
stato rafforzato il messaggio relativo a
possibili complicazioni fatali, con due
considerazioni. La prima è connessa al caso di
gravidanze ectopiche, quando l'embrione non si
impianta all'interno della parete uterina. La
seconda è quella di possibili shock settici,
ovvero di gravi infezioni del sangue causa di
shock. Alla base della prima considerazione
c'era un singolo caso, a giustificare la
seconda quello di quattro donne (un quinto
caso era avvenuto in Canada nel 2001), in due
delle quali l'infezione era stata causata
dallo stesso microbo, Clostridium sordellii. E
poiché in quei mesi la FDA stava discutendo la
sospensione dal mercato dell'antinfiammatorio
Vioxx per il suo sfavorevole rapporto rischiobeneficio, ci fu chi chiese la stessa misura
anche per il mifepristone. Sull'argomento, ha
raggiunto un'improvvisa notorietà il già
citato dottor Miech, pubblicando uno studio
sulla rivista «Annals of Pharmacotherapy» nel
2005. Secondo Miech, «la RU-486 permetterebbe
il passaggio nell'utero del batterio presente
nella normale flora vaginale e allo stesso
tempo determinerebbe un catastrofico
abbassamento delle difese immunitarie. Ne
risulterebbe un'infezione massiccia, lo shock
settico e quindi la morte».
La risposta della FDA a queste osservazioni
è stata, e continua a essere, che la
pericolosità non può essere misurata in
assoluto, ma relativamente a quella di altri
sistemi per interrompere la gravidanza.
Sostiene un documento dell'agenzia che «per
quanto siano tragici i decessi di queste
signore, il loro numero resta piccolo e
dovuto, tra l'altro, a un fatto senza una
chiara connessione causale con la tecnica
adottata per interrompere la gravidanza». Tra
l'altro, negli Stati Uniti il farmaco fu
assunto all'inizio come candeletta vaginale, e
tutti i casi di sepsi si sono verificati con
questa via di assunzione. Per questo alla fine
si è scelta la via orale anche per il
misoprostolo.
Inoltre, sempre negli Stati Uniti, i Centers
for Diseases Control and Prevention hanno poi
segnalato altri due decessi causati da C.
sordellii, entrambi avvenuti in seguito ad
aborto spontaneo nel secondo trimestre di
gravidanza. Alla luce delle informazioni
disponibili, questo ha portato gli esperti
delle agenzie sanitarie federali a ritenere
che l'infezione del microbo non sia dovuta a
un semplice effetto del farmaco, ma coinvolga
«fattori multipli legati alla gravidanza», e a
sollecitare maggiori ricerche e migliori
controlli in quella direzione.
Considerato il dibattito che lo ha
circondato dal momento della sua comparsa sul
mercato, il farmaco ha stimolato anche
l'interesse dei gruppi Cochrane, che
nell'insieme formano oggi forse la più
affidabile rete di revisione sistematica di
proposte terapeutiche. La revisione relativa
ai metodi per aborto farmacologico, aggiornata
al 2006, sostiene tra l'altro che «sono
disponibili metodi sicuri ed efficaci di
aborto medico. I metodi che prevedono
l'impiego di più farmaci sono più efficaci di
quelli basati su uno soltanto. Nel sistema
combinato, la dose di mifepristone può essere
abbassata a 200 milligrammi senza che
l'efficacia sia ridotta. Inoltre, il
misoprostolo per via vaginale è più efficace
che assunto per bocca». L'aborto
farmacologico, quindi, prevede due farmaci:
prima il mifepristone e due giorni dopo, in
caso di aborto mancato, il misoprostolo.
Accanto a tutto questo, c'è da ricordare che
sin dai primi anni novanta il mifepristone è
stato oggetto d'interesse scientifico per il
suo possibile impiego in caso di recidiva del
cancro della mammella, sindrome di Cushing,
glaucoma, per la terapia di certi meningiomi,
come contraccettivo d'emergenza, e infine per
indurre il parto, anche se su quest'ultimo
punto le prove sinora raccolte sono meno
convincenti. Una ragione per provare il
farmaco anche su questo fronte è che il
progesterone tende a bloccare le contrazioni
uterine durante il parto, e considerato che il
mifepristone contrasta l'azione ormonale ci si
potrebbe aspettare una sua azione di
facilitazione del parto. Ciò nonostante, in
una revisione che prende in esame il possibile
uso del mifepristone in questo senso, gli
studiosi dei Cochrane fanno tre osservazioni.
Primo, «gli studi clinici effettuati sinora in
proposito non forniscono prove convincenti
tanto da suggerire l'uso del farmaco».
Secondo, «abbiamo poche informazioni sui
possibili effetti avversi sia sulla madre che
sul feto». Terzo, «ci sono invece prove che il
farmaco possa ridurre il ricorso al parto
cesareo e occorre studiare meglio questo
fronte d'impiego».
Il caso italiano
Nel 1993, il «New England Journal of
Medicine» sottolineava in un editoriale che la
casa farmaceutica produttrice ritardò la
richiesta di registrazione del farmaco temendo
le reazioni dei gruppi antiabortisti. Gruppi
analoghi, con l'appoggio di una parte della
classe politica e della stampa, in Italia
impediscono da anni l'uso di un farmaco già
estesamente collaudato in altri paesi, negando
alle donne italiane l'opportunità di usarne i
vantaggi in una situazione difficile come
l'interruzione volontaria di gravidanza. Le
motivazioni di questa opposizione fanno in
genere appello alla tutela della salute della
donna, ma un sospetto diffuso è che dietro
questa preoccupazione ci sia un'opposizione di
principio all'interruzione volontaria di
gravidanza.
Nel 2002, per esempio, l'ospedale Sant'Anna
di Torino tentò una prima volta di realizzare
un trial (l'ennesimo) per verificare efficacia
e sicurezza del farmaco, presentando una
richiesta controfirmata dalla Commissione
regionale per le sperimentazioni cliniche.
«Nel 1997 l'Organizzazione mondiale della
Sanità definì il metodo sicuro ed efficace ricordava tra l'altro la commissione
piemontese nel motivare il suo parere
favorevole - e proprio sotto il coordinamento
dell'OMS l'Italia partecipò a uno studio
multicentrico che, pubblicato nel 1991, diede
il via libera all'introduzione del
mifepristone e della metodica medica in molti
paesi europei». Ma a bloccare la richiesta,
oltre al Ministero della Salute, si mobilitò
persino la magistratura, aprendo un fascicolo
sulla possibile violazione della Legge 194. Un
argomento, questo, che è tornato più volte al
centro del dibattito, e a cui i sostenitori
della RU-486 controbattono sottolineando che
la legge sull'interruzione volontaria di
gravidanza non dà indicazioni limitative in
merito al metodo. La sperimentazione al
Sant'Anna è poi iniziata nel settembre 2005,
prontamente seguita dall'iscrizione del
ginecologo responsabile nel registro degli
indagati e da una nuova ordinanza ministeriale
di sospensione.
Di pochi mesi fa è anche lo scontro tra
l'allora ministro Storace e i medici
dell'ospedale di Pontedera, in Toscana, che
avevano iniziato a somministrare la RU-486
importando il farmaco dalla Francia. In
quell'occasione, il ministro affermò che la
RU-486 rappresentava «un incentivo
all'aborto».
Alla luce di questi e di altri elementi
illustrati in queste pagine, il divieto
opposto finora dalle autorità di governo
italiane appare insomma motivato, più che da
preoccupazioni di natura medico-scientifica
sulla salute della donna, dal timore che la
soluzione farmacologica possa permettere alle
presunte «peccatrici» di farla franca. Oggi
l'Italia è l'unico paese europeo, insieme al
Portogallo e all'Irlanda, dove la RU-486 non è
commercializzata.
Mifepristone-misoprostolo: casi di interazioni
con farmaci e malattie
L'esperienza di questi anni ha indicato
interazioni tra l'associazione mifepristonemisoprostolo e altri farmaci, e altre novità
come complicazioni nel caso di alcune malattie
che possono rappresentare controindicazioni al
ricorso all'interruzione chimica della
gravidanza.
Per quanto riguarda i farmaci, può accadere
che si riduca l'efficacia di uno dei
medicamenti o che se ne alteri l'eliminazione
oppure la concentrazione nel sangue. Questo si
verifica anche con prodotti di erboristeria,
considerato per esempio che l'erba di San
Giovanni (Hypericum perforatum) può ridurre la
concentrazione di mifepristone nel sangue. In
ogni caso, occorre segnalare al medico se si
fa uso di carbamazepina, desametasone e altri
cortisonici, come pure di fenobarbitale,
fenitoina, rifampicina, eritromicina,
anticoagulanti, ketoconazolo.
Per quanto riguarda le malattie, il medico
va informato se si soffre di malattie
surrenali o della coagulazione, di diabete,
malattie di cuore, ipertensione, malattie
renali, del fegato o dei polmoni.
Cronologia di una scoperta
1933: Due studiosi statunitensi isolano un
ormone dal corpo luteo e lo chiamano
progestin.
1934: Diversi gruppi di studio europei
isolano lo stesso ormone e, inconsapevoli
della scoperta dei colleghi statunitensi, lo
chiamano luteo-sterone.
1935: In un meeting svoltosi in un albergo
londinese, il farmacologo sir Henry Dale
arriva alla soluzione compromissoria di
progesterone. Lo studio dell'ormone però è
reso difficile dalle difficoltà di ricavarlo
dagli animali: a metà degli anni trenta, un
grammo costava 1000 dollari, un prezzo
astronomico per l'epoca.
1941-1949: Russel Marker scopre un metodo di
sintesi chimica del progesterone a partire da
un prodotto vegetale, la diosgenina.
1950-1955: Si scoprono ormoni con attività
simile al progesterone, ma attivi anche dopo
assunzione orale, il noretindrone,
identificato da Carl Djerassi alla Syntex, e
il noretinodrel, sintetizzato da Frank Colton.
1975: Presso il Centro ricerche RousselUclaf a Romainville, Georges Teutsch mette a
punto un metodo per la sintesi di un tipo
particolare di derivati steroidei, la famiglia
dei 19-norsteroidi sostituiti in posizione 11.
1980: Daniel Philibert inizia le prime
indagini sull'attività biologica del
mifepristone presso la Roussel-Uclaf.
1981: Prima segnalazione di attività
antiprogestiniche del mifepristone.
1982: Segnalazione della prima interruzione
di gravidanza con mifepristone all'Accademia
francese delle scienze.
2000: Ingresso del farmaco sul mercato
statunitense dopo l'approvazione della FDA.
Stefano Cagliano
(«le Scienze» n. 458/06)