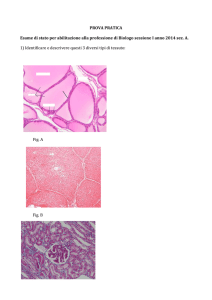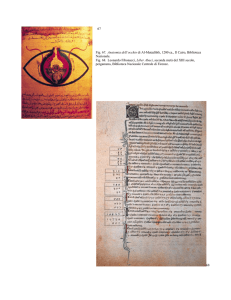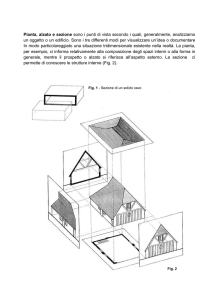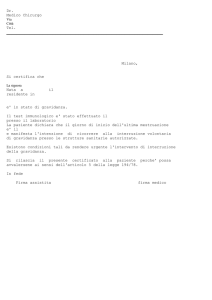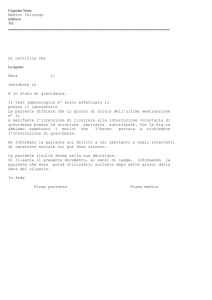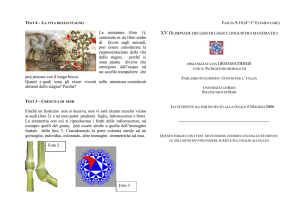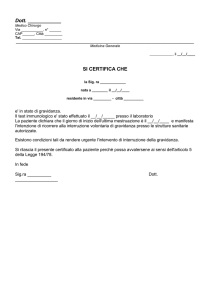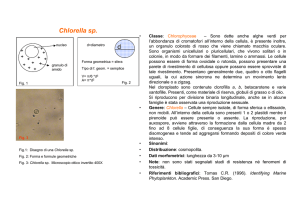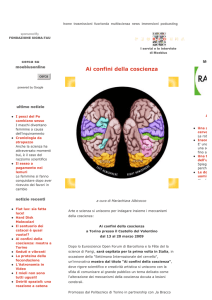Medicina dell’età prenatale
Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche
ANTONIO LUCIANO BORRELLI • DOMENICO ARDUINI
ANTONIO CARDONE • VALERIO VENTRUTO
Medicina dell’età prenatale
Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti
e delle principali patologie gravidiche
2a ed.aggiornata e ampliata
123
ANTONIO L. BORRELLI
ANTONIO CARDONE
Centro di Diagnosi Prenatale
Dipartimento di Scienze
Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
Dipartimento di Scienze
Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
DOMENICO ARDUINI
VALERIO VENTRUTO
Istituto Internazionale di
Genetica e Biofisica
Dipartimento di Chirurgia
Area Ostetrico Ginecologica
Università degli Studi “Tor Vergata”
Roma
Ospedale Fatebenefratelli
Roma
CNR
Napoli
In allegato: CD contenente 3.288 disordini genetici e 22 raggruppamenti delle
principali patologie fetali, presentati in shorts reports
La prima edizione dell’opera è stata pubblicata da Idelson-Gnocchi nel 2002.
ISBN 978-88-470-0687-4
e-ISBN 978-88-470-0688-1
Springer fa parte di Springer Science+Business Media
springer.com
© Springer-Verlag Italia 2008
Quest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla ristampa, all’utilizzo di illustrazioni e tabelle, alla citazione orale, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla registrazione su microfilm o in database, o alla
riproduzione in qualsiasi altra forma (stampata o elettronica) rimangono riservati anche nel
caso di utilizzo parziale. La riproduzione di quest’opera, anche se parziale, è ammessa solo ed
esclusivamente nei limiti stabiliti dalla legge sul diritto d’autore ed è soggetta all’autorizzazione dell’editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni previste dalla legge.
L’utilizzo in questa pubblicazione di denominazioni generiche, nomi commerciali, marchi registrati, ecc. anche se non specificamente identificati, non implica che tali denominazioni o
marchi non siano protetti dalle relative leggi e regolamenti.
Layout di copertina: Simona Colombo, Milano
Impaginazione: Graficando, Milano
Stampa: Printer Trento, Trento
Stampato in Italia
Springer-Verlag Italia S.r.l., Via Decembrio 28, I-20137 Milano
Presentazione
della Seconda Edizione
La medicina dell’età prenatale è a pieno diritto diventata parte integrante
della cultura ostetrica, assumendo un ruolo preminente, anche in considerazione dei progressi compiuti negli ultimi anni sia dalle tecniche di imaging
fetale sia dalle metodiche biochimiche che di biologia molecolare.
Cultura, ricerca, valutazione critica dei risultati insieme a esperienza maturata sul campo, intuizione clinica e audacia di voler osare sono gli strumenti
necessari e indispensabili per raggiungere risultati importanti e a volte sorprendenti in tale ambito della medicina.
È questo infatti un settore sul quale convergono le attenzioni della ricerca clinica e di base, e con cui, con pari dignità, si confrontano le arti mediche più varie, l’etica, le tradizioni popolari fatte spesso di antiche e sagge
credenze, la giurisprudenza e la politica.
La gestione della gravidanza, del travaglio, del parto e del puerperio sono sempre stati affidati al sapere e al saper fare del professionista ginecologo.
Gli impressionanti progressi della tecnologia hanno sicuramente migliorato le possibilità di controllo del benessere fetale nel corso della gestazione e durante le varie fasi del travaglio e del parto. Il poter verificare in
qualsiasi momento parametri come l’attività cardiaca fetale, la Doppler velocimetria e quindi le resistenze vascolari a livello del circolo materno e di
quello placentare nonché la possibilità di avere dati sull’ossimetria fetale
in corso di travaglio, insieme ai progressi delle tecniche di rianimazione e
assistenza neonatale soprattutto nei prematuri estremi, rappresentano sicuramente passi in avanti impressionanti rispetto a quello che potevano fare i nostri predecessori, spesso costretti a vivere cocenti delusioni anche a
fronte di un operato tecnicamente e culturalmente irreprensibile.
Tuttavia, alcuni risultati e alcuni indici di rischio non sono cambiati nel
tempo secondo le aspettative o, meglio ancora, non sempre il nostro deflagrante impatto culturale scientifico è in grado di cambiare la storia evolutiva di patologie caratteristiche dell’età perinatale e pediatrica.
Un tempo era impensabile fare diagnosi in utero di cardiopatia congenita
o di malformazione cerebrale o di ernia diaframmatica ecc., così come poco o nulla si sapeva circa il diabete e la sua caratteristica comparsa nel corso della gravidanza e ancora di patologie immunitarie, di genetica della
trombofilia, di poliabortività, di malformazioni uterine ecc.
Ma, riflettendo con attenzione, è realmente cambiata l’incidenza di queste patologie o siamo stati noi a spingere ad accanirsi verso il raggiungimento dell’“obiettivo vita” magari ad ogni costo o verso la selezione sistematica di soggetti affetti da patologia più o meno grave e più o meno com-
patibile con la vita stessa? E poi, magari dopo anni, siamo tornati sui nostri
passi, alla luce di osservazioni ripetute sulla qualità di vita di neonati strappati alla morte con funambolismi tecnici ma segnati a vita da handicap
enormi e devastanti o constatando che per alcune patologie esistono messaggi di speranza, di terapia e di guarigione prima impensabili.
In tale contesto giunge attesa e gradita la seconda edizione ampliata e
aggiornata del volume Medicina dell’età prenatale, arricchita di nuovi capitoli,
rinnovata nella veste tipografica e nei contenuti, rianalizzati con equilibrio
alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche.
Un plauso quindi agli Autori e a tutti coloro che insieme a loro hanno
collaborato fra mille impegni per voler ancora una volta riaffermare che la
crescita culturale è segnata non solo da momenti di grande progresso tecnologico ma anche da riflessioni attente su quanto si può e si deve fare o a
volte non fare.
Roma, 13 luglio 2007
Prof. Massimo Moscarini
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia
Direttore del Dipartimento di Scienze Ginecologiche
Università di Roma “La Sapienza”
Prefazione
alla Seconda Edizione
Questa seconda edizione del testo di Medicina dell’età prenatale nasce sia
per la necessità di aggiornare quanto già trattato nella prima edizione, sia
dall’esigenza di inserire nel nuovo testo capitoli relativi ad argomenti in precedenza solo accennati.
L’ampliarsi delle conoscenze nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce delle affezioni embrio-fetali, studi sempre più approfonditi in specifici settori della patologia ostetrica, nonché il perfezionarsi delle tecniche di
sorveglianza del benessere fetale, hanno reso necessario il prezioso aiuto di
vari esperti nell’elaborazione e trattazione degli argomenti di loro competenza.
A tal proposito un doveroso e sentito ringraziamento va ai Professori Moscarini (presidente dell’AGUI), Calabrò, Colacurci, D’Addario, Di Lieto, Di
Meglio, Guaschino, Martinelli, Nicolini, Paladini, Palmieri, Petraglia,Vaquero,
Zurzolo e ai loro collaboratori che, nella trattazione dei capitoli loro affidati,
hanno profuso la loro esperienza e la loro specifica competenza.
Si è dato così vita ad un nuovo testo che raccoglie in modo organico le
molteplici problematiche della medicina prenatale, il cui obiettivo è la prevenzione, la diagnosi precoce e, ove possibile, il trattamento delle patologie materno-fetali.
I primi 5 capitoli, dedicati allo studio ecografico dello sviluppo embriofetale, alle nozioni basilari della genetica medica e alla diagnosi prenatale delle cromosomopatie, sono stati aggiornati ed ampliati. I capitoli dal 6 all’11
sono stati trattati ex novo e riguardano lo studio delle malformazioni dei vari organi ed apparati fetali. I capitoli 12, 13 e 14, anch’essi elaborati ex novo,
riguardano gli ormoni feto-placentari, i tumori fetali e le possibili terapie endouterine di talune patologie fetali. Nei capitoli successivi sono state trattate
le principali patologie ostetriche e i metodi di monitoraggio delle condizioni fetali, con particolare riguardo alla diagnosi e al trattamento della sofferenza
e della restrizione dell’accrescimento fetale. Gli ultimi 3 capitoli sono dedicati
all’uso gravidico dei farmaci, alla tossicodipendenza in gravidanza e ai problemi etici e medico-legali in medicina prenatale.
Quest’opera, certamente perfettibile, vuole essere un utile e pratico manuale di consultazione per specializzandi e specialisti in Ginecologia ed Ostetricia, per genetisti, neonatologi, infettivologi e soprattutto per quanti vogliano dedicarsi allo studio della medicina prenatale con l’obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l’incidenza delle affezioni embriofetali.
Un doveroso riconoscimento va ai Dottori Anna Di Domenico, Maria Felicetti, Giuseppe Feroce, Maria Borrelli, Claudio Ferrara e Simona Sorrentino
che hanno fattivamente contribuito alla correzione delle bozze.
Va, inoltre, reiterato un ringraziamento particolare ai Sig.ri Francesco, Salvatore e Luigi Carbone della tipografia Alba di Napoli senza la cui disponibilità
e pazienza sarebbe risultato molto difficile se non impossibile realizzare questo testo.
La più viva gratitudine ed un elogio sentito merita, infine, la casa Editrice Springer-Verlag per aver accolto e curato in ogni sua parte l’opera con professionalità, efficienza ed affettuosa sollecitudine.
Napoli-Roma, settembre 2007
Gli Autori
Presentazione
della Prima Edizione
L’Ostetricia era considerata un’Arte dai nostri Maestri, e probabilmente lo
era, un’Arte empirica, affidata alla cultura, alle esperienze, alle intuizioni,
all’ispezione critica della gestante da parte del ginecologo durante tutta la
gravidanza sino alla gestione del travaglio e all’espletamento del parto.
Il destino della gravida e del prodotto del concepimento era tutto nel
sapere e nell’operare del ginecologo, affidato alla sua saggezza nel porsi di
fronte ai problemi di una madre clinicamente nota e di un feto quasi
sconosciuto.
Nacque così negli anni ’60 sia da un punto di vista dottrinale sia clinicooperativo, una nuova area di interesse ostetrico: la Puericultura Prenatale,
dizione piuttosto ambigua, che tanti malintesi ha generato in campo perinatale
e pediatrico-neonatale, in seguito più opportunamente convertita in Medicina
dell’età Prenatale, area di esclusivo interesse ostetrico, centrata sullo studio
della simbiosi materno-fetale.
Oggi con il progresso della scienza e delle tecniche, con l’approfondirsi
della ricerca sperimentale e clinica, con l’apporto di sempre più sofisticate
ed innovative tecnologie biofisiche e biochimiche, è possibile seguire lo
sviluppo morfofunzionale e strutturale dell’innesto gravidico e del prodotto
del concepimento fetale durante tutto l’arco gravidico, dall’impianto della
blastocisti al travaglio di parto.
Per uno come me che è stato da sempre un convinto propugnatore della
necessità programmatica di definire l’area culturale “Medicina Fetale” da
integrare nella più vasta area di Fisiopatologia Ostetrico-Ginecologica, è stato
un vero piacere constatare la realizzazione di un volume di Medicina dell’Età
Prenatale aggiornato, completo, dotato di una eccellente iconografia, di facile
consultazione per laureandi in Medicina e Chirurgia, in Ostetrica/o,
specializzandi in Ginecologia e Ostetricia, per Pediatri neonatologi, Genetisti,
Cardiologi pediatri e quanti altri interessati a quest’area di alto interesse
scientifico e clinico.
Complimentandomi con i tre Autori, che hanno profuso il meglio del loro
sapere, dimostrandosi veri cultori della materia, auguro al libro il successo
editoriale che certamente merita.
Prof. Ugo Montemagno
Ordinario di Ginecologia e Ostretricia fr
Università degli Studi “Federico II” Napoli
Prefazione
alla Prima Edizione
La Medicina dell’Età Prenatale è certamente il campo dell’Ostetricia moderna in più notevole espansione.
La rapida diffusione di tecnologie innovative per lo studio del feto in utero e nuove metodiche diagnostiche entrate nella pratica clinica hanno notevolmente ampliato le conoscenze sulla fisiologia e fisiopatologia fetale: il prodotto del concepimento fin dalle prime fasi del suo sviluppo è diventato un
“paziente” raggiungibile ed esplorabile, venendosi a realizzare nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche del tutto insperate fino a poco tempo fa.
Oltre che per l’attualità e il notevole interesse dell’argomento, questo testo nasce come risposta ad una effettiva necessità: quella di riunire in uno
stesso manuale nozioni e dati di diversa estrazione, finora dispersi in pubblicazioni e trattati diversi.
Si è voluto, quindi, dar vita ad un testo di facile consultazione che raccogliesse in modo organico, ma sintetico e pratico, i vari argomenti di questa nuova branca dell’Ostetricia i cui obiettivi sono la prevenzione, la diagnosi precoce e ove possibile il trattamento delle malattie fetali.
I primi 2 capitoli del testo sono dedicati allo studio dello sviluppo embrio-fetale e all’inquadramento dei difetti congeniti. Nel 3° e 4° capitolo sono trattati, in modo semplice ma metodologicamente completo, argomenti talora misconosciuti e spesso dimenticati dai cultori della maleria e cioè i principi generali della genetica applicati alle eredopatie e l’importanza della
citogenetica e della genetica molecolare in diagnosi prenatale. Sono successivamente trattate le varie tecniche invasive di diagnosi prenatale, i test di
screening e i progressi attuali delle terapie fetali. Nell’8° capitolo, avvalendoci della competenza specifica del Prof. Michele Russo, infettivologo della nostra Facoltà, sono state trattate le malattie infettive di maggior interesse ostetrico, curando soprattutto i protocolli diagnostico-terapeutici.
Nei capitoli successivi, accanto alla trattazione di patologie di particolare
importanza (diabete in gravidanza, isoimmunizzazione e sofferenza fetale),
notevole attenzione è stata dedicata al monitoraggio delle condizioni fetali e
al conseguente trattamento ostetrico.
Quest’opera certamente incompleta ed ancora perfettibile vuole essere
un utile e pratico manuale di consultazione non solo per studenti, medici di
base, per specializzandi e specialisti ostetrici, ma anche per genetisti, pediatri neonatologi, infettivologi, diabetologi etc.
Nell’elaborazione del manuale ci si è avvalsi anche dell’opera dei colleghi che lavorano nel centro di Diagnosi Prenatale della II Università di Napoli, Carlo Alberto De Leo, Andrea Borrelli, Domenico Labriola, Antonio
Palagiano, Alfredo Laboccetta, Paola Salzano e della dottoressa Maria Luisa
Ventruto del BIO. GE.M. di Napoli.
Un ringraziamento particolare va ai colleghi Vito S. Zurzolo e Maria Felicetti che hanno fornito l’iconografia ultrasonica e hanno collaborato insieme alla dott.ssa Anna Di Domenico nella ricerca bibliografica e nella correzione delle bozze.
Un grazie di cuore va ai Signori Francesco, Luigi e Salvatore Carbone della tipografia Alba di Napoli per la disponibilità e pazienza profuse nella realizzazione delle tabelle e degli schemi esplicativi presenti nel testo.
Infine all’editore, dottor Guido Gnocchi, la più viva gratitudine per aver
accolto e curato l’opera in ogni sua parte con somma cura e affettuosa sollecitudine.
Napoli-Roma, 2002
Gli Autori
Indice
...................................................
XVII
Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi
embrio-fetale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Elenco degli Autori
CAPITOLO 1
A.L. Borrelli, V.S. Zurzolo, M. Felicetti
CAPITOLO 2
Difetti congeniti
......................................................
13
A.L. Borrelli, V. Ventruto, P. Borrelli
CAPITOLO 3
......................
29
Diagnostica prenatale dei difetti congeniti: tecniche invasive
e non invasive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Malattie genetiche nella medicina prenatale
M.L. Ventruto, V. Ventruto
CAPITOLO 4
A.L. Borrelli, M. Felicetti, A. Di Domenico
CAPITOLO 5
Screening prenatale, ecografico e biochimico di
cromosomopatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
A.L. Borrelli, M. Felicetti, A. Di Domenico
CAPITOLO 6
Malformazioni del sistema nervoso centrale
V. D’Addario, V. Pinto, L. Di Cagno
......................
87
XIV
Indice
CAPITOLO 7
Anomalie scheletriche
...............................................
103
...............................................
121
G. Vullo, A. Di Meglio
CAPITOLO 8
Malformazioni facciali
G. Vullo, A. Di Meglio, S. Sorrentino
CAPITOLO 9
Cuore fetale normale e patologico
..................................
133
D. Paladini, M.G. Russo, M. Felicetti, R. Calabrò
CAPITOLO 10
Malformazioni gastrointestinali
....................................
171
G. Vullo, A. Di Meglio
CAPITOLO 11
Anomalie dell’apparato urogenitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
V.S. Zurzolo, A. Di Domenico, P. Borrelli
CAPITOLO 12
Utilizzo degli ormoni placentari e fetali in diagnosi
prenatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
G. Centini, L. Rosignoli, E. Faldini, F. Calonaci, F. Petraglia
CAPITOLO 13
Tumori fetali
..........................................................
237
D. Arduini, G. Barraco, I. Oronzi
CAPITOLO 14
Terapia fetale
..........................................................
247
U. Nicolini
CAPITOLO 15
Aborto spontaneo ricorrente: nuovi sviluppi patogenetici,
diagnostici e terapeutici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
E. Vaquero, N. Lazzarin, G. Di Pierro, D. Arduini
XV
Indice
CAPITOLO 16
Malattie infettive in gravidanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
S. Guaschino, F. De Seta, S. Smiroldo, E. Bianchini, C. Piva
CAPITOLO 17
Complicanze ipertensive della gravidanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
L. Brienza, M.E. Pietrolucci, H. Valensise, D. Arduini
CAPITOLO 18
Alloimmunizzazione Rh e malattia emolitica feto-neonatale
...
359
A.L. Borrelli, C. Ferrara, P. Borrelli
CAPITOLO 19
Idrope fetale non immunologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
M.E. Pietrolucci, L. Brienza, D. Arduini
CAPITOLO 20
Diabete mellito e gravidanza
........................................
383
A.L. Borrelli, C. Ferrara, P. Borrelli
CAPITOLO 21
Sorveglianza della gravidanza
......................................
395
D. Arduini, I. Oronzi, G. Barraco, R. Mastrangeli
CAPITOLO 22
Monitoraggio delle condizioni fetali
...............................
405
A.L. Borrelli, A. Di Lieto, P. Borrelli
CAPITOLO 23
.........................
431
......................................................
445
Ecografia 3D/4D in diagnostica prenatale
L. Caserta, V.S. Zurzolo
CAPITOLO 24
Sofferenza fetale
M. Moscarini, F. Torcia, T. Di Netta
XVI
Indice
CAPITOLO 25
Patologia degli annessi fetali
........................................
459
A.L. Borrelli, A. Cardone, P. De Franciscis
CAPITOLO 26
Parto pretermine
.....................................................
481
G. M. Maruotti, A. Agangi, L. Mazzarelli, P. Martinelli
CAPITOLO 27
.....................................
497
..................................................
503
Restrizione della crescita fetale
A.L. Borrelli, P. Borrelli
CAPITOLO 28
Gravidanza ectopica
N. Colacurci, P. De Franciscis, C. Scaffa
CAPITOLO 29
Farmaci e gravidanza
................................................
513
A.L. Borrelli, M. Felicetti, G. Feroce
CAPITOLO 30
Tossicodipendenze e gravidanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
A.L. Borrelli, P. Borrelli, A. Di Domenico
CAPITOLO 31
Diagnosi prenatale: morale, deontologia e diritto
................
551
L. Palmieri, A.L. Graziussi
Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Elenco degli Autori
ANNALISA AGANGI
RAFFAELE CALABRÒ
Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia
Università degli Studi “Federico II”
Napoli
Unità Operativa Coronarica di Cardiologia
Azienda Ospedaliera “Monaldi”
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
DOMENICO ARDUINI
Dipartimento di Chirurgia
Area Ostetrico Ginecologica
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Ospedale “Fatebenefratelli”
Roma
GIANCARLO BARRACO
Dipartimento di Chirurgia
Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”
Roma
ERICA BIANCHINI
Dipartimento di Scienze della
Riproduzione e dello Sviluppo
IRCCS “Burlo Garofalo”
Università degli Studi di Trieste
Trieste
ANTONIO L. BORRELLI
Centro di Diagnosi Prenatale
Dipartimento di Scienze Ginecologiche
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
PAOLA BORRELLI
Department of Obstetrics and Gynaecology
University College Hospital
London, UK
LETIZIA BRIENZA
Dipartimento di Chirurgia
Area Ostetrico Ginecologica
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Roma
FRANCESCO CALONACI
Centro di Diagnosi Prenatale
Clinica ostetrica e ginecologica
Dipartimento di Pediatria,
Ostetricia e Medicina della Riproduzione
Università degli Studi di Siena
Siena
ANTONIO CARDONE
Dipartimento di Scienze Ginecologiche
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
LUIGI CASERTA
Centro di Diagnosi Prenatale
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
GIOVANNI CENTINI
Centro di Diagnosi Prenatale
Clinica Ostetrica e Ginecologica
Dipartimento di Pediatria,
Ostetricia e Medicina della Riproduzione
Università degli Studi di Siena
Siena
NICOLA COLACURCI
Dipartimento di Scienze Ginecologiche
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
XVIII
Elenco degli Autori
VINCENZO D’ADDARIO
ELISA FALDINI
Clinica Ostetrica e Ginecologica IV
Università degli Studi di Bari
Bari
Centro di Diagnosi Prenatale
Clinica Ostetrica e Ginecologica
Dipartimento di Pediatria,
Ostetricia e Medicina della Riproduzione
Università degli Studi di Siena
Siena
PASQUALE DE FRANCISCIS
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
FRANCESCO DE SETA
Dipartimento di Scienze della
Riproduzione e dello Sviluppo
IRCCS “Burlo Garofalo”
Università degli Studi di Trieste
Trieste
LUCA DI CAGNO
Clinica Ostetrica e Ginecologica IV
Università degli Studi di Bari
Bari
ANNA DI DOMENICO
Centro di Diagnosi Prenatale
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
ANDREA DI LIETO
Dipartimento di Scienze
Ostetrico-Ginecologiche,
Urologiche e Medicina della Riproduzione
Università degli Studi “Federico II”
Napoli
ANIELLO DI MEGLIO
Diagnostica Ecografica e Prenatale
Aniello Di Meglio srl - www.dimed.com
Napoli
TIZIANA DI NETTA
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Perinatologia e Puericultura
Università degli Studi “La Sapienza”
Roma
GIUSEPPE DI PIERRO
Dipartimento di Chirurgia
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Ospedale “Fatebenefratelli”
Roma
MARIA FELICETTI
Centro di Diagnosi Prenatale
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
GIUSEPPE FEROCE
Centro di Diagnosi Prenatale
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
CLAUDIO FERRARA
Centro di Diagnosi Prenatale
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
ANNA LAURA GRAZIUSSI
Medicina Legale delle Assicurazioni
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
SECONDO GUASCHINO
Dipartimento di Scienze della
Riproduzione e dello Sviluppo
IRCCS Burlo Garofalo
Università degli Studi di Trieste
Trieste
NATALIA LAZZARIN
AFaR, Associazione Fatebenefratelli per la
Ricerca Biomedica e Sanitaria
Roma
PASQUALE MARTINELLI
Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia
Università degli Studi “Federico II”
Napoli
GIUSEPPE MARIA MARUOTTI
Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia
Università degli Studi “Federico II”
Napoli
XIX
Elenco degli Autori
ROBERTA MASTRANGELI
CATERINA PIVA
Dipartimento di Chirurgia
Area Ostetrico Ginecologica
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Roma
Dipartimento di Scienze della
Riproduzione e dello sviluppo
IRCCS Burlo Garofalo
Università degli Studi di Trieste
Trieste
LAURA LETIZIA MAZZARELLI
Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia
Università degli Studi “Federico II”
Napoli
MASSIMO MOSCARINI
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Perinatologia e Puericultura
Università degli Studi “La Sapienza”
Roma
LUCIA ROSIGNOLI
Centro di Diagnosi Prenatale
Clinica ostetrica e ginecologica
Dipartimento di Pediatria,
Ostetricia e Medicina della Riproduzione
Università degli Studi di Siena
Siena
MARIA GIOVANNA RUSSO
UMBERTO NICOLINI
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale “Vittore Buzzi”
Milano
IRMA ORONZI
Dipartimento di Chirurgia
Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”
Roma
DARIO PALADINI
Unità di Cardiologia Fetale
Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia
Università degli Studi “Federico II”
Napoli
Unità Operativa Coronarica Cardiologia
Unità Operativa Semplice Cardiologia
Pediatrica
Azienda Ospedaliera “Monaldi”
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
CONO SCAFFA
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
SILVIA SMIROLDO
Medicina Legale delle Assicurazioni
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
Dipartimento di Scienze della
Riproduzione e dello Sviluppo
IRCCS “Burlo Garofalo”
Università degli Studi di Trieste
Trieste
FELICE PETRAGLIA
SIMONA SORRENTINO
Centro di Diagnosi Prenatale
Clinica ostetrica e ginecologica
Dipartimento di Pediatria,
Ostetricia e Medicina della Riproduzione
Università degli Studi di Siena
Siena
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
LUIGI PALMIERI
MARIA ELENA PIETROLUCCI
Dipartimento di Chirurgia
Area Ostetrico Ginecologica
Università degli Studi di Roma“Tor Vergata”
Roma
VINCENZO PINTO
Clinica Ostetrica e Ginecologica IV
Università degli Studi di Bari
Bari
FRANCESCO TORCIA
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Perinatologia e Puericultura
Università degli Studi “La Sapienza”
Roma
HERBERT VALENSISE
Dipartimento di Chirurgia
Sezione di Ginecologia e Ostetricia
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Roma
XX
Elenco degli Autori
ELENA VAQUERO
GABRIELLA VULLO
Dipartimento di Chirurgia
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Ospedale “Fatebenefratelli”
Roma
Diagnostica Ecografica e Prenatale
Aniello Di Meglio srl - www.dimed.com
Napoli
VITO S. ZURZOLO
MARIA LUISA VENTRUTO
Istituto Internazionale di Genetica e
Biofisica, CNR
Napoli
VALERIO VENTRUTO
Istituto Internazionale di Genetica e
Biofisica, CNR
Napoli
Centro di Diagnosi Prenatale
Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Ostetriche e della Riproduzione
II Università degli Studi di Napoli
Napoli
CAPITOLO 1
Sonoembriologia e studio ecografico
dell’organogenesi embrio-fetale
A. L. Borrelli • V. S. Zurzolo • M. Felicetti
PREMESSA
La realizzazione di ecografie ad alta risoluzione e soprattutto di sonde trans-vaginali (TV) ad elevata frequenza (5,5-7,5 MHz) ha consentito uno studio sempre
più approfondito della morfogenesi embrio-fetale [1]. Si
è così definita la sonoembriologia o embriologia ultrasonica [2] che, attraverso il rilievo ecografico delle varie fasi dello sviluppo embrio-fetale, pone le basi non solo per
una corretta datazione della gravidanza1, ma anche per la
diagnosi di patologie embrio-fetali2 già nel I trimestre.
Poiché un numero notevole di gravidanze (~3,5%) presenta anomalie fetali in epoca gestazionale precoce ed
essendo ormai accertato che gran parte di dette anomalie può essere riconosciuta, da operatori esperti, mediante
l’ecografia transvaginale tra la 10ª e la 14ª settimana di gestazione [2], può essere utile l’impiego di questo mezzo
diagnostico per lo studio dell’anatomia embrio-fetale
nella fase iniziale della gestazione.
neurale, i cui bordi successivamente si elevano a formare due pliche che delimitano la doccia o solco neurale.
In una fase ulteriore di sviluppo la fusione delle pliche
(creste neurali) sulla linea mediana determina la formazione del tubo neurale (Fig. 1.1) che inizialmente resta aperto alle due estremità dette neuropori.
Solco neurale
Cresta neurale
a
Cellula della cresta neurale
Tubo neurale
Ectoderma
SONOEMBRIOLOGIA - SVILUPPO PRENATALE
DEI VARI ORGANI E APPARATI
Sistema nervoso centrale (SNC)
b
Fig. 1a, b. a Gravidanza 2ª sett.di sviluppo.Solco neurale e cresta neurale.
b Gravidanza 3a sett.di sviluppo.Tubo neurale
Embriogenesi
A 2 settimane dalla fecondazione (4ª settimana di amenorrea) il sistema nervoso comincia a strutturarsi da
un ispessimento dell’ectoderma embrionale, il piatto
1
A 3 settimane circa dal concepimento (5ª settimana
di amenorrea) si chiude prima il neuroporo anteriore e
due giorni dopo quello posteriore. In questa fase dello
La datazione della gravidanza può essere calcolata facendo riferimento alla data di inizio dell’ultima mestruazione regolare (età gestazionale
o di amenorrea) che normalmente, in un ciclo di 28 giorni, si verifica 2 settimane prima dell’ovulazione e quindi del concepimento. Poiché
non è sempre possibile stabilire la data esatta del concepimento e quindi l’età concezionale o di sviluppo, in quanto l’ovulazione può verificarsi tra l’8º e il 20º giorno del ciclo anche in donne regolarmente mestruate, la datazione della gravidanza in base alla amenorrea può risultare
non corretta. Per una esatta datazione della gestazione, quindi, bisogna spesso ricorrere alla misurazione ecografica dell’embrione (lunghezza vertice-sacro o CRL - Crown Rump Lenght) tra l’8ª e la 11ª settimana (Fig. 1.28).
2Il prodotto del concepimento è definito pre-embrione dalla 2ª alla fine della 4ª settimana di amenorrea, embrione della 5ª alla fine della 10ª
settimana di amenorrea; si parla di feto dalla 10ª settimana fino al termine della gravidanza.
2
Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche
sviluppo il SNC appare come una struttura tubulare la
cui porzione cefalica darà luogo al cervello, mentre la
porzione caudale diverrà il midollo spinale.
Dalla fine della 6ª settimana di amenorrea la porzione anteriore o cefalica del tubo neurale si differenzia
nelle tre vescicole primarie dell’encefalo: il proencefalo o cervello anteriore, il mesencefalo o cervello medio,
il romboencefalo o cervello posteriore (Fig. 1.2).
Mesencefalo
o cervello medio
Romboencefalo
o cervello posteriore
Fig. 1.4. Gravidanza alla 10a settimana. Ecografia TV in sezione sagittale
paramediana si evidenziano le vescicole cerebrali:diencefalica, mesencefalica e romboencefalica
Proencefalo o cervello anteriore
Fig.1.2. 6ª settimana di amenorrea.Dalla porzione cefalica del tubo neurale si differenziano le 3 vescicole primarie dell’encefalo:il proencefalo,il mesencefalo e il romboencefalo
Entro l’8ª settimana di amenorrea il proencefalo si
differenzia in telencefalo e diencefalo, il mesencefalo rimane unico, mentre il romboencefalo dà luogo al metencefalo e mielencefalo (Fig. 1.3).
Regione del
futuro ponte
(metencefalo)
Superficie esterna
del romboencefalo
Regione del futuro
midollo
(mielencefalo)
Proencefalo
Mesencefalo
Successivamente, dalla 9ª settimana di amenorrea
comincia la differenziazione delle principali strutture
encefaliche e le flessure delimitano le vescicole mesencefalica e pontina. Dal telencefalo si formano gli emisferi e i ventricoli cerebrali con i plessi corioidei, mentre dal diencefalo si sviluppano il talamo, l’ipotalamo e
il 3° ventricolo. L’acquedotto di Silvio trae origine dal
mesencefalo, mentre il cervelletto, il ponte e il 4° ventricolo dal metencefalo. Il mielencefalo darà origine al
midollo spinale.
Nella 10ª settimana di amenorrea la cavità dei ventricoli laterali risulta quasi totalmente occupata dai plessi corioidei [3] che assumono un aspetto ad ali di farfalla
separati dalla falce (Fig. 1.5).
diencefalo
telencefalo
Fessura pontina
Peduncolo ottico
Fig. 1.3. 8ª settimana di amenorrea.Il proencefalo si differenzia in telencefalo e diencefalo,il romboencefalo in metencefalo e mielencefalo
Tra la 9ª e la 10ª settimana, utilizzando sonde transvaginali (TV) ad elevata risoluzione, è possibile riconoscere nel polo encefalico le vescicole cerebrali diencefalica, mesencefalica e romboencefalica come formazioni anecogene mediane (Fig. 1.4).
Fig. 1.5. Gravidanza alla 10a settimana.Plessi corioidei
3
Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti
Tra la 11a e la 12a settimana è già possibile individuare le suture craniche, il 3° e 4° ventricolo, i talami.
Successivamente, a partire dalla 18a settimana, le formazioni rilevanti dell’encefalo possono essere chiaramente identificate mediante scansioni assiali. I talami
appaiono come strutture ipoecogene che circondano il
3° ventricolo (Fig. 1.6); il cervelletto e la cisterna magna sono visualizzati nella Figura 1.7.
Colonna vertebrale
Nel corso della 6ª settimana di amenorrea comincia a
strutturarsi la colonna vertebrale per la proliferazione
di cellule somitiche intorno alla notocorda localizzata
centralmente al tubo neurale. Successivamente si ha la
formazione dei corpi e degli archi vertebrali per migrazione delle cellule somitiche intorno al tubo neurale (Fig. 1.8). La mineralizzazione della colonna comincia dall’8ª settimana, per cui è possibile individuarne ecograficamente la presenza come due linee
ecogeniche parallele lungo l’asse maggiore dell’embrione (immagine a binario) (Fig. 1.9). Nelle settimane
successive si distinguono i vari segmenti, ma solo dopo la 18ª settimana è possibile uno studio ecografico
dettagliato (Fig. 1.10).
Arco neurale
vertebrale in via
di sviluppo
Placca dorsale
embrionale
Arco neurale
vertebrale in via
di sviluppo
Fig. 1.6. Gravidanza alla 22ª settimana.Talami e 3º ventricolo.Per gentile
concessione di Dimed Informatica srl (www.dimed.it)
Lamina basale
Pavimento
del tubo neurale
Notocorda
Cellula somitica
Fig. 1.8. 6ª settimana di amenorrea. Iniziale sviluppo della colonna vertebrale per proliferazione delle cellule somitiche intorno alla notocorda
Fig.1.7. Gravidanza alla 22 ª settimana.Cervelletto e cisterna magna.Per
gentile concessione di Dimed Informatica srl (www.dimed.it)
Completatasi, nel I trimestre, la morfogenesi delle varie strutture encefaliche, l’accrescimento e la maturazione del cervello si realizza nell’ulteriore corso della gravidanza, completandosi soltanto dopo la nascita. Lo studio approfondito dell’anatomia cerebrale va effettuato
nel corso dell’esame “morfologico” da realizzarsi tra la
20ª e la 22ª settimana di gestazione (vedi Capitoli 6 e 22).
Fig. 1.9. Gravidanza alla 8a settimana. Ecografia transvaginale, la colonna vertebrale appare come una struttura a binario
4
Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche
successivamente (3° trimestre) a livello epifisario (cartilagini) come aree ipoecogene.
Tra la 13ª e la 16ª settimana si verifica l’ossificazione del massiccio facciale e delle ossa metacarpali e metatarsali; successivamente si avrà l’ossificazione del piede e del calcagno.
Solo verso la fine del 2° trimestre è possibile, quindi, visualizzare con chiarezza le varie strutture ossee fetali e individuare eventuali anomalie scheletriche la cui
diagnosi tuttavia, in taluni casi, rimane particolarmente difficoltosa.
Apparato cardiocircolatorio
Fig. 1.10. Rachide in sezione longitudinale
Scheletro
Dall’8ª settimana si può individuare, a mezzo dell’ecografia, la conformazione iniziale dei vari segmenti scheletrici e l’abbozzo degli arti, la cui struttura sarà meglio definita non prima della 12ª-13ª settimana, quando inizia l’ossificazione (Fig. 1.11).
L’intero sistema cardiovascolare (cuore, vasi, e cellule
del sangue) trae origine dal foglietto germinale mesodermico. Inizialmente il cuore primitivo consta di strutture tubulari appaiate che a partire dalla 5ª settimana di
amenorrea danno luogo ad un’unica struttura tubulare
leggermente incurvata che consta di uno strato endocardico interno circondato da un mantello mioepicardico esterno.
Tra la 5ª e la 7ª settimana di amenorrea, il cuore primitivo va incontro a molteplici e successive modifiche
evolutive che danno luogo poi alla caratteristica struttura a quattro camere.
In embrioni con CRL≥5 mm (6ª settimana di amenorrea) si può visualizzare l’attività cardiaca con sonda
vaginale, però solo a partire dalla 11ª-12ª settimana è
possibile riconoscere gli elementi principali dell’anatomia cardiaca (Fig. 1.12).
Fig. 1.11. Gravidanza 12a settimana. Con sonda vaginale si evidenziano
femore e omero
Nel 2° trimestre, nelle diafisi delle ossa lunghe, sono
visualizzabili ecograficamente i centri di ossificazione
primaria che appaiono come aree iperecogene. I centri
di ossificazione secondaria possono essere evidenziati
Fig. 1.12. Gravidanza 12a settimana.Strutture cardiache (ventricoli)
Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti
Tuttavia, è tra la 19ª e la 22ª settimana, mediante l’ecografia transaddominale con sonda da 3,5 MHz, che
si ottengono le immagini migliori ed è possibile uno
studio accurato del cuore fetale. Dopo aver individuato
la posizione fetale e la normalità del situs (vedi Capitolo 9), la scansione “4 camere”, rendendo possibile lo
studio dell’anatomia cardiaca (camere atriali e ventricolari, setto interventricolare ed interatriale e valvole
atrio-ventricolari) (Fig. 1.13), consente di diagnosticare anche talune anomalie cardiache maggiori (difetti
interventricolari, canale atrioventricolare, ecc.).
In tali casi ed in presenza di quadri ecografici dubbi, va comunque sempre richiesto un approfondimento ecocardiografico di II livello multidisciplinare (cardiologo-pediatra, perinatologo).
Posta la diagnosi sarà effettuato il counseling che
servirà ad informare i genitori circa l’entità, le possibilità terapeutiche e la prognosi relative all’eventuale cardiopatia rilevata.
A causa dell’ossificazione del torace fetale e della riduzione relativa del liquido amniotico, nel terzo trimestre peggiora la qualità delle immagini rendendo più
difficile lo studio ecocardiografico del cuore.
5
Fig. 1.14. Gravidanza alla 23a settimana.Stomaco,fegato e diaframma
dalla placenta al feto, penetra attraverso l’ombelico nell’addome fetale dove in parte raggiunge il fegato anastomizzandosi con la vena porta di sinistra e in parte
si riversa nella cava inferiore attraverso il dotto venoso
di Aranzio. L’inserzione ombelicale può essere visualizzata seguendo le strutture vascolari (arteria e vena
ombelicale) che penetrano nell’addome fetale. Una scansione trasversa dell’addome fetale che visualizzi stomaco, punto di ingresso della vena ombelicale e colonna vertebrale si usa attualmente per determinare la circonferenza addominale (Fig. 1.15); detto parametro,
rapportato alla circonferenza cranica e alla lunghezza
del femore, fornisce utili elementi di valutazione circa
l’accrescimento fetale (vedi Capitolo 22).
Fig. 1.13. Gravidanza alla 24a settimana.Cuore in proiezione “4 camere”
Apparato gastroenterico
Il diaframma si forma tra la 6ª e la 14ª settimana di amenorrea, ma appare ben evidente nel secondo trimestre
come una sottile stria ipoecogena che separa cuore e
polmoni dai visceri addominali sottostanti; tra questi
il fegato appare molto sviluppato ed ha un aspetto omogeneo ed uniformemente ecogeno (Fig. 1.14), al suo interno in epoche successive si possono evidenziare i vasi del circolo portale, le vene sovraepatiche, le arterie
epatiche e i dotti biliari.
La vena ombelicale, che veicola sangue ossigenato
Fig. 1.15. Gravidanza alla 25a settimana. Addome fetale in sezione trasversale.Si evidenziano stomaco,rachide e vena ombelicale
6
Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche
Dopo la 20ª settimana al di sotto del fegato è visibile la colecisti come una struttura piriforme anecogena.
Lo stomaco, che si struttura intorno alla 6ª settimana, può essere visualizzato dalla 9ª-10ª settimana come
una formazione anecogena arrotondata o semilunare
in rapporto al suo grado di riempimento. Nel secondo
trimestre (15ª-16ª settimana) possono individuarsi diversi elementi dell’anatomia gastrica e la milza può essere evidenziata come una formazione triangolare in
rapporto posteriormente e lateralmente con la parete
addominale e medialmente con lo stomaco (Fig. 1.16).
La visualizzazione ultrasonografica dell’intestino
varia con l’epoca gestazionale. Nel II trimestre l’intestino tenue appare omogeneo ed iperecogeno e dotato
di attività peristaltica che inizia generalmente già dall’11a
settimana. La presenza di meconio ne altera l’omogeneità.Verso la fine del II trimestre le anse appaiono come formazioni tubulari ipoecogene localizzate al centro
dell’addome di diametro non superiore a 7 mm. L’aumento abnorme dell’ecogenicità intestinale è stata associata a malattie genetiche (trisomia 21, fibrosi cistica)
o ad infezioni da virus citomegalico.
L’intestino crasso all’inizio del III trimestre può essere individuato come una struttura tubulare ipoecogena del diametro di 18-20 mm localizzata lungo il contorno dell’intestino tenue.
Arterie
segmentali
Aorta
dorsale
Surrene
Glomerulo mesonefrico
Mesonefro
Gonade
Blastema metanefrogenico
Escrescenza ureterale
Fig. 1.17. Ontogenesi dell’apparato urinario
mana dal metanefro inizia lo sviluppo dei glomeruli , dei
tubuli contorti e delle anse di Henle (vedi Capitolo 11).
Ecograficamente i reni sono visualizzati dalla 10ª
settimana come due strutture ovalari ecogene localizzate ai lati della colonna vertebrale in una sezione trasversa dell’addome; nel II trimestre (22-25 settimane)
le varie componenti anatomiche sono più evidenti potendosi differenziare le piramidi midollari ipoecogene dalla corticale iperecogena (Fig. 1.18). Con l’evolvere
della gestazione il grasso perirenale rende la capsula
sempre più visibile contribuendo in tal modo alla migliore definizione dei reni dalle strutture circostanti. La
produzione di urina inizia piuttosto precocemente (13ª
settimana) tuttavia non influisce significativamente
sul volume del liquido amniotico prima della 16ª-18ª
settimana. Del sistema collettore l’unica formazione
Fig. 1.16. Gravidanza alla 25a settimana.Milza e stomaco
Apparato urinario
L’ontogenesi dell’apparato urinario, che embriologicamente trae origine dal seno urogenitale, è caratterizzato dalla rapida regressione del pronefro e mesonefro e
dello sviluppo verso il metanefro della gemma ureterale (Fig. 1.17) da cui traggono origine: pelvi renale, calici, tubuli collettori, ureteri e vescica. Verso la 10ª setti-
Fig. 1.18. Gravidanza alla 25a settimana.Sezione trasversale dei reni
Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti
identificabile all’esame ecografico è la pelvi renale che
appare come una formazione anecogena nella parte
centrale dell’organo. Detta struttura si ritiene normale quando il diametro antero-posteriore non supera i
5 mm. Taluni autori tuttavia ritengono normali valori
bilaterali della pelvi di 7 mm. Dilatazioni monolaterali di modeste dimensioni (<7 mm) generalmente regrediscono alla nascita (Fig. 1.19). Gli ureteri sono in
genere identificabili solo se dilatati per un ostacolo al
deflusso dell’urina.
La vescica fetale è evidenziabile a partire dalla 10ª
settimana come un’area anecogena situata al centro della pelvi renale; le sue dimensioni dipendono dal suo
stato di riempimento e quindi dalla funzionalità renale (Fig. 1.20).
7
In presenza di una normale quantità di liquido amniotico la mancata visualizzazione della vescica può indicare un suo recente svuotamento, in presenza di oligoamnios è utile ripetere l’esame ecografico dopo 30
minuti per confermare il riempimento vescicale considerando che di norma la minzione fetale si verifica ogni
20-25 minuti.
Genitali esterni
La corretta identificazione del sesso fetale riveste particolare importanza non solo per la diagnosi prenatale
delle malformazioni genitali, ma anche per la individuazione, nei casi a rischio, di affezioni genetiche legate al cromosoma X. L’esatta diagnosi di sesso risulta
particolarmente utile anche nei casi di mosaicismi rilevati all’esame citogenetico.
La distinzione dei sessi è possibile solo dopo la 12ª settimana, epoca in cui si è completata la differenziazione.
I genitali maschili sono identificabili, infatti, dalla
15ª settimana quando è possibile evidenziare il pene e
lo scroto al cui interno sono rilevabili in epoca successiva (30ª-32ª settimana), quando si è completata la migrazione, anche i testicoli (Fig. 1.21).
Fig. 1.19. Gravidanza alla 23a settimana. Sezione trasversa dei reni con
evidenza di pielectasia renale monolaterale sinistra
Fig. 1.21. Gravidanza alla 35a settimana.Genitali maschili
Fig. 1.20. Gravidanza alla 25a settimana.Vescica fetale
Nel corso del 2° trimestre il sesso femminile può essere riconosciuto evidenziando le grandi labbra al cui interno è generalmente visibile una sottile linea mediana che deriva dalla separazione delle ninfe (Fig. 1.22).
Va ricordato come un edema delle grandi labbra può
determinare errori diagnostici in quanto dà luogo ad
una immagine ecografica non dissimile da quella relativa al sacco scrotale.
8
Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche
Alla fine della 5ª settimana la proliferazione dell’endometrio circostante può dare luogo ad una immagine a doppio anello dovuto all’area falciforme ipoecogena corrispondente allo spazio tra decidua capsulare
e decidua parietale. I vasi deciduali materni si evidenziano al color doppler [4-7].
6ª settimana di amenorrea
Fig. 1.22. Gravidanza alla 24a settimana.Genitali femminili
Da 5 sett. + 0 gg. a 5 sett. + 6 gg. pm; 22-28 gg. pc.
All’inizio della 6ª settimana (5 settimane+2-3 giorni)
con sonda TV può essere evidenziato il sacco vitellino o
sacco di Yolk che è la prima struttura embrionale presente nella camera gestazionale, ha una forma ad anello ed in genere non supera i 3 mm di diametro (Fig. 1.24).
GRAVIDANZA FISIOLOGICA: STUDIO ECOGRAFICO
DELL’ORGANOGENESI EMBRIOFETALE
Sino alla fine della 4ª settimana di amenorrea non è
possibile la diretta osservazione, mediante ultrasuoni,
delle prime fasi dello sviluppo embrionale.
5ª settimana di amenorrea
Da 4 sett. + 0 gg. a 4 sett. + 6 gg. post-mestruali (pm);
15-21 gg. post-concepimento (pc).
Nel corso della 5ª settimana di amenorrea è possibile visualizzare la camera o sacco gestazionale (SG)
che appare come una struttura circolare del diametro
di 3-6 mm, ipoecogena ed eccentrica; essa è circondata
da un’area iperecogena di tessuto trofoblastico ed endometrio iperplastico (decidua) di spessore non uniforme (Fig. 1.23). In condizioni fisiologiche si può rilevare con sonda TV il sacco gestazionale quando la concentrazione di β-hCG supera le 800 mU/ml.
Fig. 1.23. Gravidanza nel corso della 5a settimana.Con sonda vaginale si
evidenzia la camera gestazionale di 5,3 mm circondata dalla decidua
Fig. 1.24. Gravidanza alla 6a settimana.Con sonda vaginale si rileva, nella camera gestazionale,il sacco vitellino di 2,2 mm
Nel corso della 6ª settimana nel SG è evidenziabile,adiacente al sacco vitellino,l’embrione (CRL 2-5 mm) (Fig.1.25)
che risulta già costituito dai tre foglietti embrionali (ectoderma,mesoderma ed endoderma).L’embrione è dotato di
attività cardiaca che può essere rilevata quando il CRL ha
raggiunto almeno i 5-6 mm; la frequenza cardiaca fetale
inizialmente non supera i 90 battiti al minuto [4, 5].
Fig. 1.25. Gravidanza 6a settimana.Con sonda vaginale si evidenzia, nella camera gestazionale,l’embrione adiacente al sacco vitellino
Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti
9
7ª settimana di amenorrea
Da 6 sett. + 0 gg. a 6 sett. + 6 gg. pm; 29-35 gg. pc.
Alla 7ª settimana di gestazione l’embrione (CRL 59 mm) è avvolto dalla membrana amniotica; in esso è
già possibile distinguere l’estremo cefalico dal tronco
dove è evidenziabile l’attività cardiaca che supera generalmente i 130 bpm (Fig. 1.26).
In questa fase l’embrione, in conseguenza di movimenti di piegamento, assume una forma a C; esso
appare collegato al trofoblasto mediante un peduncolo di connessione che si differenzierà poi in cordone
ombelicale.
Il sacco di Yolk viene estruso nel celoma extra-embrionario e l’ampia comunicazione tra embrione e sacco vitellino si riduce fino a formare un canale stretto
e lungo: il dotto vitellino [4-7].
Fig. 1.27. Gravidanza alla 8a settimana. Con sonda vaginale si rileva un
embrione di 13 mm accanto al sacco vitellino
Fig. 1.28. Gravidanza 8a settimana.CRL (Crown-Rump Lenght)
Fig. 1.26. Gravidanza 7a settimana.Attività cardiaca fetale
8ª settimana di amenorrea
Da 7 sett. + 0 gg. a 7 sett. + 6 gg. pm; 36-42 gg. pc.
L’embrione misura 10-14 mm (Fig. 1.27), determinando il CRL è possibile datare correttamente la gravidanza (Fig. 1.28). In questa fase lo sviluppo cerebrale
procede rapidamente: la testa alla fine dell’8ª settimana
diventa grande quasi quanto il resto del corpo. Mediante
scansioni sagittali e coronali si evidenzia anteriormente il telencefalo dove sono riconoscibili i plessi corioidei
che appaiono come formazioni ecogene simmetriche e
posteriormente, nella porzione occipitale si rinviene la
vescicola romboencefalica come una formazione anecogena (Fig. 1.29).
Fig.1.29. Gravidanza alla 8a settimana.Con sonda vaginale si rileva che l’estremo cefalico è grande quasi come il resto del corpo.Nella zona occipitale
posteriore si rinviene la vescicola romboencefalica
10
Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche
Si rilevano, inoltre, all’M-mode due camere cardiache separate da un setto interventricolare. Con l’ulteriore sviluppo del mesoderma cominciano a riconoscersi gli abbozzi degli arti (Fig. 1.30), ed è possibile individuare l’inizio dell’attività motoria fetale.
10ª settimana di amenorrea
Da 9 sett. + 0 gg. a 9 sett. + 6 gg. pm; 50-56 gg. pc.
Si completa la strutturazione dei vari organi ed apparati ad eccezione dell’encefalo la cui maturazione e differenziazione si realizza nell’ulteriore evoluzione della
gestazione. Il feto raggiunge una lunghezza di 23-31 mm.
Le dimensioni della testa prevalgono ancora su quelle del resto del corpo. Il profilo fetale è evidente ed in
esso possono distinguersi la mascella e la mandibola; i
due emisferi cerebrali sono separati dalla falce e i plessi corioidei sono evidenti nelle cavità dei ventricoli laterali (Fig. 1.5).
Sono riconoscibili i quattro arti che hanno una lunghezza tale da raggiungere il lato mediale fetale e si possono riconoscere le dita delle mani e dei piedi. La cavità amniotica è estesa con riduzione del celoma extraembrionario. In questa fase è anche possibile rilevare
modesti movimenti degli arti. Risulta ancora più evidente l’onfalocele fisiologico (Fig. 1.31).
Fig.1.30.Gravidanza alla 8a settimana.Con sonda vaginale si rinvengono
gli abbozzi degli arti ai lati del corpo dell’embrione
La colonna vertebrale nelle scansioni coronali appare come una struttura a binario (Fig. 1.9).
La membrana amniotica è chiaramente visibile come
una formazione ovale che circonda l’embrione segnando il confine con il sacco gestazionale, mentre il sacco e
il dotto vitellino sono definitivamente dislocati nel celoma extraembrionario. Il cordone ombelicale ben evidente si sviluppa sia in larghezza che in lunghezza.
9ª settimana di amenorrea
Da 8 sett. + 0 gg. a 8 sett. + 6 gg. pm; 43-49 gg. pc.
L’embrione procede nel suo sviluppo (CRL 15-22 mm)
e inizia la differenziazione degli arti, prima superiori e
poi inferiori. Si evidenzia l’onfalocele fisiologico con erniazione di parte delle anse intestinali riconoscibile come un rigonfiamento iperecogeno a livello dell’inserzione ombelicale del cordone onde la necessità di non porre diagnosi di onfalocele prima della 12ª settimana, epoca in cui normalmente questa ernia fisiologica regredisce [8]. Il cuore completa lo sviluppo strutturale e la frequenza cardiaca fetale risulta doppia rispetto a quella materna; in questa fase si chiude il setto interventricolare,
l’ostium primum regredisce e si completa la separazione
tra circolazione sistemica e polmonare.
Nell’encefalo sono riconoscibili la linea mediana e
la fossa romboencefalica dominante, mentre i contorni del telencefalo diventano più chiari. La colonna vertebrale si sviluppa ulteriormente [4-7].
Fig. 1.31. Gravidanza alla 10a settimana.Con sonda vaginale si evidenzia
l’onfalocele fisiologico
Dall’11ª alla 13ª settimana si evidenziano le ossa della faccia, i principali organi interni (stomaco, reni e vescica). Nella colonna vertebrale si possono individuare
i diversi segmenti. È possibile la misurazione della translucenza nucale (NT) e l’individuazione dell’osso nasale (Fig. 1.32).
11ª settimana di amenorrea
Da 10 sett. + 0 gg. a 10 sett. + 6 gg. pm; 57-63 gg. pc.
Il CRL fetale è compreso tra 31 e 40 mm ed è possibile misurare il diametro biparietale (BPD) le cui dimensioni variano tra 14 e 18 mm. Diventa più chiaro il
profilo fetale, mentre nella parte inferiore del tronco
Capitolo 1 • Sonoembriologia e studio ecografico dell’organogenesi embrio-fetale • A.L.Borrelli,V.S.Zurzolo,M.Felicetti
Fig. 1.32. Gravidanza alla 12a settimana.Con sonda vaginale: misurazione della translucenza nucale e individuazione dell’osso nasale
appare la vescica. La cavità amniotica è estesa e comprime il sacco vitellino nel celoma. Amnios e corion cominciano a fondersi.
12ª settimana di amenorrea
Da 11 sett. + 0 gg. a 11 sett. + 6 gg. pm 64-70 gg. pc.
Il feto ha una lunghezza di 41-53 mm. Il BPD è compreso tra 18 e 21 mm. Si evidenziano lo stomaco, la vescica e i reni. Nel cuore sono individuabili i due ventricoli anche con l’ausilio del doppler; in scansioni coronali della faccia possono essere individuate le cavità
orbitarie.
13ª settimana di amenorrea
Da 12 sett. + 0 gg. a 12 sett. + 6 gg. pm; 71-77 gg. pc.
Alla fine della 13ª settimana il CRL misura ~70 mm,
il BPD 24 mm. È chiaramente distinta la faccia fetale,
mentre non si osserva più l’ernia ombelicale fisiologica; si evidenzia il cordone ombelicale con il color
doppler [4-7].
Lo studio ecografico dell’organogenesi embriofetale
consente il rilievo sequenziale di markers ecografici di
gravidanza che hanno molteplici e diverse implicazioni
cliniche.
In una gravidanza fisiologica, nel corso della 5ª settimana di amenorrea, dovrebbe sempre essere visualizzato il sacco gestazionale (SG) all’interno della cavità ute-
3
11
rina; la mancata visualizzazione del SG in questa epoca
di gravidanza e per concentrazioni di β-hCG ≥800
mUI/ml deve far sospettare o una sua evoluzione anomala o una gravidanza extra-uterina [9, 10].
• All’inizio della 6ª settimana di amenorrea di una
gravidanza correttamente datata dovrebbe sempre
essere visibile il sacco vitellino il che può essere utilizzato come criterio di certezza per la diagnosi di
gravidanza intrauterina.
• Alla fine della 6ª settimana (5ª sett.+5-6 giorni)
quando il CRL raggiunge i 5-6 mm può essere identificato il battito cardiaco fetale che, in ogni caso,
deve poter essere rilevato nel corso della 7ª settimana (6ª sett.+3-4 gg.); tutte le volte che venga visualizzato un polo embrionale (estremo cefalico,
tronco) dovrebbe poter essere rilevata l’attività cardiaca; il mancato rilievo del BCF, in tali condizioni,
depone per un probabile aborto [9, 10].
• L’8ª settimana è caratterizzata dalla comparsa di movimenti del corpo embrionale, mentre modesti movimenti degli arti non sono individuabili prima della 10ª settimana di amenorrea.
• La fisiologica erniazione dell’intestino medio nel funicolo compare nella 9ª settimana e deve scomparire dopo la 11ª, per cui non si può porre la diagnosi di onfalocele prima della 12ª settimana, come non
è possibile studiare le mani e i piedi del feto prima
della 11ª settimana [9, 10].
STUDIO DELL’ANATOMIA FETALE
PER LO SCREENING PRECOCE
DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE
L’ecografia del I trimestre non ha come specifica finalità la ricerca di eventuali malformazioni embrio-fetali. Tuttavia alla fine del I trimestre, grazie ai progressi
tecnologici in campo ecografico (sonde vaginali ad elevata risoluzione, 3D e 4D ecc.), è possibile riconoscere
molte anomalie fetali. Tutto ciò induce ad effettuare
precoci verifiche dell’assetto cromosomico fetale (villocentesi) con la conseguente possibilità di scelte consapevoli circa l’ulteriore destino della gravidanza [11].
Le anomalie fetali che è possibile diagnosticare tra
la 10ª e la 14ª settimana di gravidanza [12] sono riportate nella Tabella 1.1 e verranno trattate in successivi capitoli3.
Appare evidente, tuttavia, che la diagnosi precoce
delle predette anomalie non è sempre agevole per l’evolutività oltre il I trimestre di alcune di esse; a ciò si
Le anomalie del SNC, quelle scheletriche, quelle cardiache addominali e renali, sono trattate rispettivamente nei Capitoli 6, 7, 9, 10 e 11.
12
Medicina dell’età prenatale • Prevenzione,diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche
aggiunge il necessario impiego di apparecchi ecografici d’avanguardia e di operatori di notevole e provata esperienza. Per i motivi suddetti, lo studio dell’anatomia embrio-fetale nel I trimestre non può essere
utilizzato come screening routinario precoce delle malformazioni, ma può rappresentare un utile mezzo diagnostico nel caso di gravidanze ad alto rischio malformativo.
Tabella 1.1. Anomalie fetali che è possibile diagnosticare tra la 10ª e la 14ª settimana
Sistema nervoso centrale (SNC)
Encefalocele
Sindrome Meckel Gruber
Idrocefalia
Morbo Dandy Walker
Oloprosencefalia
Iniencefalia
Spina bifida
Cardiache
Diversi tipi di difetti cardiaci a volte associati ad altre anomalie
Aumentata traslucenza nucale
Addominali
Ernia diaframmatica
Onfalocele
Gastroschisi
Renali
Agenesia renale bilaterale
Reni policistici dell’infanzia
Rene multicistico
Megacisti
Scheletriche
Acondrogenesi tipo II
Nanismo tanatoforo
Osteogenesi imperfetta
Displasia toracica asfissiante
Sindrome di Robert
Ectrodattilia displasia ectodermica
Palatoschisi
Body stalk anomaly
Sindrome della regressione caudale
BIBLIOGRAFIA
1. Beck F, Moffat DB, Davies DP (1985) Human embriology,
2nd edn. Blackwell, Oxford
2. Timor Tritsch IE, Monteagudo A (2002) Sonoembriologia: valutazione ecografica transvaginale nel I e II trimestre iniziale di gravidanza. Editoriale SIEOG News
1:9-13
3. Zurzolo VS, Borrelli AL, Pecchillo MA (1992) Diagnosi
prenatale precoce di cisti dei plessi corioidei fetali associata
ad onfalocele. Atti Soc Camp. Cal. Luc. di Ostetricia e Ginecologia, Venosa, 16-17 maggio 1992
4. Callen PW (1988) Ultrasonography in obstetrics and gynecology, second edition. WB Saunders, Filadelfia
5. Chervenak FA, Isaacson GC, Campbell S (eds) (1993) Ultrasound in obstetrics and gynecology. Little, Brown and
Company, Boston
6. Fleischer AC, Romero R, Manning FA et al (1991) The principles and practice of ultrasonography in obstetrics and
gynecology, fourth edition. Appleton & Lange, Norwalk
7. Filly RA (1994) Ultrasond evaluation during the first trimester. In: Callen PW (ed) Ultrasound in obstetrics and
gynecology. WB Saunders, Philadelphia
8. Goldstein SR, Synder JR, Watson C et al (1988) Very early
pregnancy detection with endovaginal ultrasound. Obstet Gynecol 72:200-204
9. Romero R, Pilu G, Jeanty P et al (1987) Prenatal diagnosis
of congenital anomalies. Appleton & Lange, Norwalk
10. Timor Tritsch IE, Rottem S (1991) Transvaginal sonography, second edition. Elsevier, New York
11. Timor Tritsch IE, Rottem S (1994) Normal and abnormal
fetal anatomy in the first 15 weeks of pregnancy using
transvaginal ultrasoud. In: Sabbagha RE (ed) Diagnostic
ultrasound applied to obstetric and gynaecology. JP Lippincott, Philadelphia
12. Souka AP, Nicolaides HK (1997) Diagnosis of fetal abnormalities at the 10-14 week scan. Ultrasound Obstetr
Gynecol 10:429-442