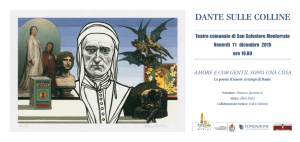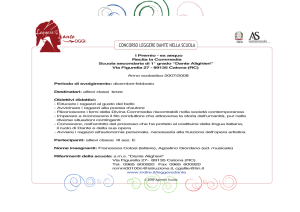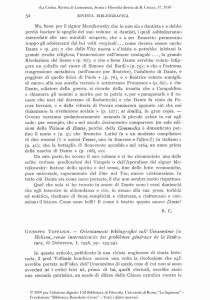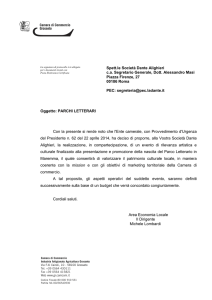Le promesse della filosofia.
Analisi del proemio della Commedia
CARLOS LÓPEZ CORTEZO
Universidad Complutense de Madrid
Asociación Complutense de Dantología
[email protected]
I.
IL “VARCO FOLLE” DI DANTE
Il fatto che Dante cominci -e concluda- il suo viaggio
immaginario ai trentacinque anni (“Nel mezzo del cammin di nostra
vita”) ha ulteriori e importanti implicazioni filosofiche che trascendono
il mero dato autobiografico. Infatti, per Averroè e gli averroisti,
“soltanto verso la fine della vita l’uomo raggiunge il compimento
dell’intelletto e realizza il fine” (Gagliardi 2002: 30), vale a dire,
raggiunge la felicità consistente nella visione dell’essenza di Dio.
Quando il poeta scrive questo primo verso è sicuramente consapevole
di contraddire questa teoria1, se si tiene conto che il suo “averroista”
Ulisse (Gagliardi 2002: 138, 146, 283) fa il suo vano quanto “folle
volo” alla fine della sua vita (senio)2: “Io e ’ compagni eravam vecchi
e tardi / quando venimmo a quella foce stretta / dov’ Ercule segnò li
suoi riguardi // acciò che l’uom più oltre non si metta; […] "O frati",
dissi, "che per cento milia / perigli siete giunti a l’occidente, / a questa
tanto picciola vigilia // d’i nostri sensi ch’è del rimanente / non
vogliate negar l’esperïenza, / di retro al sol, del mondo sanza gente. //
Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti, / ma
per seguir virtute e canoscenza" (If. XXVI, 106-120). Il personaggio
Dante, invece, preciserà, nella sua risposta alla domanda di Brunetto
(“Qual fortuna o destino / anzi l’ultimo dì qua giù ti mena?” If. XV,
46-47), che il suo smarrimento è avvenuto “avanti che l’età mia fosse
piena” (51)3. Mi sembra che questa differenza d’età possa segnare una
115
Tenzone nº 4
2003
diversità ideologica tra i due personaggi4, anche se li accomuna una
stessa “follia”: “Questi non vide mai l’ultima sera; / ma per la sua
follia le fu sì presso, / che molto poco tempo a volger era.” (Pg. I, 5860). Che questa follia, nel caso d’Ulisse, vada riferita al suo “varcare”
la “foce stretta / dov’ Ercule segnò li suoi riguardi // acciò che l’uom
più oltre non si metta”, (“de’ remi facemmo ali al folle volo”, If.
XXVI, 125; “il varco / folle d’Ulisse” di Pd. XXVII, 82-83) mi sembra
indubbio, ma non altrettanto si può dire del “varco” di Dante, di
dubbia determinazione, anche se una cosa è sicura: la sua “follia” -e
perciò il suo “folle varco”- rimanda al proemio, nel quale l’unico
“varco” rintracciabile è “lo passo / che non lasciò già mai persona
viva” (26-27), vale a dire il passaggio dalla selva al colle, situato “là
dove terminava quella valle” (14). Importante al riguardo è la
similitudine del naufrago, in quanto ci aiuta a comprendere il
significato delle immagini:
E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
si volge a l’acqua perigliosa e guata,
così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva. (22-27)
La prima osservazione da fare -soprattutto in un contesto di
“follia” ulissiana- è che l’animo di Dante -a cui è riferito il
personaggio della similitudine- si salva da un naufragio, a differenza
d’Ulisse, che muore (“com’ altrui piacque”) prima di poter arrivare
alla montagna “bruna / per la distanza” e “alta tanto / quanto veduta
non avëa alcuna” (XXVI, 133-135). La seconda è che al “passo” dalla
selva alla “piaggia diserta” del colle, corrisponde, nella similitudine,
quello "del pelago a la riva”. Lucia, nel secondo canto, manterrà la
stessa metafora marina, per riferirsi alla situazione di Dante:
Non odi tu la pieta del suo pianto,
non vedi tu la morte che ‘l combatte
su la fiumana ove ‘l mar non ha vanto? (106-108)
116
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
Il verso 108 dovrebbe intendersi: 'presso la corrente, ove ‘l mar
non ha vanto'5, vale a dire, a riva, “fuor del pelago” e, anche se vicino
all’acqua “perigliosa”, dove questa però non può arrivare (“ove ‘l mar
non ha vanto”). Mi è sembrato necessario chiarire il significato di
questo verso, perché sicuramente rimanda al Salmo 103, in cui si parla
del limite posto da Dio alle acque (“Terminum posuisti quem non
transgredientur"), interpretato da Dante nel Convivio come il limite
posto da Dio alla vita umana6: “E alcuna morte è violenta, o vero per
accidentale infertade affrettata; ma solamente quella che naturale è
chiamata dal vulgo, e che è, è quel termine del quale si dice per lo
Salmista: «Ponesti termine, lo quale passare non si può»” (IV xxiii 8),
vale a dire, non si può passare 'da vivo' (con il corpo), il che spiega il
significato di “lo passo / che non lasciò già mai persona viva” come il
limite o “termine” naturale della vita7 (“là dove terminava quella
valle”, la valle “lacrymarum” del Salmo 83,7, dove si dice
“Concupiscit, et deficit anima mea in / atria Domini”), che mai
nessuno ha potuto 'varcare' da vivo. Si noti anche l’analogia del passo
del Salmo citato nel Convivio con “quella foce stretta / dov’ Ercule
segnò li suoi riguardi // acciò che l’uom più oltre non si metta” e che
Ulisse -come il Dante della selva- invece varca8, in un vano e folle
tentativo di raggiungere 'da vivo' quel che è stato posto da Dio al di là
della vita mortale. E qui va ricordato che la sapienza “non si trova
nella terra dei viventi” (“Sapientia vero ubi invenitur? / Et quis est
locus intelligentiae? / Nescit homo pretium eius, / Nec invenitur in
terra suaviter viventium”, Iob 28,12-13) e che soltanto Dio la
attribuisce a chi vuole: (“Atque utinam Deus loqueretur tecum, / Et
aperiret labia sua tibi, / Ut ostenderet tibi secreta sapientiae”, Iob 11,56; “Quia Dominus dat sapientiam, / Et ex ore eius prudentia et scientia.
/ Custodiet rectorum salutem, / Et proteget gradientes simpliciter”,
Prov. 2,6-7; “Et ut scivi quoniam aliter non possem esse continens,
nisi Deus det; / Et hoc ipsum erat sapientiae, scire cuius esset hoc
donum: / Adii Dominum, et deprecatus sum illum, / Et dixi ex totis
praecordiis meis: […] Da mihi sedium tuarum assistricem sapientiam“,
117
Tenzone nº 4
2003
Sap. 8,21 e 9,4). Nel Convivio, questi limiti 'naturali' coincidono anche
con quelli posti alla conoscenza umana e al desiderio di sapere:
Dov’è da sapere che in alcuno modo queste cose nostro
intelletto abbagliano, in quanto certe cose [si] affermano essere
che lo intelletto nostro guardare non può, cioè Dio e la
etternitate e la prima materia; che certissimamente si veggiono9,
e con tutta fede si credono essere, e per quello che sono
intendere noi non potemo; [e nullo] se non cose negando si può
appressare a la sua conoscenza, e non altrimenti. Veramente può
qui alcuno forte dubitare come ciò sia, che la sapienza possa
fare l’uomo beato, non potendo a lui perfettamente certe cose
mostrare; con ciò sia cosa che ‘l naturale desiderio sia a l’uomo
di sapere, e sanza compiere lo desiderio beato essere non possa.
A ciò si può chiaramente rispondere che lo desiderio naturale in
ciascuna cosa è misurato secondo la possibilitade de la cosa
desiderante: altrimenti andrebbe in contrario di se medesimo,
che impossibile è; e la Natura l’avrebbe fatto indarno, che è
anche impossibile. In contrario andrebbe: chè, desiderando la
sua perfezione, desiderrebbe la sua imperfezione; imperò che
desiderrebbe sè sempre desiderare e non compiere mai suo
desiderio (e in questo errore cade l’avaro maladetto, e non
s’accorge che desidera sè sempre desiderare, andando dietro al
numero impossibile a giugnere). Avrebbelo anco la Natura fatto
indarno, però che non sarebbe ad alcuno fine ordinato. E però
l’umano desiderio è misurato in questa vita a quella scienza che
qui avere si può, e quello punto non passa se non per errore, lo
quale è di fuori di naturale intenzione […] Onde, con ciò sia
cosa che conoscere di Dio e di certe altre cose quello esse sono
non sia possibile a la nostra natura, quello da noi naturalmente
non è desiderato di sapere (III xv 6-10).
II.
IL NAUFRAGO AVARO
Il fatto che Dante esemplifichi “l’errore” di chi desidera “in
questa vita” possedere la “scienza che qui avere non si può”, con
“l’errore” dell’avaro che va “dietro al numero impossibile a giugnere”,
118
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
mi sembra significativo, e indicativo riguardo all’episodio del colle,
nel quale si serve anche della stessa figura all’interno di una
similitudine che verrà più avanti considerata: basti per ora osservare
che se l’avaro si condanna ad un desiderio impossibile di saziare,
anche colui che, in questa vita, desidera di sapere oltre i limiti della
natura umana: “Avaritia…non solum pecuniae est, sed etiam
altitudinis. Recte enim avaritia dicitur cum supra modum sublimitas
ambitur” (Gregorio Magno, In Evang. I. 1 hom. 16:ML 76, 1136).
Interessanti al riguardo le osservazioni di Isidoro: “Avidus dictus ab
avendo; avere enim cupere est. Hinc et avarus. Nam quid est avarum
esse ? progredi ultra quam sufficit. Avarus ex eo dictus, quod sit
avidus auri, et numquam opibus expleatur, et quantum plus habuerit
tantum plus cupiat” (Etym. X, 9). Il fatto va considerato alla luce della
teoria aristotelica della concupiscenza (“appetito di ciò che diletta”,
Rhetor. I, c.11 n.5, 1370a17) e della distinzione tra concupiscenza
'naturale' e 'non naturale'10, ripresa da S. Tommaso:
concupiscenza è l’appetito del bene dilettevole. Ma una cosa è
dilettevole in due maniere. Una perché è convenevole alla
natura dell’animale, come l’alimento, la bibita e altre cose
simili. Questa concupiscenza di ciò che è dilettevole si chiama
naturale. Un’altra, quando qualcosa è dilettevole perché
convenevole all’animale secondo l’apprensione, come quando
si apprende qualcosa come buona e convenevole e
conseguentemente ci si diletta in essa. Questa concupiscenza di
ciò che è dilettevole si dice non naturale, e piuttosto si suole
chiamarla cupidigia […] Ma le seconde concupiscenze sono
proprie degli uomini, dei quali è proprio rappresentarsi qualcosa
come buono e convenevole aldilà di ciò che la natura esige […]
La concupiscenza naturale non può, in verità, essere infinita in
atto, perché è di quello che esige la natura, e la natura sempre
tende verso qualcosa finita e certa. Per questo l’uomo non
desidera mai alimento infinito o bibita infinita. Ma così come
nella natura si dà l’infinito in potenza, mediante la successione,
così anche questa concupiscenza può essere infinita
successivamente, vale a dire, in maniera che dopo aver presso
l’alimento, se ne desideri di prendere altro o qualche altra cosa
119
Tenzone nº 4
2003
che esiga la natura, perché simili beni corporali, una volta
ottenuti non durano sempre, ma finiscono. Per questo motivo
disse il Signore alla Samaritana: ‘Chi berrà di quest’acqua,
riavrà sete' (Giov. 4,13).
La concupiscenza non naturale, però, è assolutamente
infinita, perché segue la ragione, come detto (a.3), ed è proprio
della ragione procedere all’infinito. Per questo chi desidera le
ricchezze lo può fare non fino un determinato limite, ma vuole
essere assolutamente ricco, tanto quanto gli sia possibile.
Secondo il Filosofo in I Polit. c’è un’altra ragione per la quale
una concupiscenza è finita e l’altra infinita. In effetti, la
concupiscenza del fine è sempre infinita, dato che il fine si
desidera per se stesso, come la salute. Di qui che si desideri
sempre una maggiore salute, e così fino all’infinito […] Invece,
la concupiscenza di ciò che è per il fine non è infinita, ma si
desidera nella misura in che è convenevole per il fine. Perciò
coloro che pongono il fine nelle ricchezze ne hanno
concupiscenza fino all’infinito, mentre coloro che le desiderano
per soddisfare i bisogni della vita, le desiderano limitate,
sufficienti per coprire questi bisogni, come dice il Filosofo nello
stesso luogo. E lo stesso argomento può essere applicato alla
concupiscenza di qualunque altra cosa (S. Theol. I-II, C.30, a.3
e 4)11.
Va considerato, però, che ci sono due classi di ricchezze, allo
stesso modo che ci sono due classi di beni: quelle materiali e
temporali, e quelle intellettuali e spirituali. Questo sdoppiamento
semantico, come si sa, ha una lunga tradizione, tanto classica quanto
biblica12, e Dante ne fa largo uso13, ma specialmente interessante mi
sembra questo passo del Paradiso:
Oh gioia! oh ineffabile allegrezza!
oh vita intègra d’amore e di pace!
oh sanza brama sicura ricchezza! (XXVII 7-9)
ed il commento che ne fa Anna Maria Chiavacci Leonardi:
120
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
ed ecco l’altro segno distintivo del cielo, che è ignoto alla terra:
il possesso di una ricchezza che nessuno potrà togliere, e che
non lascia spazio a desiderio, perché non può essere maggiore.
Si veda come l’accento batte su ogni parola del verso (sanza
brama sicura): senza il tormento quotidiano dell’uomo che
sempre sospira qualcosa che possa appagarlo e sempre teme di
perdere ciò che ha acquistato. Così già scriveva Dante in Conv.
III xv 3: «lo quale (scil. il desiderio) essere non può colla
beatitudine, acciò che la beatitudine sia perfetta cosa, e lo
desiderio sia cosa defettiva» […] Dietro queste parole [“sicura
ricchezza”] c’è una lunga storia della meditazione dantesca, da
quelle ricchezze «false traditrici» che mai mantengono ciò che
promettono (Conv. IV xii 3-7) alla sicura povertà di Par. XI 67
(e ancora, in quel canto, al v.82: Oh ignota ricchezza!), fino al
sicuro e gaudïoso regno che definirà l’Empireo nel canto XXXI
al v. 25.
La relazione tra “ricchezza” e “altezza” (“guardai in alto…”) e i
suoi significati allegorici viene stabilita da Alain de Lille in un modo
molto preciso: “altitudo: proprie dicitur profunditas, id est
incomprehensibilitas secretorum Dei, unde Apostolus: ‘O altitudo
divitiarum sapientiae Dei!’. Dicitur sublimitas potestatis, unde Paulus:
‘Neque altitudo, neque profundum separabit nos a charitate Dei’”. Se il
desiderio di ricchezza materiale dell’avaro (cioè, del Dante
personaggio) è inappagabile, anche quello analogo 'intellettuale e
spirituale' non può essere soddisfatto in questa vita mortale che, come
tale, è finita. Il fatto che il poeta stabilisca nella similitudine
un’analogia tra il suo personaggio, che “volontieri” guadagna terreno
nel suo salire il colle, e “quei che volontieri acquista”, rimanda
sicuramente al suo desiderio insaziabile, vale a dire, non ad una
“concupiscenza naturale” (“finita”), ma ad una “non naturale” e perciò
“infinita” (“cupiditas”), in contrasto con il carattere 'finito' del colle, i
cui limiti coincidono con quelli della sua cima. Ma anche la
similitudine del naufrago conduce agli stessi concetti; infatti, è
implicito che sia arrivato a riva seguendo un desiderio naturale di
fuggire la morte, di salvarsi (salute) o, in altre parole, di vivere. Non
121
Tenzone nº 4
2003
gli basta, però, di essere a riva, vale a dire, di aver raggiunto ormai la
sua “salus” e riposarsi, ma dopo -e qui va continuata (implicito)
l’analogia stabilita (esplicito) dal poeta tra i due personaggi- vuole
salire il più alto che può, come Dante. I naufraghi, nella letteratura di
tutti i tempi, dopo essersi salvati dalla morte in mare, cercano -anche
per allontanarsi sempre più dal pericolo- un’altezza dalla quale non
soltanto osservare (contemplare) le dimensioni e le caratteristiche del
luogo dove sono arrivati, ma pure raggiungere con lo sguardo
l’orizzonte, cioè guardare il più lontano possibile: più salgono, di più
aumenta il loro campo visivo e la loro sensazione di sicurezza (“fin
dove si stende la contemplazione anche la felicità, e quelli che possono
contemplare di più sono anche più felici […] in maniera che la felicità
è una specie di contemplazione” (Aristotele, Et. Nic., X, 8, 1178b 28).
Il raggiungimento della riva risponde ad un desiderio naturale (proprio
dell’animale) di salvezza, di sopravvivenza; ma l’altro è un desiderio
'aggiunto' e perciò “non naturale” (razionale), come quello delle
ricchezze, perché il naufrago (l’animo di Dante, “ch'ancor fuggiva”),
dopo essersi volto “a rimirar lo passo / che non lasciò già mai persona
viva”, vuole allontanarsi il più che può dal pericolo e dalla sofferenza
patita in mare (selva oscura), cercando la protezione dell’altezza, la
luce del sole (le spalle illuminate del colle), e anche un maggiore
campo visivo (conoscenza), ma rimarrà sempre insoddisfatto, perché il
suo desiderio, illimitato, dovrà fermarsi nei limiti del colle. Le due
similitudini, quella del naufrago e quella dell’avaro, rimandano quindi
al passo di Tommaso, e a una “concupiscenza del fine”, riprendendo
esattamente i due esempi scelti dal filosofo: la salute e le ricchezze, ma
senza dimenticare il loro significato gnoseologico e che ‘affrettare il
passo, accelerare l’andatura’ (“Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,
/ ripresi via per la piaggia diserta, / sì che ‘l piè fermo sempre era ‘l più
basso”) rimanda al verbo “studiare” (cfr. Pg. XXVII 62; Cv. IV xxiv
5). Il fatto che Dante si riposi soltanto “un poco” dopo una notte nella
selva, come quella descritta nei versi iniziali, indica la sua fretta
(desiderio ardente) di salire il colle, o in altre parole, il suo
122
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
appassionato incontro con la filosofia, raffigurato nella Vita nuova
nell’episodio della donna pietosa.
Ma tornando al passo del Convivio (III xv 6-10), si osservi che
Dante non nega il desiderio di conoscere l’essenza di Dio (“per quello
che sono”, infatti, riproduce la definizione aristotelica di essenza: “ciò
per cui una cosa è quel che è”), ma si limita a considerarlo un desiderio
“non naturale” (“Onde, con ciò sia cosa che conoscere Dio e di certe
altre cose quello esse sono non sia possibile a la nostra natura, quello
da noi naturalmente non è desiderato di sapere”), allo stesso modo che
le ricchezze possono desiderarsi “naturalmente” come fanno, secondo
Tommaso, “coloro che le desiderano per soddisfare i bisogni della
vita”, cioè, “limitate, sufficienti per coprire questi bisogni”, o in un
modo “non naturale”, come -sempre in parole di Tommaso- “coloro
che pongono il fine nelle ricchezze” e perciò “ne hanno concupiscenza
fino all’infinito” (“cupiditas”). Il passo non si contraddice con quel che
afferma il personaggio Dante nel canto IV del Paradiso:
Io veggio ben che già mai non si sazia
nostro intelletto, se ‘l ver non lo illustra
di fuor dal qual nessun vero si spazia.
Posasi in esso, come fera in lustra,
tosto che giunto l’ha; e giugner puollo:
se non, ciascun disio sarebbe frustra.
Nasce per quello, a guisa di rampollo,
a piè del vero il dubbio; ed è natura
ch’al sommo pinge noi di collo in collo. (124-132)
E non si contraddice, in primo luogo, perché qui si parla della
conoscenza che di Dio abbiamo “per rivelazione” (“se ‘l ver non lo
illustra / di fuor dal qual nessun vero si spazia”), senza la quale “già
mai non si sazia / nostro intelletto” e “ciascun disio sarebbe frustra”.
In secondo luogo, perché “Posasi in esso, come fera in lustra, / tosto
che giunto l’ha; e giugner puollo: / se non, ciascun disio sarebbe
frustra” non vuol dire che l’uomo possa conoscere in questa vita
l’essenza di Dio, ma piuttosto credo vada riferito a ciò che afferma
123
Tenzone nº 4
2003
Tommaso sulla conoscenza che di Dio si ha mediante la grazia e quella
che si ha mediante la filosofia naturale:
Anche se in questa vita per rivelazione della grazia non
possiamo sapere di Dio ‘ciò che è’, e in conseguenza ci uniamo
a Lui come qualcosa sconosciuta, in ogni modo però lo
conosciamo più profondamente [che per ragione naturale]
perché ci mette a portata di mano opere sue sempre più sublimi,
e perché gli conferiamo per rivelazione divina proprietà alle
quali la ragione naturale non può arrivare, come che Dio sia
trino e uno (S. Theol. I. C12 a.13).
Quel che di Dio può intendere la ragione umana da sola,
necessita anche della rivelazione divina, perché con solo la
ragione umana la verità di Dio sarebbe conosciuta da pochi,
dopo molte analisi e con dei risultati pieni di errori (S. Theol. I.
C1 a.1).
In terzo luogo, perché qui si parla di “desiderio naturale” di
raggiungere “il sommo” (“ed è natura / ch’al sommo pinge noi di collo
in collo”), ma al “sommo” di quella scienza “che qui avere si può”, che
esclude non Dio, ma sì la sua essenza. Infatti, non a caso Dante si
serve dell’immagine della “fera in lustra”, cioè, dell’animale che si
riposa dopo aver saziato la sua fame14 (diversamente dall’avaro,
sempre insaziabile), ma che sicuramente riavrà fame e dovrà un’altra
volta cercare un altro cibo ecc.: “La concupiscenza naturale non può,
in verità, essere infinita in atto, perché è di quello che esige la natura, e
la natura sempre tende verso qualcosa di finito e certo. Per questo
l’uomo [ma anche l’animale] non desidera mai alimento infinito o
bibita infinita. Ma così come nella natura si dà l’infinito in potenza,
mediante la successione, così anche questa concupiscenza può essere
infinita successivamente, vale a dire, in maniera che dopo aver presso
il cibo, se ne desideri di prendere altro o qualche altra cosa che esiga la
natura, perché simili beni corporali, una volta ottenuti non durano
sempre, ma finiscono. Per questo motivo disse il Signore alla
Samaritana: ‘Chi berrà di quest’acqua, riavrà sete’ (Gio. 4,13)” (S.
Theol. I-II, C.30, a. 4). Si noti anche che il motivo della “successione”
124
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
è palesemente introdotto nei versi che seguono: “Nasce per quello, a
guisa di rampollo, / a piè del vero il dubbio; ed è natura / ch’al sommo
pinge noi di collo in collo”. Nel passo evangelico citato da Tommaso
sono implicite le restanti parole di Gesù: “Ma chi berrà della mia
acqua non riavrà mai sete…”, che rimandano non ad un’acqua
'naturale' quale la filosofia (ragione naturale), ma 'sopranaturale' quali
la rivelazione e la grazia, senza le quali il nostro intelletto “già mai non
si sazia”.
Il desiderio naturale si appaga al quia, mentre il desiderare di
conoscere il quid (l’essenza), in questa vita e senza l’aiuto divino, è
considerato un eccesso (cupiditas) destinato a rimanere insoddisfatto,
come la cupidigia dell’avaro, ma anche come il desiderio dei
“limbicoli”, tra i quali i massimi filosofi naturali, Aristotele e Platone,
“che sanza speme” vivono “in disio”:
«Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via
che tiene una sustanza in tre persone.
State contenti, umana gente, al quia;
ché, se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria;
e disïar vedeste sanza frutto
tai che sarebbe lor disio quetato,
ch’etternalmente è dato lor per lutto:
io dico d’Aristotile e di Plato
e di molt’altri»; e qui chinò la fronte,
e più non disse, e rimase turbato.
(Pg. III, 34-45)
Si osservi, però, che qui non si nega il desiderio, ma lo si
sospende nel senso che non verrà mai soddisfatto. Folle (“matto”) è chi
non si limita15 al quia, ma spera “che nostra ragione / possa trascorrer
la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone”, vale a dire, la
misteriosa essenza di Dio, la quale non solo è inaccessibile all’uomo in
questa vita, ma anche vietata. Il richiamo al peccato originale e ai
limiti (divieto) posti da Dio al primo uomo è palese in “se potuto
aveste veder tutto, / mestier non era parturir Maria”16: la trasgressione
125
Tenzone nº 4
2003
d’Adamo, che volle conoscere quanto Dio, fece necessaria la
redenzione di Cristo. Infatti Tommaso, trattando del peccato del primo
uomo, ed in risposta all’obbiezione che difendeva che Adamo non
peccò per voler essere simile a Dio, perché il desiderio di scienza è
naturale all’uomo, afferma: "Non è peccato desiderare la somiglianza
con Dio riguardo alla scienza. Lo è, però, desiderarla in un modo
disordinato, vale a dire, aldilà di quel che è conveniente. Per questo,
nel suo commentario al salmo 70,19, dice Sant’Agostino: ‘Chi vuole
essere Dio mediante le sole sue forze desidera essere simile a Dio in un
modo cattivo, come il diavolo, che non volle sommettersi a Lui, e
l’uomo, che non volle ubbidire i suoi mandati’” (S. Theol. II-II, C.163
a.2). Voler trascorrere “la infinita via” in questa vita “finita” e da soli è
una follia.
Assieme a questo dell’Aquinate va considerato anche
quest’altro passo dantesco, di un’opera posteriore alla Commedia quale
la Questio de Aqua et Terra:
Cessino dunque, cessino gli uomini di voler capire le cose al
di sopra di loro, e indaghino fin dove possono, accostandosi alle
cose immortali e divine secondo le loro possibilità, e lascino da
parte quanto è più grande di loro. Odano l’Amico di Giobbe che
dice: «Forse che potrai descrivere le orme di Dio, e ritrovare
l’Onnipotente fino alla perfezione?». Odano il Salmista che
dice: «Mirabile è divenuta per me la tua scienza; è vigorosa, e
non potrò acquisirla». Ascoltino Isaia che dice: «Quanto distano
i cieli dalla terra, cotanto distano le mie vie dalle vie vostre»;
parlava invero agli uomini nel nome di Dio. Odano la voce
dell’Apostolo Ai Romani: «O altezza delle divizie della sapienza
e della scienza di Dio, come sono incomprensibili i suoi giudizi
e ininvestigabili le sue vie». E finalmente odano la voce stessa
del Creatore, che dice: «Dove io vado, voi non potete venire». E
questo basti a indagare la ricercata verità (XXII)17.
La metafora paolina delle “ricchezze de la sapienza di Dio”, che
sta alla base della “cupiditas” gnoseologica del passo del Purgatorio, è
126
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
ricorrente nell’opera di Dante, come osserva F. Mazzoni in nota al
passo:
Siamo invece manifestamente di fronte ad un autore, ad uno
scrittore che tiene sul tavolo e rimescola le medesime schede,
come prova quest’altro esempio, che rilega con filo non certo
sottile -mediante le parole di Paolo- Convivio, Monarchia e
Questio. Si veda Conv., IV, xxi, 6: «Per che io voglio dire come
l’Apostolo: "O altezza de le divizie de la sapienza di Dio, come
sono incomprensibili li tuoi giudicii e investigabili le tue vie!"»;
Mon., II, viii, 10: «O altitudo divitiarum scientie et sapientie
Dei…»; Questio, XXII, 77: «Audiant vocem Apostoli ad
Romanos: "O altitudo divitiarum scientie et sapientie Dei, quam
incomprehensibilia iudicia eius et investigabiles vie eius!”».
III.
VENERUNT IN SOLITUDINEM SINAI
Penso, però, che quando si affronti la cornice del proemio
dovrebbe essere considerata anche la sua connotazione biblica,
probabile supporto dell’allegoria. Sorprende, infatti, la sua somiglianza
con quella che si descrive in Exodus 19:
Mense tertio egressionis Israel terra Aegypti, in die hac
venerunt in solitudinem Sinai. Nam profecti de Raphidim, et
pervenientes usque in desertum Sinai, castrametati sunt in
eodem loco, ibique Israel fixit tentoria e regione montis.
Moyses autem ascendit ad Deum: vocavitque eum Dominus de
monte [...] Qui dixit ei: [...] Constituesque terminos populo per
circuitum, et dices ad eos: Cavete ne ascendatis in montem, nec
tangatis fines illius: omnis qui tetigerit montem, morte morietur.
[...] Descenditque Dominus super montem Sinai in ipso montis
vertice, et vocavit Moysen in cacumen eius. Quo cum
ascendisset, dixit ad eum: Descende, et contestare populum: ne
forte velit transcendere terminos ad videndum Dominum, et
pereat ex eis plurima multitudo. [...] Dixitque Moyses
Dominum: Non poterit vulgus ascendere in montem Sinai: tu
enim testificatus es, et iussisti, dicens: Pone terminos circa
127
Tenzone nº 4
2003
montem, et sanctifica illum. Cui ait Dominus: Vade, descende:
ascendesque tu, et Aaron tecum: sacerdotes autem et populus ne
transeant terminos, nec ascendant ad Dominum, ne forte
interficiat illos (1-25).
Si noti che il luogo dove arriva Dante appena uscito dalla selva
(equivalente alla uscita di “Israel terra Aegypti”) corrisponde nei suoi
elementi essenziali a quello dove arriva Moisè: il “gran deserto” e il
“monte”; e lo stesso si può dire del “termine…lo quale passare non si
può”, coincidente con quello posto da Dio in torno al monte per
impedire al popolo, sotto minaccia di morte, di salire “ad videndum
Dominum”: in entrambi i casi “termine” e “morte” sono inseparabili e,
come si vedrà, sarà anche la morte ad impedire al vivente Dante di
salire sul colle. Importante è notare il significato che Tommaso
d’Aquino attribuisce al passo biblico in una delle obiezioni della
Somma Teologica: “Aspetta alla vita attiva disporre e dirigere la
contemplativa, d’accordo con gli ordini ricevuti da Moisè in Ex. 19,21:
‘Scendi e vieta al popolo di varcare il termine da me segnato per
andare a vedere Yahveh’. Dunque la vita attiva è migliore della
contemplativa” (II-II C.182 a.1): quindi il salire il monte era
interpretato come “vita contemplativa”18, mentre il rimanere a valle
come “vita attiva”. La risposta all’obiezione mi sembra anche
interessante: “La vita contemplativa consiste in una certa libertà di
spirito, attenendoci a quel che dice S. Gregorio in Super Ez.: «La vita
contemplativa produce una qualche libertà di spirito dato che non si
preoccupa delle cose temporali», ma di quelle eterne. E Boezio dice
nella Consolatio (V 2): «Le anime umane, poi, risultano,
necessariamente, più libere proprio quando si conservano nella
contemplazione della mente divina, meno, invece, quando si
abbassano agli esseri materiali, e meno ancora quando sono incatenate
nelle membra terrene»19.
In ogni modo conviene osservare che, nel caso di Moisè, è Dio a
chiamarlo in cima al monte, dove gli apparirà, mentre in quello di
Dante no, il che vorrebbe dire che sta trasgredendo il divieto, o, in altre
parole, varcando i limiti segnati o vietati dalla divinità al comune dei
128
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
mortali, con eccezion fatta di quelli da lui chiamati (grazia), come
Moisè. Il ragionamento, però, varrebbe nel caso che il colle fosse il
monte “santo” del Purgatorio, cosa che non accade, tra l’altro perché
Beatrice -a mio parere- li distingue nel suo rimprovero a Dante di
Purgatorio XXX: “Come degnasti d’accedere al monte? / non sapei tu
che qui è l’uom felice?”. La domanda di Beatrice, infatti, sarebbe
assurda nel caso si trattasse del monte del Purgatorio, se si considera
che è stata lei stessa a chiedere Virgilio di menare Dante fin lì. Il passo
-sempre a mio parere- andrebbe letto in quest’altra maniera: 'Come
degnasti (osasti) d’accedere al monte (il colle)? non sapevi tu che qui
(e non lì) è l’uom felice?'.
L’interpretazione più “piena” dell’importante passo biblico,
però, è quella analitica fatta da Agostino nel suo trattato De Trinitate
(II, 15, 25-26; 16, 27-28; 17,28-32), dove si nega che Moisè abbia
visto l’essenza di Dio, limitando la sua visione a un’immagine di Dio,
e dove si afferma -citando la prima epistola a Timoteo- “Regi autem
saeculorum immortali, invisibili soli Deo” (1,17) e “Quem nemo
hominum vidit, nec videre potest” (6,16).
IV.
“O DONNA DI VIRTÙ…”
Credo sia utile e forse necessario riflettere nuovamente su alcuni
passi iniziali della Commedia -già rilevati dalla critica come
chiaramente 'boeziani'- che sono stati inseriti da Dante con
un’intenzione precisa, la cui vera portata -a mio avviso- non è stata
sempre valutata nei suoi giusti termini e implicazioni. Per esempio,
quando nel canto secondo dell’Inferno, Virgilio si rivolge a Beatrice in
questi termini:
“O donna di virtù, sola per cui
l’umana spezie eccede ogne contento
di quel ciel c’ha minor li cerchi sui, (76-78)
Ma dimmi la cagion che non ti guardi
de lo scender qua giuso in questo centro
129
Tenzone nº 4
2003
de l’ampio loco ove tornar tu ardi” (82-84)
Come si sa l’intervento di Virgilio riproduce la domanda di
Boezio alla Filosofia nella Consolatio: “Quid, inquam, tu in has exsilii
nostri solitudines, o omnium magistra virtutum, supero cardine delapsa
venisti?” (I, III) [“Come mai -dissi- tu, o maestra di tutte le virtù, sei
discesa dalla tua alta dimora celeste per venire nella solitudine del mio
esilio?”20]. In questo caso ci sarebbe da rilevare -oltre che nel passo
dantesco la “maestra di tutte le virtù” non è la Filosofia, ma Beatrice-,
anche, o soprattutto, il fatto che l’aggettivo “sola” (“sola per cui /
l’umana spezie eccede ogne contento / di quel ciel c’ha minor li cerchi
sui”), riferito con marcata “esclusività” a Beatrice, rimanda ad un
potere o ad una “virtù” attribuiti, nella Consolatio, alla sola Filosofia:
“Finora tu [dice la Filosofia a Boezio], seguendo le mie
indicazioni, hai visto la vera immagine della felicità, ed hai anche
appreso dove essa si trovi; ora io, una volta esaurito l’esame delle
premesse che ritengo necessarie, ti mostrerò la via che è in grado di
riportarti a casa. Applicherò anche ali al tuo ingegno, perché si possa
sollevare verso l’alto, di modo che tu, liberato da ogni turbamento,
possa ritornare in patria con la mia guida, per il mio sentiero e
addirittura, con i mezzi di trasporto da me forniti.
Io posseggo infatti ali veloci,
capaci di sollevarsi alle alte regioni del cielo;
quando la mente le indossa, alzandosi celermente,
vede dall’alto la terra e la detesta,
supera la smisurata sfera dell’aria,
lasciando alle sue spalle le nubi,
trascende la massa vorticosa del fuoco
che trae il suo calore dal rapido movimento dell’etere,
finché assurge alle dimore degli astri
e unisce la sua traiettoria a quella di Febo
o accompagna il cammino del gelido vegliardo
come cavaliere dell’astro dalla tremula luce
o, dovunque la notte si anima di scintille,
essa rincorre l’orbita dell’astro notturno,
130
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
e, una volta sazia di quanto già ha osservato,
abbandona le zone più periferiche del cielo,
si posa sulla sommità del rapido etere,
padrona, ormai, della sacra luce dell’empireo.
Qui sta, con il suo scettro, il signore dei re,
e regola con le sue mani le redini del mondo
e, immobile, guida il celere cocchio,
lui, lo splendente arbitro dell’universo.
Se qui ti farà ritornare quella strada
che ora, immemore del tuo passato, vai ricercando,
questa –dirai-, me ne ricordo, è la mia patria,
di qui son nato, qui fermerò i miei passi.
E se di qui vorrai rimirare
le tenebre della terra che hai lasciato,
vedrai che vi stanno, come proscritti dalla patria,
i torvi tiranni, tanto temuti dai popoli infelici (IV,I)21
In poche parole, la Filosofia promette a Boezio lo stesso viaggio
che Dante, guidato prima da Virgilio e poi da Beatrice, farà nella
seconda e terza cantica, e lo fa, per di più, usando le stesse metafore
che troviamo nel Purgatorio (“Tanto voler sopra voler mi venne / de
l’esser sù, ch’ad ogne passo poi / al volo mi sentia crescer le penne”,
XXVII, 121-123) e nel Paradiso riferite a Beatrice: “E quella pïa che
guidò le penne / de le mie ali a così alto volo” (XXV 49-50) o
“…mercè di colei / ch’a l’alto volo ti vestì le piume” (XV 54). Il fatto
mi sembra importante perché qui la Filosofia si attribuisce la capacità
di sollevare, da sola, la “mente” dell’uomo fino all’empireo, cioè, fino
alla visione di Dio, “il signore dei re”; vale a dire, gli promette non
solo la somma felicità ma anche la “deificazione:
Infatti, poiché gli uomini diventano felici quando
raggiungono la felicità, e, d’altra parte, la felicità è la divinità
stessa, risulta evidente che essi diventano felici quando
raggiungono la divinità. Ma come i giusti diventano tali
quando raggiungono la giustizia, i sapienti quando
raggiungono la sapienza, così, per un criterio analogo,
diventeranno necessariamente dèi coloro che hanno raggiunto la
131
Tenzone nº 4
2003
divinità. Ogni persona felice è dunque un dio (III,10; cfr. anche
IV,3).22
Il fatto straordinario è messo in risalto nella risposta di Boezio:
“Caspita -dissi- che grandi cose prometti! E non dubito che tu possa
realizzarle; solo, non lasciarmi in attesa, dopo aver suscitato il mio
interesse” (IV,2)23. Siccome non possiamo identificare la Beatrice di
Dante con la personificazione della Filosofia della Consolatio, ne
deriva che la consolatrice di Boezio (una pretesa “beatrice”, ma con la
minuscola) entra in concorrenza con la Beatrice dantesca, promettendo
cose che soltanto lei, mediante la grazia, dovrebbe essere in grado di
compiere, come risulta dalle già citate parole poste dal poeta in bocca
di Virgilio: “O donna di virtù, sola per cui / l’umana specie eccede
ogne contento / di quel ciel c’ha minor li cerchi sui”24. Nella
Commedia, infatti, è Virgilio a promettere:
Dunque: che è? perché, perché restai,
perché tanta viltà nel core allette,
perché ardire e franchezza non hai,
poscia che tai tre donne benedette
curan di te ne la corte del cielo,
e ‘l mio parlar tanto ben ti promette?” (If. II, 121-126)
ma sempre tenendo conto che le sue promesse sono state fatte in nome
di Beatrice, autentica soccorritrice (“Oh pietosa colei che mi soccorse!
/ e te cortese ch’ubidisti tosto / a le vere parole che ti porse!”, If. II,
133-135; “Da me non venni: / donna scese del ciel, per li cui prieghi /
de la mia compagnia costui sovvenni”, Pg. I, 52-54) e il loro
compimento dipende sempre dell’appoggio del Cielo (“de l’alto
scende virtù che m’aiuta”, Pg I, 68), un aiuto che gli permetterà di
guidare Dante per l’inferno e il purgatorio fino alla sua cima dove
“anima…a ciò più di me degna” -se Dante vorrà- lo farà salire “a le
beate genti”, cioè, all’empireo, alla visione di Dio. Questi sono i limiti
di Virgilio, ma anche quelli del suo significato allegorico, e questi
dovrebbero essere pure quelli della Filosofia, una Filosofia che invece
non dice il vero, perché promette cose che non è in grado di poter
compiere, diventando, in conseguenza, anche lei una di quelle false
132
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
“imagini di ben…che nulla promession rendono intera”. Si confrontino
le “vere parole” di Beatrice con quelle non veritiere della Filosofia. Di
qui forse il suo rimprovero nel Paradiso Terrestre:
Sì tosto come in su la soglia fui
di mia seconda etade e mutai vita,
questi si tolse a me, e diessi altrui.
Quando di carne a spirto era salita,
e bellezza e virtù cresciuta m’era,
fu’ io a lui men cara e men gradita;
e volse i passi suoi per via non vera,
imagini di ben seguendo false,
che nulla promession rendono intera.
Tanto giù cadde, che tutti argomenti
a la salute sua eran già corti,
fuor che mostrarli le perdute genti.
Per questo visitai l’uscio d’i morti,
e a colui che l’ha qua su condotto,
li preghi miei, piangendo, furon porti. (Pg. XXX, 124-141)
Il discorso di Beatrice situa il suo soccorso (la sua discesa al
Limbo) rimandando esattamente al momento nel quale Dante rinuncia,
a causa delle tre fiere, alla sua salita al colle, facendolo coincidere con
la tappa in cui “si diede altrui” dimenticandola, vale a dire con la tappa
della Donna gentile o la Filosofia, come lui stesso spiega nel Convivio:
come per me fu perduto lo primo diletto de la mia anima, […]
io rimasi di tanta tristizia punto, che conforto non mi valeva
alcuno. Tuttavia, dopo alquanto tempo, la mia mente, che si
argomentava di sanare, provide, poi che nè ‘l mio nè l’altrui
consolare valea, ritornare al modo che alcuno sconsolato avea
tenuto a consolarsi; e misimi a leggere quello non conosciuto da
molti libro di Boezio, nel quale, cattivo e discacciato, consolato
s’avea […] io, che cercava di consolarme, trovai non solamente
a le mie lagrime rimedio, ma vocabuli d’autori e di scienze e di
libri: li quali considerando, giudicava bene che la filosofia, che
era donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri,
fosse somma cosa. E imaginava lei fatta come una donna
133
Tenzone nº 4
2003
gentile, e non la poteva imaginare in atto alcuno se non
misericordioso (Cv. II xii 1-6).
Che questo periodo sia immaginato nel proemio come l’uscita
dalla selva oscura (il periodo di “tristizia” o perdita del suo “diletto”,
come definisce Tommaso la “tristizia”25) e il tentativo di raggiungere il
“sommo” del “dilettoso monte” mi sembra molto probabile. In primo
luogo perché il gesto che il personaggio fa appena uscito dalla selva è
quello di guardare in alto (“guardai in alto e vidi le sue spalle / vestite
già de’ raggi del pianeta / che mena dritto altrui per ogne calle”), lo
stesso gesto che fa il Dante della Vita Nuova quando vede per la prima
volta la Donna gentile: “Ond’io, accorgendomi del mio travagliare,
levai gli occhi per vedere se altri mi vedesse. Allora vidi una gentile
donna giovane e bella molto, la quale da una finestra26 mi riguardava
sì pietosamente, quanto a la vista, che tutta la pietà parea in lei accolta”
(XXXV); in secondo luogo, perché è in questo momento preciso che
appare Virgilio, il soccorso inviatogli da Beatrice, e, nella Vita Nuova,
il ricupero di Beatrice coincide con l’abbandono della Donna gentile;
in terzo luogo, perché l’immagine del colle rimanda al latino specula,
che valeva 'luogo elevato, monte' da dove si osserva o contempla
(speculazione)27, e come il proprio Dante afferma nel Convivio: “fine
della Filosofia è quella eccellentissima dilezione che non pate alcuna
intermissione o vero difetto, cioè vera felicitade che per
contemplazione de la veritade s’acquista. E così si può vedere chi è
omai questa mia donna, per tutte le sue cagioni e per la sua ragione, e
perché Filosofia si chiama, e chi è vero filosofo, e chi è per accidente.”
(III xi 14-15). Credo al riguardo che nel tentativo di Dante di salire il
colle (“il dilettoso monte”), sia implicito il “fine” della Filosofia di cui
si parla nel Convivio, cioè, la contemplazione del “sole” o della
“veritade” in che consiste la “vera felicitade”. Il diletto, oltre ad essere
proprio dei sensi, appartiene anche alla speculazione: “è naturale
all’uomo dilettarsi nella contemplazione della verità” (S. Theol. I-II,
C.31 a.7); “C’è, pertanto, un diletto che si da nell’uso della ragione,
come quando ci si diletta nel contemplare o nel ragionare” (S. Theol. III, C.33 a.3; cfr. anche C.31 a.4). La relazione “sole”—“sapienza” è
134
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
evidente nel Paradiso, dove il personaggio incontrerà gli spiriti
sapienti nel cielo del sole, e tra questi anche Boezio. Ma è proprio in
quest’episodio che Beatrice dirà a Dante qualcosa che mi sembra
interessante:
E Bëatrice cominciò: «Ringrazia,
ringrazia il Sol de li angeli, ch’a questo
sensibil t’ha levato per sua grazia». (X, 52-54)
La distinzione tra il “Sol de li angeli”, ovvero Dio, e il “sole
sensibile”, soltanto immagine di Dio (“Nullo sensibile in tutto lo
mondo è più degno di farsi essemplo di Dio che ‘l sole. Lo quale di
sensibile luce sè prima e poi tutte le corpora celestiali e le elementali
allumina: così Dio prima sè con luce intellettuale allumina, e poi le
[creature] celestiali e l’altre intelligibili”, Cv. III xii 7) rimanda anche
al sole del proemio che Dante vuole contemplare dal colle: “guardai in
alto e vidi le sue spalle / vestite già de’ raggi del pianeta / che mena
dritto altrui per ogne calle”. Qui si tratta del sole sensibile, e non del
“vero” Sole, quello “degli angeli”, l’unico capace di dare all’uomo la
“vera felicitade” (beatitudine). Se il colle significa la filosofia, vuol
dire che questa non ci può dare la “vera felicitade”, come si afferma
nel passo del Convivio, ma soltanto diletto. In effetti, Virgilio,
riferendosi al colle, parla di “diletto” e di “gioia”, opponendolo alla
“noia” della selva (“Ma tu perché ritorni a tanta noia? / perché non sali
il dilettoso monte / ch’è principio e cagion di tutta gioia?” vv. 76-78),
ma non propriamente di felicità: S. Tommaso distingue tra diletto e
felicità, spiegando che il diletto è un accidente che accompagna la
felicità o beatitudine, ma non è la sua essenza:
Secondo questo, va considerato che ogni diletto è un
accidente proprio che accompagna la beatitudine o alcuna parte
di essa, perché si sente diletto quando si possiede un bene
conveniente, sia reale, sperato o ricordato. Ma un bene
conveniente, se in più è perfetto, s’identifica con la beatitudine
dell’uomo; ma se è imperfetto s’identifica con una parte
prossima, remota o almeno apparente, della beatitudine.
Pertanto, è chiaro che nemmeno il diletto che accompagna il
135
Tenzone nº 4
2003
bene perfetto è l’essenza stessa della beatitudine, ma qualcosa
che l’accompagna come accidente (S. Theol. I-II C. 2 a.6).
Si osservi al rispetto che “diletto” è anche parola chiave
dell’episodio della Donna gentile: “Io venni a tanto per la vista di
questa donna, che li miei occhi si cominciaro a dilettare troppo di
vederla” (V.N. XXXVII), allo stesso modo che “consolare”
(XXXVIII), con un chiaro rimando alla Filosofia di Boezio. Ci sarebbe
da notare anche, che dal sommo del colle questo sole sensibile è
contemplato da lontano, senza che si possa raggiungere, mentre il
Dante del Paradiso Terrestre, sarà 'levato' da Beatrice, 'per grazia'
divina -come lei stessa dice- dal sommo del monte, fino al sole
'sensibile' ed oltre, allo stesso modo che per grazia divina, e non dalla
Filosofia, sono stati levati tutti gli spiriti sapienti, tra i quali Boezio28.
Se la Filosofia -ovvero, il colle- non può innalzare l’uomo fino al sole,
meno ancora potrà farlo fino a Dio, il vero Sole, come il proprio
Boezio lo chiama nella Consolatio, opponendolo o distinguendolo da
Febo, i cui raggi non hanno la forza di penetrare “le intime viscere
della terra o del mare”, allo stesso modo che i raggi del sole del
proemio non possono penetrare la materia montuosa del colle o la
vegetazione della selva “oscura” (“là dove ‘l sol tace”):
Non così il creatore dell’immenso mondo;
a lui che dall’alto vede ogni cosa
non fann o schermo con la loro mole i mondi,
non si oppone la notte con le sue caliginose nubi.
Le cose che furono, che sono e che saranno
con un solo lampo della sua mente scruta
e lui, poiché solo vede tutte le cose,
si potrà chiamare vero sole. (V,II)29
Ma se il desiderio umano, rispetto al sole sensibile, è limitato
alla sua contemplazione da lontano, data l’impossibilità di
raggiungerlo (“l’umano desiderio è misurato in questa vita a quella
scienza che qui avere si può, e quello punto non passa se non per
errore, lo quale è di fuori di naturale intenzione”, Cv. III xv 9), a
maggior ragione il desiderio della visione divina, cioè del “vero Sole”,
136
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
è anche limitato a quella visione che qui possiamo avere, ai suoi
effetti: “Onde, con ciò sia cosa che conoscere di Dio e di certe altre
cose quello esse sono non sia possibile a la nostra natura, quello da noi
naturalmente non è desiderato di sapere.” (ivi, 10). L’immagine del
colle, in questo senso, implica anche non soltanto i limiti della
speculazione, ma anche i limiti “naturali” del desiderio.
Ma oltre quello già detto fin qui, penso sia proficuo comparare
questo “dilettoso monte” con il “sacro monte” (Pg. XIX, 38) o “santo
monte”30 (XXVIII, 12) del Purgatorio, che s’innalza fino alla terza
regione dell’aria, cioè fino al cielo della luna (Pg. XXI, 40-57;
XXVIII, 101). Che i monti siano diversi mi sembra ovvio, ma anche il
modo di salire di Dante: infatti la salita del monte del Purgatorio è a
spirale (XIV, 1; XV, 8; XXII, 123), mentre quella del colle è quella più
breve (“corto andar”, la chiama Virgilio), vale a dire, “retta” (“sì che ‘l
piè fermo sempre era ‘l più basso”)31. Al riguardo Tommaso osserva
che nella contemplazione si parla di movimento “a spirale” per
significare che l’anima usa razionalmente la rivelazione divina, e di
movimento “rettilineo” quando il discorso della ragione passa dal
sensibile all’intelligibile senza uscire dall’ordine naturale, e quando si
procede di verità in verità (S.Theol. II-II C.180 a.6). Significativo in
questo senso mi sembra come Dante metta in risalto, nel suo tentativo
di salire il colle, il fatto che lo faccia a passo a passo, cioè, di verità in
verità ("'l piè fermo"), indicando implicitamente, allo stesso tempo,
anche lo sforzo e l’attaccamento dei piedi al suolo, vale a dire, il peso
del corpo (“l’intelligenza umana finché rimane unita al corpo non può
vedere Dio, perché appesantita dal corpo corruttibile, e così non può
raggiungere l’apice della contemplazione”, Tommaso d’Aquino 1990:
148). Il fatto è risaltato pure nel Purgatorio: “ché questi che vien
meco, per lo ‘ncarco / de la carne d’Adamo onde si veste, / al montar
su, contra sua voglia, è parco” (XI, 43-45), anche se alla fine per
descrivere i suoi ultimi passi prima di arrivare al sommo del monte si
serve della metafora del volo: “Tanto voler sopra voler mi venne / de
l’esser sù, ch’ad ogne passo poi / al volo mi sentia crescer le penne”
(XXVII, 121-123)32. Tuttavia, oltre il già detto, la chiave per “sì che ‘l
137
Tenzone nº 4
2003
piè fermo sempre era ‘l più basso” si trova nel De Trinitate di
Agostino, nel capitolo intitolato “Requies et finis voluntatis in visione
qualis censeri debeat”:
Beati ergo qui factis et moribus cantant canticum graduum: et
vae iis qui trahunt peccata, sicut restem longam (cf. Is. 5,18). Sic
est autem requies voluntatis quem dicimus finem, si adhuc
refertur ad aliud, quemadmodum possumus dicere requiem
pedis esse in ambulando cum ponitur unde alius innitatur quo
passibus pergitur. Si autem aliquid ita placet, ut in eo cum
aliqua delectatione voluntas acquiescat: nondum est tamen illud
quo tenditur, sed et hoc refertur ad aliud, ut deputetur non
tanquam patria civis, sed tanquam refectio, vel etiam mansio
viatoris (XI, 6, 10)33.
A questo punto credo non si possano ignorare le implicazioni e
ulteriori sviluppi della bellissima -e non comune- metafora del 'sole
che tace' (“mi ripigneva là dove ‘l sol tace”), riferita sì alla “selva
oscura”, ma che, per opposizione, coinvolge anche il colle, le cui
“spalle” erano “vestite già de’ raggi del pianeta / che mena dritto altrui
per ogne calle”. Se nella selva il sole “tace” (oscurità), nel sommo del
colle invece dovrebbe, implicitamente, 'parlare' (illuminazione): 'luce'
e 'parola' s’identificano, allo stesso modo che 'oscurità' e 'silenzio'. Ma
se il sole, oltre al suo significato letterale, assume un significato
simbolico, vale a dire 'Dio', conseguentemente, a tacere o a parlare è
Dio34, “divina podestate”, “somma sapïenza” e “primo amore” (If. III,
5-6; Cv. II v 8), tratti teologici che combaciano con la potenza, la luce
e il calore del sole, il quale invia i suoi 'potenti', 'luminosi' e 'caldi'
raggi fino alla terra, varcando l’immensa distanza che separa i due
astri: sono questi raggi 'la parola' (rivelazione) e il 'Verbo' divino, che
'illuminano' il sommo del colle, e senza i quali questo rimarrebbe
immerso nella tenebra, come la selva. Questi raggi 'verbali' sono anche
'mediatori' tra il sole e la terra, separati come sono da un’immensa
distanza, non varcabile dall’uomo, ma questa 'mediazione' è di vita, in
quanto senza il sole la vita non è possibile:
138
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
Qui è da sapere che sì come trattando di sensibile cosa per
cosa insensibile, si tratta convenevolemente, così di cosa
intelligibile per cosa inintelligibile trattare si conviene. E però sì
come ne la litterale si parlava cominciando dal sole corporale e
sensibile, così ora è da ragionare per lo sole spirituale e
intelligibile, che è Iddio. Nullo sensibile in tutto lo mondo è più
degno di farsi essemplo di Dio che ‘l sole. Lo quale di sensibile
luce sè prima e poi tutte le corpora celestiali e le elementali
allumina: così Dio prima sè con luce intellettuale allumina, e poi
le [creature] celestiali e l’altre intelligibili. Lo sole tutte le cose
col suo calore vivifica, e se alcuna ne corrompe, non è de la
‘ntenzione de la cagione, ma è accidentale effetto: così Iddio
tutte le cose vivifica in bontade, e se alcuna n’è rea, non è de la
divina intenzione, ma conviene quello per accidente essere [ne]
lo processo de lo inteso effetto. […] Dico adunque che Iddio,
che tutto intende (chè suo ‘girare’ è suo ‘intendere’), non vede
tanto gentil cosa quanto elli vede quando mira là dove è questa
Filosofia (Cv. III xii 5-11):
guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.
V.
LA METAMORFOSI DELLA BESTIA. IL VELTRO
Sul significato dei tre animali che ostacolano la salita del
personaggio c’è ancora molto da dire. È vero che Dante si sofferma
soprattutto sulla lupa, ma questo fatto non dovrebbe distogliere lo
sguardo critico dalle altre due fiere, specialmente dal leone,
considerato da sempre -e anche nel medioevo- il “re” degli animali, e
situato dal poeta nella posizione mediana della triade, nel posto
centrale. La regalità, infatti, è un tratto inerente al leone, e ciò
dovrebbe implicare anche la sua superiorità fisica e gerarchica sulla
lonza e la lupa. Questa condizione di re viene ad aggiungersi all’altro
tratto già rilevato dalla critica, la superbia (“con la test’ alta”), una
coppia ben avvenuta se si considera che la superbia è “la regina di tutti
139
Tenzone nº 4
2003
i vizi” (S. Gregorio, XXXI Moral. C.45: ML 76,621), ma che ha
l’inconveniente del sesso: qui non abbiamo una leonessa-regina, ma un
maschio, allo stesso modo che gli altri due animali non sono maschi,
ma femmine. Questo fatto fa pensare più che alla superbia
(femminile), al “rex superbus” di cui parla Agostino in un passo del
suo De Trinitate che mi pare sia una delle chiavi fondamentali del
proemio:
Nequaquam igitur per sacrilegas similitudines et impias
curiositates et magicas consecrationes animae purgantur et
reconciliantur Deo: quia falsus mediator non traicit ad
superiora, sed potius obsidens intercludit viam per affectus,
quos tanto maligniores, quanto superbiores suae societati
inspirat; qui non possunt ad evolandum pennas nutrire
virtutum, sed potius ad demergendum pondera exaggerare
vitiorum, tanto gravius anima ruitura, quanto sibi videtur evecta
sublimius. Proinde, sicut Magi fecerunt divinitus moniti (cf. Mt.
2,12), quos ad humilitatem Domini adorandam stella perduxit,
ita et nos, non qua venimus, sed per aliam viam in patriam
redire debemus, quam rex humilis docuit, et quam rex superbus
humili regi adversarius obsidere non possit. […] Via nobis fuit
ad mortem per peccatum in Adam. Per unum quippe hominem
peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors; et ita in
omnes homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt (Rom.
5,12). Huius viae mediator diabolus fuit, persuasor peccati, et
praecipitator in mortem. […] Ut ergo sicut per unum hominem
mors, ita et per unum hominem fieret resurrectio mortuorum,
quia magis vitabant homines quod evitare non poterant, mortem
carnis, quam mortem spiritus, id est, magis poenam quam
meritum poenae (nam non peccare, aut non curatur, aut parum
curatur; non mori autem quamvis non obtineatur, vehementer
satagitur); vitae Mediator ostendens, quam non sit mors
timenda, quae per humanam condicionem iam evadi non potest,
sed potius impietas, quae per fidem caveri potest, occurrit nobis
ad finem quo venimus, sed non qua venimus. Nos enim ad
mortem per peccatum venimus; ille, per iustitiam: et ideo cum
140
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
sit mors nostra poena peccati, mors illius facta est hostia pro
peccato (IV xii 15)35.
Si osservi, infatti, come nel passo di Agostino il “rex superbus”
o falso mediatore, impedisce l’anima di salire “ad superiora”,
tagliandole la strada e facendole rovinare “quanto sibi videtur evecta
sublimius”36, in opposizione al “rex humilis”, mediatore di vita, che fa
ritornare l’anima in patria per un’altra via da quella percorsa37. Se nel
leone “con la test’ alta” è possibile riconoscere il “rex superbus”
(Lucifero), nel Veltro, la cui “nazion sarà tra feltro e feltro”, si
potrebbe intravedere il “rex humilis”. Infatti, la associazione 'cane'
("veltro")38 - “feltro” è analoga a quella che figura in questo passo di
G. Villani: “Feciono per divina visione loro imperadore e signore uno
fabbro di povero stato, il quale avea nome Cangius, il quale in su un
povero feltro fu levato imperadore, e come fu fatto signore, fu
chiamato il soprannome di Cane, cioè in loro lingua imperadore”
(apud Grande Dizionario della Lingua Italiana, vox “cane”). Va
chiarito, però, che Dante non intende accennare ad un Can, ma
volendo elaborare un discorso profetico ed enigmatico, si serve di
queste immagini per riferirsi ad un imperatore o re “umile”, forse non
tanto -o solo- di 'nascita', quanto di 'natura' (“nazion”)39, in
opposizione al “re superbo”40. In sintesi, si servirebbe del passo e dei
concetti agostiniani, riferiti a Cristo, per trasferirli ad un imperatore
“venturo”, figura o prefigura Christi41. In questo senso va tenuta
presente l’epistola VII, nella quale -come si sa- rivolge ad Arrigo VII
la stessa domanda del Battista a Cristo: “«Tu es qui venturus es, an
alium expectamus?»”, senza esitare in presentarlo addirittura come
“Agnus Dei”: “Tunc exultavit in te spiritus meus, cum tacitus dixi
mecum: «Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi»”. L’idea non
è necessariamente originale di Dante, infatti è probabile che l’abbia
presa dal libro III del De Regimine Principum di S. Tommaso (1998:
331), nel cui capitolo XIII si parla dell’imperatore come
'rappresentazione' di Cristo “vero Dio e Monarca del mondo”.
Importante mi sembra il fatto che, in questo stesso capitolo dell’opera
dell’Aquinate, e a proposito dell’umiltà di Cristo Re, si dica: “Per
141
Tenzone nº 4
2003
questo, anche se Cristo, per significare il suo dominio universale, fu
adorato dai magi e glorificato dagli angeli, tuttavia si coricò in un
luogo umile, avvolto in poveri panni” (1998: 330): che il poeta abbia
'tradotto' quest’ultima espressione nella enigmatica formula “tra feltro
e feltro” non mi sembra improbabile, dato che il feltro è -come si sa e
come è stato detto- una specie di panno 'povero'. Per concludere
quest’approccio provvisorio al Veltro, osserverei, però, che anche se
l’immagine segnala un imperatore, questo a sua volta significa
(rappresenta) Cristo, il quale diventerebbe così il suo ultimo referente.
A questo punto, però, c’è da domandarsi cosa c’entri la filosofia
con l’imperatore venturo: al riguardo credo che sia utile rimandare al
Convivio:
Per che, tutto ricogliendo, è manifesto lo principale intento,
cioè che l’autoritade del filosofo sommo di cui s’intende
[Aristotele] sia piena di tutto vigore. E non repugna a la
imperiale autoritade; ma quella sanza questa è pericolosa, e
questa sanza quella è quasi debile, non per sé, ma per
disordinanza de la gente; sì che l’una con l’altra congiunta
utilissime e pienissime sono d’ogni vigore. E però si scrive in
quello di Sapienza: «Amate lo lume de la sapienza, voi tutti che
siete dinanzi a’ populi». Ciò è a dire: Congiungasi la filosofica
autoritade con la imperiale, a bene e perfettamente reggere (IV
vi 17-19).
Si osservi che nel passo si afferma che la “autoritade” filosofica
di Aristotele “è pericolosa” senza quella imperiale (cioè, senza il
Veltro), affermazione che può chiarire -a mio parere- la situazione di
estremo “pericolo”42 del personaggio Dante, all’inizio della sua salita
“filosofica”, minacciato dalla bestia.
Della lonza [un raro animale che non è famelico, come il leone e
la lupa, (l’osservazione appartiene a Gorni), che è “leggero e presto
molto” (cioè, difficile a catturare) e che “alcuna volta” Dante aveva
pensato prendere con una corda, cioè, al laccio (If. XVI, 105-108)]43, si
è detto che corrisponde alla “lynx” dell’Eneide, la cui pelle avvolge la
142
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
compagna di Venere (I, 323) od anche al “pardus” di Geremia (5,6), e
che perciò significa la lussuria. Ma se questo fosse stato il significato
che il poeta voleva dare all’animale, ci sarebbe da chiedersi perché non
parla di “lince” o di “pardo”, considerato che avevano le stesse
caratteristiche: pel maculato, leggeri e presti anche loro, ed inoltre i
loro nomi non offrivano problemi metrici. Evidentemente se sceglie la
“lonza” è perché gli interessa proprio questo nome, interpretabile
(nomina sunt consequentia rerum) come “la onza” (l’onza) o “la
oncia” (l’oncia), l’antica unità di misura dell’oro e anche moneta in
uso in molti stati italiani nel Medioevo (Cfr. Boccaccio, Dec. I, IV,
433; Cielo d’Alcamo, Contrasto)44, ed infatti così, con l’articolo, il
nome dell’animale figura nei Proverbia super natura feminarum.
Credo sia proprio questo il significato della lonza: l’oro, la ricchezza, e
non la lussuria45. Anche perché l’apparizione successiva dei tre animali
sta ad indicare, oltre la gerarchica già considerata, un rapporto di
causalità -Gorni (1995: 23-55), le cui preziose osservazioni tengo
molto presenti, a questo proposito parla di metamorfosi della “bestia”-,
e non vedo la relazione tra lussuria (almeno che non sia intesa nel suo
significato latino di 'vita lussuosa') e il significato attribuito al leone
(superbia) e alla lupa (cupidigia)46: la lussuria non genera superbia e
non ha niente a che vedere con la cupidigia. Sì invece le ricchezze,
dalle quali nasce la superbia: “ex divitiis nascitur superbia” (Alain de
Lille: vox dives) e la cupidigia (cfr. Pg. XXII, 40-41: “Perché non
reggi tu, o sacra fame / de l’oro, l’appetito de’ mortali?”), se si
considera che è “un desiderio disordinato di possedere ricchezze” (S.
Theol. II-II C.118 a.2), ma -come si è visto sopra- in un senso ampio
era definita pure come un desiderio smisurato, non soltanto di danaro,
ma anche di scienza (ibid.)47. Al riguardo mi sembra fondamentale
l’epistola I a Timoteo: “Nam qui volunt divites fieri, incidunt in
tentationem, et in laqueum diaboli, et desideria multa inutilia, et
nociva, quae mergunt homines in interitum et perditionem. Radix enim
omnium malorum est cupiditas: quam quidam appetentes erraverunt a
fide, et inseruerunt se doloribus multis […] Divitibus huius speculi
praecipe non sublime sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed
143
Tenzone nº 4
2003
in Deo vivo (qui praestat omnia abunde ad fruendum) bene agere,
divites fieri in bonis operibus, facile tribuere, comunicare, thesaurizare
sibi fundamentum bonum in futurum; ut apprehendant veram
vitam”(6, 9-19).
Al carattere 'fraudolento' e 'traditore' delle ricchezze è dedicato,
come si sa, un ampio passo del Convivio (IV x-xiii), in gran parte
ispirato a Boezio, il quale tratta in profondità il tema nella Consolatio
(1991: 125, 145, 149, 151, 159, 183, 195, 221), ed è proprio questo il
significato del “pel maculato” (“gaetta pelle”, “pelle dipinta”) della
lonza, se si tiene conto del simbolismo attribuito da Alain de Lille ai
colori di un altro felino, di diverso significato, ma di uguali
caratteristiche quale il “pardus”: “Dicitur etiam haereticus qui diversis
fraudibus decipit, sicut pardus diversis coloribus est distinctus” (vox
“pardus”)48. Una conferma di questo valore simbolico si trova nella
fisionomia di Gerione (“sozza immagine di froda”): “lo dosso e ‘l petto
e ambedue le coste / dipinti avea di nodi e di rotelle. // Con più color,
sommesse e sovraposte / non fer mai drappi Tartari né Turchi, / né fuor
tai tele per Aragne imposte.” (If. XVII, 14-18). Dei passi indicati del
Convivio credo basti riprodurre questo brano:
Promettono le false traditrici sempre, in certo numero
adunate, rendere lo raunatore pieno d’ogni appagamento; e con
questa promissione conducono l’umana volontade in vizio
d’avarizia […] Promettono le false traditrici, se bene si guarda,
di torre ogni sete e ogni mancanza, e apportare ogni saziamento
e bastanza; e questo fanno nel principio a ciascuno uomo,
questa promissione in certa quantità di loro accrescimento
affermando: e poi che quivi sono adunate, in loco di saziamento
e di refrigerio danno e recano sete di casso febricante
intollerabile; e in loco di bastanza recano nuovo termine, cioè
maggiore quantitade a desiderio, e, con questa, paura grande e
sollecitudine sopra l’acquisto (IV xii 4-5).
Ho risaltato nel passo il tema della 'promessa' delle ricchezze
perché penso che non sia assente nell’episodio della lonza: questa,
infatti, 'si mette davanti' (pro-mette) a Dante (“e non mi si partia
144
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
dinanzi al volto”) suscitando in lui, in un primo momento, timore
(“anzi ‘mpediva tanto il mio cammino, / ch’i’ fui per ritornar più volte
vòlto”), e poi -a causa de “l’ora del tempo e la dolce stagione”- un
sentimento di speranza (“sì ch’a bene sperar m’era cagione / di quella
fiera a la gaetta pelle”)49, sentimenti che in un certo modo
preannunciano quelli analoghi che il personaggio sentirà davanti alla
'promessa' di Virgilio (vid. If. II, 121-126). È palese che quel che
promettono di saziare le ricchezze è il desiderio umano di felicità,
anche se non soltanto non sono in grado di compiere la promessa, ma
anzi “molto sovente si son rivelate dannose per chi le detiene, dato che
sono i tipi più prepotenti, e perciò più avidi della roba altrui, a ritener
di essere loro soli i più degni di possedere tutto l’oro e le pietre
preziose che ci son nel mondo […] Magnifica veramente la felicità che
viene dalle ricchezze terrene, felicità che, quando l’hai raggiunta, ti
toglie la condizione di serenità.” (Boezio II, 5). Il significato della
lonza, perciò, implica anche il problema della felicità. L’animale,
d’altronde come la lince, doveva essere un ‘felino’ molto simile al
gatto, anche se non era un ‘vero’ gatto: il ragionamento potrebbe
sembrare non pertinente -e forse lo è- se non fosse che la parola
“felicità” offriva a Dante la possibilità di essere interpretata (ancora
nomina sunt consequentia rerum) come il latino “felis-cita”50, vale a
dire, “gatta presta, veloce” (“una lonza leggera e presta molto”), cioè
-come detto- non facile da prendere, sfuggevole come la ricchezza, ma
anche come la felicità. In sintesi, il tutto condurrebbe alla seguente
conclusione: allo stesso modo che la lonza non è un vero gatto –anche
se apparentemente gli somiglia-, la ricchezza (lonza) non è nemmeno
la vera felicità (gatto).
La speranza, però, non dura molto: la lonza si trasforma in un
leone che, non contento di mettersi davanti, gli viene incontro
minaccioso, “con la test’ alta e con rabbiosa fame”, impaurendolo. A
prescindere d’altri significati, è un fatto che l’aggressività delle fiere, e
perciò anche la loro pericolosità, è significata nella loro fame: è questa
che giustifica l’aggressione, e il suo significato va spiegato nel fatto
che tanto la superbia quanto la cupidigia sono 'appetiti': il primo, “della
145
Tenzone nº 4
2003
propria eccellenza” (S. Theol. II-II C.162 a.3); il secondo, di ricchezza,
ma come si è visto, anche nel suo significato metaforico di 'sapienza'.
Questa considerazione spiega il carattere famelico dei due animali e,
allo stesso tempo, conferma il significato attribuito alla lonza, giacché
le ricchezze non sono un appetito, ma lo suscitano (cupidigia): se
Dante avesse voluto rappresentare nella lonza la lussuria (un altro
appetito), l’avrebbe sicuramente descritta 'famelica'.
Le ricchezze -come la lonza- sono una pro-messa (tentazione)
del diavolo o Rex superbus (“qui volunt divites fieri, incidunt in
tentationem, et in laqueum diaboli”), fraudolenta, perché all’inizio
promettono di saziare ogni appetito (la lonza è sazia) e poi invece
rendono una fame insaziabile: la lupa, “che mai non empie la bramosa
voglia, / e dopo il pasto ha più fame che pria”. Gorni (1995: 33), per
questi versi, rimanda ad Ovidio (Metam. VIII 834): “Plusque cupit quo
plura suam demittit in alvum”, esametro riferito al sacrilego Erissitone,
punito per aver profanato un recinto di Cèrere e abbattuto una quercia
immensa cara alla dea. L’incaricata di punirlo è Fames51, che
s’impossessa del personaggio trasmettendogli una fame tale che solo
potrà saziare alla fine divorando il proprio corpo, cioè morendo. Il
mito ricorda fortemente il peccato d’Adamo ed Eva, castigato con una
concupiscenza (fomes) che non ha termine se non con la morte; e non
credo casuale che a proposito della “bestia” il poeta rimandi a
quest’episodio biblico: “Questi la caccerà per ogne villa, / fin che
l’avrà rimessa ne lo ‘nferno, / là onde ‘nvidia prima dipartilla”. Se il
verso è un rinvio al momento della tentazione di Eva (“invidia autem
diaboli mors introivit in orbem terrarum”, Sap. 2, 24), non possiamo
dimenticare che la promessa del diavolo consisteva proprio nel fatto
che se avessero mangiato il frutto vietato gli si sarebbero aperti gli
occhi (conoscenza del bene e del male) e sarebbero diventati “sicut
dii” (Gen. I, 3), vale a dire, la stessa promessa fatta a Boezio dalla
Filosofia. È, quindi, questa promessa a suscitare la cupidigia d’Eva, il
suo desiderio di mangiare il frutto, allo stesso modo che è la promessa
della ricchezza-sapienza (lonza) a suscitare il desiderio di Dante, il
quale non casualmente si compara nei versi 55-57 ad un avaro:
146
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
E qual è quei che volentieri acquista,
e giugne ‘l tempo che perder lo face,
che ‘n tutti suoi pensier piange e s’attrista;
tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi ‘ncontro, a poco a poco
mi ripigneva là dove ‘l sol tace.
Evidentemente la bestia gli fa retrocedere e perdere il terreno
guadagnato, come la sfortuna52 fa perdere all’avaro la ricchezza
accumulata (l’acquisto). Il terreno (il colle) dunque è considerato come
l’acquisto dell’avaro, e l’avaro non è altro che Dante che sta salendo il
colle con 'cupidigia', vale a dire, con un desiderio ‘insaziabile’ come
quello che suscitano le ricchezze, anche se promettono “rendere lo
raunatore pieno d’ogni appagamento” (cfr. Cv. IV xii 4). A questo
punto, quindi, appare chiara la funzione della similitudine: Dante è
l’avaro, ma la lonza (la ricchezza) è il proprio “colle”, che all’inizio gli
si presenta come un bene 'seduttore' (nel senso etimologico), amabile
(“gaetta”) anche se 'arduo' (“fiera”), difficile da conquistare (come la
ricchezza), ma possibile per lui (data “l’ora del tempo e la dolce
stagione”), e che dopo diventa, ai suoi occhi, sempre più alto e
aggressivo (il leone) fino al punto di non lasciarsi togliere le sue
“ricchezze” (la lupa), anzi uccidendo chi tenta di farlo: “ché questa
bestia, per la qual tu gride, / non lascia altrui passar per la sua via, /
ma tanto lo ‘mpedisce che l’uccide;”. Infatti, la lonza (un animale
probabilmente piccolo come la lince) appare davanti a Dante “quasi al
cominciar de l’erta”, cioè quando la salita è meno ripida e perciò più
promettente, anche se non facile se si pensa che Dante fu “per ritornar
più volte vòlto”; il leone compare quando la costa del monte si fa più
verticale e la cima, perciò, pare più alta (“con la test’ alta”), vale a dire,
'superba', in tal modo che "parea che contra me venisse / con la test’
alta e con rabbiosa fame, / sì che parea che l’aere ne tremesse”53: al
riguardo, credo sia chiarificatore questo passo del Purgatorio: “Lo
sommo er’ alto che vincea la vista, / e la costa superba più assai / che
da mezzo quadrante a centro lista” (IV, 40-42); ed infine la lupa, che
viene a segnare l’impossibilità di raggiungere il sommo senza
147
Tenzone nº 4
2003
ammazzarsi. C’è da notare che il colle, che all’inizio pare arduo ma
sormontabile e successivamente diventa, allo sguardo di Dante, sempre
più pericoloso e alto, impossibile a salirsi (mortale), presenta delle
caratteristiche opposte a quelle del monte del Purgatorio: “Ed elli a
me: «Questa montagna è tale, / che sempre al cominciar di sotto è
grave; / e quant’ om più va su, e men fa male. // Però, quand’ ella ti
parrà soave / tanto, che sù andar ti fia leggero / com’ a seconda giù
andar per nave, // allor sarai al fin d’esto sentiero; / quivi di riposar
l’affanno aspetta.»” (IV, 88-95)54. Mi sembra che, oltre a quelli già
rilevati, questi tratti opposti distinguano con chiarezza i due monti.
Quello del Purgatorio è “santo”, invece quello del proemio è assimilato
alla “bestia”: ingannatore -come la ricchezza- (lonza), superbo (leone)
e avaro (lupa). E qui bisogna chiarire che non è che Dante progredisca
nel suo salire e perciò la sua ascesa si faccia sempre più difficile fino a
diventare impossibile, ma che è il suo sguardo -alzatosi dal suolo,
all’inizio dell’erta, fino alla cima- a giudicare il colle 'superbo' e
'avaro', intendendo quest’ultimo come avarus in retinendo e non in
capiendo, come è il caso del Dante personaggio.
L’immagine del monte ed il suo carattere mutevole -rilevabile
nella metamorfosi della bestia-, ricordano fortemente la descrizione
che della Filosofia fa Boezio all’inizio della Consolatio:
La sua statura era di ambigua valutazione. Ora infatti si
manteneva nei limiti della normale statura degli uomini,
ora invece sembrava toccare il cielo con la sommità del
capo: e quando levava la testa ancor più in alto, penetrava
nel cielo stesso, rendendo vano lo sguardo di chi tentava
di seguirla con gli occhi (I,1)55.
Insieme a questi tratti va considerato anche che Boezio vede la
Filosofia -come Dante il monte- innanzi a sé e sopra la sua testa
(“astitisse mihi supra verticem visa est mulier…”), rilevandosi pure,
nello stesso passo, la sua capacità di scorgere lontano assai maggiore
di quella degli uomini (“oculis ardentibus et ultra communem
hominum valentiam perspicacibus”), fatto quest’ultimo già notato nel
148
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
caso del colle (“specula”), alla cima del quale Dante tenta di salire
cercando di poter vedere (“speculari”) più lontano.
A questo punto c’è da chiedersi, però, perché Virgilio lo chiami
“il dilettoso monte / ch’è principio e cagion di tutta gioia”.
Evidentemente il problema non sta soltanto nel monte, ma soprattutto
nel proprio Dante che lo “vede” e lo giudica così, influito dalla fatica
dovuta alla gravezza del proprio corpo che si fa sentire già sin
dall’inizio dell’erta in contrapposizione al suo ardente desiderio
d’arrivare al sommo. Se Dante, appena uscito dalla selva, vede “il
dilettoso monte” come un “colle” (si noti che non lo denominerà più
così e che non ci sono ragioni di rima che giustifichino la scelta)56 è
perché prima, nella "piaggia", gli sembra ‘poco levato’ per le sue
forze, vale a dire 'umile' (“Di quella umile Italia fia salute”), e poi
'molto levato', cioè 'superbo'; in altre parole, all’inizio pensa di farcela
a salire, mentre dopo invece quando guarda dall’erta la cima,
impaurito dall’altezza, sente di non farcela a causa del proprio corpo
che prevedibilmente diventerà sempre più pesante per lui (“questa mi
porse tanto di gravezza / con la paura ch’uscia di sua vista, / ch’io
perdei la speranza de l’altezza”). D’altronde non va dimenticato che
proprio il corpo costituisce anche il principale problema
(impedimento) per il personaggio di fronte al leone e alla lupa che,
famelici, vogliono -letteralmente- divorarlo57. Il fatto che il
personaggio “veda” il monte successivamente come una lonza, un
leone e una lupa, è un fenomeno da riportare a quel che Dante racconta
nel Convivio della donna gentile (la Filosofia):
E dico che par che parli [la canzone seconda] contrara a
quella [la ballatetta], dicendo: tu fai costei umile, e quella la fa
superba, cioè fera e disdegnosa, che tanto vale. Proposta questa
accusa, procedo a la scusa per essemplo, ne lo quale, alcuna
volta, la veritade si discorda da l’apparenza, e, altra, per diverso
rispetto si puote tra[nsmu]tare. Dico: Tu sai che ‘l ciel sempr’ è
lucente e chiaro, cioè sempr' è con chiaritade; ma per alcuna
cagione alcuna volta è licito di dire quello essere tenebroso. […]
Partendomi da questa digressione, che mestiere è stata a vedere
149
Tenzone nº 4
2003
la veritade, ritorno al proposito e dico che sì come li nostri occhi
‘chiamano’, cioè giudicano, la stella talora altrimenti che sia la
vera sua condizione, così quella ballatetta considerò questa
donna secondo l’apparenza, discordante dal vero per infertade
de l’anima, che di troppo disio era passionata. E ciò manifesto
quando dico: chè l’anima temea, sì che fiero mi parea ciò che
vedea ne la sua presenza. Dov’è da sapere che quanto l’agente
più al paziente sé unisce, tanto più forte è però la passione, sì
come per la sentenza del Filosofo in quello De Generatione si
può comprendere; onde, quanto la cosa desiderata più
appropinqua al desiderante, tanto lo desiderio è maggiore, e
l’anima, più passionata, più si unisce a la parte concupiscibile e
più abbandona la ragione. Sì che allora non giudica come uomo
la persona, ma quasi come altro animale pur secondo
l’apparenza, non discernendo la veritade. E questo è quello per
che lo sembiante, onesto secondo lo vero, ne pare disdegnoso e
fero (III ix 4-5; x 1-3).
Credo che lo stesso accada al personaggio Dante “per infertade
de l’anima, che di troppo disio era passionata” sì che 'fiero e
disdegnoso', cioè superbo, gli “parea ciò che vedea ne la sua
presenza”; ma il difetto sta in lui e non nel colle: “e di tutto questo lo
difetto era dal mio lato”(Cv. III xv 20). Nel nostro caso la sua
“infertade” è quella di voler salire il monte da solo, vale a dire, di
cercare, con cupidigia, la propria eccellenza (nel senso etimologico di
“eccellere”), che è come definisce Agostino la “superbia”: “un
desiderio d’eccellenza smisurata” (De Civ. Dei, XIV, C.13: ML
41,420) e, per l’Aquinate, anche “ardua”: “Oggetto proprio della
superbia è l’arduo, dato che è il desiderio della propria eccellenza” (S.
Theol. II-II C.162, a. 3); ma pure nella Commedia si trovano gli stessi
concetti: “È chi, per esser suo vicin soppresso, / spera eccellenza, e sol
per questo brama / ch’el sia di sua grandezza in basso messo” (Pg.
XVII 115-117). Ma l’esempio più significativo al riguardo lo troviamo
nel personaggio Adriano V (“Vidi che lì non s’acquetava il core, / né
più salir potiesi in quella vita; / per che di questa in me s’accese
amore. // Fino a quel punto misera e partita / da Dio anima fui, del
150
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
tutto avara; / or, come vedi, qui ne son punita” (Pg. XIX 109-114), nel
quale si uniscono inseparabilmente avarizia e superbia: si ricordi al
proposito l’osservazione -già citata- di S. Gregorio: “Avaritia…non
solum pecuniae est, sed etiam altitudinis. Recte enim avaritia dicitur
cum supra modum sublimitas ambitur”. È la propria avarizia e
superbia a far sì che il ‘dilettoso monte’ si trasformi ai suoi occhi in un
‘superbo e avaro’ monte: è il suo desiderio smisurato di ‘eccellenza’ ad
elevare anche smisuratamente il sommo che vuole raggiungere,
facendolo diventare inaccessibile. L’amore per la sapienza (filosofia),
la speculazione, è un’attività interiore: l’immaginare quest’attività
intellettuale come il salire un “umile” colle o una “superba” montagna,
rimanda anche all’ambizione del soggetto e alla valutazione delle
proprie forze:
L’umiltà considera la norma della retta ragione, secondo la
quale uno fa una vera valutazione di se stesso. La superbia,
diversamente, non segue questa norma, ma crede di valere più di
quel che vale. Questo deriva dal desiderio disordinato della
propria eccellenza, perché quel che si desidera ardentemente si
crede facile d’ottenere. Per questo anche il suo appetito si leva ad
oggetti più alti di quelli che gli convengono. Per questo tutte le
cose che contribuiscono ad una sopravalutazione di se stesso
conducono l’uomo alla superbia (S. Theol. II-II C.162 a.3).
L’altezza equivale alla profondità e questa all’incomprensibilità
della sapienza divina: “Altitudo proprie dicitur profunditas, id est
incomprehensibilitas secretorum Dei, unde Apostolus: «O altitudo
divitiarum sapientiae Dei!»” (Alain de Lille); “...il superbo non
sommette il suo intelletto a Dio per conoscere la verità da Lui, secondo
si dice in Mt. 11,25: ‘Nascondesti queste cose ai sapienti e ai prudenti’,
vale a dire ai superbi, che credono di essere sapienti e prudenti, ‘e le
rivelasti ai piccoli’, cioè, agli umili”’ (S. Theol. II-II C.162 a.3). Paolo
chiama questi sapienti-superbi “principi di questo mondo” (I Cor. 2,6 e
8), vale a dire, “filosofi”, secondo l’interpretazione della Glossa
accolta da Tommaso (S.Theol. I C.12 a.13)58. Ma forse è nel De beata
vita di S. Agostino dove si può trovare una spiegazione più chiara del
151
Tenzone nº 4
2003
significato “soggettivo” del “monte” dantesco, in un passo nel quale
figurano elementi molto simili a quelli del proemio:
se fosse vero che soltanto la via della ragione e la nostra
volontà conducono al porto della filosofia, dal quale si sbarca
sul suolo e sulla terra della felicità, non esiterei a dire che vi
giungerebbe un numero di persone ancora più esiguo di quello
che ora possiamo vedere. Dal momento che Dio, la natura, la
nostra volontà, forze che tutte assieme, ci hanno gettato a caso e
senza un ordine apparente in questo mondo come in un mare in
burrasca, chi potrebbe conoscere la rotta da seguire e sapere per
quale via tornare se una tempesta, che gli stolti credono nemica,
non spingesse noi verso questa terra desideratissima noi,
errabondi e inconsapevoli? […] Tutti coloro che in un modo o
nell’altro fanno rotta verso la terra della felicità devono
guardarsi bene e cercare di evitare in tutti i modi quell’altissimo
monte che s’innalza giusto di fronte al porto e lascia aperto un
piccolo spiraglio a chi si appresta ad entrare. Infatti esso è
avvolto [uestitur] e brilla di una luce tanto ingannevole da
sembrare, scambiato per la terra della felicità da coloro che vi
arrivano e ancora non sono entrati, il posto giusto per fermarsi e
soddisfare le proprie aspirazioni; ma non solo: sovente richiama
persone dal porto stesso e li vincola a sé con la lusinga di
un’altezza, la sua, da dove disprezzare gli altri è fonte di
soddisfazione […] Quale altro monte la ragione potrebbe
rappresentare, temibile a chi si avvicini o già sia entrato nella
filosofia, se non il superbo affannarsi per una gloria del tutto
vana? Un monte scavato e vuoto, di una solidità solo apparente.
Al punto che, sfondatasi la leggera crosta, rovini e sprofondi
quei tronfi individui che lo solcano vietando loro, ripiombati
nelle tenebre, quella splendida patria che appena cominciavano
a scorgere (I, 1-3)59.
Per una maggiore comprensione delle immagini credo sia utile
anche ricorrere a Riccardo di San Vittore, per il quale l’anima non può
arrivare alla contemplazione di Dio senza prima avere una piena
conoscenza di sé: “l’anima che non si è esercitata a lungo e non è
pienamente istruita nella conoscenza di sé non può elevarsi alla
152
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
conoscenza di Dio” (1991:137). L’immagine della quale si serve è
proprio quella del “monte”:
L’animo che si sforza di ascendere all’altitudine della
scienza, deve prima di tutto impegnarsi a conoscere se stesso.
Aver conosciuto profondamente se stessi rappresenta una
grande profondità di scienza.
La piena cognizione dello spirito razionale è come un monte
grande e alto. Questo monte supera le vette di tutte le scienze
del mondo, e guarda dall’alto ogni filosofia e ogni scienza del
mondo.
Che cosa di simile hanno trovato Aristotele e Platone, che
cosa di simile ha potuto trovare una così grande moltitudine di
filosofi? Senza dubbio, se essi avessero potuto salire su questo
monte con l’acutezza del loro ingegno, se gli studi fossero
bastati loro a trovare se stessi, se avessero potuto conoscere
pienamente se stessi, non avrebbero mai adorato gli idoli, non
avrebbero mai piegato il collo a una creatura né alzata la testa
contro il Creatore.
Qui i ricercatori sono venuti meno nella loro ricerca. Qui
sono venuti meno, e non potevano assolutamente salire su
questo monte. […] Quanto più ogni giorno avanzerai nella
conoscenza di te stesso, tanto più tenderai alle cose più alte. Chi
arriva a una piena conoscenza di sé, prende già possesso della
cima del monte (Ib. 143-144).
Riccardo distingue tra salita del monte e sosta nella sua cima:
La salita del monte, come si è detto, appartiene alla
conoscenza di sé, mentre le cose che avvengono sopra il monte
portano alla conoscenza di Dio (Ib. 155)
L’uomo salga quindi a cuore alto su questo monte se vuole
conoscere quelle cose che sono al di sopra delle facoltà umane.
Salga attraverso la conoscenza di se stesso: attraverso la
conoscenza di sé alla conoscenza di Dio (Ib.155),
anche se
153
Tenzone nº 4
2003
bisogna però dire che molti pensano di aver già conquistato la
cima di questo monte quando ne hanno toccato appena le falde
(Ib.149).
Il monte, quindi, sarebbe non soltanto “specula” dal quale si
contempla, ma anche “speculum” nel quale si contempla la propria
immagine: in questo senso vanno interpretate Lia e Rachele, simboli
rispettivamente della vita attiva e contemplativa. La prima, difatti,
dichiara: “Per piacermi a lo specchio, qui m’adorno; / ma mia suora
Rachel mai non si smaga / dal suo miraglio, e siede tutto giorno. // Ell’
è d’i suoi belli occhi veder vaga / com’io de l’addornarmi con le mani;
/ lei lo vedere, e me l’ovrare appaga” (Pg. XXVII 103-108). Le due
sorelle, effettivamente, rappresentano, oltre che la vita attiva e la
contemplativa, le due fasi dell’ascesa al monte santo: una prima (Lia)
nella quale l’anima “adorna” la sua immagine (purificazione) e
un’altra nella quale contempla sullo specchio la propria immagine
diventata ormai immagine di Dio:
L’anima razionale senza dubbio ha a disposizione se stessa
come immagine speciale e principale per vedere Dio. Se infatti
si colgono i misteri di Dio attraverso la comprensione delle cose
create, le tracce della conoscenza dove si trovano impresse più
esplicitamente che nella sua stessa immagine?
Noi leggiamo e crediamo che l’uomo, nella sua anima, è
creato a immagine di Dio, e finché «camminiamo nella fede e
non in visione», finché vediamo «attraverso uno specchio e
confusamente», non possiamo trovare uno specchio più adatto
alla sua immagine simbolica dello spirito razionale. Chiunque
desidera vedere Dio, pulisca il suo specchio, purifichi il suo
spirito. (Ib. 138).
Si osservi la coincidenza in uno stesso significato
(‘autoconoscenza’) delle due immagini: specchio (“speculum”) e
monte (“specula”), a differenza di ciò che afferma Agostino nel De
Trinitate:
154
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
Speculantes dixit, per speculum videntes, non de specula
prospicientes. Quod in greca lingua non est ambiguum, unde in
latinam translatae sunt apostolicae Litterae. Ibi quippe speculum
ubi apparent imagines rerum, a specula de cuius altitudine
longius aliquid intuemur, etiam sono verbi distat omnino;
satisque apparet Apostolum a speculo, non a specula dixisse
gloriam Domini speculantes. Quod vero ait: In eamdem
imaginem transformamur, utique imaginem Dei vult intellegi,
eamdem dicens, istam ipsam scilicet, id est, quam speculamur
(XV,8,14)60.
Se non mi sono sbagliato nell’analisi fatta, il colle dantesco come quello di Riccardo- oltre che “specula”, sarebbe anche
“speculum”, cioè, immagine interiore del personaggio, dominato dalla
superbia e dall’avarizia (leone e lupa), cioè dalla “bestia”: “Sed
peccando, iustitiam et sanctitatem veritatis amisit; propter quod imago
deformis et decolor facta est: hanc recipit, cum reformatur et
renovatur” (De Trinitate, XIV, 16,22. Cfr. anche XII, 11,16: «Imago
pecudis in nomine»). In altre parole nel monte Dante vedrebbe
l’immagine della sua anima diventata simile, non a Dio, ma alla
“bestia”, vale a dire, a Lucifero (“rex superbus”).
155
Tenzone nº 4
2003
NOTE
1
Altrettanto può dirsi riguardo all’allusione alla creazione del mondo dei versi 3940 (“Temp’ era dal principio del mattino, / e ‘l sol montava ‘n sù con quelle stelle /
ch’eran con lui quando l’amor divino // mosse di prima quelle cose belle”) che -oltre
il già detto dalla critica- va considerata –in un contesto filosofico come quello del
canto primo- come un rifiuto della tesi aristotelica dell’eternità del mondo (De
Caelo, I,9, 279a25), sostenuta anche dagli averroisti.
2
Ulisse è nel "senio" quando arriva alle Colonne d'Ercole (settanta anni secondo ciò
che Dante dice nel quarto trattato del Convivio), il che vuol dire che il Dante del
proemio avrebbe la metà dei suoi anni (trentacinque).
3
L’interpretazione che si fa di questo verso (prima che la mia vita fosse giunta alla
sua pienezza, al colmo dell’arco, cioè al trentacinquesimo anno) non mi pare
corretta. Il colmo dell’arco, infatti, sarebbero esattamente i trentacinque anni, non
giustificandosi in questo caso che dica “avanti”, quando nel primo verso della
Commedia dice “nel mezzo”. Penso si deva intendere 'prima che la mia età fosse
giunta alla sua pienezza, cioè, alla sua fine', senso che d’altronde si corrisponde con i
termini e il contenuto della domanda di Brunetto (“anzi l’ultimo dì”).
4
Sarà la grazia divina a concedere finalmente il “varco” del personaggio Dante ai
trentacinque anni, allo stesso modo che è Dio a non concederglielo a Ulisse alla fine
della sua vita (“com’ altrui piacque”): la grazia non ha in considerazione né l’età né
la scienza.
5
Riguardo a “su” come 'presso', si veda If. V, 98. D’altronde la situazione di Dante
in quel momento non ammette altra lettura, essendo com’è "presso” la selva e dove
questa “non ha vanto”, cioè nella “piaggia diserta”.
6
Si tenga presente anche che nel Convivio Dante adopera la metafora del mare per
riferirsi alla vita: “E dice ch’ella [l’anima nobile] fa due cose: l’una, che ella ritorna
a Dio, sì come a quello porto onde ella si partio quando venne ad entrare nel mare di
questa vita; l’altra si è che ella benedice lo cammino che ha fatto, però che è stato
diritto e buono e sanza amaritudine di tempesta.” (IV xxviii 2). In questo caso, il
personaggio della similitudine (ma anche il Dante della Commedia) sarebbe uscito
del "mare di questa vita” fuggendo la “amaritudine di tempesta” e avendo perso il
cammino “diritto e buono”.
7
Come si sa il verso è ambiguo, potendosi leggere con “che” soggetto (che non
lasciò mai sopravvivere alcuno) o con “che” oggetto (che nessuno lasciò mai da
156
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
vivo), ma la risoluzione, in entrambi i casi, è la stessa: la morte naturale non lascia
sopravvivere nessuno e nessuno ha potuto mai lasciare da vivo la vita.
8
Lo stesso concetto di 'termine della vita' si trova nel capitolo XIV della Vita Nuova:
“Onde io, quasi non sappiendo a che io fossi menato, e fidandomi ne la persona la
quale uno suo amico a l’estremitade de la vita condotto avea…”, “Allora io, riposato
alquanto, e resurressiti li morti spiriti miei, e li discacciati rivenuti a le loro
possessioni, dissi a questo mio amico queste parole: ‘Io tenni li piedi in quella parte
de la vita di là da la quale non si puote ire più per intendimento di ritornare”.
9
Si noti la diversa portata semantica di “guardare” e “vedere”: “…che lo intelletto
nostro guardare non può […] che certissimamente si veggiono…”, dove “guardare”
vuol dire ‘intendere’: “e per quello che sono intendere noi non potemo”.
10
“Il desiderio di sapienza o d’altri beni spirituali a volte si denomina
concupiscenza, o per una certa somiglianza, o per l’intensità dell’appetito della parte
superiore che ridonda in quello inferiore, in modo che anche questo tende a suo
modo al bene spirituale seguendo l’appetito superiore, e persino lo stesso corpo
serve a ciò che è spirituale, come si dice nel Salmo 83,3: ‘Cor meum et caro mea
exsultaverunt in Deum vivum’” (S. Theol. I-II, C.30 a.1, r.1).
11
Tutti i passi qui citati della Somma Teologica sono stati tradotti dall'autore
dall'edizione spagnola dell'opera.
12
“Dives: proprie amans divitias, unde in Evangelio: ‘Facilius est camelum per
foramen’, etc. […] Dicitur superbus, quia ex divitiis nascitur superbia […] Dicitur
aliquis habens spirituales divitias, unde in Psalmo: ‘Vultum tuum deprecabuntur
omnes divites plebis’, id est qui amant divitias spirituales. Dicitur Deus propter
totius boni plenitudinem et abundantiam, propter scientiam et potentiam; unde dicit
Apostolus: ‘Deus autem qui dives est in misericordia'. Dicitur etiam divina natura,
unde in Psalmo: ‘Simul in unum dives et pauper’, id est divina natura secundum
quam Christus dicitur dives et pauper, id est humana Christi natura secundum quam
fuit pauper”. “Divitiae [...] Dicuntur divitiae divinum eloquium, unde Job: ‘Et bibent
scientes divitias ejus’; […] Dicitur abundantia, unde Apostolus: ‘O altitudo
divitiarum sapientiae et scientiae!” (Alain de Lille). Va considerato al riguardo
anche l’etimologia che Varrone attribuisce alla parola dives, facendola derivare da
“divus, qui ut Deus nihil indigere videtur” (De Miguel 2000: vox "dives").
13
Vid. Enciclopedia Dantesca, vox “ricchezza”.
14
Non va dimenticato che le fiere si mangiano tra di loro. Qui la fiera è l'intelletto
umano, ma nel Purgatorio è il grifone (XXXI 80, 122, XXXII 96) simbolo di Cristo
e del mistero ("grifo" vale 'enigma') della sua doppia natura divina e umana. In
quest'ultimo caso la "fiera" non si lascerebbe divorare dal famelico intelletto umano.
157
Tenzone nº 4
2003
15
“State contenti” va interpretato nel senso che gli dà Chimenz: “Accontentatevi, o
–come parrebbe piuttosto suggerire l’uso della prep. a, invece di di– restate
contenuti (contenti, latinismo: cfr. Inf. II, 77), contenetevi, limitatevi a constatare che
le cose sono (quia sunt, formula scolastica), senza presumere di volerne sapere le
cause e l’essenza, perché, se la ragione umana avesse potuto da sé spiegar tutto, non
era necessaria la venuta di Cristo”.
16
“Dixit autem serpens ad mulierem. Nequaquam morte moriemini. Scit enim Deus
quod in quocumque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri et eritis sicut dii,
scientes bonum et malum” (Gen. I,3).
17
“Desinant ergo, desinant homines querere que supra eos sunt, et querant usque quo
possunt, ut trahant se ad inmortalia et divina pro posse, ac maiora se relinquant.
Audiant amicum Iob dicentem: «Nunquid vestigia Dei comprehendes, et
Omnipotentem usque ad perfectionem reperies?». Audiant Psalmistam dicentem:
«Mirabilis facta est scientia tua ex me: confortata est, et non potero ad eam».
Audiant Ysaiam dicentem: «Quam distant celi a terra, tantum distant vie mee a viis
vestris»; loquebatur equidem in persona Dei ad hominem. Audiant vocem Apostoli
ad Romanos: «O altitudo divitiarum scientie et sapientie Dei, quam
incomprehensibilia iudicia eius et investigabiles vie eius!». Et denique audiant
propriam Creatoris vocem dicentis: «Quo ego vado, vos non potestis venire». Et hec
sufficiant ad inquisitionem intente veritatis”. (Alighieri 1979: II, 768).
18
Si confronti Alain de Lille, vox “mons”: “Dicitur alta contemplatio”.
19
"Humanas vero animas liberiores quidam esse necesse est, cum se in mentis
divinae speculatione conservant, minus vero, cum dilabuntur ad corpora, minusque
etiam, cum terrenis artubus colligantur".
20
Se si considera che la vera patria dell’uomo è il Cielo, anche Virgilio è esiliato nel
Limbo.
21
“Sunt etenim pennae volucres mihi, / quae celsa conscendant poli; / quas sibi cum
velox mens induit, / terras perosa despicit, / aeris immensi superat globum /
nubesque postergum videt, / quique agili motu calet aetheris, / trascendit ignis
verticem, / donec in astriferas surgat domos / Phoeboque coniungat vias / aut
comitetur iter gelidi senis / miles corusci sideris, / vel, quocumque micans nox
pingitur, / recurrat astri circulum / atque, ubi iam exhausti fuerit satis, / polum
relinquat extimum / dorsaque velocis premat aetheris / compos verendi luminis. / Hic
regum sceptrum dominus tenet / orbisque habenas temperat / et volucrem currum
stabilis regit / rerum coruscus arbiter. / Huc te si reducem referat via, / quam nunc
requiris immemor, / haec, dices, memini, patria est mihi, / hinc ortus, hic sistam
gradum. / Quodsi terrarum placeat tibi / noctem relictam visere, / quos miseri torvos
populi timent / cernes tyrannos exsules”.
158
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
22
“Nam quoniam beatitudinis adeptione fiunt homines beati, beatitudo vero est ipsa
divinitas, divinitatis adeptione beatos fieri manifestum est. Sed uti iustitiae adeptione
iusti, sapientiae sapientes fiunt, ita divinitatem adeptos deos fieri simili ratione
necesse est. Omnis igitur beatus deus”.
23
“Tum ego: Papae, inquam, ut magna promittis! Nec dubito, quin possis effimere,
tu modo, quem excitaveris, ne moreris”.
24
Si osservi che nelle parole di Virgilio è implicito il desiderio umano di “eccedere
ogne contento / di quel ciel c’ha minor li cerchi sui”, cioè il desiderio del “volo”, ma
anche la sua incapacità di farlo se non tramite Beatrice.
25
“Se il diletto proviene dalla presenza di una determinata cosa, la tristezza proviene
dall’assenza di quella cosa” (S. Theol. I-2 C. 36 a. 1) (Trad. nostra).
26
Mi pare altamente significativo che la Donna gentile ci sia presentata per la prima
volta guardando –cioè “contemplando”- da una finestra, vale a dire, da un luogo alto
che serve appunto per contemplare. Una conferma di questo significato si trova in
Alain de Lille: “Dicitur mens contemplativa” (Vox: “fenestra”).
27
S. Agostino nel suo De Trinitate fa derivare speculantes da speculum, non da
specula (XV, 8, 14). L'argomento verrà trattato più avanti.
28
Nell’ultimo Libro della Consolatio, Boezio sembra contraddire ciò che la Filosofia
afferma nel passo del Libro IV citato: “Verrà, dunque, eliminato quell’unico
rapporto possibile tra uomini e Dio, che consiste appunto nello sperare e nel pregare,
se è vero che noi, in premio di un doveroso riconoscimento della nostra bassezza,
meritiamo l’inestimabile contraccambio della grazia divina, che è la sola via per cui
sembra che gli uomini possano entrare in colloquio con Dio e congiungersi con
quella inaccessibile luce, grazie all’atto stesso della preghiera, prima ancora di
essere esauditi.” (V,3) [Auferetur igitur unicum illud inter homines deumque
commercium sperandi scilicet ac deprecandi, si quidem iustae humilitatis pretio
inaestimabilem vicem divinae gratiae promeremur, qui solus modus est, quo cum
deo colloqui homines posse videantur illique inaccessae luci prius quoque, quam
impetrent, ipsa supplicandi ratione coniungi].
29
"Haud sic magni conditor orbis; / huic ex alto cuncta tuenti / nulla terrae mole
resistunt, / non nox atris nubibus obstat. / Quae sint, quae fuerint veniantque, / uno
mentis cernit in ictu; / quem, quia respicit omnia solus, / verum possis dicere solem".
30
“Quis ascendet in montem Domini? aut quis stabit in loco sancto eius?” (Ps. 23,3).
31
“Mostra l’usato costume di coloro che salgono, che sempre si fermano più in su
quel piè che più basso rimane” (Boccaccio). L’osservazione è vera soltanto nel caso
si salga rettamente, non se la salita è a spirale.
159
Tenzone nº 4
2003
32
Si osservi che qui si parla soltanto di “volo” e non ancora di “alto volo”, riservato
al mondo sopra lunare.
33
Questo passo agostiniano merita un ulteriore studio in relazione con quello del
proemio.
34
“Silere proprie. Notat verbum Dei Patris ab humana separari natura, illa enim
separatio metaphorice dicitur silentium. Qui loquitur ad aliquem, quodammodo ad
eum mittit verbum suum, Pater ergo quodammodo ad Filium locutus est quando ad
eum verbum suum misit, id est ei univit. A simile silere diceretur si verbum ab
nomine separaretur, unde David: ‘Ad te, Domine, Deus meus, ne sileas a me’”
(Alain de Lille, vox “silere”). “Verbum. Dei Filius etiam dicitur Verbum, quia sicut
intellectus procedit a mente et est coevus menti, alius tamen a mente, sic Filius
procedit a Patre, Patri coeternus, alius tamen a Patre” (vox “verbum”).
35
Gli stessi concetti o molto simili in quest’altro passo: “Sunt autem quidam qui se
putant ad contemplandum Deum et inhaerendum Deo virtute propria posse purgari:
quos ipsa superbia maxime maculat. Nullum enim vitium est cui magis divina lege
resistatur, et in quod maius accipiat dominandi ius ille superbissimus spiritus, ad
ima mediator, ad summa interclusor: nisi occulte insidians alia via devitetur; aut per
populum deficientem, quod interpretatur Amalec, aperte saeviens, et ad terram
promissionis repugnando transitum negans, per crucem Domini quae Moysi manibus
extensis est prefigurata, superetur. Hinc enim purgationem sibi isti virtute propria
pollicentur, quia nonnulla eorum potuerunt aciem mentis ultra omnem creaturam
transmittere, et lucem incommutabilis veritatis quantulacumque ex parte contingere:
quod christianos multos ex fide interim sola viventes, nondum potuisse derident”
(IV, xv, 20).
36
Il fatto sarebbe da riportare alla similitudine di “quei che volentieri acquista, / e
giugne ‘l tempo che perder lo face, / che ‘n tutti suoi pensier piange e s’attrista”.
37
Si tengano presenti le parole di Virgilio dei versi 91-96 (“A te convien tenere altro
vïaggio…”), ma anche quelle di Dante a Brunetto: “«Là sù di sopra, in la vita
serena», / rispuos’ io lui, «mi smarri’ in una valle, / avanti che l’età mia fosse piena.
// Pur ier mattina le volsi le spalle: / questi m’apparve, tornand’ ïo in quella, / e
reducemi a ca per questo calle” (If. XV, 49-54).
38
C’è da domandarsi perché “veltro” e non “cane”. Oltre i motivi di rima, si
potrebbe pensare ad una “interpretatio nominis”, basata nel greco “bélteros”,
comparativo poetico di “ágazòs”, che significa “il migliore”: si tenga presente che la
monarchia era considerata da Dante la migliore forma di governo.
39
“Ant. Insieme delle caratteristiche innate, fisiche e morali, di una persona […],
natura, costituzione; carattere: Anonimo, I-568: ‘Simile hai nazion di badalischio /
160
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
che pur concedi male e già non bene’” (Grande Dizionario della Lingua Italiana,
vox “nazione”).
40
Per il problema del Veltro va considerato anche Alain de Lille: “Canis, proprie,
dicitur praedicator vel bonus praelatus. Canis insignes habet proprietates: bonos
significat pastores; secundum dejectos mercenarios et fures. Canis autem hae sunt
insignes proprietates. Canis est animal exhibens homini familiaritatem domini
custodiens aedem, furem arcens, latrans contra lupum venientem, fugans latronem,
linguam medicinalem habens: secundum has proprietates signat bonum pastorem qui
tenetur subditis exhibere compassionis familiaritatem, judicare subditorum
infirmitatem, congaudere sanis, compati aegris, regere viantes, corrigere deviantes;
hic etiam tenetur custodire domum Domini, id est Ecclesiam Dei ne fur, id est
haereticus, aliquem subripiat de Ecclesia per sugestionem; ne lupus, id est diabolus,
aliquem devoret per tentationem; ne latro, id est tyrannus, in Ecclesia irruat per
violentam tyrannidem, unde Psalmista: ‘Famem patientur ut canes’, et alibi: “Lingua
canum tuorum”.
41
Escludo che il Veltro possa riferirsi ad un pontefice, in quanto nell’epistola VI, la
situazione della Chiesa e del Papato è considerata anche una conseguenza del trono
imperiale vacante: “solio augustali vacante, totus orbis exorbitat, quod nauclerus et
remiges in navicula Petri dormitant, et quod Ytalia misera, sola, privatis arbitriis
derelicta omnique publico moderamine destituta, quanta ventorum fluentorumve
concussione feratur verba non caperent, sed et vix Ytali infelices lacrimis
metiuntur”.
42
Si ricordi che “pericolo” rimanda etimologicamente al latino “periri”, ‘perire,
morire’.
43
Il fatto che nel 1285 ci fosse una lonza ingabbiata nel Comune di Firenze fa
pensare ad un animale raro, che non abbondava e difficile a catturare: in caso
contrario non si spiegherebbe che fosse esposta alla curiosità pubblica e, addirittura,
in un luogo così marcato politicamente e così rappresentativo della città. Per
riassumere, doveva essere considerato una preda difficile e ambita dai cacciatori. La
sua esposizione al pubblico sarà stata probabilmente un’espressione dell’orgoglio
cittadino di possederla, qualcosa che gli altri Comuni non erano riusciti ad avere.
44
“ha il suo corrispondente nel francese antico ‘lonce’ [nel francese antico si ritenne
però articolo la l- iniziale, e tale forma, ‘la onça’, è conservata nel nostro Proverbia
super natura feminarum [I 542] 461” (E. Dantesca).
45
Va ricordato al riguardo che Ricchezza è anche personaggio allegorico del Roman
de la rose (10051-271), del Fiore (LXXIV-LXXVI) e del Detto d’Amore (277-360),
e che impedisce l’amante di salire al Castello per la via più breve (“la droite voie”
nel Roman, “camino / Più corto” nel Detto), mostrandosi verso questo “crudel e
161
Tenzone nº 4
2003
fera” (Fiore LXXVII, CCXXXII; Roman 10074). Il tema merita ulteriori e più
profonde considerazioni.
46
Sono dell’opinione che, basicamente, il leone significhi il potere e la lupa, la fame.
Infatti il verso 99, “e dopo ‘l pasto ha più fame che pria”, come si vedrà più avanti,
rinvia a Ovidio, “plusque cupit, quo plura suam demittit in alvum” ['e quanto più
insacca nel ventre, tanto più brama'], riferito a Fames, personificazione della fame
(Metam. VIII, 834).
47
“Aurum dicitur contemplatio, unde in Apostolo: ‘Alii sunt qui aedificant aurum,
alii argentum, alii lapides pretiosos’, id est contemplantur” (Alain de Lille).
48
Significativo anche il simbolismo della “pelle”: “Dicitur etiam bonum temporale”
(vox “pellis”) se si considera che le ricchezze sono un bene temporale.
49
La chiave di queste passioni contrastanti di fronte alla lonza si trova in questo
passo di S. Tommaso: “…il bene arduo ha qualcosa che attrae l’appetito, cioè, il
fatto che è un bene, e qualcosa che lo ritrae, la difficoltà di riuscire ad averlo.
Dall’essere un bene ne deriva il movimento di speranza e dall’essere arduo quello di
disperazione. D’altra parte i movimenti dell’appetito che si comportano come
impulsi esigono una virtù che li moderi e li freni, mentre quelli che indicano un
ritiramento necessitano una virtù morale che li riaffermi e li spinga. Perciò riguardo
l’appetito del bene arduo è necessaria una doppia virtù. Una che temperi e raffreni
l’animo affinché non aspiri smisuratamente alle cose eccelse, e questa sarebbe
l’umiltà, e l’altra dovrà rafforzare l’animo contro la disperazione ed spingerlo a
desiderare le cose grandi conforme alla retta ragione, e questo è quel che fa la
magnanimità” (S. Theol. II-II, C. 161 a. 1).
50
Da felis -is (fem.), 'gatto' e citus -a -um, 'presto, rapido'. Ovviamente si tratterebbe
di un’interpretazione del nome, non di un’etimologia.
51
Jean de Meun s’ispira al personaggio ovidiano per la sua Faim, della quale fa una
dettagliata descrizione nell’episodio di Ricchezza (10167-10185).
52
La “bestia” ha a che vedere con la sfortuna ("'l tempo che perder lo face”), mentre
la lonza con la fortuna (“sì ch’a bene sperar m’era cagione / di quella fiera a la gaetta
pelle / l’ora del tempo e la dolce stagione”).
53
Il fenomeno ottico è simile a quello che Dante descrive in If. XXXI: “Qual pare a
riguardar la Carisenda / sotto ‘l chinato, quando un nuvol vada / sovr’ essa sì, ched
ella incontro penda” (136-138).
54
Montagna e anima sembrano fondersi in uno stesso significato: "il significato
spirituale di questa condizione della montagna è evidente: le difficoltà che l'anima
gravata dall'abito del peccato, dapprima trova a spogliarsene, diminuiscono man
mano ch'essa si purifica mediante la penitenza" (Chimenz). Non si dimentichi che
nel monte sono rappresentati i peccati che appesantiscono l'anima e che il primo, la
162
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
superbia, è il più 'grave'. Virgilio rileva il carattere 'non naturale' del monte ("Questa
montagna è tale" vale 'questa montagna non è come le altre'): infatti le montagne
generalmente offrono meno difficoltà alla base e più a seconda che si salgono.
55
“…statura discretionis ambiguae. Nam nunc quidam ad communem sese hominum
mensuram cohibebat, nunc vero pulsare caelum summi verticis cacumine videbatur;
quae cum altius caput extulisset, ipsum etiam caelum penetrabat respicientiumque
hominum frustrabatur intuitum”.
56
La scelta del nome si giustificherebbe nel principio nomina sunt consequentia
rerum. Infatti -come si sa- “colle” valeva tanto ‘collina’ quanto ‘monte’ o
‘montagna’: il fatto linguistico rimanderebbe al carattere ‘mutevole’ del colle.
57
In questo senso i tre animali, che come afferma Gorni “sono accomunati
dall’iniziale comune”, rappresentano “la morte” per Dante. All’interpretazione che
dell’iniziale fa lo studioso, “L (El) è il nome stesso di Dio […] Dunque in questa L
iniziale il poeta autorizza a scorgere –come nelle tre facce di Lucifero, come nella
maiuscola iniziale del nome stesso dell’angelo ribelle- un segno negato della
divinità” (1995: 31-32), ci sarebbe da aggiungere che questa lettera simbolicamente
significava anche “morte violenta” (Pérez-Rioja 1988: 262), simbolismo da riportare
forse al significato del latino “letum”. Si ricordi a questo proposito che la morte
-della quale Lucifero è il mediatore- è negazione della vita (Dio).
58
L’espressione paolina e l’interpretazione che ne danno la Glossa e Tommaso,
giustificano e spiegano l’analoga formula dantesca di Vita Nuova XXX: “Poi che fue
partita da questo secolo, rimase tutta la sopradetta cittade quasi vedova dispogliata
da ogni dignitade; onde io, ancora lacrimando in questa desolata cittade, scrissi a li
principi de la terra alquanto de la sua condizione, pigliando quello cominciamento
di Geremia profeta che dice: Quomodo sedet sola civitas”. Non si tratta, come in
genere si commenta, dei governanti del mondo, ma dei filosofi o sapienti di questo
mondo. Si noti che Paolo, forse non casualmente, per riferirsi ai filosofi usa, al
plurale, la stessa espressione che nel Vangelo si applica al diavolo: “Dicitur
diabolus, unde in Evangelio: Venit enim princeps hujus mundi” (Alain de Lille: vox
“princeps”).
59
“Si ad philosophiae portum, e quo iam in beatae uitae regionem solumque
proceditur […] ratione institutus cursus et uoluntas ipsa perduceret, nescio, utrum
temere dixerim multo minoris numeri homines ad eum peruenturus fuisse, quamuis
nunc quoque, ut uidemus, rari admodum paucique perueniant. Cum enim in hunc
mundum siue natura siue necessitas siue uoluntas nostra siue coniuncta horum aliqua
siue simul omnia […] uelut in quoddam procellosum salum nos quasi temere
passimque proiecerit, quotusquisque cognosceret, quo sibi nitendum esset quaue
redeundum, nisi aliquando et inuitos contraque obnitentes aliqua tempestas, quae
stultis uidetur aduersa, in optatissimam terram nescientes errantesque conpingeret?
163
Tenzone nº 4
2003
[…] His autem omnibus, qui quocumque modo ad beatae uitae regionem feruntur,
unus inmanissimus mons ante ipsum portum constitutus, qui etiam magnas
ingredientibus gignit angustias, uehementissime formidandus cautissimeque uitandus
est. Nam ita fulget, ita mentiente illa luce uestitur, ut non solum peruenientibus
nondumque ingressis incolendum se offerat et eorum uoluntati pro ipsa beata terra
satisfacturum polliceatur sed plerumque de ipso portu ad sese homines inuitet,
eosque nonnumquam detineat ipsa altitudine delectatos, unde ceteros despicere
libeat […] Nam quem montem alium uult intellegi ratio propinquantibus ad
philosophiam ingressisue metuendum nisi superbum studium inanissimae gloriae,
quo ita nihil intus plenum atque solidum habet, ut inflatos sibi superambulantes
subcrepante fragili solo demergat ac sorbeat eisque in tenebras reuolutis eripiat
luculentam domum, quam paene iam uiderant?”.
60
Agostino sembra riferirsi all’etimologia, ma questa non esclude ulteriori
interpretazioni del termine.
164
Carlos
LÓPEZ CORTEZO Le promesse della filosofia. Analisi del proemio della ...
_____________________________________________________________________________________________________
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI∗
AAVV. (1993): “Lettura del Fiore”, in Letture Classensi, vol. XXII, a
c. di Z. G. Baranski, P. Boyde e L. Pertile. Ravenna, Longo Ed.
AGUSTÍN DE HIPONA (1985): La Trinidad, Madrid, B.A.C.
——
(1995): La felicità. La libertà, Milano, B.U.R.
ALANI DE INSULI: Liber in
theologicalium, P.L. 210,687-1.112.
distinctionibus
dictionum
ALIGHIERI, D. (1968): Il Convivio, a c. di G. Busnelli e G. Vandelli,
Firenze, Le Monnier.
—— (1968): La Divina Commedia, a c. di S. A. Chimenz, Torino,
Unione Tipografico-Editrice Torinese.
—— (1979): Opere minori, in La letteratura Italiana, Storia e Testi,
vol. 5, tomo II, Milano-Napoli, Ricciardi.
——
(1991): Commedia. Inferno. Con il commento di A. Mª.
Chiavacci Leonardi, Milano, Garzanti.
—— (1994): Commedia. Purgatorio. Con il commento di A. Mª.
Chiavacci Leonardi, Milano, Garzanti.
—— (1997): Commedia. Paradiso. Con il commento di A. Mª.
Chiavacci Leonardi, Milano, Garzanti.
ARISTÓTELES (1990): Retórica. Introducción, traducción y notas
por Q. Racionero, Madrid, Gredos.
—— (1998): Ética Nicomáquea. Ética Eudemia. Traducción y notas
de J. Pallí Bonet, Madrid, Gredos.
Biblia Vulgata (1999), Madrid, BAC.
BOEZIO, A. M. S. (1977): La consolazione della filosofia, Milano,
B.U.R.
165
Tenzone nº 4
2003
DE MIGUEL, R. (2000): Nuevo diccionario Latino-Español
etimológico, Madrid, Visor.
Enciclopedia Dantesca (1984): Appendice. Biografia. Lingua e stile.
Opere. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.
GAGLIARDI, A. (1998): “Dante e Averroè”. Studi Testuali, 5,
Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 185-198.
GAGLIARDI, A. (2002): Tommaso d’Aquino e Averroè. La visione di
Dio, Soneria Mannelli, Rubbettino.
GORNI, G. (1995): Dante nella selva. Il primo canto della Commedia,
Parma, Nuova Pratiche Editrice.
GREGORIO MAGNO: Quadraginta homiliarum in Evangelia libri
duo, ML 76, 1075-1312.
GUILLAUME DE LORRIS ET JEAN DE MEUN (1992): Le Roman
de la Rose, édition d’après les manuscrits BN 12786 et BN 378,
traduction, présentation et notes par A. Strubel. Paris, Le Livre de
Poche.
ISIDORO DE SEVILLA (1993): Etimologías, Madrid, B.A.C.
PÉREZ RIOJA, J.A. (1971): Diccionario de símbolos y mitos, Madrid,
Tecnos.
RICCARDO DI SAN VITTORE (1991): La preparazione dell’anima
alla contemplazione. Beniamino minore, a c. di C. Nardini, Firenze,
Nardini Editore.
TOMÁS DE AQUINO (1994): Suma de Teología, Madrid, B.A.C.
—— (1990): Commento al Vangelo di San Giovanni, Roma, Città Nuova.
∗
Rinuncio ad elencare la sterminata bibliografia sul canto primo dell’Inferno, con
eccezione fatta dello studio di G. Gorni.
166