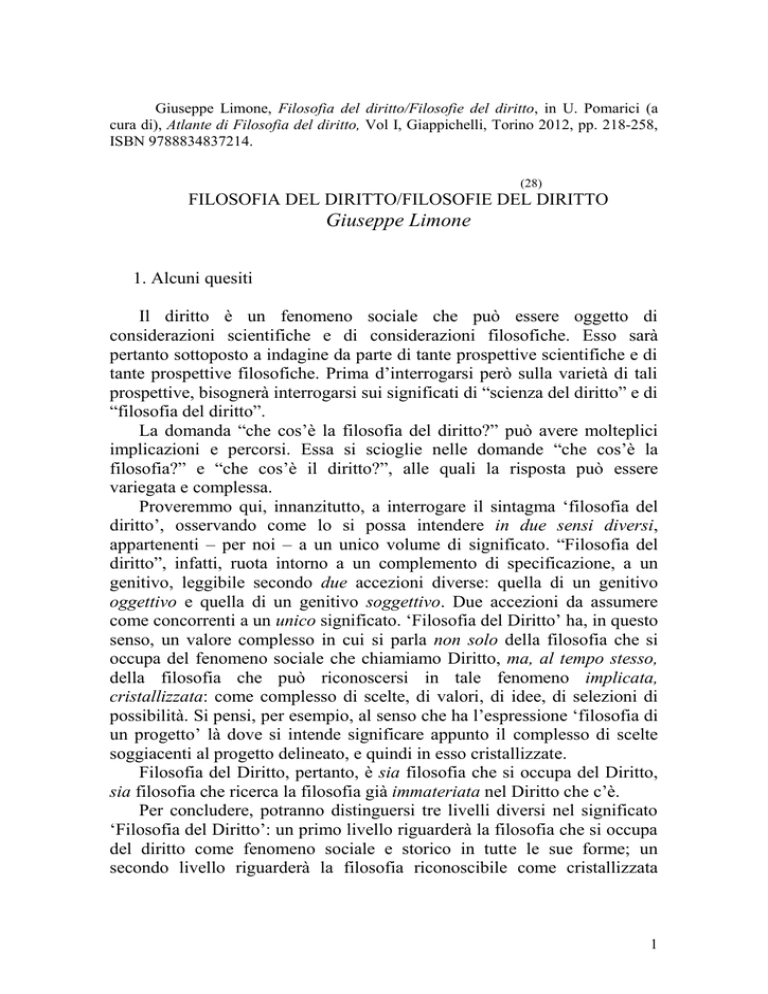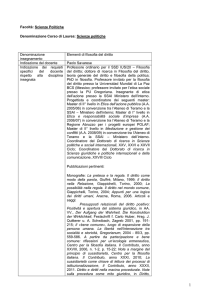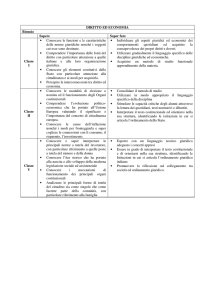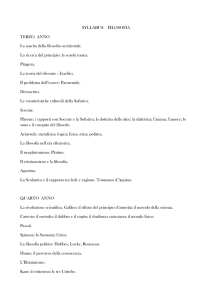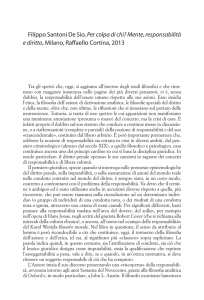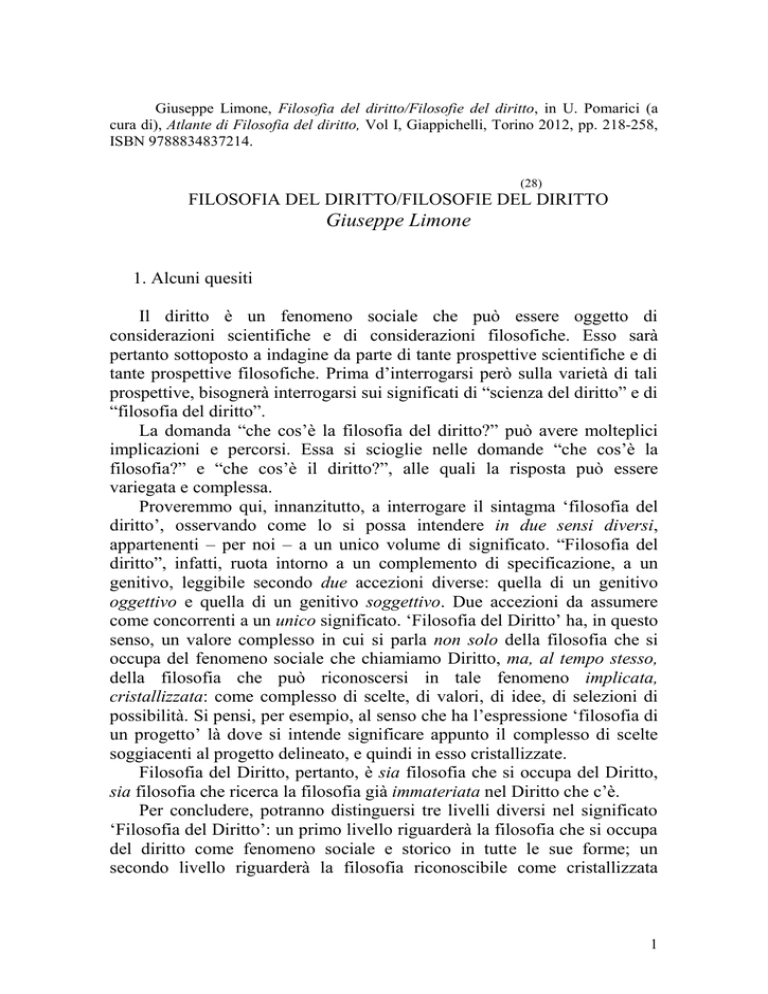
Giuseppe Limone, Filosofia del diritto/Filosofie del diritto, in U. Pomarici (a
cura di), Atlante di Filosofia del diritto, Vol I, Giappichelli, Torino 2012, pp. 218-258,
ISBN 9788834837214.
(28)
FILOSOFIA DEL DIRITTO/FILOSOFIE DEL DIRITTO
Giuseppe Limone
1. Alcuni quesiti
Il diritto è un fenomeno sociale che può essere oggetto di
considerazioni scientifiche e di considerazioni filosofiche. Esso sarà
pertanto sottoposto a indagine da parte di tante prospettive scientifiche e di
tante prospettive filosofiche. Prima d’interrogarsi però sulla varietà di tali
prospettive, bisognerà interrogarsi sui significati di “scienza del diritto” e di
“filosofia del diritto”.
La domanda “che cos’è la filosofia del diritto?” può avere molteplici
implicazioni e percorsi. Essa si scioglie nelle domande “che cos’è la
filosofia?” e “che cos’è il diritto?”, alle quali la risposta può essere
variegata e complessa.
Proveremmo qui, innanzitutto, a interrogare il sintagma ‘filosofia del
diritto’, osservando come lo si possa intendere in due sensi diversi,
appartenenti – per noi – a un unico volume di significato. “Filosofia del
diritto”, infatti, ruota intorno a un complemento di specificazione, a un
genitivo, leggibile secondo due accezioni diverse: quella di un genitivo
oggettivo e quella di un genitivo soggettivo. Due accezioni da assumere
come concorrenti a un unico significato. ‘Filosofia del Diritto’ ha, in questo
senso, un valore complesso in cui si parla non solo della filosofia che si
occupa del fenomeno sociale che chiamiamo Diritto, ma, al tempo stesso,
della filosofia che può riconoscersi in tale fenomeno implicata,
cristallizzata: come complesso di scelte, di valori, di idee, di selezioni di
possibilità. Si pensi, per esempio, al senso che ha l’espressione ‘filosofia di
un progetto’ là dove si intende significare appunto il complesso di scelte
soggiacenti al progetto delineato, e quindi in esso cristallizzate.
Filosofia del Diritto, pertanto, è sia filosofia che si occupa del Diritto,
sia filosofia che ricerca la filosofia già immateriata nel Diritto che c’è.
Per concludere, potranno distinguersi tre livelli diversi nel significato
‘Filosofia del Diritto’: un primo livello riguarderà la filosofia che si occupa
del diritto come fenomeno sociale e storico in tutte le sue forme; un
secondo livello riguarderà la filosofia riconoscibile come cristallizzata
1
nello stesso fenomeno osservato; infine, un terzo livello, semanticamente
più pregnante, riguarderà la filosofia che si occupa del fenomeno-diritto sia
in relazione agli altri fenomeni della vita, sia nei significati filosofici già
cristallizzati in quell’oggetto.
2. Filosofia e Diritto
Ma che cos’è ‘Filosofia’ e che cos’è ‘Diritto’? Preferiremmo muovere
da una distinzione capitale, portata in auge da Martin Heidegger, il quale,
come è noto, ha scritto: “La scienza calcola, la filosofia pensa”.
La scienza calcola. La scienza misura il suo oggetto come un dato che
non mette in discussione e che, anzi, assume come premessa del discorso.
E, nel farlo, misura, all’interno del suo oggetto, tutte le possibili relazioni,
strutture, funzioni. Misurazione compiuta attraverso passi logici anch’essi
misurati (‘algoritmici’): il ‘metodo’. Che è la strada attraverso la quale la
scienza conosce il suo oggetto per sezionarlo noeticamente in tutte le
possibili relazioni, strutture, funzioni.
La filosofia pensa. Mentre la scienza identifica e calcola significati, la
filosofia apre la domanda sui valori e sul senso, assumendo il primato del
domandare sul rispondere e prospettando come oggetto problematico lo
stesso conoscere, valutare e agire. La filosofia indaga il suo oggetto
insieme col lessico in cui arriva: studiandone i presupposti, mettendolo in
rapporto con le prospettive possibili, coi valori, coi caratteri
dell’interpretazione e del linguaggio, coi limiti della conoscenza e del
pensiero, con l’incidenza del metodo sull’oggetto, con le condizioni di
possibilità del guardare e del guardato, col complessivo mondo dell’agire,
con l’essere profondo della realtà, con l’esistere umano e con le sue
domande di senso. E, nel far questo, la filosofia mette in questione tutto ciò
che le appare come un dato, scoprendolo come un problema. In quanto
attività investigante sui presupposti, infatti, la filosofia è una straordinaria
forza di demistificazione dell’ovvio e, perciò, di vigilanza critica nei
confronti del reale e delle sue forme. In questo senso, essa è interrogazione
che muove dai più radicali centri di senso dell’esistenza umana, per
investire ogni possibile oggetto da cui esigere risposte. Sulla sua
consistenza conoscitiva sembra opportuno, perciò, fin da ora, indicare due
profili di riflessione. In primo luogo, in quanto l’attività filosofica nasce
all’incrocio tra forza critica e fantasia speculativa. In secondo luogo, in
quanto l’attività filosofica è aperta alle necessità originarie di ogni pensante
(ogni uomo è naturalmente filosofo) ed è abbisognevole di capacità critiche
e talenti che non è facile a tutti conseguire.
2
Dicevamo che la scienza calcola e la filosofia pensa. In un senso
semplice e rigoroso è certamente vero che sia il calcolare sia il pensare
sono attività intellettuali. Ma fra queste due forme di attività va individuata
fin dall’inizio una differenza essenziale: mentre il calcolare cerca di
individuare una risposta all’interno dei presupposti già dati, risposta quindi
già determinata ancor prima che la si trovi (si pensi, per esempio, al calcolo
di una soluzione all’interno di un sistema di equazioni), il pensare è
inventare percorsi nuovi non predeterminabili in astratto e potenzialmente
infiniti, percorsi la cui qualità deriva dalla fantasia teoretica con cui
l’autore, collocandosi davanti al possibile e non al determinato, cerca di
immaginare, tra gli infiniti percorsi possibili, quello che apre un punto di
vista nuovo e illuminante sulla questione delineata. In sintesi, il calcolare si
confronta col determinato, il pensare si confronta col possibile: il primo
cerca risposte, il secondo pone domande; il primo cattura soluzioni, il
secondo imposta questioni; il primo lavora con la logica che determina, il
secondo con la fantasia che inventa.
Non va certamente trascurato, in proposito, che fra il ‘calcolare’ e il
‘pensare’ si dànno molte zone di frontiera, di sovrapposizione e d’incrocio.
Una tale considerazione conduce ai molteplici modi in cui scienza e
filosofia sono chiamate a collaborare e a interagire. Non a caso, il livello
filosofico dell’investigare emerge sempre, prima o poi, dal seno stesso delle
scienze, le quali, a un certo livello del loro calcolare, avvertono un bisogno
teorico ineludibile: sia – in termini verticali – nel riflettere sul senso del
loro operare, sia – in termini orizzontali – nel rompere le paratie
disciplinari in nome di un’epistemologia della complessità. Si pensi, oggi,
all’emergere incontenibile, dal seno delle stesse scienze, di interrogazioni
filosofiche miranti a saperi transdisciplinari, epistemologici, bioetici,
biogiuridici, biopolitici, biofilosofici.
In questo senso, se il calcolare della scienza si pone a un livello primo,
il pensare che essa scienza propizia si colloca al livello secondo di un
meta-calcolare, donde si apre lo spazio alla filosofia.
Ma che cos’è il Diritto? Varie sono state le risposte a una tale
domanda. Il diritto è stato visto, volta per volta, come modello inscritto
nella natura, o nella vita, o nella ragione umana, o come norma, o rapporto,
o istituzione, o come attività dello spirito, o come libera creazione dei
commerci, o come elaborazione simbolica della pressione psico-sociale, o
come previsione concettuale delle sentenze del giudice, o come
ordinamento imposto da un’Autorità idonea a farsi obbedire, o come
complesso fenomeno interpretativo fondato su una scienza delle
precomprensioni (in quest’ultimo caso, ‘ermeneutica’). A ognuno di questi
3
atteggiamenti con cui può guardarsi il diritto corrisponde una particolare
“filosofia del diritto”, o meglio una particolare dottrina filosofica del
diritto.
Andando oltre le sfaccettature indicate, va fatta una precisazione
preliminare. In una prima approssimazione, può dirsi che il diritto va visto
a due livelli di fondo: 1) come la complessiva attività pratica con cui una
società – strutturata o no in Stato – si autoregola in un ordine garantito; 2)
come il risultato in cui quest’attività si deposita, facendosi conoscere e
rispettare.
Non c’è società umana che possa vivere senza un ordine, il quale ne è
imprescindibile condizione di possibilità. Ma ogni società si avvale di più
strategie di persuasione all’ordine: il costume, l’etica, le credenze comuni,
la religione, l’economia, il buon gusto, il buon senso, le regole di
convenienza, le sanzioni sociali, il diritto. Si tratta di forme regolatrici,
configurabili come tanti circoli attraverso cui una società mira, per la sua
conservazione, a darsi un ordine, ossia strutture vincolanti di
comportamenti prevedibili e ripetibili nel cui quadro far vivere stabilmente
attività, cómpiti, richieste, aspettative. Ma tali forme di persuasione
all’ordine non sempre conseguono il proprio scopo. Se proviamo a pensare
a tali strategie come a tanti circoli inscritti in uno più grande, possiamo
accorgerci che il diritto costituisce, almeno nelle società più evolute, il
circolo più interno e più duro, quello in cui l’attività autoregolatrice si
esprime in una forma più stringente, capace di strutturare – attraverso
vincoli imposti e aspettative tutelate – un ordine garantito. “Ordine”,
infatti, è l’insieme delle strutture prevedibili e ripetibili entro le quali può
svolgersi stabilmente la convivenza umana. Esso è “garantito” nella misura
in cui l’attività regolatrice che lo pone sia capace di imporre
complessivamente l’osservanza delle sue regole. In questo senso, la
“garanzia” è null’altro che l’idoneità strutturale della forza regolatrice a
rendere “effettiva” – almeno in certi limiti – l’osservanza di quanto da essa
disposto, mentre l’“effettività” è null’altro che il concreto svolgersi dei
comportamenti, almeno nelle linee generali, secondo l’ordine imposto. Si
pensi, per un esempio, all’importanza di garantire dalla volubilità la parola
data.
Il Diritto, perciò, è sia l’attività pratica con cui una società regola sé
stessa in forme vincolanti, sia il prodotto in cui una simile attività si
sedimenta. Si tratta di due piani che non vanno confusi. Molto spesso,
invece, soprattutto nell’era contemporanea, le dottrine giuridiche e
filosofico-giuridiche li confondono, riducendo di fatto, consapevolmente o
inconsapevolmente, il primo livello al secondo. La dottrina
giuspositivistica, per esempio, considerando come unico Diritto esistente
4
l’ordinamento formale imposto da un’Autorità capace di renderlo effettivo
nel sociale, riduce il primo piano al secondo, espellendo dall’orizzonte
conoscitivo il primo. Si tratta di un’estromissione che è fonte di molti
equivoci e conseguenze.
A prescindere dalla distinzione teorica fra l’attività regolatrice della
società e il prodotto in cui si esprime, se ci limitiamo a osservare
empiricamente il diritto come fenomeno sociale, incontriamo
necessariamente una pratica sociale. Una società non è solo un insieme di
uomini, ma un insieme di pratiche sociali. Ogni uomo, nel momento stesso
in cui nasce, è già inserito in una rete sociale, nella quale sarà poi condotto
progressivamente a maturare. Non è possibile, d’altra parte, pensare una
pratica sociale indipendentemente dalla regola che in essa si incarna. Ciò
significa che ogni pratica sociale nasce insieme con la regola che in essa si
dà. Ludwig Wittgenstein avrebbe detto che una pratica sociale è una
Lebensform, una Forma di vita. Non è possibile dissociare in questa forma
di vita quanto attiene al comportamento e quanto attiene alla regola, perché
comportamento e regola nascono e vivono insieme. Dentro una pratica
sociale vive una regola già inscritta in essa. Questa regola rappresenta
l’ordine antropologico incarnato in quella pratica e in quella società.
Questo ordine è ciò che consente a una società di conservarsi e di evolvere
secondo una struttura di base. Dentro la società vive necessariamente una
regola, che è il suo jus. Una società non aspetta lo Stato per avere un suo
diritto. Ogni società, in quanto pratica sociale, ha un suo jus. Ubi societas,
ibi jus. Si pensi, per esempio, ad alcune forme socialmente incarnate di jus,
ossia di diritto antropologicamente considerato: il promettere e il rispettare
la parola data, il risarcire le lesioni inferte a un altro, il contrarre
matrimonio, il seppellire e onorare i morti, il prestare giuramento,
l’esprimersi in culti religiosi, il darsi forme di autorità e di giurisdizione,
etcetera. In questo modo, una società realizza da sempre una continua e
invisibile autorigenerazione (conservativa, ricreativa, interpretativa) della
propria tradizione. In questo senso, il jus costituisce l’ordine minimo
attraverso cui una società si conserva nello scorrere delle generazioni.
In senso generalissimo, pertanto, il diritto è una regola condivisa e la
sua esperienza, regola sia in quanto socialmente incarnata nella pratica, sia
in quanto autoritativamente prodotta, sia in quanto intellettualmente
elaborata, studiata, compresa, conosciuta, interpretata, applicata, tradotta
nei vari contesti della vita, allo scopo di realizzare un ordine sociale
osservabile e garantito. In un tale contesto comunitario, storicamente
determinato, circola quel senso di un ordine valoriale minimo condiviso,
che è un principio e che chiamiamo “senso del diritto”, ossia il senso del
diritto di quella determinata comunità.
5
Sul piano dello sviluppo epocale, il diritto passerà da un significato
antichissimo, per cui nell’ordine del diritto vivono insieme confusi fattori
religiosi, etici e sociali, a un significato secolarizzato in cui si intenderà per
diritto solo quell’ordine minimo, più stringente e garantito, che consente a
una società di conservarsi, nello spazio e nel tempo, nelle sue linee
essenziali.
3. Forme di diritto e forme di conoscenza
Una società, nel suo autoregolarsi come convivenza stabile, si dà un
Jus – un Diritto. Un tale Jus si esprime in un vissuto comune, storicamente
sedimentato in ragioni sociali e valoriali: attraverso una consuetudine più o
meno identificata con pratiche e credenze religiose, attraverso strutture
oracolari o sapienziali o giurisprudenziali, attraverso princípi sociali
condivisi, attraverso forme di monopolio della forza (“Stato”) che si
traducono in Leggi. Un “Jus” può – non ‘deve’ – darsi in forma di “Lex”.
Ciò che è costitutivo del Diritto come prodotto dell’attività pratica della
società regolatrice non è il puro manifestarsi dello Stato in una legge, ma la
sua idoneità strutturale a determinare un (minimo di) ordine garantito. Ciò
significa che, anche quando una società evoluta si è configurata in Stato,
non cessa affatto di esistere, intanto, quell’attività sociale autoregolatrice
che – in modo meno cosciente e visibile – continua a generare componenti
essenziali del Diritto, che s’incrociano con l’Ordinamento giuridico
formale in tutti i luoghi in cui il diritto, attraverso soggetti concreti, si fa:
guidandone l’identificazione, decidendone le connessioni logiche,
modellandone i significati, valutandone la forza, precisandone l’estensione.
Si tratta di punti d’incrocio in cui il Diritto, pur provenendo da luoghi
diversi del sociale (la coscienza civile, morale, religiosa; il senso della
storia; i costumi; il buon senso; etc.) viene, in punti apicali e ultimativi,
identificato e fatto vivere come mirante a un unico ordine garantito.
È questa la profonda ragione per cui alcuni degli autori più avvertiti,
soprattutto in epoca moderna, hanno preferito distinguere – anche sulle
orme romanistiche e su quelle vichiane – fra Jus e Lex: il Jus come il
prodotto essenziale e complesso che ogni società si dà in ragioni sociali e
valoriali sedimentate per realizzare un ordine antropologico garantito; e la
Lex come una possibile modalità in cui, a opera dello Stato, un tale Jus può
completarsi e specificarsi, ma senza che mai la Lex cessi di far esistere il
‘Jus’, che pur sempre la sottende e la circonda, la precede e la eccede.
Il Diritto, quindi, è un fenomeno sociale che si pone come capace di
dare, alla società umana e ai gruppi in essa operanti, un ordine, almeno
6
esterno, garantito.
Il convivere degli uomini, come si sa, è fatto di relazioni. Relazioni di
cooperazione, di conflitto, di organizzazione e perfino (in certi limiti) di
indifferenza. Vi si osserveranno, fra l’altro, relazioni di cooperazione nel
conflitto e di conflitto nella cooperazione. Si tratta di relazioni
indissociabili dalla vita umana. Non possono esserci, infatti, uomini senza
relazioni. Né relazioni senza un minimo di ordine garantito. Se la relazione
è, perciò, una struttura essenziale per l’esistere umano, il diritto è una
struttura essenziale per la relazione. Non a caso un autore – Vincenzo
Tomeo – ha parlato del diritto come della struttura del conflitto. Si precisi:
il diritto è struttura delle relazioni, cui garantisce l’ordine. E lo fa, almeno
negli stadi più evoluti, non solo regolando i comportamenti per impedirne il
conflitto e per consentirne la cooperazione, ma anche per regolare, a un
primo livello, il conflitto fra le azioni; a un secondo livello, il modo con cui
si confligge; e, a un terzo livello, il modo con cui si confligge
nell’interpretare le norme che regolano il conflitto. Come dire che il diritto
non determina solo le regole per non litigare, ma le regole sul come litigare
e le regole sul come litigare sulle regole che regolano il litigare. Ubi
societas, ibi jus.
La filosofia del diritto, pertanto, non indaga su un fenomeno eventuale
della vita degli uomini, ma strutturale. E lo fa secondo due prospettive, da
combinare: 1) sia in quanto è attività della società che si autoregola, sia in
quanto è diritto da essa generato; 2) sia in quanto è ‘Diritto’, sia in quanto,
nel suo costituirsi come Diritto, contiene in sé una filosofia.
4. Ordine
Ma che cos’è ‘ordine’? Il concetto di ‘ordine’, come è noto fin dal
dibattito medievale, implica un duplice livello: un ordine ordinante (‘ordo
ordinans’) e un ordine ordinato (‘ordo ordinatus’). C’è, in ogni assetto, un
ordine pensante e volente che si traduce in ordine realizzato. Si tratta di una
distinzione che, trasferita sul piano del diritto, apre la strada a molte
distinzioni ulteriori, importanti e specifiche, anche se collocate a più scale
di analisi e non sovrapponibili fra loro. Si pensi alla distinzione fra Diritto
formale – depositato in un ‘ordinamento’ – e Diritto effettivo, depositato
nel funzionamento reale delle ‘Istituzioni’. Oppure si pensi alla distinzione
fra ‘Costituzione formale’ (quella scritta nella Legge fondamentale di uno
Stato) e ‘Costituzione materiale’ (quella effettivamente vivente nella prassi,
anche evolutiva, degli Organi supremi).
Un’attenzione prevalente all’uno o all’altro profilo del discorso
7
genererà atteggiamenti dottrinali diversi nei confronti del diritto
(normativismo e istituzionalismo, ad esempio) e atteggiamenti disciplinari
diversi nei confronti dello stesso (filosofia del diritto e sociologia del
diritto, ad esempio).
Ma un ‘ordine’ non implica necessariamente l’idea di un ordine giusto.
Come scrive Borges parlando della sua «Biblioteca di Babele»: « ... gli
stessi volumi si ripetono nello stesso disordine (che, ripetuto, sarebbe un
ordine: l’Ordine)»1. Un ‘ordine’ implica, infatti, una prevedibilità e una
ripetibilità di forme che consentano uno strutturarsi stabile di attività e di
aspettative. Ma un tale ordine, se è giuridico, deve essere garantito. Là
dove il concetto di garanzia implica quello di idoneità strutturale a rendere
effettivo, in modo più forte e stringente, la prevedibilità e la ripetibilità
stabilite.
Si pensi, in proposito, a quelle forme di garanzia che vengono chiamate
“sanzioni”: previsioni punitive e/o premiali e/o invalidanti, appartenenti a
una strategia idonea a imporre un ordine, almeno esterno, nelle relazioni
sociali. Si pensi, tra le possibili figure di sanzione, alla costrizione,
all’esecuzione forzata, alla rimessa in pristino della situazione violata
(‘reductio in integrum’), al risarcimento dei danni, ad altre forme di
riparazione, all’invalidazione degli atti compiuti, alla privazione o
restrizione della libertà, all’inflizione di pene fisiche o pecuniarie e, nella
più recente evoluzione giuridica, alla predisposizione di misure ‘premiali’
capaci di indurre al comportamento positivamente apprezzato dal diritto.
Occorre, cioè, un ‘ordine ordinante’ idoneo a tradursi di fatto – almeno in
certi limiti – in un ‘ordine ordinato’.
Tali sanzioni, nel comportare un ordine di vincoli, presuppongono, al
tempo stesso, un ordine di poteri, capaci di rendere effettivi quei vincoli. I
quali, a loro volta, presuppongono un ordine di regole (non
necessariamente scritte) che attribuiscano quei poteri.
Il diritto potrà essere indagato, pertanto, a livello fenomenico,
ontologico, semantico, teleologico, logico, metodologico, valoriale,
epistemologico, sociale, politico-istituzionale. In ciò che è, in ciò che
intende essere, in ciò che può essere, in ciò che dovrebbe essere, in ciò che
non può non essere, in ciò che deve poter essere, nelle sue articolazioni
d’essere, nella sua ragion d’essere, nel suo fondamento d’essere, in ciò che
complessivamente significa all’interno dell’esistenza umana.
Si distinguerà pertanto, nell’attività filosofica che investiga sul Diritto,
un’Assiologia del Diritto, una Teoria generale del Diritto (col suo lessico
specifico: diritto soggettivo e diritto oggettivo; norma e ordinamento;
ordinamento giuridico: unità, coerenza, completezza; validità, efficacia,
1
Jorge Luis Borges, Finzioni, Einaudi, Torino 1995, p. 78.
8
giustizia, effettività), una Teoria dello Stato (col suo lessico specifico:
sovranità e suo fondamento, divisione dei poteri, Stato di diritto, Stato
sociale, etc.), una Logica del Diritto (col suo lessico specifico: norme
contrarie, contraddittorie, subalterne; norme regolative e costitutive; il
problema delle lacune nell’ordinamento giuridico, etc.), una Filosofia del
linguaggio giuridico, un’Ermeneutica del Diritto, una Critica delle
Istituzioni giuridiche, una Metafisica del Diritto, un’Epistemologia della
scienza giuridica, una Teoria dell’argomentazione, una Filosofia
degl’istituti giuridici nella storia civile. Sono approcci importanti della
filosofia, che però non esauriscono l’universo degli approcci possibili.
Dire ‘ordine’ non significa necessariamente dire ‘ordine giusto’.
Mentre l’ordine giusto, infatti, implica la messa in rapporto con una
filosofia dei valori, l’ordine implica soltanto il rapporto con un insieme di
comportamenti regolati secondo un criterio di prevedibilità, di ripetibilità e
di relativa stabilità, nel quale caso l’ordine non è necessariamente giusto.
Va considerato, inoltre, che un tale ordine può presentarsi secondo due
profili completamente diversi: può concepirsi un ordine razionalmente
pensato e artificialmente imposto a un insieme sociale e può concepirsi un
ordine già immediatamente incarnato in un insieme sociale, in una società.
L’ordine concepito secondo il primo profilo è un ordine che si presenta
come razionale e artificiale, cioè delineato dalla capacità artefice della
ragione di elaborare artifici. L’ordine concepito in base al secondo profilo,
invece, è un ordine immediatamente vivente nell’insieme sociale, nelle sue
pratiche, nelle sue consuetudini: si tratta cioè di un ordine non artificiale,
ma antropologico, grazie al quale l’insieme sociale può conservarsi come
tale, pur nella sua necessaria evoluzione. Occorrerà distinguere perciò, in
ultima analisi, fra un ordine antropologico, un ordine razional-artificiale e
un ordine giusto. Una tale distinzione non implica che i tre ordini indicati
non possano sovrapporsi, ma implica che questi tre profili vanno
analiticamente differenziati. Il primo ordine (l’ordine antropologico)
riguarda il jus, il secondo (l’ordine razional-artificiale) riguarda il diritto
positivo, il terzo (l’ordine giusto) riguarda un ordine discusso alla luce di
una filosofia dei valori.
A ben vedere, tutte le varie dottrine filosofiche del diritto si
distinguono fra loro sulla base della diversa accentuazione di valore che
dànno ai tre profili di ordine qui considerati. Si parlerà pertanto di
giusnaturalismo, di giuspositivismo, di scuola libera del diritto, di
istituzionalismo, di realismo giuridico scandinavo, di realismo giuridico
americano, di ermeneutica etcetera a seconda del diverso ruolo assegnato a
quei tre significati.
9
5. Dalla ragione scientifica all’illuminismo: il Diritto nella modernità
L’era moderna si apre, come è noto, fra il Cinquecento e il Seicento,
con le grandi scoperte geografiche, con l’invenzione della stampa, con la
Riforma luterana, con la discussione di un ‘diritto naturale razionale’ (di un
diritto naturale, cioè, che la ragione, natura dell’uomo, emancipandosi dal
fondamento teologico, riconosce nella natura dei soggetti umani in quanto
razionali: giusrazionalismo), con la nascita dello Stato moderno e delle sue
visioni teoriche (Machiavelli, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu,
Rousseau), con la nascita dei canoni della scienza nuova e del suo metodo
(Copernico, Keplero, Galileo, Bacone, Cartesio, Newton, Leibniz, Vico). In
un tale contesto, la nuova concezione della scienza, istituendo un diverso
paradigma della ragione, che si emancipa dall’ipoteca del divino e
preferisce muovere dal fondamento del pensiero, individuerà, come
caratteristica del nuovo modo di investigare sul vero, l’incontro metodico
delle esperienze con la ragione: e, di qui, la sperimentalità, la ripetibilità, la
misurabilità, la prevedibilità, la riproducibilità e controllabilità delle
verifiche, insieme con la possibile artificialità derivante dal riprodurre
sperimentalmente il compreso, nell’ambito della fondamentale soggettività
ponente dell’attività ricercatrice.
In questo senso, nel Settecento, il movimento dell’illuminismo,
nascendo in Francia e irradiandosi in Europa, darà vita, nelle diverse sue
declinazioni, a un grande fenomeno di trasferimento dei princípi della
scienza moderna, dello Stato moderno e della coscienza religiosa moderna
sul piano politico-sociale. Si tratta di quell’illuminismo di cui Kant ha
lapidariamente scritto che è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità in
nome della ragione.
Il Diritto tenderà ad acquistare così, nel dibattito fra gli illuministi, una
sua forma e un suo valore, strutturalmente legati al configurarsi dello Stato
moderno e alla sua idea di sovranità. In questo evento complesso il
baricentro teorico dell’illuminismo giuridico sarà costituito da una Ragione
legislatrice, chiamata a dare le basi a un diritto razionale, semplice, uguale,
capace di garantire i diritti naturali dei consociati. La potestà legislatrice, in
un tale discorso, deve essere illuminata dalla ragione e, quindi, idonea a
porsi come unica produttrice di diritto e come autrice di una
semplificazione razionale che elimini ogni altra fonte, allo scopo di
garantire una disciplina, in quanto razionale, unica e unificante. In questa
concezione, secondo le linee emergenti dal dibattito, le leggi prodotte dalla
Ragione legislatrice dovranno essere: pre-date (ossia poste in essere prima
dei comportamenti da normare), scritte, poche, semplici, chiare, astratte,
10
generali, stabili, costituenti un ordine coerente e completo.
Ognuna di queste caratteristiche strutturali ha un suo specifico senso.
Attraverso tali prescrizioni razionali al potere legislativo, infatti, il
movimento illuminista tendeva a porre limiti – più che di contenuto – di
struttura all’Autorità sovrana: ciò affinché essa, qualunque cosa
disponesse, si sottoponesse, nel disporlo, a forme che assicurassero, sempre
e necessariamente, la precostituzione e la chiarezza del disposto, la sua
valenza per tutti, la sua stabilità nel tempo, la sua complessiva coerenza e la
sua radicale completezza. Si veniva a perseguire, così, come fine
fondamentale della ragione legislatrice, l’idoneità strutturale della norma a
disciplinare ex ante – e quindi senza interventi ex post – tutti i
comportamenti e le situazioni possibili. In una simile concezione sulla
sostanza e sui limiti razionali del potere sovrano, si trattava, in realtà, di
pensare, più che le regole, le regole con cui pensare le regole.
Collocandosi, quindi, in un’ottica, più che regolatrice, meta-regolatrice.
Vediamo. Le leggi, in base alla filosofia implicata in una simile
strategia di pensiero, dovranno essere poche, semplici e chiare: per essere
comprese senza equivoci da chi le applica e da chi vi è sottoposto.
Dovranno essere, inoltre, astratte e generali: per essere uguali per tutti
nello spazio; e stabili, per essere uguali per tutti nel tempo. Se le leggi
fossero, infatti, solo astratte e generali e non stabili, l’uguaglianza di
trattamento normativo garantita nello spazio sarebbe aggirata dalla
disuguaglianza di trattamento nel tempo.
Le leggi, infine, dovranno costituire un ordinamento completo, perché
solo in tal caso, prevedendo tutti i casi possibili, saranno veramente affidate
al potere del legislatore (diventando uguali per tutti) e non rimesse
all’arbitrio del giudice, che si esprimerebbe caso per caso, trasformandosi,
così, in un arbitrario legislatore.
Le leggi, quindi, dovranno costituire un ordine coerente e completo.
Esse non saranno, perciò, né contraddittorie né lacunose: là dove ne va non
della bellezza letteraria dell’ordinamento, ma della libertà e
dell’uguaglianza dei cittadini.
È prefigurata qui, in termini di ingegneria normativa, quella situazione
strutturale dello Stato che si chiamerà “divisione dei poteri”, per la quale il
potere legislativo è l’unico depositario della funzione di normare in via
astratta e generale, laddove al potere giudiziario compete soltanto la
funzione di applicare la norma al caso concreto: senza poter nemmeno
interpretarla, perché la possibilità interpretativa significherebbe pur
sempre la sostituzione di più norme a una norma sola, con la contestuale
creazione, da parte del giudice, di norme per i casi singoli e, quindi,
usurpatrici del potere di normare in via astratta e generale, spettante solo al
11
legislatore. Il giudice deve solo rilevare la norma. Egli è semplicemente la
bocca che pronuncia le parole della legge sul caso a lui sottoposto. Il
modello del suo giudizio è il sillogismo.
Si tratta, in realtà, della concezione attraverso cui, affidando il compito
di creare leggi (astratte, generali, stabili, coerenti, complete) al solo potere
legislativo e nessun potere creativo al giudice, si intende assicurare la
libertà del cittadino: una libertà sostanziata nel fatto che il cittadino sarà
sottoposto a una legge che conosce con chiarezza e da prima, emanata per
tutti, tale da non consentire a nessuno, nemmeno al giudice, di interpretarla
secondo l’arbitrio e il caso.
Risulta prefigurato, in queste caratteristiche strutturali per le norme e le
leggi, quel particolare valore giuridico che si chiamerà “certezza del
diritto”: valore per il quale, da un lato, la regola deve poter essere
sufficientemente chiara fin dal tempo che precede il comportamento tenuto
e per il quale, dall’altro lato, la regola deve essere stabile nel tempo. La
certezza del diritto, in realtà, intende assicurare una situazione in cui i
soggetti sottoposti alla norma siano sottratti a ogni incertezza e a ogni
precarietà.
Una tale opzione valutativa porrà alla scienza futura il problema teorico
su se sia possibile un ordinamento senza lacune o su se una norma possa
veramente prevedere tutte le situazioni possibili, dovendo conoscere
quindi, per prevederle, tutte le condizioni di possibilità della sua previsione.
Si badi. È proprio a partire dalla crisi teorica della possibilità di
concepire un ordinamento completo, senza lacune – il quale, nella sua
intenzione di fondo, intende conferire massima fiducia al legislatore e
minima al giudice –, è proprio a partire da una tale crisi che si svilupperà,
nel Novecento, una concezione ermeneutica del diritto. La quale,
esprimendo precise sensibilità filosofiche e filosofico-giuridiche
(Heidegger, Gadamer, Betti) e considerando ineludibile il problema teorico
dell’interpretazione, proprio al momento interpretativo assegnerà, nel
costituirsi del diritto, il ruolo fondamentale. Si darà vita, così, a una diversa
sensibilità nella concezione del legislatore e del giudice, attribuendosi, di
fatto, una maggiore fiducia al giudice e alla sua potestà di intervenire –
sulla base della scienza ermeneutica – nella più consapevole conoscenza e
ponderazione del caso concreto.
Come Norberto Bobbio ha mostrato, la scienza del Novecento ha
chiarito come nessun ordinamento giuridico può presentarsi come
completo, e pertanto l’attività interpretativa non è mai eliminabile. In tale
contesto, nei tempi post-illuministici una norma si dirà dotata di certezza
del diritto se sarà chiara e precisa in maniera sufficiente a non essere
sottoposta ad arbitrio interpretativo e se sarà stabile nel tempo in maniera
12
sufficiente a non essere esposta ad arbitrii di mutamento.
6. Jus e Lex
Il processo filosofico e politico avviato dall’illuminismo giuridico
tenderà a conferire, pertanto, razionalità al potere, conducendo in Europa –
anche attraverso l’evento della rivoluzione francese e dei suoi riflessi – al
movimento delle codificazioni, con cui il diritto di un territorio verrà
concentrato in un’unica fonte di produzione, di origine statuale: la Lex.
Da un lato, quindi, si chiederà al potere sovrano di esprimersi in forme
razionali e, dall’altro, si mirerà a rendere il potere sovrano l’unico
produttore di diritto. Ciò concorrerà certamente a un’unificazione delle
fonti di produzione giuridica e a una semplificazione delle norme, ma
tenderà, al tempo stesso, a ridurre tutto il Jus a Lex. Il prezzo della
semplificazione del diritto significherà la sua totale riconduzione alla
volontà politica. Ciò produrrà il progressivo occultamento del Jus, che,
riconosciuto o no dal produttore della Lex, pur continua a sussistere nella
vita giuridica delle società. Sotto forme latenti ogni società infatti continua
a generare il suo Jus e a renderlo, nei soggetti e momenti topici, vivente. La
prassi di una volontà formalizzata in ‘Lex’ con la quale si imponga che il
‘Jus’ non ci sia, non può annichilire la considerazione teorica del suo
effettivo perdurare. Potranno passare tempi anche lunghi in cui la Lex,
decretando l’inesistenza del Jus, ne renda invisibile il perdurare (e nel
plurisecolare tempo degli Stati moderni ciò è di fatto accaduto). Ma il
possibile oscuramento del Jus non ne annichilisce affatto l’esistere, né
significa che non ci saranno più tempi in cui il Jus possa riapparire alla
luce. La Lex non può – per l’impossibilità teoretica che non lo consente –
decretare qual è il Diritto e che il Jus non c’è. Perché il Diritto – di cui la
stessa Lex è espressione – la sottende e la supera da ogni lato, non solo nei
luoghi della considerazione filosofica ma nei luoghi e nei soggetti reali in
cui ogni conoscenza coglie il farsi del diritto.
C’è il diritto come attività autoregolatrice della società e il diritto come
prodotto della stessa. Ma, fra i due livelli, ce n’è uno ulteriore e preciso,
che è venuto il tempo di disoccultare: è il diritto inteso come il complesso
di orientamenti vissuti con cui l’attività sociale regolatrice guida
all’identificazione del diritto esistente e alla sua interpretazione. È diritto,
infatti, non solo quello riconosciuto dai funzionari attuatori dello stesso
(Herbert Hart), ma anche quello continuamente emergente, attraverso
soggetti topici, negli orientamenti di principio che guidano al
riconoscimento e all’interpretazione dello stesso, facendolo apparire alla
13
luce. Attraverso soggetti, luoghi e tempi il cui disconoscimento sarebbe non
solo falso ma inefficace. Per un’esemplificazione possibile, si guardi agli
stessi massimari di giurisprudenza, specialmente (ma non soltanto) quelli
della Corte di Cassazione, delle Corti Costituzionali e delle Alte Corti. In
questi massimari viene alla luce non solo l’interpretazione di ciò che
l’ordinamento dice, ma anche ciò che lo spirito del tempo di una data
comunità storica ha maturato come “senso del diritto”. In questa
prospettiva il jus di una comunità storicamente determinata si trasforma,
attraverso i processi della sua coscienza storica, nel suo attuale “senso del
diritto”.
Il Diritto formale, in definitiva, non può decretare – sostituendosi alla
teoria – di essere l’unico Diritto. Decretare che il sole non esiste non
significa l’annichilimento del sole!
Se proviamo a scavare nel livello intermedio fra l’attività
autoregolatrice della società e il diritto formalmente prodotto, se scaviamo
cioè in quello che abbiamo chiamato il complesso degli orientamenti di
principio che guidano all’identificazione e all’interpretazione del diritto
esistente, possiamo trovare più falde, strettissimamente connesse e viventi: i
valori, i princípi, le norme. Ma fra i princípi stessi bisogna distinguere. È
necessario, infatti, non confondere fra i princípi enucleabili
dall’ordinamento stesso – i ‘princípi generali dell’ordinamento’ – e i
princípi che, pur attraversando l’ordinamento, non derivano da esso. Così
come, ancora più a monte, sono individuabili orientamenti di principio che
guidano alla stessa identificazione e allo stesso rimodellamento del diritto
che esiste.
Nell’architettura qui individuata, pertanto, si distinguerà fra valori,
princípi e norme. Là dove i princípi, collocati topologicamente fra i valori
e le norme, sono, da un lato, continuamente esposti ai valori e, dall’altro,
mirati a tradursi in norme senza mai esaurirsi in esse, perché orientano
sempre oltre di esse eccedendone i confini. Mentre le norme, quindi, si
esprimono in classi definite (di fatti, di comportamenti, di situazioni) nelle
quali si circoscrive in modo esclusivo il loro dominio regolatore, i princípi
non si esauriscono mai in classi determinate e orientano, con razionalità
strategica, sempre oltre le classi stesse.
Si badi. La collocazione dei princípi fra valori e norme non è solo
topologica, ma epistemologica: dice l’essere dei princípi. Si potrebbe anche
dire, con linguaggio geometrico, che il ‘principio’ è la figura che si pone
fra la tendenza dei valori al limite della loro attuazione operativa e la
tendenza delle norme al limite della loro riconduzione all’intero. Il
‘principio’ è, in questo senso – fra i valori e le norme – il luogo geometrico
14
che costituisce il limite comune fra queste due tendenze al limite.
7. Il diritto moderno: caratteristiche strutturali delle norme
Nell’imporsi di un ordine scritto e unificato l’ordine ordinante
acquista, almeno per certi versi, una sua cospicua autonomia rispetto
all’ordine ordinato. Il che, d’altra parte, significa il progressivo
complessificarsi dei modi strutturali di cui quell’ordine scritto, per
diventare ordine effettivo nel sociale, si dota.
Un illustre giurista contemporaneo, Sergio Cotta, ha sottolineato le
forme specifiche del diritto nei confronti delle altre attività umane,
individuandole in alcuni tratti normativi. Il Diritto soprattutto nella sua
forma moderna, si esprime in alcune costanti modalità:
a. Esso regola comportamenti esteriori e non interiori (“esteriorità”). Si
tratta di un preciso guadagno teorico realizzato soprattutto in età moderna.
Si pensi come in Hobbes sia esplicitamente sancita la distinzione fra il
diritto, che si occupa dell’esteriorità, e l’etica, che si occupa
dell’interiorità. Una confusione fra i due livelli genererebbe un diritto
inquisitorio sulle intenzioni che, con l’era moderna, esce dai parametri
della civiltà giuridica. Al diritto moderno non interessa che l’obbligato
adempia imprecando dentro di sé, ma che adempia. Il che non significa che
il diritto non possa attribuire rilievo alle intenzioni (se compiute, ad
esempio, per dolo o per colpa), ma significa che una tale valutazione il
diritto compie – ove la compia – sempre in presenza di un comportamento
esteriore. Per i comportamenti interiori isolatamente presi, il diritto
moderno, per sua scelta strutturale, si astiene dal normare.
b. Il Diritto regola comportamenti e situazioni modellati in tipi
(“tipicità”). Si tratta di una caratteristica che non sussiste con eguale
nettezza in un diritto che pure è diritto, come il consuetudinario o in un
diritto – pur sempre diritto – che sia tutto processualizzato.
c. Il Diritto regola in modo eteronomo e non autonomo, dal momento
che la norma giuridica non deriva dallo stesso soggetto che vi è sottoposto
(“eteronomia”).
d. Il Diritto regola secondo una strategia di comandi e permessi
congiunti, perché comanda e permette nel senso che comanda nello stesso
tempo in cui permette e permette nello stesso tempo in cui comanda
(“imperativo-attributività”). Anche qui si tratta di un diritto pervenuto a una
sua maturazione formale e, in quanto tale, a una sua unificazione.
e. Il Diritto regola secondo una strategia di coordinazione, allo scopo
di impedire fenomeni di contraddittorietà, contrarietà, incongruenza sia tra
15
le norme sia tra le figure create (“coordinazione”). Vale, anche qui, la
considerazione di cui al punto precedente.
f. Il Diritto regola secondo una strategia sanzionatoria di traduzione
del disposto in forme sociali corrispondenti, allo scopo di rendere effettivo
il risultato voluto, per lo meno nei comportamenti esteriori (“garanzia”).
Tutto ciò fa emergere con nettezza alcuni tratti distintivi nel rapporto
fra l’etica e il diritto. Mentre al diritto, infatti, basta l’osservanza esteriore,
all’etica una tale osservanza non basta affatto, perché rimane, per essa,
decisiva l’intenzione conforme alla coscienza; mentre nel diritto si dà una
puntuale tipizzazione dei comportamenti regolati, nell’etica è decisivo,
almeno in ultima istanza, il rapporto fra la coscienza interiore e la
situazione concretamente vissuta; mentre al diritto è consustanziale
l’eteronomia, l’etica, soprattutto nell’era moderna, non è pensabile senza
autonomia; mentre nel diritto il ‘comandato’ e il ‘permesso’ sono
indissolubilmente congiunti, ciò non è necessariamente osservabile
nell’etica; mentre nel diritto, soprattutto nella fase moderna, si dà
coordinazione tra le figure create, ciò non accade affatto nell’etica; mentre
nel diritto, per la sua traduzione in comportamenti effettivi, è necessaria la
garanzia, questa è assolutamente assente nell’etica. Un uomo può essere
buono, eppure ciò non gli garantirà alcun premio. Anzi, troppo spesso il
comportamento buono incontra misconoscimenti e castighi: il rischio è
strutturalmente connesso all’azione etica, che opera per coscienza e senza
garanzie.
Le precedenti considerazioni mostrano quanto il diritto sia, rispetto
all’etica, forma specifica. Esso è, infatti, diritto non per i motivi e i
contenuti che possono alimentarlo (etici, economici, ideologici, tecnici, di
convenienza sociale, di opportunità congiunturale, etc.), ma per il fatto che
la sua forma è strutturalmente destinata a realizzare un ordine garantito.
Giuseppe Capograssi scriveva che il diritto è discreto. Esso, cioè, a
differenza dell’etica, si accontenta del comportamento esteriore. Eppure da
questa sua discrezione, che chiede il minimo, emerge un intero ordine, che
nemmeno l’etica saprebbe assicurare. Non a caso, l’antica sapienza
cristiana insegna che la bontà di tutti non garantisce l’ordine, perché anche
fra i buoni può esserci conflitto.
8. Etica giuridicizzata, etica nel diritto, etica del diritto
Giova qui dissipare un’illusione teorica – vera fata morgana – che può
gravemente oscurare la percezione speculativa dei rapporti fra etica e
16
diritto. Potrebbe pensarsi che sarebbe massimamente auspicabile tradurre
l’intera etica in diritto.
Si distingua, in proposito, fra un’etica giuridicizzata, un’etica nel
diritto e un’etica del diritto. Se si volesse che un’etica si traducesse tutta in
diritto, si determinerebbe una situazione in cui si comanderebbero con
sanzioni esterne tutti i comportamenti che l’etica chiede innanzi tutto alle
intenzioni. Si determinerebbe, cioè, uno stato di polizia. Ciò significa che
non è etico che tutto l’etico sia diritto.
Altra cosa è che alcuni contenuti etici, importanti per l’ordine esterno,
siano imposti nell’ordine giuridico (etica nel diritto). In tal caso, la scelta
nasce dalla decisione di imporre con sanzioni determinate comportamenti,
valutati come imprescindibili per l’ordine sociale. Ciò vale anche se la
scelta è incarnata nella stessa consuetudine che costituisce il “senso del
diritto” in quel momento storicamente operante all’interno di una comunità.
Altra cosa ancora è che il diritto, nei limiti delle proprie caratteristiche
strutturali, scelga le modalità eticamente più proprie al suo modo d’essere:
ad esempio, attraverso la certezza del diritto e/o aperture all’equità (etica
del diritto).
9. Caratteristiche strutturali della razionalità giuridica
Aggiungeremmo alle considerazioni strutturali di Sergio Cotta alcuni
tratti che riguardano sia l’attività regolatrice che genera diritto, sia lo stesso
diritto generato.
Il diritto, infatti, in entrambe le accezioni individuate, soprattutto nelle
sue forme più evolute, risponde a una razionalità strategica, a una
razionalità processuale e a una razionalità empirico-analitica.
a. Il Diritto risponde a una razionalità strategica, nel senso che fa sua
una razionalità non parametrica. È noto che la differenza fra razionalità
parametrica e razionalità strategica consiste nel fatto che, mentre la prima
individua un modello, da applicare ai fatti, che rimane fisso al mutare dei
fatti stessi, la seconda invece, come nel gioco degli scacchi, individua un
modello che, tenendo conto dell’eventuale mossa dell’altro giocatore, ne
pre-assuma la possibilità, rispondendole nel proseguimento dell’azione.
Chi, nel gioco degli scacchi, operasse con la razionalità parametrica e non
con quella strategica, perderebbe la partita. Quando una norma viene
inserita nel corpo vivo delle azioni di una società, essa è introdotta in un
agone di tensioni mobili, dove si osservano reazioni all’azione normante,
non consistenti solo in una possibile osservanza, ma anche in una strategia
di violazioni o di aggiramenti (comportamentali, interpretativi, esecutivi).
17
Una norma giuridica – così come l’attività regolatrice della società che in
essa si esprime – non potrebbe realizzare il suo obiettivo se non perseguisse
una razionalità strategica, che, in quanto tale, precostituisca – sia nella sua
azione complessiva di mutamento delle norme sia nella predisposizione dei
loro dettati – la risposta a possibili violazioni e/o aggiramenti. Una diversa
razionalità fallirebbe l’obiettivo strutturale del Diritto. La razionalità
strategica quindi, a ben vedere, caratterizza il diritto in entrambi i suoi
livelli: sia nella modalità con cui la società genera e muta il diritto, sia nelle
modalità attraverso cui viene predisposta la regola giuridica. Si tratta di due
diverse forme: 1. della modalità, svolgentesi nel tempo, con cui viene
pensato e modificato il diritto (modalità complessiva e diacronica); 2. della
modalità, strutturata nella regola, attraverso cui questa viene modellata,
anche prescrivendo speciali esigenze formali (modalità decentrata e
sincronica).
b. D’altra parte, il Diritto risponde a una razionalità processuale.
Perché – riscuota osservanza o no – viene concepito e strutturato in vista di
un’applicazione, ossia di un processo che ne garantisca l’attuazione:
processo che – anche se di fatto non si verificasse – deve poter esserci. La
processualità, pur potendo non esserci, deve poter esserci. L’eventualità
del processo deve costituire una precisa struttura del pensare giuridico,
ossia della sua razionalità processuale. È in questa luce, in realtà, che
diventano comprensibili i vari ‘formalismi’ di cui il diritto si dota e che
potrebbero sembrare inutilmente gravosi e fuorvianti rispetto ad autentiche
esigenze di valore.
c. D’altra parte ancora, il Diritto corrisponde a una razionalità
empirico-analitica, scompositiva. Perché, per poter pervenire alla puntuale
applicazione al caso concreto, deve poter definire, scomporre, individuare
con circostanziata precisione gli elementi del suo oggetto, e ciò esso fa allo
scopo di poter toccare alla fine la situazione concreta da regolare. Il diritto
presenta in modo spezzettato le caratteristiche a partire da cui regola
(metodo analitico), allo scopo di pervenire a una fattispecie empirica,
individuata nella sua concretezza (metodo empirico). Attraverso
l’astrazione dei tipi (l’uomo proprietario, l’uomo omicida, l’uomo
lavoratore etc.) il diritto arriva alla concretezza della situazione. In questo
senso, il diritto, come sottolinea Enrico Opocher, non disciplina “la”
libertà, ma “le” libertà, tutte tipicamente nominate; non disciplina “il”
tempo, ma “i” tanti possibili eventi temporali (decorsi qualificati, termini
ordinatòri e perentòri, termini dilatòri, termini di usucapione, scadenze,
etc.); non disciplina “la” società o “la” socialità, ma i concreti singoli
individui che agiscono in essa, in quanto inclusi nel suo tipo. Il Diritto
esercita una razionalità che abbisogna di scomporre e spezzettare il suo
18
oggetto, per raggiungerlo applicativamente in modo preciso. Esso mira
progressivamente a individuare, attraverso forme di tipicità, singoli uomini
e singole situazioni. Se il Diritto non impiegasse una simile razionalità,
fallirebbe il suo obiettivo.
10. Il fenomeno diritto visto dalle diverse dottrine filosofiche.
L’ermeneutica come problema
Essendo il diritto un fenomeno strutturale, inevitabile, in qualsiasi
società, è necessario che su di esso si costituiscano un’indagine scientifica
e un punto di vista filosofico. Ogni investigazione scientifica si articolerà
secondo le varie partizioni che individuerà nel fenomeno sociale osservato
(diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, etcetera). Ma rimarrà in
ogni caso problematica la questione su che cosa sia il fenomeno sociale
osservato. Rispondono a tale questione varie dottrine filosofiche, che
esprimono un particolare punto di vista sul fenomeno giuridico. Tali
dottrine si diversificano innanzitutto secondo che guardino al diritto come
ordine naturale, come ordine sociale condiviso o come ordine
artificialmente imposto da un’autorità. Naturalmente, questi tre punti di
vista possono essere anche fra loro intrecciati o reciprocamente innestati. Si
distingueranno perciò, nella storia del pensiero, una dottrina
giusnaturalistica, una dottrina comunitaria e una dottrina giuspositivistica.
La dottrina giusnaturalistica, che avrà diverse scansioni nella storia della
civiltà, ruota intorno al concetto di un diritto della natura, di un jus naturae,
comunque sia una tale ‘natura’ considerata (diritto del cosmo, diritto di
Dio, diritto degli esseri viventi, diritto del più forte, diritto della ragione
umana, etcetera). La dottrina comunitaria ruota intorno al concetto di un
diritto incarnato nel costume stesso di una comunità, di un “jus”,
fattualmente e socialmente assunto nella sua realtà vivente. La dottrina
giuspositivistica ruota intorno a un diritto posto da un’autorità, intorno a un
jus positum, comunque sia questa autorità considerata e comunque essa si
esprima (per comandi verbali, per iscritto o in qualsiasi altro modo).
Intorno a questi tre filoni fondamentali si sono stratificate nel tempo varie
dottrine del diritto.
Se osserviamo in particolar modo la vicenda che va dal movimento
illuministico del Settecento al movimento della codificazione del primo
Ottocento, ci accorgiamo di un particolare fenomeno. Il movimento
illuministico nasce con l’affermazione della Ragione come principio della
natura che deve essere posta a fondamento di ogni legislazione. Tale
movimento approderà, come è noto, attraverso la rivoluzione francese,
19
all’evento della codificazione, intesa come modo per unificare e
semplificare le fonti del diritto. Nel momento in cui l’illuminismo diventa
codificazione un movimento giusnaturalistico approda a un diritto positivo
di cui si è fatto assertore, e quindi approda a una prima concezione
giuspositivistica, fondata sul principio del rispetto dell’autorità costituita.
In altre parole, una concezione giusnaturalista genera come ultima sua
conseguenza una concezione giuspositivistica.
L’Ottocento e il Novecento saranno un interessante laboratorio di
dottrine filosofiche sull’essenza del diritto. Distingueremmo in proposito
varie scuole.
Importante è stata, dopo la codificazione, una “Scuola dell’esegesi”,
per la quale il diritto è quello posto dalla codificazione, e pertanto al
giurista spetta solo il compito di commentare e chiarificare il significato di
ogni articolo normativo, uno alla volta considerato.
Diversa per impostazione mentale e per forza è stata la “Scuola
pandettistica” (Friedrich Carl von Savigny), per la quale il fenomeno del
diritto va considerato incrociando due livelli del discorso: da un lato, il
fenomeno giuridico va concettualizzato a partire dai tanti istituti (coordinati
organici di norme socialmente rilevanti) che si sono storicamente
sedimentati nel tempo e, dall’altro lato, va concettualizzato a partire dalla
fondamentale esperienza giuridica dei Romani, i quali vengono visti non
solo come portatori di una particolare idea del diritto, ma come portatori di
un diritto esemplare per l’intera umanità, diritto di cui la storia successiva è
stata testimone e maestra. Ciò che costituisce pertanto il tratto tipico della
pandettistica è l’affermarsi di una logica della storia che è anche logica
della storia del diritto, della quale bisogna cercare i fondamentali
progenitori nei giuristi romani.
Altra scuola, sviluppatasi soprattutto in Germania negli ultimi anni
dell’Ottocento e nei primi del Novecento, è stata il “movimento del diritto
libero” (Eugen Ehrlich, François Gény, Hermann Kantorowicz),
movimento del quale sono stati momenti la giurisprudenza sociologica e la
giurisprudenza degli interessi. Per questa scuola il diritto positivo non
riesce a rispondere a tutti i bisogni della società, sia perché insufficiente sia
perché incompleto, ragion per cui deve essere innanzitutto cercato in quelle
regole che la stessa società continuamente ricrea per rispondere alle sue
esigenze.
Molto interessante per individuare la natura del diritto nella sua vivente
realtà sociale è stata, agli inizi del Novecento, la teoria istituzionalista (
Maurice Hauriou, Léon Duguit, Santi Romano), per la quale si coglie il
nucleo primo del fenomeno giuridico nella realtà sociale organizzata, in cui
sono teoricamente indissociabili l’organizzazione e la sua regola.
20
Diversa sarà l’impostazione del realismo scandinavo (Axel
Hägerström, Vilhelm Lundstedt, Karl Olivecrona, Alf Ross) che si
domanderà sull’essenza del fenomeno giuridico guardato a partire dalla sua
empirica esistenza in un comando, trovando il suo nucleo nella pressione
psico-sociale che è la vera e invisibile ragione per cui i consociati
obbediscono.
Di tutt’altro tenore è la scuola del realismo giuridico americano (Oliver
Wendell Holmes, Jerome Frank, Karl Llewellyn), che, individuando la
materia empirica del diritto nelle sentenze dei tribunali, identifica la scienza
del diritto nella previsione ragionata di ciò che i giudici decideranno a
contatto con le concrete controversie.
Grande impatto nella scienza giuridica del secondo Novecento ha avuto
la teoria ermeneutica, la quale ha posto al centro dell’attenzione del
fenomeno conoscitivo l’attività dell’interpretazione. Come ha ben
sintetizzato Arthur Kaufmann, «l’ermeneutica ha a che fare con le
condizioni trascendentali della possibilità in assoluto della comprensione
linguistica […]. Essa è una filosofia trascendentale, nel senso che dice le
condizioni della possibilità in assoluto della comprensione di significati. In
quanto tale, essa non prescrive alcun metodo, ma dice soltanto quali sono i
presupposti perché si possa intendere qualcosa secondo il suo senso»2.
Nella prospettiva ermeneutica, il pensiero è contemporaneamente
comprensione e linguaggio. Ogni conoscenza si rivela, in questa ottica,
interpretazione, ossia espressione, comprensione, ri-espressione,
trasferimento di significati da un contesto di vita a un altro.
Bisogna
distinguere,
in
realtà,
quattro
livelli
diversi
dell’interpretazione. A un primo livello, puramente esegetico, essa è
semplicemente l’attività con cui si individua in un testo linguistico una
eventuale pluralità di significati, allo scopo di chiarificare e scegliere quelli
da privilegiare. In questo senso, come dice il brocardo giuridico antico, in
claris non fit interpretatio (nelle cose chiare non si fa interpretazione). A
un secondo livello, critico-filosofico, l’interpretazione è attività di
comprensione che prescinde dalla mera chiarezza del significato linguistico
a cui si applica, perché è attività necessariamente situata tra un significato
linguistico da comprendere, che vale all’interno dei presupposti in cui si dà,
e il soggetto comprendente, che prospetta il suo oggetto a partire dai
presupposti storico-sociali in cui è lui stesso incardinato. A un terzo livello
(reso particolarmente visibile dall’esperienza musicale e da quella
giuridica), l’interpretazione è trasferimento di significati da un ordine
linguistico a un altro, e quindi da un ordine di presupposti a un altro (traduzione). Si pensi all’esecuzione di uno spartito musicale e all’emanazione
2
Arthur Kaufmann, Filosofia del diritto ed ermeneutica, a cura di G. Marino, Giuffrè, Milano 2003.
21
di una sentenza. A un quarto livello, che combina il secondo e il terzo in
modo ulteriore e complesso, l’interpretazione è contemporaneamente
comprensione di significati per trasferirli e trasferimento di significati per
ulteriormente comprenderli e farli comprendere. Né ciò basta, perché non si
tratta soltanto di un comprendere per trasferire e di un trasferire per
comprendere e far comprendere, perché anche nel comprendere si
trasferisce (nell’ordine linguistico interiore) e anche nel trasferire si
comprende (perché si comprende in modo nuovo all’interno di un altro
ordine linguistico). In definitiva, a questo livello agiscono
contemporaneamente quattro fattori: un comprendere per trasferire, un
trasferire per comprendere e far comprendere, un trasferire nel
comprendere, e un comprendere nel trasferire. In questo senso
l’interpretazione è nello stesso tempo esperienza conoscitiva ed esperienza
pratica, risultando pressoché indissociabili la componente conoscitiva
(ossia noetica, intellettuale, comprendente) e la componente pratica (ossia
traduttiva, esecutiva, trasformativa): si comprende in quanto si traduce e si
traduce in quanto si comprende. E ancora più radicalmente: si esprime in
quanto si comprende e traduce, e si traduce in quanto si esprime e
comprende. Il giudice, nel dare sentenza, comprende un significato
all’interno di un contesto e lo trasferisce in un altro e, d’altra parte, mentre
lo trasferisce nell’altro lo comprende lui stesso in modo nuovo. Ogni
fenomeno ermeneutico, in quanto fenomeno interpretativo, è evento
traduttivo in cui si perde necessariamente qualche cosa per trovarla in un
altro contesto trasformata. L’ermeneutica è scienza e pratica della perenne
trasformazione. In conclusione, se ci si colloca al quarto livello
dell’interpretazione, l’ermeneutica è la teoria e la pratica per cui la
comprensione è necessariamente trasformazione e la trasformazione è
necessariamente nuova comprensione, là dove la stessa attività espressiva
è, per l’inevitabilità del linguaggio in cui nasce, conoscenza, e la
conoscenza attività espressiva. L’attività dell’interpretazione, facendo
transitare da una forma espressiva a un’altra, in un unico processo di
trasformazione, un medesimo modello di significato, declina in ogni
stazione del suo transito medesimezza e differenza del modello di
riferimento, generandone sempre nuove dislocazioni analogiche e
disseminazioni.
Ciò che vale per la conoscenza in generale vale anche per la
conoscenza del diritto. Dato ormai per acquisito che una norma, per quanto
chiara, non possa non essere oggetto d’interpretazione, la scienza
ermeneutica del diritto, sulla base della tradizione ermeneutica moderna
nelle sue varie scansioni (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer,
Ricoeur, Betti, Derrida) va oltre. Essa sostiene che qualsiasi significato
22
della vita (di un testo, di una figura storica, di un comportamento umano, di
un essere al mondo, di una civiltà) va inteso all’interno del contesto e dei
presupposti in cui è inserito (fenomeno del ‘circolo ermeneutico’) e che,
d’altra parte, lo stesso soggetto interpretante risulta preliminarmente
condizionato dal contesto storico-sociale in cui è lui stesso incardinato
(situazione strutturale di ‘pre-comprensione’). Sia l’interpretato che
l’interpretante sono, nel fenomeno dell’interpretazione, strutturalmente
condizionati dai loro presupposti.
Ciò che vale per ogni significato della vita, vale anche per il significato
di cui è portatrice la norma giuridica, la quale è da intendere pertanto a
partire da due condizioni limitative: il contesto storico-sociale in cui è
inserita e il contesto storico-sociale in cui lo stesso interpretante è
incardinato. Come sopra sottolineavamo, nel fenomeno dell’interpretazione
giuridica si rende manifesto il fatto per cui interpretare è non solo
comprendere ma “applicare”, ossia tradurre in altri contesti il compreso.
Interpretare è comprendere e riesprimere: è comprendere e trasferire. In tale
prospettiva, ogni norma non è il presupposto ma il risultato di
un’interpretazione e in particolare di quell’interprete autorizzato a
interpretare che è il giudice, il quale trasferisce il significato che una norma
ha in un ordinamento traducendolo all’interno di una situazione concreta. Il
giudice trasforma il testo normativo in norma.
Nel mondo dell’esperienza giuridica si susseguono, insieme legate,
molte possibili prospettive: la prospettiva del legislatore, quella
dell’interprete, quella del giudice, quella del funzionario, quella del
consociato. Sia il legislatore sia il giudice sia lo scienziato del diritto
interpretano, ossia comprendono e traducono: il legislatore interpreta i
significati della società traducendoli in leggi, il giudice interpreta i testi
normativi traducendoli in norme e casi regolati, lo scienziato del diritto
interpreta l’ordinamento traducendolo in fattispecie concettualizzate. Così
come una situazione concreta può essere guardata a partire
dall’ordinamento giuridico, un ordinamento giuridico può essere guardato,
e re-illuminato, a partire dalla singola situazione concreta. L’interprete, e in
particolare il giudice, è colui che può guardare il caso a partire dalla norma
o la norma a partire dal caso, compiendo in questa sua attività un ponderato
trasferimento di punti di vista. La norma è la sua interpretazione.
Se la norma consiste nella sua interpretazione, esiste una norma che
attribuisce la potestà d’interpretare? In realtà, a fondamento e alle spalle di
ogni interpretazione esiste una “comunità interpretante” che, come suo jus,
continuamente pratica e interpreta la sua forma di vita. E, in nome di questa
comunità interpretante, opera la più ristretta comunità interpretante di
coloro che esercitano di fatto la forza di praticare e rendere effettiva la
23
forma di vita del diritto.
Nella misura in cui il pensiero critico diventa consapevole che nessuna
normativa può essere esente da interpretazione, nella stessa misura la
‘certezza del diritto’ come valore va compresa in più ragionati e rigorosi
limiti, ossia come la qualità positiva di una normativa che riduca al
massimo la sua interpretabilità, limitando il più possibile l’arbitrio del
potere e la precarietà di chi vi è sottoposto. Mentre quindi l’esigenza di
certezza del diritto è la tendenza del diritto a ridurre a zero l’incidenza del
punto di vista interpretante, la prospettiva ermeneutica si dichiara fin
dall’inizio consapevole dell’inevitabilità dei punti di vista nell’attività di
conoscenza della normativa. In ogni caso, la prospettiva ermeneutica nel
diritto, condotta alle sue più radicali conseguenze, attribuisce un particolare
valore alla singolarità della fattispecie concreta a partire da cui si invoca
l’intervento dell’ordinamento giuridico. Per così dire, ogni nuovo caso
concreto esige una reinvenzione ermeneutica della norma.
L’esigenza della certezza del diritto fa scoprire l’inevitabilità della
pratica ermeneutica e l’inevitabilità della pratica ermeneutica fa riscoprire
daccapo l’esigenza della certezza del diritto. D’altra parte, la certezza del
diritto, volendo ridurre al minimo l’arbitrio dell’interprete e la precarietà di
chi vi è sottoposto, realizza una rigidità che richiama, all’opposto,
l’esigenza di una proporzionata adeguatezza della norma al caso concreto
secondo criteri di equità, là dove l’equità è la proporzionata adeguatezza
della norma al caso concreto secondo il senso del diritto storicamente
sedimentato in quella comunità. Certezza del diritto ed ermeneutica,
certezza del diritto ed equità sono le esigenze opposte e complementari tra
cui necessariamente oscilla, come fra Scilla e Cariddi, l’intero universo
dell’esperienza giuridica.
Per cogliere in concreto i dilemmi teorici presenti nella concezione del
diritto come fenomeno di regolazione sociale, interessante e paradigmatica
è la disputa fra Ronald Dworkin ed Herbert Hart. Mentre per Hart il diritto
è un complesso ordinamentale di norme, per Dworkin il fenomeno
giuridico non può affatto esaurirsi nelle norme perché risiede innanzitutto
in quei princìpi, di valore etico e di carattere vincolante, che vivono nel
corpo sociale di una comunità come jus. Hart è ben consapevole che
l’ordinamento giuridico, espresso in norme, è necessariamente aperto,
perché ogni norma è costituita di parole e quindi di enunciati
strutturalmente ambigui. Ciò significa per lui che un ordinamento giuridico
è imprescindibilmente connesso con l’attività interpretativa di un
giudicante che ne trasferisca nel contesto sociale i significati. Del tutto
opposta è la posizione antipositivistica di Dworkin, il quale muove invece
dalla primarietà vincolante di quei princìpi etici che vivono nella società
24
cui si appartiene. Le due posizioni però, pur contrastandosi, mantengono
una loro paradossale possibilità di dialogo, perché da un lato Hart sostiene
un giuspositivismo moderato che accetta alla sua base un minimo di diritto
naturale, e perché dall’altro lato Dworkin ammette che i princìpi etici, cui il
giudice è sottoposto, hanno un loro storico, e quindi relativo, radicamento.
In ogni caso, le due posizioni mostrano nella loro fenomenologia modi
diversi in cui possono articolarsi, all’interno di una comunità storica, il jus
e la lex.3
11. Ordine sintattico, ordine semantico, ordine giusto
Se pensiamo alle caratteristiche strutturali di cui Sergio Cotta parla, ci
accorgiamo che un tale ordine di norme si presenta, fondamentalmente,
come ordine sintattico. Si sta parlando, cioè, qui, di caratteristiche
strutturali di un diritto che assicura un ordine a prescindere dai significati
sociali di cui sia portatore. L’ordine sintattico è, infatti, un ordine fondato
sul puro funzionamento dei nessi relazionali fra le componenti a
prescindere dall’ordine dei significati. L’ordine sintattico in quanto tale,
come è riscontrabile all’interno di una proposizione linguistica, può
prescindere da un qualsiasi ordine semantico, allo stesso modo in cui una
proposizione linguistica può essere sintatticamente corretta a prescindere
dal suo significato, e addirittura a prescindere dall’esistenza di un qualsiasi
significato. Nell’orizzonte di una pura funzione sintattica, ad esempio, una
sentenza non è affatto necessario che sia ‘giusta’: basta che assolva la sua
funzione sintattica, consistente nel chiudere definitivamente, con atto
dell’autorità, il conflitto fra i contendenti. È solo questo che l’ordine
sintattico del diritto chiede, non altro.
Ma c’è, qui, una considerazione decisiva da fare. Se è vero che un
ordine sintattico può prescindere da un ordine semantico, ossia da un
ordine dei significati sociali della vita, l’ordine sintattico del diritto, se è
reale, implica sempre e necessariamente un minimo di ordine semantico
condiviso dai consociati. Un ordine del diritto che intendesse prescinderne,
cadrebbe, prima o poi, come un castello di carte.
D’altra parte, anche l’ordine semantico può prescindere dalla giustizia
– da un ordine giusto. Un ordine semanticamente condiviso, infatti, non è
necessariamente un ordine giusto. Ma, anche qui, c’è una considerazione da
fare. Se un ordine semantico può prescindere da un ordine giusto, un ordine
3
Sul rapporto Dworkin-Hart ci permettiamo richiamare Giuseppe Limone, Dal Giusnaturalismo al
Giuspersonalismo. Alla frontiera geoculturale della persona come bene comune, Graf, Napoli 2005, pp.
61-64.
25
semantico del diritto non può prescindere da un minimo di ordine giusto,
ossia da un minimo di risposta a una domanda forte di giustizia, sollevata
sotto pena di intollerabilità (è, come si sa, la formula di Gustav Radbruch).
Un ordine semantico che non rispondesse mai a una domanda forte di
giustizia, prima o poi, col crescere delle esigenze di questa, imploderebbe
da sé.
Ergo, un ordine sintattico del diritto implica sempre un minimo di
ordine semantico condiviso; un ordine semantico del diritto implica sempre
un minimo di ordine giusto, ossia un minimo di risposta alla domanda di
giustizia.
Si badi. Si possono relativizzare e demolire tutte le risposte alla
questione della Giustizia, mai la domanda. Che emerge, innanzitutto e per
lo più, non dall’individuazione di un concetto, ma dall’imporsi di un rifiuto
reale. Dal rifiuto di un intollerabile. Che emerge non come figura
concettuale, ma da un improvviso sfondo di condizioni non previste.
Apparendo alla luce, per così dire, non dal pensato, ma dall’impensato. In
forma pascaliana diremmo che il rifiuto dell’intollerabile è gravido di un
mondo noetico di cui il rifiuto non sa. E di cui la stessa nòesis, la stessa
conoscenza non sa. Ma di cui deve sapere. E che solo l’investigazione
filosofica può, da dentro, illuminare.
L’ordine sintattico del diritto, pur indipendente dall’ordine semantico,
non può prescindere da un minimo di ordine semantico condiviso; l’ordine
semantico del diritto condiviso, pur indipendente dall’ordine della giustizia,
non può prescindere da un minimo di ordine giusto, ossia da un minimo di
risposta a una domanda forte di giustizia, elevata sotto pena di
intollerabilità.
Proviamo ora a guardare il rapporto fra ordine sintattico, ordine
semantico e ordine giusto secondo un’articolazione fra coni verticalmente
sovrapposti e reciprocamente innestati in una sequenza di vertici e basi. Il
minimo comune cui si riferisce l’ordine sintattico, quello cui si riferisce
l’ordine semantico e quello cui si riferisce l’ordine giusto verranno a
configurarsi come coni più piccoli, individuati e messi in comune dai
reciproci innesti. Si ascenderà, così, – lungo la linea ideale che va dal cono
più basso al più alto – dall’ordine sintattico all’ordine semantico all’ordine
giusto, disegnando un collegamento fra vertici, difficile ma percorribile,
che congiunge ordine imposto, ordine condiviso e ordine giusto: ossia il
cammino che lega Lex, Jus e Justitia.
12. La società fra attività autoregolatrice e diritto formale: il problema
26
dei “princípi”
Dicevamo che il Diritto non è solo il prodotto formale e visibile
dell’attività della società che si autoregola per realizzare un ordine, almeno
esterno, garantito, ma è anche l’attività della società che a quello scopo si
autoregola. E dicevamo che il Diritto, anche nei suoi stadi più evoluti, non
è solo il prodotto formale e visibile di questa attività, ma anche il prodotto
più ampio che nella società vive: sia orientando a regolare i comportamenti
sociali sia guidando a identificare il diritto esistente e le sue interpretazioni.
Nulla toglie a questa considerazione di fondo il fatto che il diritto
formale, dichiarandosi l’unico esistente, non riconosca altre forme. Il
problema, infatti, di che cosa sia Diritto, non lo decide il Diritto formale
che si autodichiara l’unico, ma chi di fatto lo crea e chi scientificamente lo
vede, guardando a quei punti apicali in cui il Diritto effettivamente si fa. Si
pensi, in proposito, a quelle sedi e a quei momenti apicali in cui il diritto
viene prodotto e deciso, là dove esso è praticato, cercato, trovato,
dichiarato, costituito, interpretato, applicato, eseguito, fatto vivere.
In queste sedi, nodi effettuali della rete giuridica, chi identifica il diritto
come tale permanentemente lo istituisce e lo fa vivere. Questo Diritto, in
realtà, nasce sotto la pressione permanente dell’attività sociale regolatrice
che in determinati soggetti, in modo più o meno riflesso, matura. Un fatto è
certo: un tale Diritto – lo si voglia o no – si fa o concorre a farsi decisione
giuridica e ordine giuridico. E concorre a identificare, intersecare,
modellare e rimodellare significati giuridici.
Se è vero, quindi, che il diritto è identificato da chi ha la forza di
renderlo vivente e se è vero che il diritto è l’autoregolazione con cui una
società riconosce e reinterpreta il suo ordine, il diritto si esprime non solo
in un ordinamento formale ma in orientamenti vissuti e riflessi che sono
“princìpi”. Per giunta, giuridici, in quanto esteriormente vincolanti. Si tratta
di “princìpi” che non appaiono – almeno innanzi tutto e per lo più – per
investigazione razionale diretta, assiomatizzata, ma, piuttosto, per
emersione contrastiva da situazioni concrete che, all’improvviso, bucando
il tessuto del previsto, ne accendano l’impensato.
E valga il vero. Ronald Dworkin, in un passo del suo testo più noto, I
diritti presi sul serio, ricorda: “Nel 1889 un tribunale di New York, nel
famoso caso Riggs v. Palmer, doveva decidere se una persona, designata
erede nel testamento di suo nonno, potesse ereditare in base a quel
testamento, sebbene a tale scopo avesse assassinato il nonno. Il tribunale
iniziava il suo ragionamento con questa ammissione: «È vero che le leggi
che disciplinano la stesura, la prova, gli effetti dei testamenti e la
trasmissione della proprietà, se interpretate alla lettera, e non potendosi in
27
alcun modo o in alcuna circostanza attenuarne la forza e gli effetti,
attribuiscono questa proprietà all’assassino». Ma il tribunale continuava
osservando che «tutte le leggi, come tutti i contratti, possono essere
attenuati nel loro operare e nei loro effetti dalle generali e fondamentali
massime del common law. A nessuno sarà permesso di trarre profitto dalla
propria frode, o di trarre vantaggio dal suo illecito, o di fondare una pretesa
sul suo comportamento iniquo, o di acquisire una proprietà per mezzo di un
delitto»”. Dworkin conclude: «L’assassino non ottenne la sua proprietà»4.
Nella situazione prospettatasi ai giudici emergeva un fatto che appariva
nuovo in quanto prima non previsto: risultava nominato erede dal testatore
colui che l’aveva assassinato. Si trattava, a dire il vero, di un fatto che
poteva essere percepito come ‘nuovo’ solo alla luce della considerazione
cruciale che non fosse concepibile come prevista con favore
dall’ordinamento una situazione in cui l’assassino potesse ereditare
dall’assassinato. In realtà, in una situazione come questa si avvertiva,
imperiosa, la rivolta della coscienza comune contro una interpretazione che
vedesse in questo un generico caso di successione ereditaria, solo
occasionalmente accompagnato dalla circostanza che l’erede era anche
l’assassino del testatore. La coscienza comune si rivoltava, cioè, davanti
all’ipotesi che il fatto accaduto potesse considerarsi non dissimile dagli altri
casi di successione ereditaria, e quindi non nuovo.
Una tale percezione di ‘novità’ non era, a ben vedere, la mera
percezione di un ‘dato’, ma di un punto di vista. Infatti, l’identificazione di
un tale fatto come ‘nuovo’ nasceva dalla percezione dell’ordinamento come
lacunoso sul punto. E, d’altra parte, la percezione dell’ordinamento come
lacunoso sul punto nasceva, a sua volta, dal bisogno ineludibile di assumere
nella situazione data un’altra regola che, restringendo l’area semantica
della regola normante, escludesse dalla successione ereditaria l’erede
assassino sulla base del principio che non si potesse succedere in questo
caso, perché sarebbe stato violentemente iniquo il poter trarre profitto da un
proprio delitto.
Intendiamoci. Se si ragionasse, qui, invece, secondo il modello con cui
Hans Kelsen giuridicamente ragiona, ossia secondo la concezione del più
radicale giuspositivismo, in questo caso non ci troveremmo davanti ad
alcun fatto ‘dissimile’ o ‘nuovo’ o ‘non previsto’, e quindi non ci
troveremmo davanti a nessuna lacuna dell’ordinamento. Per Kelsen, infatti,
l’ordinamento giuridico positivo dovrebbe essere considerato, anche in una
tale situazione, niente affatto lacunoso. Perché esso, non indicando
esplicite eccezioni alla possibilità di ereditare, prevede in realtà, in questo
caso, che il chiamato all’eredità possa succedere al testatore a prescindere
4
R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Il Mulino, Bologna 1982, p. 91.
28
dal delitto da lui consumato, non avendo rilevanza alcuna, per
l’ordinamento giuridico considerato, la circostanza per cui il chiamato
all’eredità abbia ucciso il testatore. Per la concezione kelseniana affermare,
contra l’ordinamento positivo, che esso avrebbe dovuto prevedere un tal
caso come dissimile dagli altri significherebbe semplicemente affermare
che si desidererebbe che in questo caso l’ordinamento avesse disposto
diversamente da come ha disposto. Il che vuol dire che la pretesa ‘lacuna’
contestata all’ordinamento giuridico positivo è, in questo caso, null’altro
che l’avvertita discrepanza morale fra l’ordinamento giuridico esistente e
l’ordinamento giuridico desiderato. Ma, come si sa, secondo il modello
giuspositivistico, l’ordinamento giuridico desiderato non è diritto.
L’idea di ‘lacuna’ quindi, in tali coordinate di pensiero, diventa
null’altro che il travestimento ideologico del proprio desiderio di vedere
operare, in quel punto della fattispecie, un diverso ordinamento, o un
diverso suo segmento. Il problema del ‘principio’ nasce qui. Ci si domanda,
a questo punto: l’idea che il significato della norma debba essere ristretto
secondo il principio per cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio delitto
nasce da un mero desiderio di sottrarsi all’ordinamento giuridico oppure
nasce da un vincolante principio giuridico, enucleabile dallo stesso
ordinamento o altrove?
Precisiamo un primo punto. Oggi, a meno che non si voglia ragionare
secondo il modello kelseniano, l’incompletezza strutturale di ogni
ordinamento giuridico è stata oggetto di convincenti argomentazioni. Ci
basti qui ricordare la serrata discussione svolta da Norberto Bobbio in
Teoria dell’ordinamento giuridico, là dove egli individua le deficienze di
quelle teorie (come quella dello ‘spazio giuridico pieno e vuoto’ e quella
della ‘norma generale esclusiva’) che pretendevano dimostrare la
completezza di ogni ordinamento giuridico. Né va dimenticata, in
proposito, la teoria dell’incompletezza di Kurt Gödel, valida per ogni
sistema teorico, e quindi anche per un sistema giuridico. Né va soprattutto
trascurato che un sistema di norme non può essere completo non solo
perché non può prevedere, di fatto, la totalità dei casi possibili, ma anche e
soprattutto perché, per principio pur nello sforzo di prevederli, non può
conoscere la totalità delle condizioni che sottostanno al suo sistema di
previsione.
Un ordinamento giuridico quindi è, contrariamente a ogni pretesa
scientifica di completezza, sempre incompleto, per lo meno nel senso che ci
sono situazioni ermeneutiche in cui, come osserva ancora Bobbio, non è
possibile dimostrare se si debba applicare la ‘norma generale esclusiva’ o la
‘norma generale inclusiva’, le quali accompagnano ogni norma, essendo fra
l’altro impossibile la presenza di una metanorma che in via astratta e
29
generale decida. Infatti, anche se è sempre pensabile la presenza di un
criterio positivizzato con cui distinguere quando si debba applicare una
‘norma’ e quando un’altra, non è pensabile che, a una seconda potenza,
esista sempre un criterio positivizzato con cui distinguere come interpretare
quel criterio, ossia con quali criteri si debbano interpretare i criteri. Il
risultato teorico è che resta, sempre, in un ordinamento giuridico, un varco
ermeneutico ineludibile e indecidibile. E la lacuna, per Bobbio, è
configurabile proprio in questa luce. Un tale fenomeno di indecidibilità
interpretativa mostra come il linguaggio abbia una sua costitutiva
ambiguità. Non a caso, Herbert Hart ha sostenuto che il diritto ha sempre
una struttura aperta, ossia costitutivamente esposta a più interpretazioni
possibili, di cui mai è pre-decidibile in via astratta e generale la chiave
ultimativa5.
Tali osservazioni possono mettere in luce come sia proprio la
concezione kelseniana a rivelarsi nascostamente ideologica, in quanto essa
medesima muove dalla finzione, non confessata, che l’ordinamento
giuridico positivo contenga già tutte le soluzioni per tutti i casi presenti e
futuri. O, ancora più precisamente, potrà dirsi che la concezione kelseniana
della cosiddetta ‘dottrina pura’ sceglie, fra le tante possibili finzioni, la sua,
occultando il fatto che è pur sempre una finzione.
13. Per uno statuto epistemologico della persona
La situazione dei nostri tempi è certamente inquietante. Ma nella storia
dei popoli è importante non solo cogliere la realtà massiva che inquieta, ma
anche ciò che, pur debole, esprime, in punte alte e circoscritte, un progresso
morale dell’umanità. Come già osservava Giuseppe Capograssi, la
Dichiarazione Universale del 1948, rovesciando il rapporto fra sovranità e
diritti individuali, costituiva un progresso morale cruciale anche se gli Stati
firmatari fossero stati ad essa ipocritamente indotti dalla percezione di una
pubblica opinione mondiale al cui giudizio si sentivano sottoposti.
Ricorre sempre più, nelle Dichiarazioni, nelle Costituzioni e nelle
Convenzioni, la ‘persona’. Che è, forse, oggi la nuova scoperta – scoperta
d’antico! – del Jus.
Come si è in più sedi sottolineato, la persona non è la semplice nozione
dell’uomo in generale. Perché essa è, almeno in una prima
approssimazione, l’uomo concreto, visto nella sua irriducibile singolarità.
In quanto tale, l’idea di ‘persona’ non è sovrapponibile a quella di
‘individuo’. ‘Persona’ e ‘Individuo’ hanno significato uguale e senso
5
H. Hart, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino 1991.
30
diverso. La persona e l’individuo si riferiscono al singolo uomo concreto
(uguale significato), ma, mentre nella percezione epistemologica
dell’‘individuo’ non rileva la differenza di uno da un altro, nella persona la
distinzione di ognuno da ogni altro è a fondamento del suo senso.
Occorre partire, quindi, da una ‘dignità epistemologica’ della persona
che concettualmente preceda la sua ‘dignità assiologica’. Come dare, in
questo senso, le linee di uno statuto epistemologico della persona? Essa è
coglibile all’incrocio fra tre coordinate, non separabili, pena lo
snaturamento del loro senso: unicità, relazionalità, profondità.
1. La persona è unicità. Essa non è copia di un’altra. Non è seriale. Non
è fungibile. È un novum. Un originale. Essa è necessaria a sé stessa: in lei
ne va di lei e di tutta lei. Non s’individua col cognome, ma col nome. E,
d’altra parte, dire ‘persona’ implica un paradosso logico, perché si dice,
con una parola, ciò che non può dirsi con una parola; perché si dice, con la
sua idea, ciò che non è suscettibile di idea; perché si dice, con la sua
classificazione, ciò che non è classificabile. La persona è unicità. Di cui è
segnale, in un evento non solo reale ma epistemologico, il dolore.
2. La persona è relazionalità. Essa è e manca d’essere. In quanto tale, è
difettiva. Potrebbe, qui, richiamarsi Agostino, esplorando le sue riflessioni
sul male metafisico. La persona, come dice Pietro Piovani, est in quanto
deest, cioè essa è in quanto manca di qualcosa. Essa, in quanto difettiva e
cosciente di mancare, è relazione, bisognosa di relazione, capace di
relazione. Difettiva e fragile, e oscuramente cosciente della sua condizione.
Essa non ‘ha’ relazioni: ‘è’ relazione. Perché non è atomo irrelato. Né è
pensabile al di fuori delle sue relazioni come realtà precedente le stesse, a
prescindere dai rapporti in cui vive, dai gruppi cui appartiene, dalla cultura
in cui opera, dal tempo in cui è incardinata. La persona è cura. In me, ne va
dell’altro; nell’altro, di me.
Come la stessa scienza sperimentale mostra, un uomo muore non solo
per mancanza di cibo, ma di relazioni. E, d’altra parte, la dimensione
costitutiva della relazionalità si coglie non solo sul piano sincronico (nello
spazio) ma su quello diacronico (nel tempo). La persona, infatti, in una
trama di simmetrie di cui nemmeno si avvede, cerca nel tempo tracce altrui
e semina tracce di sé. Si fa fecondità di tracce (atti, opere, figli, ricordi,
scritti, documenti d’arte, il proprio medesimo nome), verso la quale
fecondità è comportamento simmetrico la spinta profonda a un’ermeneutica
delle tracce altrui (atti, opere, figli, ricordi, scritti, documenti d’arte, i nomi
altrui, tutta la frantumata archeologia che si dà). È la storia della civiltà. Di
cui, nella sua tessitura profonda, è segnale la ‘pietà’, la pietas.
3. La persona è profondità. La ‘profondità’ non è una condizione
mistica, né la semplice ‘interiorità’, ma il complesso energetico di possibili
31
che nella persona vivono e che non potranno mai in toto darsi alla luce.
Aristotele diceva che «quel che ogni cosa è quando ha compiuto il suo
sviluppo, noi lo diciamo la sua natura»6. Questa ‘natura’ non dice la
persona. La quale, infatti, non è soltanto lo sviluppo e la storia in cui si è
espressa. Non è solo ciò che è stata, ma tutto ciò che poteva essere e non fu.
Essa è centro energetico di possibili. Lo sviluppo dice l’essere del genus
che nella persona si dà, non la persona. Se ne desume una profondità a più
livelli: 1. una profondità di livello primo, che è la storicità in quanto
sviluppo nel tempo; 2. una profondità di livello secondo per la quale la
persona è più di ciò che appare; 3. una profondità di livello terzo, che è il
mondo dei possibili, cui appartiene, insieme con l’emerso, tutto ciò che non
ebbe il tempo o le condizioni per darsi alla luce: in ogni uomo, infatti,
quiescono tanti percorsi possibili, tanti ‘io’ possibili, su cui non c’è
possibile sguardo esaustivo; 4. una profondità di livello quarto, per cui quel
‘centro di possibili’ si dà non come catena di cause, ma come un’istanza di
fondo abitata da una domanda di senso. Un tale ‘possibile’ è, nell’orizzonte
della persona, dimensione costitutiva del suo essere ciò che è. E, quindi, un
infinito. Un infinito di potenza non qualsiasi ma determinata: un
transfinito. Si tratta di una ‘profondità’ che, vista ex post, è ‘possibilità’
(come resistenza alla totalizzazione concettuale), e, vista ex ante, ‘libertà’.
Perché la libertà è la profondità al grado avvenire. Il cui essere è il
possibile, un posse – non solo dynamis ma enérgheia in cammino – da cui
emerge un’istanza profonda, radicalmente irriducibile alla catena
meccanica delle cause da cui pur fluisce: l’interrogazione del senso.
La persona – infinito possibile abitato da un’istanza di senso – è un
abisso ontologico. Abisso – Ab-Grund – il cui fondamento – il cui Grund –
è nella relazione con gli altri, divisi eppure indivisibili da lui. Grund dal
quale la sua possibile forza acquista sponda, limite, specchio, provocazione
al risveglio, messa in forma, possibile luce.
Le tre coordinate della persona (unicità, relazionalità, profondità) non
si comprenderebbero bene se non si capisse che sono tutte e tre radicate in
una condizione ontologica della persona che è, in quanto tale, prospettiva:
prospettiva ontologica su un mondo di cui essa è partecipe e su cui è punto
di vista vissuto. In questo senso, la persona, in quanto punto di vista vissuto
che comprende ed esprime, si rivela ontologicamente il grado zero
dell’ermeneutica.
La persona, abisso ontologico, è più di quello che appare. E, in quanto
tale, pudore. Che è il sentimento dei confini e il timore complesso a non
varcarli e a non farli varcare. Perché si teme che, da un lato, si scrutino i
propri punti di fragilità e, dall’altro, si riduca l’oggetto scrutato a un
6
Aristotele, Politica, 1252 b, 30.
32
repertorio di dati, a una pura catena di cause, senza domanda di senso e
senza libertà. Chi oggettiva e banalizza l’altro, infatti, tende a ridurlo a una
cosa, a una copia. A una riproducibile copia. Rispetto a ogni atteggiamento
che ci riduca a copia, la resistenza indomabile – ontologica resistenza, ben
prima che psicologica – è il ‘pudore’. Di cui si rivelano espressioni
fenomenologiche forti il rispetto dei vivi, la venerazione dei morti, il timor
sacro di punizioni, l’idea di un Dio Provvidente, la percezione di un Senso
che erompa da una catena di cause di cui appare paradossale la causa. In
questo senso, la persona è più di ogni preteso giudizio definitivo su essa,
perché la sua profondità si pone oltre ogni definitività. Con tutto ciò che, in
termini etici e giuridici, consegue. Nessuna persona pertanto può essere
definitivamente condannata.
Se la pietà dice la relazione e il pudore la profondità, può cogliersi, qui,
un nesso profondo fra loro. Si delinea, alla scala della persona, un rapporto
fra relatio e revelatio7. La persona, nella sua differenza, è costitutiva
apertura, orizzontale e verticale. In essa, la ratio è relatio e revelatio. Là
dove si tratta di cogliere, in termini filosofici e non soltanto teologici, il
senso dell’agostiniano ‘Dio mi è più intimo della mia intimità’. Sentiero sul
quale ci si può avviare anche a partire da prospettive molto diverse: da una
riflessione filosofico-psicologica come quella di Ignacio Matte Blanco e da
una riflessione biofilosofica come quella di Antonio Damasio.
Émile Benveniste sottolinea il nesso coglibile – nella costellazione
semantica dell’‘aidòs’ greco (il ‘pudore’) – fra ‘pudore’ e ‘onore’. Se il
pudore, infatti, spinge al profondo rispettare, l’onore sollecita, soprattutto,
al profondo agire. E il ‘pudore-onore’ si rivela, in un tale contesto, centro
di radicamento della dignità. La quale è una ‘majestas’, una maestà. Di
carattere onto-epistemologico ben prima che assiologico. Fatta di
prerogative e di vincoli. Di attrazione e di rispetto. Di diritti e doveri
originari. Costituendo fine in sé. Nel significato complesso del poter porsi
come fine e del non poter sottrarsi alla propria forza di fine.
In questo senso, la dignità è una ‘maiestas’ in cui si rivela una traccia
del sacro. Del sacro còlto nei limiti della ragione. Il ‘sacro’, infatti, assunto
nella sua origine dal ‘numinoso’, nasconde una forza assoluta che è fonte
primordiale di ammirazione e terrore. E che, come tale, comanda e vieta,
assolutamente domina, lega. A pena della vita. In quanto comanda e vieta,
è fonte di diritti e doveri; in quanto domina, fonte di soggezione e rispetto;
in quanto lega, fonte di una condivisione essenziale a cui è impossibile
sfuggire.
In questa dignità vive il valore cruciale che Giambattista Vico, nel De
7
Sul doppio livello della ‘revelatio’ ha insistito più volte il teologo Bruno Forte. Per altri versi, si veda
V. Vitello, La voce riflessa. Logica ed etica della contraddizione, Lanfranchi, Milano 2004.
33
Uno, chiama, in opposizione a Hobbes, l’Homo homini deus. In cui, non a
caso, si dànno i valori dell’unicità, del pudore e della pietà: dell’unicità,
della profondità e del legame.
Una frase scherzosa dice che in ogni grasso c’è un magro che fa sforzi
immani per essere riconosciuto. Espunto ogni possibile scherzo da una tale
espressione, potremmo trarne l’immagine per capire come in ogni corpo
(corpo intelligente complesso, ‘pensoso’) ci sia una persona che cerca di
essere riconosciuta. Marc Augé ha scritto che un uomo concreto si delinea
all’interno di un’appartenenza biologica, di un’appartenenza culturale e di
un’appartenenza storica8. Ma un tale uomo è ancora un seriale individuo:
esso non intercetta quell’unità di senso che è la ‘persona’. Che è –
all’interno di più appartenenze – un atto di esistere unico, relazionato,
profondo. Non confondibile col fondo comune da cui pur emerge.
Nel paradigma epistemologico della persona è riconoscibile uno statuto
assiologico9. A ben guardare, tre atti negano la persona, violandone
nichilisticamente le coordinate.
a. “Tu per me non sei che una copia, un ente seriale”. Perché – per me
– in te non c’è traccia di te, e in un tale non esservi traccia, ne va di te.
b. “Io non ho per te nessun interesse, perché per me sei un assente”. In
me di te non c’è traccia, né ci sarà. Io non ho alcuna cura di te. Esattamente
nei termini radicali in cui Kolja Krasotkin si rivolge al compagno Kartasëv
nei Fratelli Karamazov, durante il funerale del piccolo Iliuscia, quando gli
intima di tacere, dal momento che «nessuno parla con voi, e non desidera
neppur sapere se ci siate o no al mondo»10. E’ il massimo attacco
d’indifferenza sferrato da chi non vuol sapere nulla dell’altro: da quel Kolja
che pur, poco prima, dichiarava ad Alioscia di invidiare chi può morire,
come martire ignoto e innocente, per l’intera umanità. Qui, la
contraddizione fra un’umanità come mera nozione generale e una persona
in carne e ossa è lampante: colui che si dichiara disposto a morire
eroicamente e oscuramente per l’umanità, non è disposto a sopportare la
presenza di una sola persona!
c. “Io di te mi sono appropriato, conoscitivamente e praticamente”.
Non solo vietandoti comportamenti, ma favorendoli e potenziandoli, e
soprattutto impossessandomi di te.
Quali, invece, gli atteggiamenti che negano queste negazioni?
Diremmo che sono il riconoscimento dell’altro, la compassione per l’altro e
il pudore. Là dove il riconoscimento dell’altro avviene non per intersezione
8
Marc Augé, L’uomo trino e uno, in “Micromega”, n. 4/ 2005, pp. 103 ss.
Né ciò significa ‘fallacia naturalistica’: sul punto, Giuseppe Limone, Il sacro come la contraddizione
rubata, Jovene, Napoli 2000, p. 31 ss.
10
Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Einaudi, Torino 1993, p. 1013.
9
34
concettuale di dati (‘calcolo logico’), ma per intuizione, per intuizione
empatica: quella che coglie, dell’altro, l’irriducibile simplicitas.
Una ‘persona’, pur unica, non è mai pensabile elidendo gli spazi
intermedi che la legano alla famiglia, ai gruppi, alle patrie, alle culture di
appartenenza. Una persona non può essere pensata se non nella sua rete di
relazioni. Davanti all’alternativa fra individuo e rete di relazioni ci
collocano, invece, soprattutto negli Stati Uniti, le teorie ‘liberali’ e quelle
‘comunitarie’. L’idea di ‘persona’ è, in un tale contesto dilemmatico, la
strada che ne rompe la struttura, dissolvendone i termini. Perché questa
‘persona’ è la singolarità concreta che, stando in tutti i gruppi in cui è
radicata, è indissolvibile in essi. Ciò che caratterizza questa ‘persona’ è non
l’uguaglianza, ma la differenza. Dal cui luogo essa invoca la sua dignità,
ossia il suo diritto a una considerazione universale, corrosiva di ogni
‘universale’ formulato troppo presto.
14. L’irriducibile e la radice
Se interroghiamo la persona come unicità, essa è, in un tale orizzonte,
irriducibile. In tre sensi specifici, esprimenti un livello verticale e un livello
orizzontale: nel senso che una persona non è riducibile a un’altra
(altrimenti sarebbe un complesso seriale: una copia); nel senso che essa non
è riducibile in parti che epistemologicamente la precedano; e nel senso che
non è riducibile a una Totalità che epistemologicamente l’assorba.
In questo senso, la persona sta fra indivisibilità (in parti),
indissolvibilità (nel Tutto) e infungibilità (con altre persone). In quanto
indivisibile – o, più specificamente, in quanto divisibile solo per sé stessa e
per l’unità – la persona ha lo statuto teorico di un numero primo. Essa sta
alle pretese sue parti come sta alla Totalità. Se chiamiamo ‘p’ le parti, ‘P’
la persona e ‘T’ la Totalità, abbiamo:
p: P = P: T
La persona, quindi, è il medio proporzionale fra le parti e la Totalità.
Posto che il medio proporzionale fra estremi è la loro comune radice, la
persona è, fra l’universo atomistico e l’universo totale, la loro comune
radice.
Una tale ‘irriducibilità’ acquista ulteriori significati, se la si interroga
non solo sull’asse dell’unicità, ma, al tempo stesso, su quello della
profondità e della relazione. La persona, infatti, è irriducibile a ciò che ci
35
appare e a una qualsiasi totalizzazione concettuale; così come è irriducibile
alle sue relazioni sociali e al suo mondo storico. Pertanto, essa non si riduce
né a una componentistica biologica, né fenomenica, né relazionale, né
culturale, né storica, né concettuale. Essa è – tout court – l’irriducibile. In
quanto tale, non semplice individuo o membro di una classe, ma un mondo.
Un universo. All’interno di un mondo più grande che è il suo multiverso.
15. Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo
Nella temperie d’oggi è forse possibile rivisitare e reimpostare alcune
categorie venerabili consegnateci dalla tradizione. Parleremmo, qui,
innanzitutto ma non soltanto, di “giusnaturalismo” e di “giuspositivismo”.
Veniamo al “giusnaturalismo”. È fin troppo noto che questo termine è
equivoco, perché – in quanto allude a un supposto “diritto di natura”, ove si
accetti che una “natura” esista e che abbia un suo “diritto” (un suo principio
strutturale) – il ‘giusnaturalismo’ può riferirsi a un diritto strutturato sia nel
cosmo, sia negli esseri animati, sia negli esseri razionali. Quale sia un tale
principio, a questo punto, è domanda possibile e necessaria: che potrà
avere, nell’universo giusnaturalistico, risposte diverse. Non a caso, il
ventaglio potrà andare da un puro “diritto della forza” (e si sa quanto i
sofisti – e non solo essi – abbiano insistito su questo punto) a un “diritto
degl’istinti”, a un “diritto dei sentimenti”, fino a un “diritto della ragione”.
È noto quanto il cosiddetto “giusnaturalismo moderno” si sia fondato su
quest’ultima opzione (il diritto naturale come diritto della ragione, con
particolare riguardo alla ragione soggettiva), fino al punto da essere
chiamato, più correttamente, “giusrazionalismo”.
Veniamo al “giuspositivismo”. È altrettanto noto che anche un tale
termine si pone, a rigore, come equivoco, perché – in quanto allude a un
“diritto positivo” (posto con forza effettiva da una Potestà) – può riferirsi
sia al mero insieme di comandi del sovrano sia a un ordinamento
normativo formalmente e linguisticamente ricostruito dalla scienza
giuridica attraverso un procedimento permanente di elucidazione.
Siamo perfettamente consapevoli che le categorie qui presentate
appartengono a un universo problematico nel quale concorrono molte altre
possibili istanze dottrinali. Basti pensare, soltanto, al “diritto libero”,
all’ermeneutica, al “realismo giuridico” (nelle sue varianti), alle forme di
un giuspositivismo atipico essenzialmente fondato su “princípi” (Ronald
Dworkin), e ad altre ancora.
Guardando al giuspositivismo, se assumiamo come termine di
riferimento maturo quello kelseniano, ci si può domandare: che cos’è mai
36
lo Stato, ossia l’ordinamento giuridico che nelle sue forme lo consuma? È
Kelsen stesso che, come è noto, fin dagl’inizi del suo percorso intellettuale,
risponde: lo Stato, e il diritto in cui esso si esprime, è l’organizzazione della
forza (Macht). Più tardi, Kelsen stesso sarà ancora più disincantato e
preciso: lo Stato, e il diritto in cui esso si esprime, è l’organizzazione della
violenza (Gewalt).
Ci si domanda: se il diritto è l’organizzazione della forza, una tale
concezione non appare affatto lontana da quella di chi ha sostenuto un
giusnaturalismo della forza. Certo, si tratta di un giusnaturalismo
puntualmente specificato, in quanto attribuisce una preferenza simbolica a
quella forza organizzata che è lo Stato: ma, ciò precisato, l’iscrizione del
giuspositivismo in un “giusnaturalismo della forza” non può essere negato.
Certamente, nella decostruzione del testo kelseniano vanno tenuti in
conto altri fattori: l’idea razionale di ordine, l’idea formale di linguaggio,
l’idea linguistica di proposizione normativa, l’idea epistemologica di
scienza moderna. In questo senso, il diritto è concepito come
l’organizzazione di una forza che si esprime in un ordine logico-linguistico
di cui è, al tempo stesso, a livelli diversi di intervento strutturale, cogeneratrice e ricostruttrice la ragione scientifica, ossia la scienza giuridica.
Questo è certamente vero, ma non inficia la considerazione
fondamentale: spogliato di ogni orpello, il giuspositivismo è un
giusnaturalismo della forza, della forza statuale in quanto effettiva, riflessa
ed elucidata nelle forme di un ordine logico-linguistico co-generato e
ricostruito dalla ragione della scienza nelle forme della modernità. Non a
caso, come si sa, il giuspositivismo è nato, per una paradossale eterogenesi
dei fini, dalla positivizzazione statuale del giusrazionalismo in epoca postilluminista.
Ma il diritto pensato dai giuspositivisti oggi è messo sempre più in crisi
da due processi diversi e convergenti: da un lato, il crescere di fenomeni di
globalizzazione e di aggregazioni soprastatuali che fanno decrescere la
forza dello Stato, anche dal punto di vista strettamente ordinamentale.
Dall’altro, il crescere di una sensibilità, culturale e teorica, verso quei
diritti che non sono diritti qualsiasi, giuspositivisticamente e
giustatualisticamente fondati, ma diritti più forti, a valenza (statuale e/o
suprastatuale) costituzionale.
In realtà, il processo in atto, più che determinare ex novo un fenomeno,
semplicemente rende visibile ciò che nei tempi precedenti, pur invisibile,
continuava giuridicamente a sussistere: ossia l’esistenza – di cui dicevamo
– di un diritto come attività della società nel suo complesso, mirante a un
ordine garantito. In questo senso, i processi indicati fanno solo riapparire
alla luce ciò che già c’è. Non producono, ma rivelano.
37
Non c’è diritto che non sia riconosciuto e fatto vivere – attraverso
soggetti a ciò deputati – nel suo evolversi. Ma è fondamentale sottolineare
che dietro e sotto il fatto dell’evolversi del diritto vive – talpa celata ma
indisconoscibile – un principio non visto: quello della necessità di
rimodellare continuamente l’identificazione del diritto che la società si dà;
così come è fondamentale sottolineare che dietro e sotto il fatto
dell’evolversi del diritto vivono, proprio a partire da un tale principio, i
sempre nuovi princípi – consapevoli o inconsapevoli – con cui si
rimodellano interpretazioni e applicazioni. Se a monte del diritto c’è il suo
riconoscimento (Herbert Hart), a monte del suo riconoscimento c’è
l’attività regolatrice di una società che continuamente reinterpreta i
princípi del suo ordine.
Una più matura consapevolezza dei processi globali in atto e dei diritti
fondamentali spinge ad andare oltre le tante – pur raffinate – concezioni del
diritto: per passare dalla filosofia del diritto alla filosofia dei diritti e dalla
filosofia dei diritti alla filosofia della dignità. Dignità che è, in senso etico e
giuridico, il fondamento del diritto ai diritti. E del diritto ai doveri. Ciò
significherà passare dalla svolta ermeneutica al suo centro prospettico più
radicale e profondo: la persona.
La cultura che oggi s’impone all’attenzione come risposta alta alle
sfide della globalizzazione è una cultura non dei diritti tout court, ma dei
diritti fondamentali, ossia di quei diritti che prevalgono sulle stesse leggi.
Diritti la cui sostanza etica e giuridica celata è la dignità di ogni essere
umano, assunto nella sua concretezza e nella sua differenza da ogni altro.
Dignità che è da intendere non solo al grado passivo, come aspettazione di
soccorsi, ma al grado attivo, come promozione di possibilità.
Su questi diritti fondamentali oggi esistono molte Carte internazionali –
Carte che non riguardano solo il mondo occidentale ma anche quello
islamico, orientale, africano. Si tratta di Carte differenti che, seppur in
lessico giuridico, sono un diversificato commentario al problema della
dignità. Il cui fondamento, prima e più che nella potestas degli Stati, è, per
impiegare un modello caro ai Romani, nell’auctoritas di un Jus
storicamente nuovo, degno di riconoscimento e di ossequio.
È giunto, forse, il tempo in cui mettere in discussione la necessità
giustificativa della sola “ragione”. Assumendo come criterio strutturale un
principio altro, non necessariamente sostitutivo ma, almeno, qualificativo:
la “persona”.
Si tratta di ripartire da un’ontologia del singolare che rimetta in
questione la ragione. A differenza di questa, infatti, la persona non
prescinde dal singolare, dal corpo, dal vissuto, dalla fragilità, dalla
38
condizione mortale, dalla narratività, dall’universalità iscritta nel singolare.
Il giusnaturalismo moderno è raccolto nell’idea di una ragione che scopre
nella ragione dell’uomo il suo diritto naturale: di valore universale, di
natura razionale. Si tratta di una ragione come principio cognitivo che
scava in una ragione come principio ontologico, còlto alla scala dell’uomo.
Di una ragione sempre più criticata e pluralizzata dal pensiero
contemporaneo11. Occorre un mutamento di prospettiva che tocchi tutti e
due i livelli del percorso individuato (quello ontologico e quello cognitivo):
identificando un principio personale (una ‘ragione personale’) come
principio cognitivo che scavi in ogni differente persona il principio
ontologico della sua singolarità. Intendendo quest’ultima come atto di
esistere unico, relazionato, profondo. Sono maturi, cioè, i tempi per
passare dal giusnaturalismo al giuspersonalismo. Attraverso un giudizio
riflettente, impiegato in forma nuova, in cui muovere dal singolare per
cercare un universale mai concluso.
L’umanità inscritta nella propria singolare concretezza è la persona.
Essa non è l’essere umano in generale, ma l’uomo concreto e la sua idea.
Frutto di uno sguardo empirico e di un giudizio riflettente. Là dove si
coglie radicata un’idea – a grado singolare – con valenza universale, così
come Kant la coglieva nell’opera d’arte. Questa persona è, in quanto tale
“bene comune”. Si tratta di realizzare qui una vera rivoluzione nell’idea di
bene comune. Non solo in senso etico, ma epistemologico. Perché si
postula che anche il singolarissimo, proprio di una persona, sia però, in
quanto degno di considerazione universale, “bene comune”. Donde
l’imperativo che nessuna maggioranza, per quanto ampia, possa mai
lederne la consistenza. Si tratta di compiere, in nome della persona, oltre
Kant, una rivoluzione copernicana al quadrato che non ribalti la prima
rivoluzione ma la radicalizzi. Se è vero, infatti, che la civiltà umanista – e,
a suo modo, quella kantiana – aveva posto al centro la soggettività umana,
la “rivoluzione copernicana al quadrato” di cui parliamo è quella che porrà,
se ne avrà intellettualmente la forza, al centro della soggettività umana il
suo vero centro – centro di centro – ossia l’uomo singolare e concreto,
distinto da ogni altro e guardato come irrimediabile e intotalizzabile
novum: la persona.
Occorre criticamente riflettere a fondo sulla scelta – che alcuni teorici
fanno – del corpo come del luogo più accomunante e comune. Se è vero,
infatti, che il corpo ci accomuna, è proprio questo medesimo corpo che ci
singolarizza e ci divide. Il mio dolore corporeo non è il tuo, anche se
fossimo accomunati dal massimo di solidarietà viscerale. Eppure, è proprio
qui lo scavo teorico da compiere: al massimo livello di profondità. Bisogna
11
Sul punto, l’ormai classico Pietro Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna, Liguori, Napoli 2000.
39
riuscire a pensare il “comune” non solo al primo livello – al piano di quel
‘comune’ che prescinde dalle singolarità in esso radicate –, ma, a un
secondo e a un terzo livello, al piano, più radicale, in cui è quello stesso
comune ad avere il volto del ‘singolare’ ed è quello stesso singolare a
costituire il ‘comune’. Perché il tuo dolore, che è tuo, è comune. E perché
ogni ‘comune’ ha un rivelarsi al singolare. Così come il tuo corpo, che è
tuo, è comune pur restando tuo. Il che sarà vero anche per il ‘corpo vivente’
nel suo significato più complesso, che dice tutto ciò che sei e non una tua
semplice parte. Bisogna, cioè, teoreticamente guadagnare il livello in cui è
lo stesso ‘comune’ a essere il ‘singolare’ perché è lo stesso singolare a
essere comune – e in una prospettiva in cui mai il ‘comune’ annichilisca il
‘singolare’, perché quest’ultimo resta, per il giudizio riflettente che vi si
ràdica e ne muove, il suo ‘universale concreto’ di riferimento. In questo
orizzonte, la singolarità, restando singolarità, perché e in quanto personale,
è bene comune.
L’idea contemporanea dei diritti fondamentali custodisce, a nostro
avviso, nell’era della globalizzazione, questo straordinario strato filosofico,
a sua insaputa. Essa, infatti, istituisce l’orizzonte di un “tuo” che, restando
tuo, è bene comune. E che, in quanto tale, è argine invalicabile nei
confronti di qualsiasi maggioranza, comunque qualificata, che ritenga di
poter disattenderne la consistenza. In questo senso, l’enucleazione di diritti
fondamentali della persona è un commentario – in un catalogo mai chiuso –
all’idea stessa del “bene comune”. È qui il nucleo teorico di un
“giuspersonalismo” speculativo che lavora attraverso il giudizio riflettente
come categoria speculativamente militante. Senza dimenticare che solo
all’interno di un’etica della relazione – in quanto tale, aperta – può
intercettarsi la persona come bene comune. Perché la tua libertà, i tuoi
diritti e la tua differenza sono parti costitutive e fondanti del bene comune.
16. Per una lettura a strati
Dicevamo che i princípi stanno fra i valori e le norme. E che tutte e tre
le figure – valori, princípi e norme – vivono insieme confuse nella società
umana che si regola in un ordine.
Se, proseguendo sulle orme della civiltà romana e di Vico, il Jus è lo
strato delle ragioni giuridiche storicamente sedimentate nel vissuto di una
società e la Lex l’eventuale precetto statuale della Potestà che le circostanzia
e le completa, è qui teoreticamente introducibile un ulteriore strato di
analisi: lo strato dei bisogni antropologici primordiali che permanentemente
40
soggiace sia al ‘Jus’ sia alla ‘Lex’. I quali, pur a contenuto storico variabile,
si manifestano in una storicità che si rivela null’altro che la forma variabile
della necessità di storificarsi. Ci troviamo, quindi, di fronte a tre strati:
esprimenti, nella loro struttura antropologica cogente, l’archeologia di
un’esperienza giuridica universale.
Se ricostruiamo ora il percorso del diritto dalle norme ai princípi ai
valori, possiamo scoprire che in un tale cammino a ritroso, procedendo
dalle ragioni delle parti (‘norme’) alle ragioni dell’intero (‘princípi’ e
‘valori’), noi riconosciamo l’architettura a strati di un Jus risalendo – lungo
i ‘principi generali dell’ordinamento giuridico’, i ‘principi del diritto’, gli
orientamenti di principio al diritto e i valori – fino alle fonti di
legittimazione dell’ordine sociale, alla sua giustificazione valoriale e al suo
ordine di necessità. Fino al principio dell’equità come costitutivo del
diritto12. Fino ai principi vichiani dell’umanità (come reciproco soccorrersi
fra gli uomini) e del pudore (come messa in forma e in confini della
libertà). Fino al principio, ove siano i tempi maturi, per cui il diritto di
esistere è il fondamento dell’esistere del diritto.
17. Per un nuovo paradigma della ragione
Crediamo siano maturi oggi i tempi per una nuova concezione
epistemologica della ragione. Per una ragione che, apprendendo dalle
coordinate della persona (unicità, relazionalità, profondità) assuma dalla
relazione una sua ineludibile fonte intersoggettiva (nella persona, la ‘ratio’
è ‘relatio’) e dalla forza positiva dei sentimenti la fonte del senso (nella
persona, la ‘ratio’ è ‘revelatio’). Si tratta di aprire a una ragione che sappia
definirsi secondo un modello non già teoreticamente concluso, ma in
cammino, a partire dalla propria singolare e storica diversità e, insieme, dal
pudore e dalla pietà.
Il pudore, infatti, non è solo un bisogno ineludibile. Esso è anche, per un
pensiero speculativo che con esso si confronti, una sfida teoretica: la
domanda – rivolta al potere, alla conoscenza e alle categorie della scienza –
sul se io possa essere inteso come esaurito dallo sguardo che – in modi
anche sofisticati – mi vede dall’esterno. Sul se io possa essere fatto
coincidere col repertorio dei dati che il potere e la scienza possono
conseguire di me. Un tale ‘pudore’ non può non essere profondamente
connesso alla ‘pietà’. E con la speranza che il varco ad essi non sia mai
12
G. B. Vico, De uno universi iuris principio et fine uno, in ID., Opere giuridiche. Il Diritto universale,
introduzione di N. Badaloni, a cura di P. Cristofolini, Sansoni Editore, Firenze 1974. Vedi anche G. M.
Chiodi, Equità. La categoria regolativa del diritto, Guida, Napoli 1991.
41
chiuso.
Parliamo del pudore come limite e misura di civiltà. Perché sostanza
soggiacente a ogni ‘rispetto’ e argine verso ogni ‘ragione’. Parliamo della
pietà come senso del legame nella condivisione, dei sentimenti
(‘compassione’) e della fragilità (‘sunt lacrimae rerum et pectora mortalia
tangunt’, Virgilio).
Il pudore e la pietà sono sentimenti di confine. Custodi di un allarme e di
una soglia. Che vale in due forme, doppiamente simmetriche: nel soccorrere e
nel rispettare; nel non varcare e nel non far varcare. Soglia la cui complessa
struttura, in termini di ‘diritti’ e ‘doveri’, individua la ‘dignità’. Soglia la cui
persistente negazione segna la catastrofe di una civiltà.
Da quando la modernità – nel suo lavoro di rifondazione analitica che
tutto ha consumato di sé, compreso il suo fondamento – si è trovata a
rendere conto a sé stessa del senso della sua rifondazione, la sua eredità
teorica, di cui tanto bene dà conto la storia del Novecento, si è rovesciata.
Non riesce ad apparire più vero, infatti, che porsi il problema del senso sia
un problema senza senso, perché, al contrario, appare senza senso proprio
il porsi problemi di verità a prescindere dal senso. Come in una nemesi
storica, noi assistiamo forse, oggi, a una vendetta consumata da un
particolare fatto sui fatti: da quel fatto che, pur negato, sempre
irresistibilmente risorge e che è il bisogno di senso. Se nel mondo
contemporaneo è certamente un fatto l’urgere del desiderio, tra questi fatti,
anche se non riducibile ad essi, è il desiderio di senso. Se è vero che, come
Ludwig Wittgenstein insegna, l’immortalità della vita non risolverebbe il
problema della vita13, è anche vero che l’onnipotenza della ragione non
risolverebbe il problema della ragione. Perché, come già altrove
scrivemmo, «la ragione può, certo, sostenere che domandare il senso è
problema privo di senso, ma non può – nemmeno invocando Wittgenstein e
la settima proposizione del Tractatus – sottrarsi all’ulteriore obiezione:
come negare senso al fatto del continuo bisogno di senso e come
riconoscere senso, intanto, a una ragione che questo fatto neghi?».
Ne nascono paradossi cruciali. A. La ragione, divenuta potenza
tecnologica, non asciuga, ma alimenta, i suoi bisogni di fondamento e di
senso. B. Più la ragione scientifica diventa ricca di dominio, più diventa
difettiva di certezze.
L’idea ischemica che la ragione rappresenta di sé, si rivela una paranoia della ragione, ossia un proprio raddoppiamento mimetico consumato
in una invisibile prigione. Si dà una paranoia della ragione proprio là dove
13
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, a cura di Amedeo G. Conte, Torino, Einaudi
1964, proposizione 6.4312, p. 80.
42
occorrerebbe una sua metà-noia14, che riesca a farla scoprire virtuosamente
s-fondata. Sfondata in tre punti che costitutivamente le sfuggono,
consegnandola alla radicale sua difettività: a. in senso orizzontale
(l’apertura costitutiva alla relazione con l’altro); b. in senso verticale
(l’apertura costitutiva a un profondo possibile, mai concettualmente
consumabile, cui non disappartiene il mondo delle emozioni,
dell’inconscio, della non computerizzabile vita); c. in senso riflessivo
(l’apertura costitutiva alla propria difettiva e itinerante novità).
Simile al tiranno di platonica memoria, che tutto può sugli altri e nulla
su sé, la ragione contemporanea tutto può dire su quanto essa fonda, nulla
dei suoi fondamenti. Tale esito ha, a nostro avviso, profondamente da fare
con la rivoluzione che nascostamente si annuncia, oggi, per linee invisibili,
nei rapporti confinari fra tecnologia, scienza, filosofia, religione, arte e
poesia. Si tratta, in realtà, di pensare a una ragione che si ponga, da un lato,
come relazione e, dall’altro, come apertura alla profondità e al senso.
Come apertura alla compassione e al pudore. Là dove la ragione rifiuta la
propria autotrasparenza riflessiva, la propria autoidentificazione separata e
la propria onniscienza inclusiva. Scoprendosi felicemente s-fondata. Sia in
senso orizzontale (il rapporto con l’altro), sia in senso verticale (il rapporto
col proprio possibile, che la sottende), sia in senso riflessivo (il rapporto col
sé). Una tale ragione, in quanto tende alle coordinate della persona,
costituisce la persona come principio epistemologico indagante atto a
cogliere la persona come principio ontologico indagato.
18. La scienza giuridica come conoscenza del mondo civile e la filosofia
del diritto come diritto alla filosofia
All’emersione di una ragione epistemologica nuova apre varchi possibili
la stessa stagione contemporanea. Siamo oggi, infatti, davanti a una nuova
frontiera di paradossi, che possono risultare, al tempo stesso, esiziali e
virtuosi. Viviamo in tempi in cui, per l’esponenziale progresso tecnicoscientifico, si dànno situazioni nuovissime e decisive:
a. È sempre più grande la capacità della tecnoscienza di generare effetti
straordinari e di lunga durata ed è sempre più piccola la capacità della stessa
di prevedere, calcolare e invertire tanta parte di questi effetti (evento della
complessità come paradosso della inversione delle quantità cognitive);
b. un numero sempre più piccolo di uomini può determinare un effetto
sempre più devastante nella vita di tutti gli altri (paradosso della inversione
delle quantità sociali);
14
Eligio Resta, Il diritto fraterno, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 123 e passim.
43
c. in angoli sempre più circoscritti del mondo (si pensi ai possibili effetti
combinati dei processi di miniaturizzazione, di nanotecnologizzazione e di
indeterminazione) possono generarsi eventi sempre più devastanti nella vita
di aree sempre più grandi (paradosso della inversione delle quantità
spaziali).
Tutto ciò apre a una falda di princípi cui, forse, non si era pensato.
Donde il varco a un’onto-epistemologia del singolare, vista nella sua
capacità di farsi universale, rendendo provvisoria ogni formulazione di
universale già conclusa.
Dicevamo che non c’è possibile ordine sintattico del diritto senza un
minimo di ordine semantico condiviso e che non c’è possibile ordine
semantico del diritto senza un minimo di ordine giusto, ossia di risposta a
una domanda forte di giustizia. Si può proseguire dicendo che non c’è
possibile ordine giusto che non risponda alla domanda di una persona – di
ogni persona – nel suo essere atto di esistenza unico, relazionato, profondo,
il cui nucleo sia la dignità e il cui centro di radicamento sia in quella
singolarità che si autocertifica, senza possibile dubbio, nel dolore. Perché il
dolore è l’evento che m’intercetta e m’interroga nella mia singolarità. Là
dove non posso dubitare che sono io a soffrire e non tu, né un pensiero
universale in me. Il dolore fa gravitare me su me stesso e qui. Attestando la
mia singolarità e il mio presente. Aprendo alla rottura della mia unità
inconscia incantata. Schiudendo alla possibile attesa di un senso. Se il
dolore è l’atto della singolarità irriducibile, una ragione degna di questo
nome non può essere insensibile al dolore di una persona, a maggior
ragione se è muto. E non può non tradurre una tale opzione in etica e, per
quanto possibile, in diritto. Implicando in tal gesto un riferimento alla
compassione e al pudore. Ovvero, alla relazione e alla profondità.
I tre coni di cui dicevamo, rappresentativi di rapporti epistemologici
figurati fra mondi noetici (ordine sintattico, ordine semantico, ordine
giusto), richiamano, a ben vedere, nel loro percorso ascendente, una quarta
figura. Almeno a un certo livello della civiltà giuridica, infatti, non c’è
possibile ordine giusto senza implicare un possibile ordine buono. Ciò, in
un significato del ‘bene’ che, andando oltre Thomasius, non si limiti a
differenziarsi dal ‘giusto’ trasformando le prescrizioni universali negative
(«Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te») in prescrizioni
universali positive («Fa’ agli altri ciò che vuoi sia fatto a te»), ma che
esprima quel valore – fine in sé – che rompe ogni ragione simmetrica,
facendo della dissimmetria la sua regola, in nome di una misericorde
gratuità.
Un tale ‘bene’ significa, in realtà, il passaggio dall’ordine giusto
44
all’ordine buono. Di cui punto essenziale è l’ordine di un fine in sé, la
persona. Un tale ordine buono, in realtà, radicalmente eccede l’ordine del
diritto, anche se sull’ordine del diritto ha titolo per esercitare una
permanente e utopica gravitazione. La persona, infatti, sempre eccede
l’ordine del diritto, anche se, a un certo livello di civiltà, può cominciare a
far gravitare quest’ordine verso di sé. Nei limiti della sostenibilità umana.
Il che può accadere nella misura in cui dell’attività sociale autoregolatrice –
che è diritto – entri a far parte il principio paradossale della persona, ossia
delle persone.
Pur eccedendo radicalmente il diritto, la ‘persona’ ha precise incidenze
sullo stesso: 1. Costituendo, nei confronti di ogni Diritto, criterio di
fondazione e test permanente di falsificazione. 2. Destrutturando
l’architettonica del rapporto fra ‘pubblico’ e ‘privato’. 3. Demistificando il
criterio dell’astrattezza e generalità come forma di giustizia. 4. Spingendo a
decostruire la ‘giustizia’ in termini di ‘persone’. 5. Costituendo un
riferimento, più che alla potestas, a un fondamento antico, l’auctoritas,
intesa come forza valoriale, matrice di rispetto, indipendente dal potere e
dalla negoziazione di consensi.
La scienza calcola, la filosofia pensa. Possiamo anche dire: la
tecnologia calcola, la persona pensa. Esistono, così, una scienza del diritto
e una tecnologia del diritto che calcolano, come esistono una filosofia e
una persona che pensano. Ciò non significa istituire ostilità strutturali fra
istanze, ma un confronto ineludibile. Senza calcolo, saremmo deprivati di
ogni progresso; senza pensiero, saremo privi di ogni civiltà. La radice –
l’errante radice – di questa dignità civile del pensare è la filosofia. E oggi,
in nome di un nuovo paradigma della ragione, la persona. Triplicemente sfondata: verso l’impossibile auto-trasparenza, verso la necessaria relazione
con l’altro, verso l’impossibile possesso della propria profondità.
Attraverso il senso di sé, la compassione per l’altro e il pudore.
La persona è il diritto di resistenza originario e la nuova misura: diritto
e misura affermati da ognuno nei confronti di ogni sistema (concettuale,
etico, politico, giuridico) che si presenti come concluso. Se lo ‘statuale’ si è
storicamente posto come argine rispetto al ‘privato’ e il ‘costituzionale’
come argine rispetto allo ‘statuale’, la persona è l’ultimo argine, eretto nei
confronti di qualsiasi potere, pubblico e privato. Non a caso, Antonio
Rosmini ha, con espressione pregnante e magistrale, affermato che «la
persona è diritto sussistente».
È stato lapidariamente scritto da Vico, a conclusione della Scienza
nuova: «Se non siesi pio, non si può daddovero esser saggio». Condizione
del sapere è la pietà.
45
Il nostro tempo sembra in preda a un nichilismo che si caratterizza non
per una crisi di valori, ma, più radicalmente, per una crisi di domanda di
valori. Se l’idea di persona costituisce uno stadio importante, a orizzonte di
millennio, nell’attuale temperie di civiltà, la società contemporanea può
autocomprendersi oggi come l’atto complesso del convivere tra persone.
Se, vichianamente, riflettere sul diritto è indagare sulla sua intrinseca
filosofia e se riflettere sulla sua filosofia è formarsi conoscitivamente sul
suo incarnarsi civile, meditare sulla filosofia e sul diritto è poter meditare
senza tregua, speculativamente e in concreto, sulla sostanza cruciale della
civiltà.
46