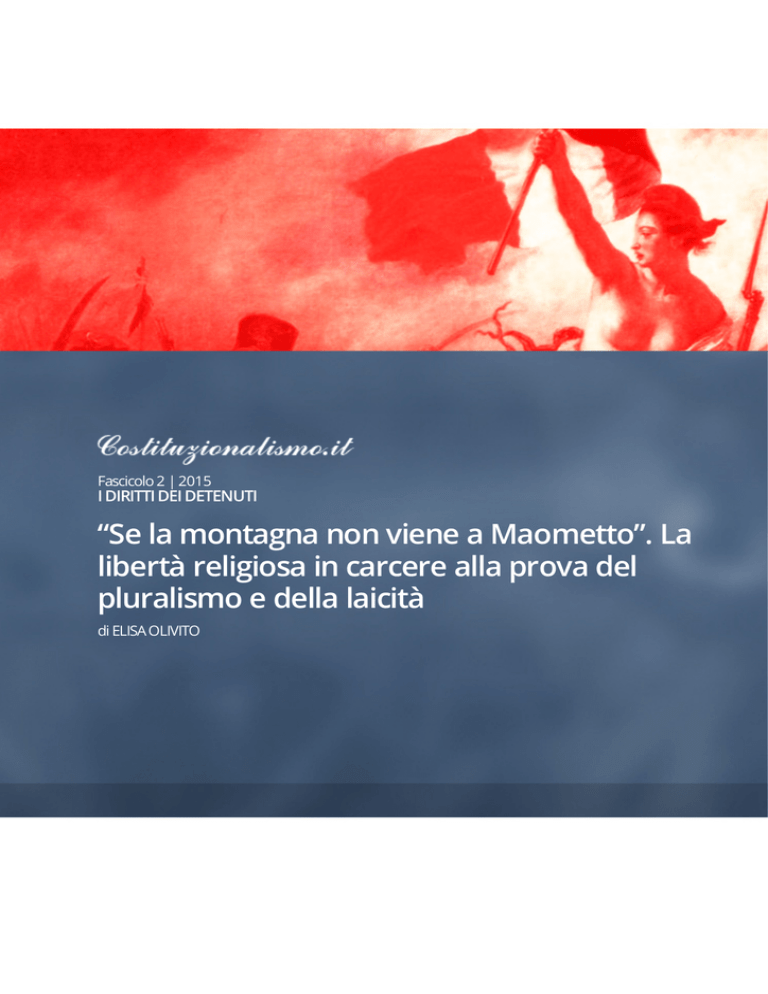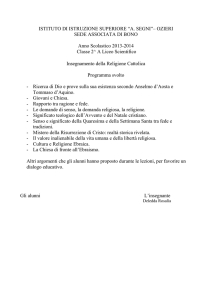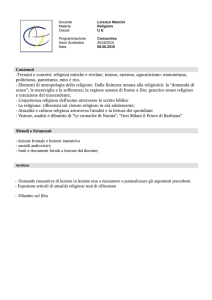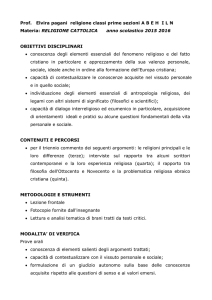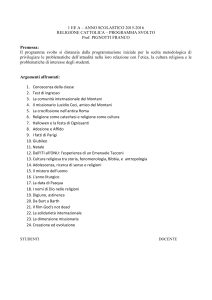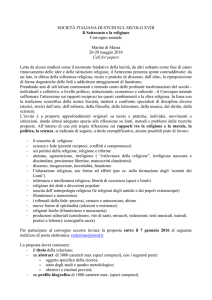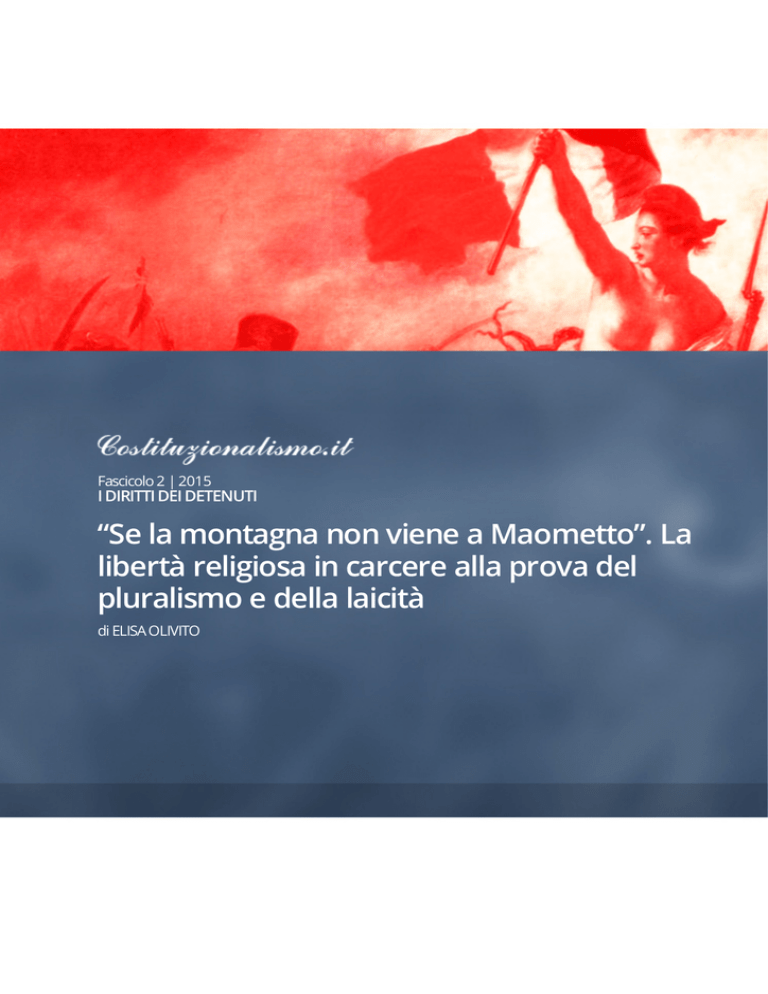
Fascicolo 2 | 2015
I DIRITTI DEI DETENUTI
“Se la montagna non viene a Maometto”. La
libertà religiosa in carcere alla prova del
pluralismo e della laicità
di ELISA OLIVITO
“Se la montagna non viene a
Maometto”. La libertà religiosa in
carcere alla prova del pluralismo e
della laicità
di ELISA OLIVITO
Ricercatrice confermata di Diritto costituzionale - Università di Roma "La Sapienza"
Abstract
Il saggio ricostruisce l’evoluzione dell’ordinamento penitenziario nella garanzia
dei diritti di libertà religiosa dei detenuti ed evidenzia come, nonostante alcune
riforme, persistano significative discrasie nelle condizioni per il loro effettivo
esercizio. Si sottolineano, in particolare, le disparità ancora sussistenti nel grado
di tutela della libertà di culto e dell’assistenza spirituale e l’impossibilità di darne
un giustificazione sulla base di un criterio meramente numerico. Anche
all’interno degli istituti penitenziari si dovrebbe, peraltro, prestare attenzione alle
esigenze dei detenuti prima che a quelle delle confessioni religiose, nel pieno
rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di laicità e in sintonia con il
crescente pluralismo religioso.
The essay analyses the evolution of the Italian penitentiary law in guaranteeing
prisoners’ rights to religious freedom and it highlights how, despite some
reforms, many significant discrepancies persist in their implementation. It
stresses, in particular, how disparities continue to exist in the protection of
freedom of worship and in that of religious assistance. The failure to excuse
those discriminations on a purely numerical criterion is strongly emphasized.
Even within “total institutions” such as prisons a special attention should,
however, be paid to the religious needs of prisoners before those of their
religions, in full respect of the constitutional principles of equality and
secularism, and in tune with an increasing religious pluralism.
***
Quanto alla maggioranza dei detenuti, esclusi i pochi che vedevano
chiaramente tutto l’inganno esercitato sugli uomini di quella fede e che in cuor
loro ne ridevano, la maggioranza credeva che in quelle icone dorate, candele,
calici, paramenti, croci, ripetizioni delle incomprensibili parole «Gesù
dolcissimo» e «ab’ pietà» fosse racchiusa una forza misteriosa, per mezzo della
quale si potevano ricavare grossi vantaggi in questa e nell’altra vita. Benché la
maggioranza di loro avesse fatto diversi tentativi di ottenere vantaggi in questa
vita per mezzo di preghiere, Te Deum e candele, ma senza ottenerli (le loro
preghiere erano rimaste inascoltate), ognuno era fermamente convinto che
l’insuccesso fosse casuale e che quella istituzione, approvata da gente colta e da
metropoliti, fosse pur sempre un’istituzione molto importante e necessaria, se
non per questa vita, certo per quella futura.
Lev Nikolaevič Tolstoj, Resurrezione
***
Sommario: 1. La religione in carcere: da strumento di disciplinamento a diritto
di libertà. 2. La libertà di culto e l’assistenza religiosa in carcere tra disparità,
intese con lo Stato e accordi procrastinati. 3. Istanze in materia religiosa e
pluralismo: l’immagine riflessa dal carcere 4. Osservazioni conclusive:
eguaglianza, laicità e principio “anti-maggioritario” nella garanzia dei diritti di
libertà religiosa dei detenuti.
1. La religione in carcere: da strumento di disciplinamento a diritto di
libertà
Nell’introduzione a “La libertà religiosa. Storia dell’idea” Francesco Ruffini
osservava che «la libertà religiosa, se genericamente si suole definire come la
facoltà dell’individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più
gli piace, a nulla, non però cade nel campo giuridico sotto questo suo aspetto di
facoltà essenzialmente interna. […] Essa cade invece nel campo giuridico
unicamente in quanto dà origine a manifestazioni esteriori e quindi
giuridicamente rilevanti»[1]. In presenza di tali manifestazioni esteriori,
tuttavia, la libertà religiosa può dirsi concretamente garantita non quando
l’ordinamento giuridico si orienti verso un atteggiamento di mera tolleranza del
fattore religioso, ma quando vi siano i presupposti per il suo effettivo
godimento, in condizioni di sostanziale eguaglianza e nel pieno rispetto del
principio di laicità dello Stato. Diversamente, non di autentica libertà dovrebbe
parlarsi, ma di graziosa concessione o di odioso privilegio in favore di alcuni
soggetti soltanto.
Tuttavia, se ci si pone dalla prospettiva di istituzioni totali come gli istituti di
pena, la libertà religiosa è costretta a fare i conti, da un lato, con le logiche di
sorveglianza, gestione dell’ordine e soggezione speciale proprie di tali luoghi;
dall’altro, con le peculiarità di un ordinamento penitenziario, che sotto
molteplici aspetti ancora risente di evidenti discrasie nei rapporti fra lo Stato e
(alcune) confessioni religiose. Alle difficoltà che conseguono da tali disparità
fanno, peraltro, eco complessi intrecci di adattamenti primari e secondari à la
Goffman[2], che incidono, performandola, sulla concreta possibilità di esercizio,
da parte dei detenuti, di diritti legati alla sfera religiosa[3].
A tal proposito, da un primo sguardo all’evoluzione della normativa in ambito
penitenziario possono cogliersi sia i cambiamenti che negli anni hanno
riguardato la presenza del fattore religioso in carcere sia le criticità che,
ciononostante, tuttora permangono. Dall’Unità d’Italia a oggi, invero, i termini
del rapporto tra carcere e religione sono stati per molti versi segnati
dall’andamento delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica e dai conseguenti
assestamenti del principio di laicità. Anche all’interno delle strutture
penitenziarie il ruolo assegnato alla religione cattolica ha, infatti, costituito la
matrice principale, attorno alla quale sono state tracciate le garanzie della
libertà religiosa e le sue concrete modalità di svolgimento[4]. Ed è spesso ai
margini di tale matrice che si sono venuti lentamente configurando i diritti dei
detenuti non credenti e di quelli appartenenti ad altre confessioni religiose.
Nel sistema penitenziario, peraltro, la conformazione della libertà religiosa sulla
falsariga della posizione riconosciuta alla religione cattolica è andata per molto
tempo di pari passo con l’impiego di quest’ultima in funzione disciplinare. Il
nesso tra i due profili si è rafforzato soprattutto a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento, quando la presenza in carcere del fattore religioso cominciò a
essere “istituzionalizzata”. Se già lo Statuto albertino, nel riconoscere la religione
cattolica come la sola religione di Stato, aveva altresì previsto che gli altri culti
fossero meramente tollerati (art. 1), tale doppio binario finì per riverberarsi
sull’organizzazione degli stabilimenti penitenziari, determinando un uso della
religione (cattolica) a servizio del potere statale di controllo e di emendamento
dei detenuti.
La strumentalizzazione dell’elemento religioso a tali fini apparve evidente sin
dall’emanazione del R.D. n. 413 del 1862 (Regolamento generale per le Case di
pena del Regno), che all’interno degli istituti di pena introdusse la figura del
cappellano, nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia su delega del Re e senza
necessità di previo consenso da parte dell’autorità ecclesiastica. Il cappellano
non era chiamato soltanto ad assicurare l’adempimento delle pratiche religiose
(art. 96, R.D. n. 260 del 1891, Regolamento generale per gli stabilimenti
carcerari e pei riformatori governativi del Regno[5]). In qualità di personale
aggregato, alle dirette dipendenze del direttore della casa di pena, egli aveva
numerosi altri compiti: sovrintendere allo svolgimento dell’istruzione scolastica
(art. 100), annotare su un apposito registro la condotta morale e religiosa dei
detenuti, comunicando al direttore tutte le informazioni utili (artt. 102-103),
prendere parte, in qualità di membro del Consiglio di disciplina locale (art. 346),
alla procedura di consegna delle punizioni e di erogazione dei premi (artt. 102 e
345). Cionondimeno, in piena corrispondenza con l’atteggiamento separatista e
anticlericale dello Stato liberale[6], l’inquadramento del cappellano
nell’organizzazione penitenziaria non rifletteva l’esigenza di garantire la libertà
religiosa dei detenuti, ma era piuttosto il segno dell’uso disciplinare della
religione a fini trattamentali[7]. Tale finalizzazione era, peraltro, confermata da
numerosi altri elementi: la partecipazione alle pratiche religiose da parte dei
detenuti era obbligatoria (art. 393)[8]; le preghiere erano fatte mentalmente e
potevano essere pronunciate solo dal cappellano o dai detenuti autorizzati, su
sua proposta, dalla direzione (art. 271); la conversione religiosa era
condizionata alla presentazione di una domanda scritta, sottoposta ad attenta
valutazione (art. 394); l’assistenza religiosa ai detenuti appartenenti a
confessioni diverse dalla quella cattolica era, infine, consentita solo dietro
espressa richiesta e ove fosse stato possibile (art. 397).
In seguito, l’impiego della religione cattolica a fini disciplinari fu pienamente
ratificato dal fascismo. Il nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e
pena (R.D. n. 787 del 1931), salve alcune modifiche conseguenti alla firma del
Concordato lateranense (legge n. 810 del 1929), confermò sia l’obbligo per i
detenuti di seguire le funzioni del culto cattolico - eccezion fatta per coloro che,
al momento dell’ingresso nello stabilimento, avessero dichiarato di appartenere
ad altra religione (artt. 1 e 142, comma 3, R.D. n. 787/1931) – sia il divieto di
pronunciare le preghiere ad alta voce (art. 142, comma 5). Il cambiamento di
religione continuò a essere vincolato alla presentazione di una domanda scritta
e all’esame del direttore dell’istituto, cui spettava verificare le cause che avessero
potuto influire sulla conversione (art. 143). Inoltre, il rapporto di evidente
asimmetria tra confessioni religiose era rafforzato dal fatto che i detenuti
appartenenti a una religione diversa da quella cattolica erano ammessi a
ricevere l’assistenza dei ministri del loro culto unicamente dietro loro richiesta e
solo là dove ciò fosse stato possibile (art. 146). La valenza istituzionale e
disciplinare della religione cattolica era, infine, rinsaldata da altri fattori: il
cappellano continuava a essere uno dei componenti del Consiglio di disciplina;
aveva il compito di annotare le qualità morali del detenuto in isolamento e le
previsioni sui risultati dell’opera di riadattamento sociale cui sottoporlo (art.
50); era, infine, sentito dal direttore dell’istituto in merito all’eventuale
inadattabilità alla vita in comune di alcuni detenuti ovvero al loro conseguente
riadattamento (artt. 52, 53, 233). Era altresì prevista la possibilità che egli
esercitasse le funzioni di insegnante, che controllasse la corrispondenza dei
detenuti e che tenesse conferenze morali ed educative «specialmente sui doveri
verso Dio, verso lo Stato e verso la società» (artt. 308 e 310).
Quando nel 1948 entrò in vigore la Costituzione repubblicana, per molti anni
ciò non fu d’ostacolo né al permanere, all’interno del sistema carcerario, di un
uso strumentale e istituzionale della religione cattolica, né al mantenimento di
vistose diseguaglianze nell’esercizio, da parte dei detenuti, della libertà religiosa
e di coscienza. La normativa regolamentare rimase, infatti, a lungo invariata,
nonostante l’espressa enunciazione in Costituzione della reciproca indipendenza
e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica (art. 7), l’eguaglianza dinanzi alla
legge di tutte le confessioni religiose (art. 8), il divieto di discriminazioni sulla
base della religione (art. 3), il riconoscimento della libertà religiosa, inclusa
quella di culto (art. 19) e, non da ultimo, il divieto di sottoporre le persone
sottoposte a restrizioni della libertà personale a violenza morale (art. 13, comma
4) o a trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, comma 3).
Risultavano, dunque, del tutto incompatibili con il dettato costituzionale quelle
disposizioni regolamentari che, in ossequio a una concezione istituzionale e
strumentale della (sola) religione cattolica, prevedevano la partecipazione
obbligatoria alle pratiche collettive del culto cattolico per chi, al momento (e
solo al momento) dell’ingresso nello stabilimento, non avesse dichiarato di
appartenere ad altra confessione religiosa; esigevano, inoltre, nell’ipotesi di
cambiamento di religione, una richiesta scritta del detenuto e la successiva
valutazione del direttore dell’istituto[9].
La questione si pose, con specifico riguardo al primo profilo, quando nel 1966
un detenuto presso il carcere di Varese chiese al giudice di sorveglianza di essere
dispensato dal frequentare le funzioni del rito cattolico, perché l’obbligo di tale
frequenza, previsto dal regolamento carcerario, era da lui ritenuto contrario alla
libertà di professione religiosa garantita dalla Costituzione. In conseguenza di
tale istanza, il giudice decise di sollevare questione di legittimità costituzionale
dell’art. 142 del R.D. n. 787 del 1931 per contrasto con gli artt. 19 e 21 della
Costituzione. Per molteplici ragioni quell’obbligo sembrava, infatti, urtare con il
profilo negativo della libertà religiosa: perché la libertà di professare una
religione diversa dalla cattolica non poteva essere condizionata a un’indicazione
resa dal detenuto al momento dell’ingresso nello stabilimento carcerario; perché
anche a lui doveva esser riconosciuta la libertà di non professare alcuna
religione e, infine, perché non potevano essergli negati i diritti relativi alle libertà
fondamentali garantite dalla Costituzione, nei limiti e nel rispetto delle esigenze
della vita carceraria.
In quell’occasione la Corte costituzionale dichiarò inammissibile la questione
sollevata con l’ordinanza di rimessione, perché aveva a oggetto la disposizione
di un atto regolamentare - e non invece di una legge o di un atto avente forza di
legge - e perché mancava l’intermediazione di un atto primario, cui poter
eventualmente ricondurre la violazione della Costituzione[10]. La Corte,
tuttavia, sottolineò che «le norme regolamentari, quando siano ritenute
illegittime per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non
diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi
ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E, dai giudici chiamati a farne applicazione».
A questa soluzione si pervenne, pertanto, l’anno successivo con la circolare
ministeriale n. 1819/4276 del 3 luglio 1969[11], con cui fu disposta non soltanto
la disapplicazione dell’art. 142 del R.D. n. 787 del 1931, ma anche quella del già
menzionato articolo 143 sulle modalità di cambiamento della religione e
dell’art. 144 sulla religione dei detenuti minorenni[12].
Rimanevano, nondimeno, numerosi altri profili di incompatibilità tra
l’ordinamento penitenziario fascista, la Costituzione del 1948 e alcuni
documenti sovranazionali[13] e a essi cominciò a mettersi mano solo nel 1975,
con l’approvazione - dopo lungo dibattito - della legge di riforma n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà). In materia religiosa un primo passo fu compiuto con il
riconoscere ai detenuti la libertà di professare la propria fede religiosa, di
istruirsi in essa e di praticarne il culto (art. 26, comma 1), non potendo dunque
loro imporsi alcuna partecipazione ai riti religiosi[14]. Fu, tuttavia, mantenuta
una differenza non di poco momento tra la religione cattolica e le altre
confessioni religiose, una differenza che - come vedremo – tuttora influisce
sulla concreta possibilità di esercizio della libertà religiosa da parte dei detenuti.
L’art. 26 del nuovo ordinamento penitenziario, infatti, ancora dispone che negli
istituti penitenziari siano assicurate la celebrazione dei riti del culto cattolico e la
presenza di almeno un cappellano (commi 2 e 3). Ai detenuti appartenenti a
religione diversa dalla cattolica si è, invece, riconosciuto il diritto di ricevere
l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, ma – salvo quanto
si specificherà - soltanto su loro espressa richiesta (comma 4)[15].
2. La libertà di culto e l’assistenza religiosa in carcere tra disparità,
intese con lo Stato e accordi procrastinati
Se la legge n. 354 del 1975 ha formalmente riconosciuto ai detenuti i diritti
legati alla sfera religiosa, ben altro discorso sembra doversi fare sul piano del
loro effettivo godimento, per il quale occorre guardare alle condizioni di
esercizio in concreto fissate dal legislatore. Non può, inoltre, prescindersi da
un’attenta riflessione sui mutamenti che negli ultimi anni hanno interessato la
popolazione carceraria, perché ciò ha reso più variegato il panorama delle
istanze religiose avanzate dai detenuti, mettendo ulteriormente a dura prova la
plausibilità e la tenuta di alcune disparità di trattamento.
Sotto il primo profilo, l’ordinamento penitenziario italiano sconta innanzitutto
alcune aporie, dovute alla persistenza di notevoli differenze, nelle condizioni di
esercizio della libertà religiosa, tra detenuti cattolici e detenuti appartenenti ad
altre confessioni religiose (e, ancora per questi ultimi, tra quelli appartenenti a
confessioni munite di intesa con lo Stato e quelli appartenenti a confessioni
senza intesa). Le disparità riguardano, per un verso, le modalità previste dalla
legge per l’assistenza religiosa ai detenuti e, per l’altro verso, gli spazi messi loro
a disposizione per l’esercizio individuale e collettivo del culto.
L’assistenza spirituale in carcere, in condizioni di equidistanza e di parità, trova
un primo significativo ostacolo nel fatto che mentre è tuttora prevista la
presenza di almeno un cappellano in ciascun istituto penitenziario (art. 26,
comma 3, l. n. 354/1975[16]), i detenuti appartenenti ad altra confessione
religiosa hanno sì diritto di ricevere assistenza da parte di un ministro del
proprio culto e di celebrarne i riti, ma per potersi avvalere di tale diritto devono
farne richiesta (art. 26, comma 4)[17]. Il cappellano, peraltro, pur non essendo
ormai membro del Consiglio di disciplina, prende parte alla commissione che
predispone e modifica il regolamento interno dell’istituto, con il quale sono tra
l’altro disciplinate le modalità del trattamento (art. 16, comma 2). A ciò si
aggiunga che la religione è inclusa tra quegli elementi, di cui l’istituto
principalmente si avvale per il trattamento dei detenuti (art. 15, comma 1).
La presenza del cappellano all’interno del carcere quale figura normativamente
prevista, la sua inclusione nella commissione per il trattamento e l’inserimento
della religione tra i mezzi del programma rieducativo incidono innanzitutto, se
complessivamente intesi, sull’aconfessionalità cui dovrebbero essere improntati
l’ordinamento penitenziario e il relativo trattamento. Inoltre, nonostante
l’obbligatorietà delle pratiche religiose sia venuta meno, la garanzia della libertà
religiosa (anche negativa) risulta essere ancora parziale: tuttora permane,
difatti, «un certo tasso di imposizione e di ufficialità»[18] della religione,
sebbene nei termini non più di un’adesione forzata ai valori religiosi, ma di una
loro indiretta somministrazione e istituzionalizzazione[19].
In uno Stato laico, tuttavia, l’inclusione della religione tra gli elementi del
trattamento e la sua “convalida istituzionale” attraverso la presenza del
cappellano non trovano alcuna giustificazione. A tal proposito, non varrebbe
neppure sostenere che «la religione può […] considerarsi valida componente del
trattamento solo in quanto, una volta spogliata del carattere tipicamente
confessionale di obbligo imposto, le si attribuisca un ruolo, che in effetti è
insopprimibile, afferente alla problematizzazione sul senso della vita, e dunque
quale possibile fonte di valori rilevanti per una pacifica convivenza» o
addirittura come garanzia di libertà per il detenuto[20]. Non si vede, infatti, per
quali ragioni tale problematizzazione debba passare attraverso un’indebita (e
fittizia) laicizzazione dell’elemento religioso e come ciò sia compatibile con la
garanzia di una libertà fondamentale, che per il detenuto vuol dire prima di
tutto libertà di coscienza e libertà di non professare alcuna fede[21].
L’assistenza religiosa prestata dal cappellano e l’assicurazione della celebrazione
dei riti del culto cattolico (art. 26, comma 2, l. n. 354/1975) pongono, del resto,
alcuni problemi anche sotto il profilo dell’eguaglianza, posto che la legge
espressamente richiede che il trattamento penitenziario sia improntato ad
assoluta imparzialità, senza discriminazioni neppure in ordine alle credenze
religiose (art. 1, comma 1). Se, per quanto concerne la libertà religiosa
individuale, il nuovo regolamento di esecuzione n. 230 del 2000 dispone, in
termini generali, che ai singoli detenuti è consentito sia praticare, durante il
tempo libero, «il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima
in comportamenti molesti per la comunità»[22], sia esporre in camera
«immagini e simboli della propria confessione religiosa» (art. 58, commi 2 e 3,
d.P.R. n. 230 del 2000), emergono invece forti disparità sotto i profili
dell’esercizio collettivo del culto, degli spazi idonei alla celebrazione dei riti e,
infine, dell’assistenza da parte dei ministri di culto.
Pur sussistendo, per la partecipazione ai riti, un limite valido per tutti,
consistente nella loro compatibilità con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e nella
non contrarietà alla legge (art. 58, comma 1, d.P.R. n. 230/2000), esso è
destinato a pesare in maggior misura – come dimostrato da alcune ricerche
empiriche[23] – sui detenuti appartenenti a confessioni religiose diverse da
quella cattolica e, in particolare, a quelle sprovviste di intesa con lo Stato.
Mentre, infatti, per la celebrazione dei riti del culto cattolico (garantita a
prescindere dall’effettiva richiesta di essi) ogni istituto è dotato di una o più
cappelle e le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza spirituale sono assicurate
da uno o più cappellani in relazione alle relative esigenze (art. 26, comma 2, l.
n. 354/1975 e art. 58, comma 4, d.P.R. n. 230/2000), i detenuti appartenenti a
una religione diversa dalla cattolica hanno sì diritto di ricevere l’assistenza dei
ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, ma si tratta di un diritto
condizionato.
È necessario, in primo luogo, che essi ne facciano richiesta (art. 26, comma 4, l.
n. 354/1975), non essendo loro assicurata né l’assistenza spirituale né la
celebrazione dei riti. Questa condizione presuppone, tuttavia, che i detenuti di
fede non cattolica siano effettivamente a conoscenza dei diritti loro riconosciuti
in questo ambito e che si attivino di conseguenza.
Inoltre, per l’istruzione religiosa e per le pratiche di culto essi possono servirsi,
anche in assenza di ministri di culto, di «locali idonei»; spetta, nondimeno, alla
direzione dell’istituto mettere a disposizione i relativi spazi (art. 50, comma 5,
d.P.R. n. 230/2000). Ciò vuol dire però che, in una situazione di endemico
sovraffollamento carcerario e di inadeguatezza delle strutture penitenziarie[24],
le soluzioni escogitabili dai singoli istituti per individuare locali da adibire ai culti
non cattolici risentiranno inevitabilmente di tali carenze, anche in conseguenza
di «una diffusa tendenza a sottostimare la rilevanza dei bisogni immateriali
nell’esperienza della detenzione rispetto a quelli materiali» e a tracciare «una
implicita gerarchia […] tra diritti, alcuni dei quali ritenuti più ‘diritti’ di
altri»[25]. E se ciò potrebbe ritenersi rispondente al fatto che si è comunque in
presenza di diritti di libertà e non di diritti a prestazione, resta nondimeno
l’evidente divario con gli strumenti messi a disposizione dei soli detenuti
cattolici.
Per chi professi una fede diversa da quella cattolica, peraltro, lo squilibrio nel
godimento dei diritti attinenti alla sfera religiosa tocca anche la possibilità di
avvalersi di ministri del proprio culto per l’istruzione religiosa, l’assistenza
spirituale e la celebrazione dei riti. A tal proposito, dal momento che non esiste
all’interno degli istituti penitenziari una struttura permanente come quella del
cappellanato - che è peraltro alle dipendenze dell’amministrazione
penitenziaria[26] (e a carico dello Stato[27]) – occorre fare una distinzione.
Il regolamento del 2000 stabilisce, infatti, che – ferma restando la necessità di
una richiesta da parte dei detenuti - la direzione dell’istituto si avvale o dei
ministri di culto indicati dalle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato
italiano sono regolati con legge, ovvero dei ministri di culto indicati a tal fine dal
Ministero dell’interno (art. 58, comma 6). Al di fuori di tali casi si ricorre,
invece, a quanto disposto dall’art. 17 della legge n. 354/1975[28].
Con formule che negli anni si sono andate omologando[29], le leggi di
approvazione delle intese finora stipulate prevedono che l’assistenza spirituale
all’interno delle comunità segreganti - e, in particolare, in carcere - sia
assicurata dai rispettivi ministri di culto: essa è consentita su richiesta dei
detenuti o delle loro famiglie ovvero su iniziativa degli stessi ministri di culto ed
è svolta in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell’istituto
penitenziario[30]. I ministri di culto sono designati dalle rispettive confessioni
religiose e, una volta inclusi negli elenchi dei responsabili dell’assistenza
spirituale negli istituti penitenziari[31], possono visitarli senza necessità di una
particolare autorizzazione[32]. Alcune delle intese finora stipulate prevedono,
tuttavia, che gli oneri finanziari per lo svolgimento di tale attività siano a carico
degli organi ecclesiastici competenti[33].
Peraltro, la spinta verso l’omologazione innescata dal meccanismo dell’intesa è
dimostrata anche dal fatto che «il concetto di ministro di culto, nell’accezione
civilistica del nostro ordinamento, è estraneo a molte confessioni che in qualche
modo si sono “adattate” a farlo proprio per poter realizzare le Intese con lo Stato
italiano e di conseguenza accedere a diritti e “vantaggi”, mentre altre ne sono
rimaste escluse»[34].
Per le confessioni sprovviste di intesa, invece, le strade percorribili al fine di
prestare assistenza religiosa ai detenuti sono due e non poco tortuose. Esse
possono, innanzitutto, ricorrere a quanto disposto dall’art. 58, comma 6, del
d.P.R. n. 230/2000, in base al quale il direttore dell’istituto si avvale anche dei
ministri di culto «indicati a tal fine dal Ministero dell’Interno». In tal caso, in
presenza di una specifica richiesta di ingresso, sarà necessario il rilascio di un
nulla-osta da parte della Direzione centrale degli Affari dei culti dello stesso
Ministero, che effettuerà un controllo sui singoli nominativi[35].
Diversamente, non resta che la strada indicata dall’art. 17 della legge n.
354/1975, che prevede la partecipazione all’azione rieducativa da parte «di
privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private». Tali soggetti sono
ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le
direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole e sotto il controllo
del direttore dell’istituto. E se è vero che, per questa via, «l’assistenza religiosa
sfrutta un passaggio più agevole e flessibile, perché meno soggetto a vincoli
centralizzati e di ordine amministrativo-burocratico (il processo è in questo caso
gestito dal singolo istituto, che si rapporta al Magistrato di Sorveglianza
competente), il ricorso a questa prassi implica, a ben vedere, una trasposizione
dell’area dell’assistenza religiosa sul piano, solo parzialmente accostabile ad
essa, dell’intervento trattamentale, con relativo disconoscimento di principio del
carattere propriamente religioso»[36].
Ad ogni modo, poiché le due alternative appena ricordate riguardano le
confessioni sprovviste di intesa, non bisogna sottovalutare che in entrambi i casi
l’incontro con i ministri di culto è comunque subordinato alla presentazione da
parte dei detenuti di una richiesta in tal senso (art. 26, comma 4, l. n.
354/1975)[37]. Si tratta, invero, di una condizione che nei fatti può scoraggiare
o rendere meno agevole l’allestimento di assistenza religiosa in favore di quei
detenuti che, in ragione di difficoltà linguistiche o culturali e della macchinosità
delle procedure amministrative, sono meno consapevoli dei diritti di cui godono
e, soprattutto, delle modalità da seguire per avanzare le relative istanze[38].
La tortuosità dei due percorsi appena indicati emerge, in particolar modo, nel
caso della religione islamica. Anche in Italia si discute, infatti, da tempo delle
difficoltà e delle inadeguatezze che, in conseguenza del numero crescente di
migranti di religione islamica, si sono dovute affrontare sul piano dell’effettiva
garanzia della loro libertà religiosa[39]. Per il profilo che si sta ora esaminando
un primo problema concerne l’impiego delle nozioni giuridiche di “ministro di
culto” e di “confessione religiosa” che, essendo state plasmate sul modello
giudaico-cristiano, mal si attagliano all’organizzazione non verticistica,
frammentata e localistica delle comunità islamiche[40]. Peraltro, in assenza di
un’intesa con lo Stato (per vari motivi di difficile realizzazione[41]), ciò ha fatto
emergere alcuni ostacoli nell’individuazione dei soggetti ammessi a prestare
assistenza spirituale ai detenuti di fede islamica. Pertanto, anche in
conseguenza delle difficoltà riscontrate nel far rientrare gli imam nella nozione
di “ministro di culto”, manca a tutt’oggi in Italia un “elenco” di “ministri di
culto islamico”, che abbiano ricevuto la prevista approvazione governativa[42].
Per ovviare a ciò, le circolari del Ministero della Giustizia n. 5354554 del 6
maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura
non agevole: per l’acquisizione del parere sull’autorizzazione all’ingresso in
carcere si prevede che alla Direzione generale detenuti e trattamento e al
Ministero dell’Interno sia data comunicazione delle generalità del ministro di
culto e della moschea o della comunità di appartenenza. La procedura prevede,
inoltre, l’invio alla Direzione generale detenuti e trattamento dei nominativi di
tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all’ingresso negli istituti
penitenziari, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 354/1975.
L’incidenza di procedure così farraginose ha, peraltro, prodotto effetti tangibili
sull’implementazione del diritto all’assistenza religiosa dei detenuti di fede
islamica. Dai dati forniti dal Ministero della Giustizia emerge, infatti, lo scarso
numero di personale esterno autorizzato a prestare assistenza religiosa ai
detenuti islamici[43]. Ciò si lega anche al fatto che i controlli preliminari al
nulla osta ministeriale, cui gli imam sono sottoposti, sono divenuti sempre più
scrupolosi, in considerazione dei rischi di proselitismo islamico di matrice
fondamentalista e terroristica, che l’amministrazione penitenziaria reputa
particolarmente alti all’interno degli istituti penitenziari[44]. Alcune ricerche sul
campo hanno, tuttavia, dimostrato che la risposta alla difficoltà di ricevere
l’assistenza religiosa di imam esterni (ad esempio per guidare la preghiera
collettiva del venerdì, recitare il sermone e fornire copie del Corano) è consistita
nell’auto-investimento del ruolo di imam da parte di alcuni detenuti[45]. Con
una conseguenza paradossale: il ricorso a espedienti informali per l’esercizio del
diritto costituzionale a ricevere assistenza spirituale contraddice le esigenze di
sicurezza e prevenzione avanzate dall’amministrazione penitenziaria per tenere
fuori gli imam dagli istituti di detenzione.
3. Istanze in materia religiosa e pluralismo: l’immagine riflessa dal
carcere
Le criticità appena evidenziate in ordine all’implementazione di alcuni diritti per
i detenuti di fede islamica sono, nondimeno, sintomatiche di un fenomeno più
ampio, che ha investito il carcere e ne ha rimodellato la fisionomia, forse
prim’ancora che ciò avvenisse con altrettanta evidenza in altri contesti. Negli
ultimi anni gli istituti penitenziari hanno, infatti, prima assorbito e poi
proiettato all’esterno cambiamenti sociali importanti, che hanno trovato
impreparate le istituzioni pubbliche così come l’organizzazione penitenziaria.
I processi migratori, che da tempo interessano anche l’Italia, hanno portato nel
nostro Paese persone di provenienza, cultura e religione molto diverse. Le
ripercussioni sul tessuto sociale si sono inevitabilmente tradotte in un «severo
banco di prova» sia per la tenuta dell’impianto giuridico, che in più ambiti ha
svelato crepe e inadeguatezze, sia per la verifica dell’effettiva attuazione dei
principi costituzionali in materia religiosa[46]. L’impatto è stato avvertito anche
all’interno di istituzioni segreganti come le carceri, che hanno in qualche
misura anticipato dinamiche più ampie. Le trasformazioni nella composizione
culturale e religiosa della popolazione carceraria hanno, infatti, messo in luce
tutte le difficoltà del sistema penitenziario nella gestione di nuove istanze[47],
molte delle quali toccano da vicino la sfera della libertà religiosa. E così come in
altri ambiti sono state le aule dei tribunali, prima ancora di quelle parlamentari,
a costituire la cassa di risonanza e il luogo di (parziale) composizione dei
conflitti derivanti da un accresciuto pluralismo religioso e culturale[48], in
modo solo in parte diverso la risoluzione delle problematiche religiose emerse
negli istituti di pena è passata prevalentemente attraverso circolari ministeriali,
risposte ad hoc dei singoli istituti e iniziative locali.
Tra i numerosi campi in cui il pluralismo religioso ha influito
sull’organizzazione penitenziaria c’è, innanzitutto, quello dei precetti religiosi
attinenti all’alimentazione. I fedeli appartenenti all’Islam e all’Ebraismo sono,
ad esempio, tenuti a osservare, rispettivamente, i precetti della cucina ḥalāl e di
quella kosher, che prevedono procedure specifiche per la macellazione rituale
degli animali e comportano controlli rigorosi sulla correttezza dei processi di
lavorazione e degli ingredienti utilizzati[49]. Dietro il rapporto tra libertà
religiosa, regimi alimentari e detenzione affiorano, quindi, questioni
particolarmente delicate. Posto, infatti, che per alcune religioni il cibo e
l’alimentazione «assumono un importante ruolo simbolico di marcatore
culturale, che identifica la Comunità e ne cementa l’identità collettiva»[50], la
crescente diversificazione anche religiosa della popolazione carceraria porta con
sé la richiesta di vitti differenziati in ragione delle relative tradizioni[51]. Per
rendersi conto dell’incidenza che tali istanze possono avere sul sistema
penitenziario, basti solo pensare che l’Islam costituisce oramai, dopo quella
cattolica, la seconda religione professata dai detenuti[52].
Per quanto attiene alla somministrazione del vitto giornaliero non bisogna,
inoltre, dimenticare che per i detenuti di fede islamica può porsi l’esigenza di
rispettare i precetti del Ramadan, quali il digiuno quotidiano, i tempi della
preghiera e la celebrazione della cerimonia conclusiva di rottura del digiuno. Di
essi gli istituti di pena dovrebbero, di conseguenza, tener conto sia per quanto
concerne il rispetto degli orari di somministrazione dei pasti sia ai fini della
partecipazione dei detenuti di fede islamica alle attività trattamentali.
A questo proposito, nella normativa penitenziaria si trova una scarna
indicazione soltanto nell’articolo 11, comma 4, del d.P.R. n. 230/2000: «[n]ella
formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto
possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose». La
puntualizzazione per cui la differenziazione dei vitti in tanto avviene, in quanto
ciò sia possibile, lascia intendere che esigenze organizzative ed economiche
possono costituire valido motivo per rigettare le richieste alimentari dei
detenuti. In tal modo, tuttavia, il rispetto dei precetti alimentari imposti dalla
propria religione è lasciato all’iniziativa (e alle possibilità) dei singoli detenuti, i
quali possono ricorrere, a proprie spese, al c.d. servizio di sopravvitto o al
servizio-spesa. Il primo funziona come uno spaccio interno all’istituto, dove è
possibile acquistare beni alimentari o di prima necessità per il tramite di un
conto corrente postale intestato all’istituto penitenziario, su cui i familiari del
detenuto versano dei soldi[53]. Per l’acquisto di ciò che non è ricompreso nelle
liste tariffate del sopravvitto (che di norma prevedono poca scelta e prezzi alti),
il detenuto deve presentare una richiesta scritta (la c.d. “domandina”). Tramite
essa egli ha accesso al servizio-spesa, ovverosia alla possibilità di acquistare
dall’esterno i beni di cui necessita.
Il ricorso a entrambe le opzioni è, tuttavia, condizionato alle disponibilità
economiche del detenuto, su cui peraltro incidono fortemente i prezzi
sproporzionati dei prodotti disponibili. Difatti, se sulla carta le tabelle vittuarie,
approvate con decreto ministeriale, devono essere aggiornate ogni cinque anni,
mentre i prezzi dei generi in vendita nello spaccio devono esserlo ogni mese così che essi corrispondano a quelli praticati negli esercizi della grande
distribuzione più vicini all’istituto (art. 9, l. n. 354/1975 e artt. 11 e 12, d.P.R. n.
230/2000) - «[r]ispetto a queste disposizioni di legge, la prassi consolida
l’esternalizzazione dell’intero servizio di fornitura dei generi alimentari mentre
l’unica cosa che rimane all’amministrazione penitenziaria, e quindi affidata al
lavoro dei detenuti, è la gestione diretta per il confezionamento dei pasti.
Inoltre, il servizio del vitto, del sopravvitto e del servizio-spesa sono affidati
congiuntamente a un’unica impresa che riesce ad assicurarsi uno o più lotti di
competenza»[54].
Occorre, nondimeno, tener presente che condizionare l’accoglimento delle
richieste alimentari dei detenuti a esigenze di natura organizzativa o economica
può determinare un contrasto con l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e con l’articolo 22 delle Regole penitenziarie europee. L’art. 9 CEDU
stabilisce, infatti, che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione include la
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo anche mediante le
pratiche e l’osservanza dei riti ed essa può essere oggetto di restrizioni solo se
esse sono stabilite dalla legge e «costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o
della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui». Le
Regole penitenziarie europee, inoltre, mentre nel testo aggiornato nel 1987 con
la Raccomandazione R(87)3 utilizzavano una formula analoga a quella del
d.P.R. n. 230/2000[55] (“nella misura del possibile”), nel testo modificato nel
2006 con la Raccomandazione R(2006)2 stabiliscono, invece, che i detenuti
«devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso,
della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e
della natura del loro lavoro» (art. 22)[56]. L’art. 4 dichiara, inoltre, che «[l]e
condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere
giustificate dalla mancanza di risorse»[57].
Per ciò che, invece, concerne l’esposizione di simboli religiosi, l’art. 58, comma
2, del d.P.R. n. 230/2000 espressamente dispone che i detenuti possano
«esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza
nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione
religiosa».
Nulla è prescritto, invece, in merito alla possibilità per i detenuti di indossare un
abbigliamento che sia espressione di convinzioni personali in materia religiosa o
che costituisca una forma di diffusione del proprio pensiero. In materia di
vestiario, l’articolo 7 della legge n. 354/1975 stabilisce soltanto che «[g]li
imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono
indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti (comma 4)» e che
«[i] detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro
proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo»
(comma 5). A questo proposito, spetta al regolamento interno dell’istituto
stabilire i casi in cui i detenuti possono essere ammessi a fare uso di indumenti
di loro proprietà, prevedendo, altresì, quali effetti di corredo possano usare; il
possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo è, inoltre, ammesso
solo qualora essi non abbiano un consistente valore economico e non siano
incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita nell’istituto (art. 10, commi 1
e 3, d.P.R. n. 230/2000).
Ad ogni modo, nonostante sul punto manchi un’espressa indicazione del
legislatore, la normativa penitenziaria, anche sulla base di quanto previsto dalle
Regole penitenziarie europee[58], deve interpretarsi in senso quanto più
favorevole alla libertà religiosa e di pensiero del detenuto. Sembra, pertanto,
potersi dire che l’uso da parte dei detenuti di un abbigliamento che sia
espressione di convinzioni religiose o filosofiche ovvero di appartenenza
culturale possa essere limitato soltanto per motivate esigenze di sicurezza.
Pertanto, l’impiego di alcuni indumenti o oggetti potrebbe, ad esempio, essere
vietato solo qualora esso risultasse di ostacolo al riconoscimento immediato e
sicuro del detenuto[59].
L’esigenza di garantire la libertà religiosa a quanti si trovino in condizioni di
limitazione della libertà personale emerge, nondimeno, anche al di fuori degli
istituti di pena. Si pensi, in primo luogo, ai cittadini stranieri sottoposti a misure
di detenzione amministrativa nei centri identificazione ed espulsione (CIE). Si
tratta di strutture all’interno delle quali gli immigrati irregolari in attesa di
espulsione sono trattenuti per un periodo non superiore a novanta giorni (art.
14, d. lgs. n. 286/1998[60]). Il regolamento di attuazione del Testo unico
sull’immigrazione (d.P.R. n. 394/1999) stabilisce, tuttavia, che «le modalità del
trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita
in comune, […] i diritti fondamentali della persona» (art. 21, comma 1) e che
nei centri la libertà del culto è assicurata nei limiti previsti dalla Costituzione
(art. 21, comma 2).
È, altresì, previsto che a tali strutture possano avere accesso i ministri di culto
(art. 21, comma 7), ma nulla si dice in ordine alle modalità da seguire per
l’individuazione di coloro che possano in concreto farlo. La mancata
specificazione di tale aspetto priva, tuttavia, la disposizione della condizione
indispensabile per far sì che i migranti trattenuti in tali centri possano
effettivamente godere della libertà di colloquio con i ministri del proprio culto
(art. 21, comma 1). Ciò vuol dire che, per scongiurare l’inoperatività della
norma, sarà necessario ricorrere «alle disposizioni (unilaterali e pattizie) dettate
per le altre forme di assistenza spirituale»; con l’ovvia conseguenza di
riproporre anche nei Cie le già evidenziate disparità di trattamento tra
immigrati cattolici o appartenenti a confessioni munite di intesa e immigrati
appartenenti a confessioni senza intesa (e con i connessi dubbi «circa l’effettiva
garanzia dell’assistenza spirituale […] in particolare per i fedeli musulmani che
fino a oggi sono risultati la stragrande maggioranza degli stranieri transitati per
detti centri»[61]).
Peraltro, la circolare del Ministero dell’Interno (Direzione generale dei servizi
civili) n. 3435/50 del 30 agosto 2000 (Direttiva generale in materia di Centri di
Permanenza Temporanea ed assistenza ai sensi dell’articolo 22, comma i del
d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), predisponendo una “Carta dei diritti e dei doveri”
per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza
temporanea, tra i diritti di cui essa gode indica anche «la libertà di culto,
l’assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso» (art. 1, lett.
i). Al fine di attuare le indicazioni relative ai diritti da garantire nei Cie,
l’amministrazione è tenuta a far sì che i gestori di tali strutture «rispettino,
compatibilmente con le esigenze della vita collettiva, le abitudini ed i precetti
religiosi dei diversi stranieri con particolare riferimento alle modalità delle
funzioni religiose, all’erogazione e alla tipologia dei pasti, nonché agli altri
aspetti relativi al culto» (art. 2, lett i). Inoltre, nella comunicazione da
consegnare allo straniero sottoposto a provvedimento di trattenimento all’atto
dell’ammissione al centro devono essere indicati il diritto ad «avere colloqui con
i ministri di culto» e quello di «professare la propria religione e di avere la
relativa assistenza spirituale»[62].
Un altro aspetto problematico, che alla luce dei mutamenti dell’ordinamento
penitenziario deve essere attentamente considerato, concerne la tutela della
libertà religiosa sia per i condannati sottoposti a misure alternative alla
detenzione, quali la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio
sociale presso una comunità terapeutica, sia per gli imputati sottoposti alla
misura cautelare degli arresti domiciliari ovvero al ricovero presso una
comunità terapeutica. Negli ultimi anni, infatti, con una serie di interventi
normativi, il legislatore ha progressivamente ampliato le condizioni di accesso a
tali misure. Si è, in tal modo, iniziato a percorrere con maggior convinzione una
delle strade indicate dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Torreggiani per
eliminare l’endemica situazione di sovraffollamento che da tempo affligge le
carceri italiane[63].
In questo ambito, tuttavia, per la garanzia della libertà di culto e dell’assistenza
spirituale si pongono problemi particolari, che non hanno ancora trovato
soluzione. La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 e le leggi
che hanno poi introdotto, disciplinato e ampliato tali misure tutelano la libertà
religiosa all’interno delle sole strutture carcerarie, non disponendo invece nulla
per le ipotesi in cui la restrizione della libertà personale avvenga in altri luoghi e
ad altre condizioni. L’esito paradossale è che i diritti in materia religiosa
costituzionalmente garantiti sono espressamente disciplinati, pur con alcuni
limiti, per le ipotesi di privazione della libertà personale più afflittive e non,
invece, per quelle più lievi (o considerate tali).
In mancanza di accorgimenti normativi espressi si registrano, pertanto, alcune
decisioni giurisprudenziali, che dinanzi alle istanze di condannati o di imputati
sottoposti a misure alternative alla detenzione e alla custodia cautelare, hanno
dato risposte non univoche.
In una prima serie di casi alcuni imputati di religione cattolica, trovandosi in
regime di arresti domiciliari, si erano rivolti al giudice per chiedere di
partecipare alla messa celebrata nei giorni di domenica e nelle altre festività
religiose. Per uno di essi il giudice istruttore di Pisa aveva accolto la richiesta
dell’imputato, ritenendo che le «indispensabili esigenze vita», in presenza delle
quali il giudice può autorizzare l’imputato «ad assentarsi nel corso della
giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario» a
provvedervi (art. 254-quater, comma 2, del previgente c.p.p.), comprendessero
per il credente anche «la partecipazione alle celebrazioni del culto cattolico».
Nell’ordinanza si rilevava, inoltre, che alla persona sottoposta al regime degli
arresti domiciliari non può riservarsi un trattamento deteriore rispetto a quello
assicurato agli imputati detenuti dall’ordinamento penitenziario[64]. Qualche
anno dopo, tuttavia, il Tribunale di Milano ha rigettato un’istanza dello stesso
tenore, ritenendo che, data l’impossibilità per l’imputato di presenziare alla
funzione religiosa in conseguenza del suo status detentionis, per l’osservanza del
precetto cattolico alla messa domenicale potesse essere equiparata quella
trasmessa dai servizi radiotelevisivi[65].
Quest’ultimo orientamento, da alcuni criticato sotto il profilo delle valutazioni
operate dal giudice in ordine al grado di vincolatività degli obblighi
canonici[66], pone ad ogni modo interrogativi più ampi sui limiti entro cui le
autorità giudiziarie (e le istituzioni penitenziarie) possono sindacare la sincerità
delle convinzioni religiose di chi, essendo in regime di detenzione, avanzi delle
richieste in materia religiosa[67].
Le difficoltà anche operative di fronte alle quali, in conseguenza del silenzio
normativo, l’amministrazione penitenziaria e i giudici possono trovarsi in tali
ipotesi emergono da una più recente pronuncia della Corte di Cassazione, con
cui si è stabilito che «incorre nel reato di evasione dal regime degli arresti
domiciliari il soggetto sottoposto a tale regime che si allontana dal suo domicilio
per partecipare ad una funzione religiosa al di fuori dei termini e senza il
rispetto delle modalità fissate dall’autorità giudiziarie»[68]. La pronuncia è
scaturita dal caso di un Testimone di Geova che, pur avendo la facoltà di
assentarsi ogni prima domenica del mese dal domicilio fissato per partecipare
con scorta ai riti liturgici presso una Sala del Regno, dopo aver sollecitato la
messa a disposizione della scorta da parte dei carabinieri, durante la seconda
domenica del mese si era comunque allontanato dal proprio domicilio senza
scorta.
L’esigenza di tutelare il diritto di libertà religiosa si pone, infine, anche nei
confronti degli imputati e dei condannati ricoverati presso le comunità
terapeutiche per tossicodipendenti e alcolisti. In tali ipotesi è necessario
distinguere a seconda che la comunità terapeutica si ponga come “agnostica”
rispetto al fenomeno religioso ovvero si caratterizzi per un orientamento di tipo
religioso: nel primo caso occorre individuare le modalità necessarie ad
assicurare l’effettivo esercizio di quei diritti; nel secondo, invece, «si pone il
problema, speculare, di garantire la libertà religiosa e di coscienza di chi, pur
ricorrendo alle prestazioni offerte dalla comunità, non intende partecipare alle
(eventuali) pratiche di culto, o religiose in senso più ampio»[69].
4. Osservazioni conclusive: eguaglianza, laicità e principio “antimaggioritario” nella garanzia dei diritti di libertà religiosa dei
detenuti
Dalla disamina delle problematiche concernenti la garanzia dei diritti di libertà
religiosa dei detenuti emerge un dato interessante: su di essi il carcere oggi
riflette un’immagine caleidoscopica, che se per un verso è lo specchio dei
numerosi cambiamenti avvenuti nella società italiana, per l’altro verso
interroga l’ordinamento penitenziario (e più in generale le istituzioni pubbliche)
su vecchie e nuove questioni.
L’immagine riflessa dal carcere, peraltro, può ritenersi caleidoscopica in un
duplice senso. È tale, in primo luogo, perché all’interno degli istituti di pena si va
sempre più delineando un pluralismo religioso e culturale, che si esprime
attraverso multiformi istanze di tutela. In maniera speculare, l’immagine è
caleidoscopica nel senso che a garanzia dei diritti in questione negli anni si è
andato formando un universo normativo eccessivamente frastagliato e
differenziato. E un così alto livello di stratificazione del quadro normativo,
anziché essere reale strumento di salvaguardia del pluralismo religioso, è
divenuto piuttosto il segno di un diritto insostenibilmente diseguale.
L’insostenibilità di un’eccessiva differenziazione nella tutela della libertà
religiosa dei detenuti deriva, come si è potuto constatare, da molteplici fattori:
dalla posizione privilegiata che all’interno delle strutture segreganti è tuttora
riconosciuta alla Chiesa cattolica; dal discrimen tra confessioni religiose munite
di intesa con lo Stato e confessioni che ne sono sprovviste; dal conseguente
divario nel grado di attuazione dei diritti costituzionali dei detenuti, in
conseguenza della religione da essi professata. In questo quadro, l’immigrazione
non ha fatto altro che mettere a nudo le carenze di un impianto normativo da
tempo superato, moltiplicando e amplificando fattori di squilibrio noti da
tempo.
I molteplici nodi problematici che l’ordinamento penitenziario mostra in tale
ambito sembrano dipendere da una scelta di fondo del legislatore che, spesso
attenuando la piena espansione all’interno delle carceri dei principi
costituzionali di eguaglianza e laicità, ha finito per penalizzare i diritti dei
detenuti. Soprattutto la disciplina (legislativa e regolamentare) concernente
l’assistenza spirituale e l’accesso al carcere dei ministri di culto tradisce, invero,
una prospettiva prevalentemente “istituzionale”: ad esser prese in
considerazione sono, cioè, più le esigenze delle confessioni religiose che non
invece quelle dei detenuti. Si ha, difatti, l’impressione che «l’attuale sistema
regolament[i] non tanto un diritto fondamentale del detenuto o della detenuta,
quanto più la possibilità data alle chiese di accedere alle carceri, in varie forme.
L’attenzione è insomma spostata sui ministri delle diverse chiese, su un “potere”
delle chiese, visto che, come per l’accesso alle cure mediche, anche l’esercizio del
diritto ad una vita spirituale piena passa per una visita di un pastore o di un
sacerdote. Insomma, la centralità non è di chi è in detenzione, ma delle chiese
ed il sospetto che a queste ultime non dispiaccia è più che fondato»[70].
È come se finora il legislatore si fosse interessato di questi temi con lo sguardo
rivolto agli articoli 7 e 8 della Costituzione più che agli articoli 2, 3 e 19 del testo
costituzionale. A ciò si aggiunga che per i profili appena ricordati (e, a maggior
ragione, per quelli non ancora o non sufficientemente regolati) molto – forse
troppo - è lasciato, «all’arbitrio dei funzionari dello Stato, si tratti di personale
dell’amministrazione o di magistrati e questo, inevitabilmente, mina un diritto
che la Costituzione sancisce come fondamentale»[71]. Si ha, così, la tendenza a
dimenticare che «il diritto di sviluppare la propria personalità deve essere
particolarmente garantito quando si viene a fare parte di una formazione
sociale contro la propria volontà. La partecipazione coatta costituisce, infatti, di
per sé una limitazione ai diritti di libertà del soggetto, che deve essere in qualche
modo controbilanciata assicurando il pieno riconoscimento di tutti quei diritti
costituzionali – in particolare modo quelli discendenti dall’art. 2 – non
incompatibili con il carattere necessario dell’appartenenza all’entità
superindividuale»[72].
La Corte costituzionale ha, d’altronde, in più occasioni sottolineato che è
«principio di civiltà giuridica che al condannato sia riconosciuta la titolarità di
situazioni soggettive attive, e garantita quella parte di personalità umana, che la
pena non intacca»[73]; ciò perché «[c]hi si trova in stato di detenzione, pur
privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo,
che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può
espandersi la sua personalità individuale»[74]. Occorre, pertanto, rimuovere
dal campo quel pregiudizio, «che in nome della primazia delle esigenze di
“sicurezza” postula di fatto una irrazionale limitazione dei diritti dei
detenuti»[75], soprattutto quando – come si è avuto modo di registrare nel caso
della libertà religiosa - la restrizione ovvero la non effettiva tutela di essi siano il
frutto di diseguaglianze prive di valido fondamento.
Le disparità emerse finora non possono, difatti, trovare alcuna giustificazione
nell’argomento maggioritario, un argomento che non può essere speso né sotto
il profilo meramente sociologico, né soprattutto sotto quello dei principi
costituzionali. La disciplina di favore per la presenza in carcere della religione
cattolica e per l’assistenza spirituale ai detenuti di tale fede è stata, difatti, spesso
difesa attraverso il richiamo al mero fattore storico-numerico, venendo negli
anni emendata solo in minima parte. Si è, ad esempio, osservato che «[l]a
situazione di privilegio sostanzialmente accordata al culto cattolico, la
celebrazione dei cui riti è assicurata negli istituti di prevenzione e pena, allo
stato attuale, può essere ritenuta non in contrasto con il principio costituzionale
di eguale libertà per tutte le confessioni, poiché trae origine non da un
particolare favore per il Credo della religione cattolica, ma dalla considerazione
di indiscutibili situazioni di fatto quali la preponderanza numerica,
statisticamente rilevabile, dei detenuti che intendano praticare i riti del culto
cattolico, la non facile disponibilità o reperibilità di culti scarsamente presenti
nel nostro paese»[76]. Analoghe considerazioni sono state, inoltre, portate a
sostegno anche di quelle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, che
all’interno degli istituti di detenzione prevedono la presenza stabile del solo
cappellano[77].
A questo proposito, si potrebbe facilmente rispondere che i cambiamenti storicosociali degli ultimi anni hanno reso tali argomenti non più sostenibili: un
pluralismo religioso sempre più accentuato si è ormai riversato anche sugli
istituti penitenziari, tanto che in alcuni casi i detenuti di fede cattolica neppure
costituiscono più la maggioranza. E tuttavia, al di là del dato storico-sociale,
l’argomento numerico non può essere impiegato innanzitutto per il vulnus che
ne conseguirebbe al principio di laicità, a quello di eguaglianza e alla libertà
religiosa dei detenuti[78]. A supporto di ciò basti solo ricordare quanto la Corte
costituzionale ha affermato in materia di tutela penale del sentimento religioso:
il criterio maggioritario non può più costituire la strada per salvare le
disposizioni che nel nostro ordinamento ancora riservano alla religione cattolica
un trattamento di maggior favore[79].
Mutatis mutandis, quel dovere di «equidistanza e imparzialità della legislazione
rispetto a tutte le confessioni religiose»[80], che nella giurisprudenza
costituzionale si è imposto come precipitato del principio costituzionale di
laicità, tanto più deve ritenersi condizione indispensabile per garantire l’effettivo
ed eguale esercizio della libertà religiosa (anche negativa) quanto più questa
libertà sia invocata all’interno di istituzioni totali.
Anche per l’ordinamento penitenziario i tempi sono d’altronde maturi, perché si
affrontino senza infingimenti le sfide che la diversità religiosa e culturale pone
alle istituzioni penitenziarie[81], senza tuttavia farsi abbagliare né dalle sirene
del «multiculturalismo irenico»[82] né da quelle della laicità c.d. “positiva”[83].
Tra eguaglianza e diversità occorre, infatti, cercare un nuovo equilibrio
costituzionalmente orientato, nella consapevolezza che esso non si dà una volta
per tutte, ma «va costruito in presa diretta con i problemi pratici, che la società
multiculturale pone incessantemente in termini di novità»[84].
E dal momento che anche in ambito penitenziario il progressivo diversificarsi
delle istanze in materia religiosa ha messo in luce una difficoltà «a venire
incontro a nuove esigenze e ad allontanarsi dai binari consolidati delle forme
organizzative riservate alle confessioni religiose»[85], si ripropone con urgenza
la necessità di giungere all’approvazione di un serio e meditato testo di legge
sulla libertà religiosa[86]. Questo passo potrebbe, invero, contribuire a
semplificare un quadro normativo che, nella tutela e nell’implementazione dei
diritti di libertà religiosa dei detenuti, è ancora irrazionalmente differenziato, in
ragione di rapporti di forza squilibrati[87]. Si potrebbe in tal modo scongiurare
il rischio che il grado di tutela di quei diritti sia di fatto lasciato allo
spontaneismo o al paternalismo delle singole strutture penitenziarie[88]. La
discussione e l’approvazione di una legge sulla libertà religiosa potrebbe, inoltre,
essere la sede per interrogarsi sullo spazio attribuibile al fattore religioso
all’interno delle carceri, anche al fine di capire se, di fronte al pluralismo
crescente di tali luoghi, l’avveramento del principio di laicità sia maggiormente
assicurato da una neutralità dell’ordinamento penitenziario del tutto cieca alle
differenze oppure sensibile a esse.
[1] F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell’idea, I, Torino, Fratelli Bocca
Editori, 1901, 12.
[2] Cfr. E. Goffman, Asylums. Essays on the social situation of mental patients
and other inmates (1961), trad. it., Le istituzioni totali: i meccanismi
dell’esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 2003, 212: «Quando un
individuo contribuisce cooperativamente ad un’attività richiesta da una
organizzazione, in determinate condizioni - con l’appoggio, nella nostra società,
di modelli di assistenza istituzionalizzati, lo stimolo di incentivi e valori comuni,
la minaccia di penalità designate - ne diventa un collaboratore; ne diventa cioè
il membro “normale” “programmato” o “determinato”. Dà e prende in modo
appropriato ciò che è stato sistematicamente progettato, sia che la cosa
comporti, da parte sua, un coinvolgimento notevole o minimo. In breve, gli
viene ufficialmente richiesto di essere né più né meno di ciò che è preparato ad
essere, ed è obbligato a vivere in un mondo che gli è, di fatto, congeniale. In
questo caso dirò che l’individuo ha un adattamento primario all’organizzazione,
tralasciando il fatto che sarebbe altrettanto ragionevole parlare
dell’adattamento primario che l’organizzazione assume nei suoi confronti. Ho
usato questo termine impreciso per ottenerne un altro, quello cioè degli
“adattamenti secondari”, che definisco come adattamenti abituali, per mezzo
dei quali un membro di un’organizzazione usa mezzi od ottiene fini non
autorizzati, oppure usa ed ottiene entrambi, sfuggendo a ciò che
l’organizzazione presume dovrebbe fare ed ottenere, quindi a ciò che dovrebbe
essere. Gli adattamenti secondari rappresentano il modo in cui l’individuo riesce
ad evitare il ruolo e il sé che l’istituzione ha presi per garantiti per lui» (corsivi
dell’A.).
[3] Su tali “adattamenti” vedi, ad esempio, lo studio di M.K. Rhazzali, L’Islam
in carcere. L’esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane,
Milano, Franco Angeli, 2010.
[4] L’influenza della dottrina e della Chiesa cattolica sul sistema carcerario va,
peraltro, ben oltre l’assistenza spirituale ai detenuti, potendo rinvenirsi nell’uso
stesso della reclusione a fini punitivi e rieducativi: cfr. M. Ruotolo, Diritti dei
detenuti e Costituzione, Torino, Giappichelli, 2002, 102 ss. e, in termini più
ampi, M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975), trad. it.,
Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1993, 154 ss. Per
l’influsso della dottrina cattolica sulle discussioni dell’Assemblea costituente in
merito al significato da attribuire alla pena vedi E. Fassone, La pena detentiva
in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Bologna, il Mulino, 75 ss.
[5] In Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, 1891, vol. 2,
1431 ss.
[6] Cfr. F. Ruffini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo (1924),
Bologna, il Mulino, 1992, 359 ss.; A.C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli
ultimi cento anni, Torino, Einaudi, 1965, 161 ss.; P. Scoppola, Laicismo e
anticlericalismo, in Aa. Vv., Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità (18611878), Atti del quarto Convegno di storia della Chiesa (La Mendola, 1971), II,
Milano, Vita e pensiero, 1973, 225 ss.; G. Spadolini, Per una storia
dell’anticlericalismo, in Id., I repubblicani dopo l’Unità, Firenze, Le Monnier,
1980, 153.
[7]
Cfr.
A.
Salvati,
L’assistenza
religiosa
in
carcere,
in
http://amministrazioneincammino.luiss.it/wp
content/uploads/2010/04/Salvati_Assistenza religiosa2.pdf, 4: «Al cappellano
si affidò il ruolo di rappresentante di una religione intesa al servizio dello Stato e
finalizzata alla rieducazione, al controllo e all’attenuazione delle tendenze
antisociali dei detenuti, ed utile strumento al miglioramento del loro carattere e
della loro moralità».
[8] «Il condannato che al suo ingresso in uno Stabilimento o Sezione penale,
abbia dichiarato di appartenere ad una confessione religiosa dello Stato, deve
seguirne le pratiche comuni collettive».
[9] Per analoghi dubbi di costituzionalità concernenti le disposizioni normative
sulla presenza in carcere del cappellano e di luoghi di culto cattolici vedi infra, §
2.
[10] Corte costituzionale, sentenza n. 72 del 1968. Cfr. V. Onida, Sulla
«disapplicazione» dei regolamenti incostituzionali (a proposito della libertà
religiosa dei detenuti), in Giurisprudenza costituzionale, 1968, 1032; M. Seitz
Ursino, La libertà religiosa e la posizione giuridica dei detenuti, in Diritto
ecclesiastico, 1967, II, 369; Ead., Regolamenti anteriori alla Costituzione e
riserva di legge (a proposito della libertà religiosa dei detenuti), in Studi in
memoria di Orazio Condorelli, III, Milano, Giuffrè, 1974, 1221.
[11] Il testo della circolare può leggersi in Diritto ecclesiastico, 1970, II, 214.
[12] «I minori degli anni ventuno devono seguire la religione nella quale sono
nati».
[13] La necessità di rispettare la libertà religiosa e di coscienza dei detenuti era
stata, infatti, nel frattempo espressamente sancita dalle Regole minime per il
trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite, adottate il 30 agosto 1955 con
risoluzione del Primo Congresso per la prevenzione del crimine e il trattamento
dei delinquenti e dalle Regole minime per il trattamento dei detenuti, adottate il
19 gennaio 1973 con la Risoluzione R73(5) del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa. Queste ultime sono state poi aggiornate dalla
Raccomandazione R(87)3 del 12 febbraio 1987 sulle Regole penitenziarie
europee e, infine, dalla Raccomandazione R(2006)2 dell’11 gennaio 2006.
[14] Art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 431/1976, recante il primo regolamento di
esecuzione della legge n. 354/1975: «I detenuti e gli internati possono
liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa».
[15] Il testo originario dell’art. 26, comma 4, l. n. 354/1975, per gli appartenenti
ad altre confessioni religiose prevedeva la mera “facoltà” di ricevere, dietro
apposita richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i
relativi riti. Successivamente, la legge n. 663 del 1986 ha sostituito la parola
“facoltà” con “diritto”.
[16] Vedi anche l’art. 11, comma 2, della legge n. 121 del 1985 (Ratifica ed
esecuzione del c.d. Nuovo Concordato con la Chiesa cattolica): «L’assistenza
spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità
italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato
giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa tra tali autorità».
[17] Sul punto si segnala ora Cass. Pen., sez. I, sentenza 25 maggio 2011, n.
20979,
rinvenibile
in
www.olir.it/documenti/index.php?
argomento=24&documento=5814. Sulla base dell’art. 26, comma 4, l. n.
354/1975, la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il
magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva respinto il reclamo di un detenuto
sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis della legge stessa. Il
reclamo era stato presentato contro il provvedimento con cui l’amministrazione
penitenziaria aveva rigettato l’istanza del detenuto, intesa ad ottenere
l’autorizzazione ad incontrare in via permanente un ministro del culto dei
Testimoni di Geova per lo studio della Bibbia. I giudici della Suprema Corte
hanno stabilito che «in linea di massima, non pare possibile negare ad un
credente ed a maggior ragione ad un Testimone di Geova, per il quale è
importante lo studio della Bibbia, almeno una qualche forma di approccio con il
ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici,
ferma restando l’esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da
assicurare l’ordine e la sicurezza dell’istituto carcerario».
Vedi inoltre Cass. Pen., Sez. I, sentenza 7 ottobre 2013, n. 41474, rinvenibile in
www.penalecontemporaneo.it/upload/1389709623Cass.pdf. Con tale pronuncia
la Suprema Corte ha affermato che la mera comunicazione, a un detenuto
sottoposto al regime detentivo del 41 bis, della relazione dell’amministrazione
penitenziaria in merito alla non inclusione di maestri buddisti Zen nel novero
dei ministri di culto abilitati all’ingresso nelle strutture penitenziarie e di una
precedente ordinanza dello stesso magistrato, pronunciata su reclamo di altro
detenuto in tema di somministrazione del vitto, «non può costituire, in effetti,
“valida risposta sia sul piano procedimentale sia sul piano del contenuto”».
[18] E. Fassone, Religione e istruzione nel quadro del trattamento, in V. Grevi
(a cura di), Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, Zanichelli,
130.
[19] Cfr. L. Stortoni, «Libertà» e «diritti» del detenuto nel nuovo ordinamento
carcerario, in F. Bricola (a cura di), Il carcere “riformato”, Bologna, il Mulino,
1977, 43.
[20] S. Zambelli, La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere, in
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2/2001, 473 (corsivi dell’A.).
[21] La circolare del Ministero della Giustizia del 25 maggio 2001, n. 3553-6003
(Attività dei cappellani) specifica nondimeno che, poiché la positiva valutazione
della religione quale fattore di relazione interpersonale non deve andare
disgiunta dal rispetto della libertà del detenuto nella scelta religiosa, «[…]
l’adesione o non adesione del detenuto alle pratiche religiose, così come i
comportamenti del medesimo aventi riferimento alla dimensione religiosa e
all’esperienza del sacro, non possono, in quanto tali, essere oggetto di
valutazione favorevole o negativa. In secondo luogo, fermo quanto previsto dal
citato art. 15 O.P., appare improprio l’inserimento dell’attività religiosa
all’interno dell’area specificamente “trattamentale” a fini amministrativi, non
potendo l’esperienza religiosa essere assimilata a uno dei “trattamenti” offerti al
detenuto dall’Amministrazione penitenziaria. La terza conseguenza consiste nel
fatto che i cappellani (come, del resto, i ministri degli altri culti eventualmente
operanti all’interno degli istituti) non debbono essere chiamati, in nessuna sede
e a nessun fine, ad esprimere valutazioni desunte dall’eventuale adesione dei
detenuti alle pratiche religiose».
[22] È, dunque, venuto meno il limite più generico (e maggiormente
suscettibile di valutazioni discrezionali), previsto dal precedente regolamento di
esecuzione (d.P.R. n. 431 del 1976). All’art. 55 il regolamento del 1976 stabiliva,
infatti, che i detenuti potevano praticare il culto della propria professione
religiosa, purché non si fosse trattato di riti pregiudizievoli all’ordine e alla
disciplina dell’istituto.
[23] Si veda, in particolare, L’assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al
culto negli istituti di pena del Lazio, Rapporto di ricerca realizzato nel 2012
dall’Università di Tor Vergata di Roma con il contributo del Garante regionale
dei diritti dei detenuti della Regione Lazio. Il Rapporto è rinvenibile all’indirizzo
http://csps.uniroma2.it/wp
content/uploads/2012/10/Report
Lassistenza
religiosa in carcere CSPS.pdf.
[24] Sul punto, basti ricordare quanto rilevato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo (Sulejmanovic c. Italia, sentenza 16 luglio 2009; Torreggiani c.
Italia, sentenza 8 gennaio del 2013) e dalla Corte costituzionale (sentenza n.
279 del 2013), nonché da ultimo i dati riportati da A. Scandurra, La promozione
con riserva ed i numeri del carcere, in Oltre i tre metri quadri (XI Rapporto
sulle condizioni di detenzione in Italia), Antigone. Quadrimestrale di critica del
sistema penale e penitenziario, 2/2014, 17 ss.
[25] L’assistenza religiosa in carcere, cit., 24.
[26] I cappellani sono, infatti, stabilmente inseriti nell’amministrazione
penitenziaria come personale aggregato - sulla base di una scelta che risale,
peraltro, al R.D.L. n. 1758 del 1924 (art. 3, comma 1) - e sono legati
all’amministrazione penitenziaria da un rapporto di servizio di diritto speciale:
cfr. N. Colaianni, La riforma dell’ordinamento del personale di assistenza
religiosa nell’amministrazione penitenziaria, in Diritto ecclesiastico, 1983, I,
214 ss.; A. Valsecchi, L’assistenza religiosa nelle comunità separate, in G.
Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2015,
216. Essi sono incaricati con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il parere
dell’ispettore dei cappellani e del competente ispettore distrettuale degli istituti di
prevenzione e di pena per adulti e previo nulla osta dell’ordinario diocesano. Se
l’incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell’ispettore distrettuale è
sostituito da quello del competente direttore del centro rieducazione minorenni
(art. 4, l. n. 68 del 1982, Trattamento giuridico ed economico dei cappellani
degli istituti di prevenzione e di pena).
[27] Il trattamento economico dei cappellani è a carico dell’amministrazione
penitenziaria (artt. 15 e 16, l. n. 68/1982).
Per quanto concerne, invece, l’orario di lavoro, la circolare del Ministero della
Giustizia n. 0261208-2014 (Attività dei cappellani penitenziari – orario di
lavoro) ha da ultimo stabilito che, in considerazione delle difficoltà degli
Ordinari diocesani a individuare i sacerdoti che possano assicurare l’orario
settimanale di diciotto ore (in precedenza fissato dalla circolare del 2001 n.
3553-6003), i cappellani penitenziari non sono più tenuti ad assicurare una
presenza in istituto pari a quanto indicato dalla circolare del 2001, ma soltanto
una presenza minima di tre giorni alla settimana (inclusa la domenica). Nulla,
però, è detto in merito al conseguente trattamento economico, che rimane
sostanzialmente invariato, consistendo esso non in un’indennità calcolata sulla
base delle ore di lavoro svolte, ma in una retribuzione annuale, cui è aggiunto
un supplemento mensile.
Il venir meno delle diciotto ore di servizio minimo settimanale indebolisce,
peraltro, ulteriormente l’argomento in passato addotto a giustificazione del
trattamento economico di favore riconosciuto ai cappellani, rispetto al solo
compenso orario attribuito ai ministri di culto non cattolico (vedi infra nt. 33).
La disparità era, infatti, da alcuni spiegata in ragione del fatto che i cappellani,
«dato l’altissimo numero di cattolici ospiti di istituzioni sanitarie e
penitenziarie» sarebbero stati occupati «praticamente a tempo pieno o quasi dai
compiti di assistenza e cura», al contrario dei ministri delle confessioni di
minoranza che, dato il minor numero di detenuti da assistere, non avrebbero
invece potuto dare alla loro attività il medesimo carattere di continuità: così L.
Musselli, Le intese con le Chiese avventiste e pentecostali, in Le nuove leggi
civili commentate, 2/1990, 452; in senso analogo anche C. Cardia, Stato e
confessioni religiose: il regime pattizio, Bologna, il Mulino, 1995, 142. Come si
dirà al § 3, l’argomento trova smentita anche nel fatto che oggi la popolazione
carceraria è in misura crescente di religione musulmana o comunque non
cattolica. Alcuni istituti di pena, peraltro, ospitano una popolazione carceraria
che per oltre il 60% è composta da detenuti di fede islamica: cfr. D.A. Telesca,
L’Islam carcerato. L’identità islamica nel pianeta penitenziario, Urbino,
Quattroventi, 2008, 54.
[28] «La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve
essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati
e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’associazione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e
secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del
direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di
risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo
sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del
direttore».
[29] Sulla progressiva standardizzazione delle intese tra lo Stato e le confessioni
acattoliche - in direzione opposta al pluralismo religioso di cui esse dovrebbero
invece essere lo strumento (artt. 3, 8, comma 3, 19 Cost.) - e sulla conseguente
tendenza a stipulare accordi fotocopia che, anziché garantire le differenze tra i
movimenti religiosi, spingono i gruppi minoritari verso una forte omologazione,
si rinvia, tra i molti, a S. Berlingò, La prospettiva di un’intesa con l’Islam in
Italia, in Anuario de derecho eclesiástico del Estado, 1998, 644 ss.; A. Vitale,
Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi,
Milano, Giuffré, 2005, 243; F. Alicino, La legislazione sulla base di intese. I test
delle religioni “altre” e degli ateismi, Bari, Cacucci, 2013, 41 ss.
[30] Art. 8 , legge n. 449/1984 (Tavola valdese); art. 9, legge n. 516/1988
(Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno); art. 6, legge n.
517/1988 (Assemblee di Dio in Italia); art. 10, legge n. 101/1989 (Unione
Comunità ebraiche in Italia); art. 7, legge n. 116/1995 (Unione cristiana
evangelica battista d’Italia); art. 7, legge n. 520/1995 (Chiesa evangelica
luterana in Italia); art. 6, legge n. 126/2012 (Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia
ed Esarcato per l’Europa meridionale); art. 10, legge n. 127/2012 (Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni); art. 7, legge n. 128/2012 (Chiesa
apostolica in Italia); art. 5, legge n. 245/2012 (Unione buddhista italiana); art.
5, legge n. 246/2012 (Unione induista italiana). Analoghe modalità sono
previste dall’intesa firmata il 4 aprile 2007 dalla Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova, che tuttavia è ancora in attesa della legge di approvazione.
[31] I nominativi sono comunicati alla Direzione generale dei detenuti e del
trattamento del Dipartimento Affari penitenziari presso il Ministero della
Giustizia, che provvede a fornirli agli istituti penitenziari.
[32] In precedenza, l’art. 58, comma 6, e l’art. 116 del d.P.R. n. 230/2000
subordinavano sempre l’accesso agli istituti penitenziari dei ministri di culto
cattolico diversi dai cappellani e di quelli degli altri culti alla richiesta dei
detenuti e alla previa autorizzazione del direttore dell’istituto. Si era parlato, al
riguardo, di «amnesia giuridica», dal momento che le due disposizioni
sembravano essere state adottate come se la stagione delle intese non ci fosse
mai stata: F. Franceschi, L’assistenza spirituale ai detenuti appartenenti alle
confessioni religiose di minoranza nel nuovo regolamento penitenziario (d.P.R.
30 giugno 2000, n. 230): un caso evidente di «amnesia giuridica» da parte
dell’Amministrazione dello Stato, in Diritto ecclesiastico, 2001, II, 81.
Nondimeno, in seguito ai ricorsi della Chiesa valdese, delle Assemblee di Dio,
dell’Unione avventista e dell’Unione battista, il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez.
I, ha annullato le parti del regolamento contestate (sentenze nn. 11398, 11399,
11400 e 11401 del 2000). Il regolamento di esecuzione era, infatti, ritenuto in
contrasto con le intese stipulate da quelle confessioni, nella parte in cui esse
prevedono che i rispettivi ministri di culto abbiano accesso agli istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione e di loro iniziativa,
indipendentemente cioè da una richiesta del detenuto.
La previsione di una previa richiesta e della successiva autorizzazione del
direttore appariva discriminante non soltanto nei confronti dei ministri dei culti
acattolici muniti di intesa, ma soprattutto per quei detenuti stranieri che, non
conoscendo bene l’italiano, avrebbero potuto incontrare molte difficoltà a
districarsi nelle pieghe dei regolamenti: cfr. le osservazioni riportate in T.
Rimoldi, L’Intesa con la Chiesa avventista del 7° giorno, in www.olir.it
(Osservatorio delle libertà e delle istituzioni religiose), febbraio 2004, 15, nt. 48,
rinvenibile
all’indirizzo
www.olir.it/areetematiche/62/documents/Rimoldi_Intesaavventista.pdf.
La discriminazione nelle condizioni previste per ricevere assistenza spirituale
permane, tuttavia, per i detenuti appartenenti a confessioni religiose senza
intesa. Difatti, per l’ingresso nell’istituto penitenziario dei ministri di culto
acattolico (e di quelli cattolici diversi dai cappellani) l’art. 67, comma 4, l. n.
354/1975, tuttora prevede l’autorizzazione del direttore.
[33] Così è disposto dalle intese stipulate con la Tavola valdese, l’Unione delle
Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa
evangelica luterana in Italia, l’Unione buddhista italiana e l’Unione induista
italiana. Per le altre confessioni non cattoliche l’articolo 18 della legge n.
68/1982 stabilisce che ai ministri di culto che abbiano prestato l’assistenza
religiosa negli istituti penitenziari sia corrisposto un compenso orario, da
stabilirsi con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri
dell’Interno e del Tesoro. Il compenso è previsto soltanto per i ministri iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 55, comma 7, del d.P.R. n. 431/1976; oggi il rinvio
deve, tuttavia, intendersi riferito a quanto disposto dal già richiamato art. 58,
comma 6, del d.P.R. 230/2000, che ha abrogato e sostituito il precedente
regolamento del 1976.
[34] A. Barone, Assistenza religiosa in carcere: un diritto in cerca di nuove
tutele, in Coscienza e libertà, 48/2014, 58, rinvenibile all’indirizzo
www.aidlr.it/rivista/testi/2014 48.pdf.
[35] Sul punto vedi, tuttavia, A. Ferrari, Libertà religiosa e nuove esperienze
confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca deregulation e super specialità,
ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa, in Diritto ecclesiastico, 34/2010, 689, nt. 54: l’A. evidenzia che l’indicazione da parte del Ministero
dell’Interno, prevista dall’art. 58, è stata interpretata «nel senso che il suddetto
Ministero si limita ad esprimere il proprio nulla osta sulla base delle richieste
sottopostegli, nominativamente, dal Ministero della Giustizia. In altre parole, il
Ministero dell’interno non dispone di uno specifico “elenco” di ministri di culto
abilitati all’accesso nelle carceri, dal momento in cui con l’abrogazione del
precedente regolamento penitenziario (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) è venuta a
cadere anche la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 55 del medesimo in
virtù della quale “la direzione dell’istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli
internati, che ne facciano richiesta, l’istruzione e l’assistenza religiosa, nonché la
celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di
culto indicati nell’elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze
delle varie confessioni, dal Ministero dell’interno”. In altre parole, venuta meno
la necessità di tenere un elenco compilato con l’accordo delle rappresentanze di
quelle che sono divenute, con il tempo, confessioni pattizie, il Ministero
dell’Interno ha interpretato il suo potere di “indicazione” come nulla osta ex
post anziché come competenza preventiva, ex ante, che avrebbe potuto offrire
maggior certezza e funzionalità: ancora una volta, dunque, i gruppi religiosi
senza intesa vedono diminuire il “patrimonio” – e si potrebbe dire il “terreno”
normativo di cui dispongono, perdendo un ulteriore momento di
riconoscimento di autonomia e - di conseguenza – di bilateralità» (corsivi
dell’A.).
[36] L’assistenza religiosa in carcere, cit., 51.
[37] L’ancora vigente art. 6 del R.D. n. 289/1930 (Norme per l’attuazione della
L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento
di essa con le altre leggi dello Stato) stabilisce in senso analogo che «[i] ministri
dei culti ammessi nello Stato possono essere autorizzati a prestare l’assistenza
religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne
siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela
giuridica dei medesimi, sotto l’osservanza delle norme contenute nei
regolamenti speciali per detti istituti».
[38] Pur non sanando la suddetta disparità di trattamento tra detenuti cattolici
e detenuti di altre fedi, a tali difficoltà sembra ora voler ovviare il nuovo testo
dell’art. 69, comma 2, del d.P.R. n. 230/2000, come modificato dal d.P.R. n.
136/2002. Tale articolo, infatti, dispone ora che «[a]ll’atto dell’ingresso, a
ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei
detenuti e degli internati, contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei
detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il
contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della Giustizia da
adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta
dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e
dell’internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e
internati stranieri».
Il contenuto della “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati” è
stato fissato con il decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, che
riproduce tuttavia alcune delle disparità prima segnalate. Ai detenuti si
riconosce, infatti, «il diritto di praticare il proprio culto, di fruire dell’assistenza
spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle
cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici»; per i detenuti stranieri si
prevede, inoltre, «il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro
esigenze di vita religiosa e spirituale». Non si vede, tuttavia, perché tale diritto
non sia genericamente riferito a tutti i detenuti.
[39] Cfr. L. Musselli, Islam ed ordinamento italiano, in Diritto ecclesiastico,
1992, I, 621; S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia: la condizione giuridica
delle comunità islamiche, Bologna, il Mulino, 2000; A. Ferrari (a cura di),
Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società, Bologna, il Mulino, 2008.
[40] M. Carnì, Islam e ministri di culto, in C. Cardia, G. Dalla Torre (a cura di),
Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, Torino, Giappichelli,
2015, 212 ss.
[41] Cfr. R. Guolo, La rappresentanza dell’Islam italiano e la questione delle
intese, in S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia, cit., 67; M. Carnì, Islam e
ministri di culto, cit., 225 ss.
[42] Alle confessioni religiose senza intesa continua ad applicarsi la legislazione
sui culti ammessi, tuttora vigente. Essa dispone che le nomine dei ministri di
culto di tali confessioni siano notificate al Ministero dell’Interno per ricevere
l’approvazione governativa, in assenza della quale nessun effetto civile può
essere riconosciuto agli atti da essi compiuti (art. 3, legge n. 1159/1929). Il
ministro di culto interessato deve chiedere l’approvazione direttamente al
Ministro dell’Interno, presentando domanda alla prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo - competente per territorio (art. 20, R.D. n. 289/1930). Ciò
comporta che la qualifica di ministro di culto approvato sia necessaria soltanto
per la celebrazione di matrimoni con effetti civili (art. 7, l. n. 1159/1929) e per
gli altri atti indicati dagli artt. 3, 4, 7 e 8 del R.D. n. 289/1930 e non invece per
lo svolgimento del servizio di assistenza spirituale all’interno degli istituti
penitenziari.
A questo proposito si è, tuttavia, rilevato che se «l’amministrazione dei culti,
negli ultimi anni, ha fatto proprio un indirizzo restrittivo, strettamente tecnico
giuridico e costituzionalmente orientato, che vede nell’approvazione non già la
porta d’ingresso di uno status generale ma, più limitatamente, una misura ad
hoc, rigorosamente riservata ai soli casi specificamente previsti dalla normativa
in vigore e, dunque, essenzialmente, alla celebrazione con effetti civili dei
matrimoni in forma religiosa, diverso è l’atteggiamento di molti nuovi gruppi
religiosi. Questi, infatti, ambiscono a fruire di un’approvazione interpretata
“politicamente” alla luce delle nuove esigenze di legittimazione espresse dai
poteri pubblici, anche locali»: A. Ferrari, Libertà religiosa e nuove esperienze
confessionali (ortodossi e islamici), cit., 689.
[43] Dal documento si evince che «fanno accesso negli Istituti 9 soggetti che
rivestono la figura di Imam e sono pertanto accreditati presso il Ministero
dell’Interno, 14 mediatori culturali autorizzati ai sensi dell’art 35 R.E. e 69
assistenti volontari ai sensi degli artt. 17 e 78 O.P.»: Le Moschee negli Istituti di
Pena, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, Sezione III Analisi e monitoraggi, 2013, rinvenibile all’indirizzo
www.ristretti.it/commenti/2014/febbraio/pdf3/moschee_carceri.pdf.
Ciò
risulta senza dubbio sintomatico di una criticità, se si considera che lo stesso
documento attesta il crescente numero negli istituti penitenziari di locali adibiti
a sala preghiera o a luogo di incontri per l’esercizio del culto. Dall’ultimo
Rapporto di Antigone risultano essere ora 10 gli imam autorizzati ad entrare
nelle carceri: cfr. Oltre i tre metri quadri (XI Rapporto sulle condizioni di
detenzione in Italia), Sintesi per la stampa, rinvenibile all’indirizzo
www.osservatorioantigone.it/upload2/uploads/docs/cartella_stampa_Rapporto.pdf,
4.
[44] Cfr. Istituto Superiore di Studi Penitenziari, La radicalizzazione del
terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in
carcere,
in
Quaderni
IISP,
6/2012,
rinvenibile
www.ristretti.it/commenti/2012/luglio/pdf4/terr_islamico.pdf.
all’indirizzo
[45] Cfr. R.M. Gennaro, Religioni in carcere, in Rassegna Penitenziaria e
criminologica, 1/2008, 94 s.; L’assistenza religiosa in carcere, cit., 50.
[46] G. Rivetti, Migrazione e fenomeno religioso: problemi (opportunità) e
prospettive, in G.B. Varnier (a cura di), La coesistenza religiosa: nuova sfida
per lo stato laico, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2008, 115.
[47] Secondo l’ultimo Rapporto dell’associazione Antigone, al 31 dicembre del
2014 la percentuale di stranieri nelle carceri italiane è del 32% del totale, con un
incremento significativo registrato successivamente all’entrata in vigore del
Testo unico sull’immigrazione (d. lgs. n. 286/1998), della legge n. 189/2002
(c.d. Bossi Fini) e delle leggi nn. 125/2008 e 94/2009 (c.d. pacchetti sicurezza):
tutti provvedimenti che hanno visto «l’affermarsi progressivo di una selezione
etnica della pena», con l’introduzione di specifiche fattispecie delittuose
connesse all’immigrazione: P. Gonnella, Detenuti stranieri in Italia. Norme,
numeri e diritti, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, 16.
[48] Al riguardo sia consentito il rinvio a E. Olivito, Giudici e legislatori di
fronte alla multiculturalità, in M. Cavino, C. Tripodina (a cura di), La tutela dei
diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, Milano,
Giuffré, 2012, 149.
[49] Halāl e kosher indicano ciò che è puro e, quindi, consentito, in
contrapposizione a ciò che è impuro e perciò vietato (rispettivamente haram e
taref): cfr. P. Lerner, A.M. Rabello, Il divieto di macellazione rituale (shechità
kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze, Trento, Università degli
Studi di Trento, 2010. L’art. 7, comma 2, della legge n. 101 del 1989 (che
recepisce l’intesa tra lo Stato italiano e l’Unione delle Comunità ebraiche
italiane) espressamente riconosce agli ebrei che si trovino negli istituti di
prevenzione e pena «il diritto di osservare, a loro richiesta e con l’assistenza
della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare
senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano». Analogamente, l’art. 5,
comma 4, dell’intesa con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova,
non ancora approvata con legge, riconosce ai testimoni di Geova detenuti negli
istituti penitenziari «il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della
propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si
trovano».
[50] S. Angeletti, Le attività delle comunità islamiche a livello locale. Alcune
considerazioni alla luce dei risultati della ricerca, in C. Cardia, G. Dalla Torre (a
cura di), Comunità islamiche in Italia, cit., 162.
[51] Sul rapporto tra cibo e religione in altre confessioni religiose vedi A.G.
Chizzoniti, M. Tallacchin (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, Quaderni
del Dipartimento di scienze giuridiche, Tricase (Le), Libellula, 2010.
[52] Cfr. P. Gonnella, Detenuti stranieri in Italia, cit., 46.
[53] Art. 9, comma 7, l. n. 354/1975: «Ai detenuti e agli internati è consentito
l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati
dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere
affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria o
da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale.
I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo
in cui è sito l’istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma,
integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’istituto,
controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’istituto».
[54] D. Galano, Il convento non passa altro, in Oltre i tre metri quadri (XI
Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia), cit., 72.
[55] Art. 25: «L’Amministrazione deve, in conformità alle norme stabilite in
materia dalle autorità sanitarie, fornire ai detenuti, negli orari abituali,
un’alimentazione convenientemente preparata e presentata, rispondente in
quantità e qualità alle regole della dietetica e dell’igiene moderna, e che tenga
conto della loro età, della loro salute, della natura del loro lavoro e, nella misura
del possibile, delle esigenze religiose e culturali. L’acqua potabile deve essere
disponibile per ogni detenuto». Non diversamente dispone, l’art. 42 delle Regole
minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite (Ris. O.N.U. del 30
agosto 1955), sebbene esso si riferisca più genericamente alle esigenze religiose
dei detenuti: «Ogni detenuto deve essere autorizzato, nei limiti del possibile, a
soddisfare alle esigenze della sua vita religiosa, partecipando ai servizi
organizzati nello stabilimento e tenendo in suo possesso libri di edificazione e di
istruzione religiosa della sua confessione».
[56] Al riguardo, si veda la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Jakóbski v. Poland del 7 dicembre 2010. In questa pronuncia i giudici di
Strasburgo, richiamando espressamente l’art. 22 delle Regole penitenziarie
europee (nonostante la loro natura di atto non vincolante), hanno
all’unanimità riconosciuto una violazione dell’art. 9 della CEDU in un caso
concernente le richieste alimentari avanzate da un detenuto buddhista. Le
autorità penitenziarie polacche avevano, infatti, rigettato l’istanza di un
detenuto, che chiedeva di seguire un regime privo di carne in osservanza delle
prescrizioni alimentari buddhiste Mahayana. La Corte ha accolto il ricorso del
detenuto, affermando che, se da un lato è vero che la decisione di prendere
accorgimenti speciali per un solo detenuto può avere conseguenze finanziarie
sull’intero sistema, incidendo indirettamente sulla qualità del trattamento degli
altri detenuti, si deve valutare se lo Stato ha raggiunto un giusto equilibrio tra
gli interessi dell’istituto penitenziario, quelli degli altri detenuti e gli interessi
particolari del richiedente.
In Jakóbski v. Poland la Corte europea ha, nondimeno, evidenziato che il
ricorrente si era limitato a chiedere una dieta vegetariana. Ciò non implicava,
dunque, che i piatti fossero preparati, cucinati o serviti secondo modalità
prescritte, né che fossero utilizzati prodotti speciali. In passato, due casi
riguardanti richieste alimentari di quest’ultimo tipo erano, invece, pervenuti
davanti alla Commissione europea dei diritti dell’uomo. Entrambi i ricorsi erano
stati promossi da detenuti di religione ebraica, che avevano chiesto di seguire un
regime alimentare a base di cibo kosher, preparato, cucinato e servito secondo
le modalità prescritte dalla religione ebraica. Il primo ricorso fu, tuttavia,
dichiarato inammissibile, perché per la Commissione le autorità penitenziarie
inglesi avevano fatto tutto il possibile per rispettare le convinzioni religiose del
ricorrente (X v. United Kingdom, decisione del 5 marzo 1976). Il secondo
ricorso fu, invece, dichiarato inammissibile per mancato previo esaurimento
delle vie interne (D. and E.S. v. United Kingdom, decisione del 7 marzo 1990).
[57] In questa direzione si era, peraltro, già mosso, seppure in termini non
vincolanti,
il
“Documento
programmatico
relativo
alla
politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 20042006”, approvato con d.P.R. del 13 maggio 2005 ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n.
286/1998. Al punto 2.18 si leggeva, infatti, che «[l]’ordinamento penitenziario
consente a tutti i detenuti la libertà di professare, di praticare e di istruirsi nella
propria fede religiosa. Alle libertà sopra individuate e ai correlativi diritti dei
detenuti, si rapporta un dovere dell’Amministrazione di predisporre gli
strumenti per renderne operativo l’esercizio. […] Per le religioni per le quali lo
Stato italiano non ha stipulato apposite convenzioni, come nel caso della
religione islamica, sono […] riconosciuti ai detenuti il diritto alla pratica e
professione della propria fede religiosa (in particolare, ai musulmani è garantito
il diritto al vitto e il diritto di consumare i pasti dopo il tramonto nel periodo del
Ramadan) e sono allestite ove possibile apposite sale per la preghiera islamica».
[…] «Per quanto riguarda i precetti legati all’alimentazione, nelle tabelle
vittuarie da adottare negli Istituti Penali per Minorenni, elaborate dall’Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, sono previste delle
specifiche variazioni di menù, per rispondere alle prescrizione alimentari legate
all’appartenenza religiosa dell’utenza detenuta» (punto 2.19).
[58] Art. 97, comma 1: «Gli imputati devono poter indossare i propri indumenti
personali qualora l’abbigliamento sia adatto al carcere».
[59] Cfr. R. Santoro, I simboli religiosi nell’ordinamento penitenziario italiano,
in www.statoechiese.it, dicembre 2010, 7. La questione potrebbe, peraltro, porsi
anche rispetto a prescrizioni religiose che attengono al corpo. Un caso del
genere fu, ad esempio, deciso dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo
(X. v. Austria, decisione del 15 febbraio 1965), che fece appello alla necessità del
personale penitenziario di poter identificare i detenuti dell’istituto. Per questa
ragione la Commissione dichiarò inammissibile il ricorso di un detenuto
buddhista, il quale sosteneva che, essendogli stata negata la possibilità di
crescersi la barba e di avere una collana per la preghiera (prayer chain), non
aveva potuto esercitare la sua religione. In senso diverso (e in un contesto
differente) si veda, invece, una recente decisione della Corte Suprema degli Stati
Uniti [Holt v. Hobbs, 574 U. S. ____ (2015)], in cui i giudici statunitensi
hanno stabilito all’unanimità (e con le concurring opinions delle giudici
Ginsburg e Sotomayor) che la politica penitenziaria dell’Arkansas, impedendo a
un detenuto di fede islamica di lasciarsi crescere la barba in deroga al
regolamento penitenziario, violava il Religious Land Use and Institutionalized
Persons Act (RLUIPA). Per osservazioni critiche sulle argomentazioni della
pronuncia vedi V. Fiorillo, La sentenza della Corte Suprema USA Holt v.
Hobbs:
l’esenzione
cresce
con
la barba del
condannato,
in
www.diritticomparati.it (16 febbraio 2015).
[60] Tali centri furono introdotti dal Testo unico sull’immigrazione (d. lgs. n.
286/1998) come Centri di permanenza temporanea (CPT). Essi furono
successivamente denominati Centri di permanenza temporanea ed assistenza
(CPTA) dall’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999 e, infine, Centri di identificazione ed
espulsione (CIE) dall’art. 9 del d.l. n. 92/2008, come convertito dalla legge n.
125/2008. Quest’ultimo articolo ha sostituito, in tutte le disposizioni di legge o
di regolamento, le parole: “centro di permanenza temporanea” ovvero “centro
di permanenza temporanea ed assistenza” con “centro di identificazione ed
espulsione”. Sull’evoluzione della normativa italiana in materia di trattenimento
dello straniero in strutture detentive vedi G. Bascherini, A proposito delle più
recenti riforme in materia di trattenimento dello straniero nei centri di
identificazione ed espulsione, in www.rivistaaic.it, fascicolo 1/2012, 1 ss.
[61] A.G. Chizzoniti, E. Vitali, Diritto ecclesiastico: manuale breve, Milano,
Giuffré, 2015, 193.
[62] Cfr. P. Consorti, Pacchetto sicurezza
www.statoechiese.it, febbraio 2011, 13 ss.
e
fattore
religioso,
in
[63] Cfr. E.V. Petralla, R.S. Ficco, D. Lobascio, Oltre il carcere: prospettive
dell’esecuzione penale esterna, in Democrazia e diritto, 2/2014, 156 ss.
[64] Tribunale di Pisa, ordinanza del 13 novembre 1984, in Diritto ecclesiastico,
1985, II, 584 ss., con un commento di V. Turchi, Arresti domiciliari e assistenza
spirituale, cui si rinvia per le implicazioni di diritto canonico concernenti la
doverosità della partecipazione ai riti, ai sacramenti e alle pratiche liturgiche
della religione cattolica per il credente che si trovi in stato di detenzione (ivi, 591
ss.).
[65] Tribunale di Milano, ordinanza del 19 agosto 1986, in Diritto ecclesiastico,
1988, II, 288, con un commento di V. Turchi, Ancora in tema di arresti
domiciliari e assistenza spirituale. Appunti su “misure alternative alla
carcerazione e libertà religiosa”, ibidem. Vedi, inoltre, l’analoga ordinanza di
rigetto del 24 luglio 1987, Corte d’Appello di Firenze, ivi, 289.
[66] V. Turchi, Misure alternative alla pena detentiva: la garanzia della libertà
religiosa, in Iustitia, 2/1989, 157 s.
[67] Cfr. V. Turchi, op. ult. cit., 160. L’Autore evidenzia, nondimeno, che la
persona sottoposta agli arresti domiciliari, «in mancanza di specifiche esigenze
cautelari contrarie, può sempre fruire dell’assistenza spirituale che i membri
della propria confessione intendono offrirgli nel luogo di arresto» (ibidem).
[68] Cass. Pen, sez. VI, sentenza 21 gennaio 2009, n. 2735, in Diritto
ecclesiastico, 3-4/2009, II, 774.
[69] V. Turchi, op. ult. cit., 167.
[70] F. Sciotto, Il carcere è un luogo di pluralismo religioso?, in Oltre i tre
metri quadri (XI Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia), cit., 80.
[71] Ibidem.
[72] G. Neppi Modona, Formazione sociale carceraria e democrazia
partecipativa, in Politica del diritto, 2/1976, 174-175. In senso analogo vedi
anche V. Onida, Sulla «disapplicazione» dei regolamenti incostituzionali (a
proposito della libertà religiosa dei detenuti, cit., 1046: «lo stato di detenzione,
se comporta ovviamente una restrizione della libertà personale (anzi a questo è
precisamente inteso) e per questo delle libertà a questa connesse o da queste in
qualche modo dipendenti (coma la libertà di circolazione o quella di riunione);
se può comportare limitazioni ad aspetti strumentali delle libertà connesse alla
manifestazione del proprio pensiero (come l’uso di determinati mezzi di
diffusione), non può però in alcun modo incidere su quegli aspetti della libertà
che concernono l’atteggiarsi della coscienza individuale e delle sue
manifestazioni […]».
[73] Corte costituzionale, sentenza n. 114/1979, punto 4 del Considerato in
diritto.
[74] Corte costituzionale, sentenza n. 349/1993, punto 4.2 del Considerato in
diritto.
[75] M. Ruotolo, Dignità e carcere, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, 55. La
Corte costituzionale ha, del resto, chiaramente affermato che l’idea secondo cui
la restrizione della libertà personale può «comportare conseguenzialmente il
disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato
assoggettamento all’organizzazione penitenziaria è estranea al vigente
ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e
dei suoi diritti»: Corte costituzionale, sentenza n. 26/1999, punto 3.1 del
Considerato in diritto.
[76] L. Governatori Renzoni, La libertà religiosa negli istituti di prevenzione e
pena, in Diritto ecclesiastico, II, 1968, 302-303.
[77] Cfr. A. Pizzorusso, I cappellani degli istituti di prevenzione e di pena nel
diritto vigente e nel progetto di riforma penitenziaria, in Studi in onore di
Ermanno Graziani, Pisa, Pacini Editore, 1973, 565. In termini più generali,
sulla posizione di favor riconosciuta alla Chiesa cattolica nel nostro
ordinamento, in ragione del fattore numerico e dell’influenza che «la sua
dottrina ha esercitato e continua a esercitare ancora oggi sulla formazione del
sentimento etico del popolo italiano», P.A. d’Avack, Libertà religiosa (dir. eccl.),
in Enciclopedia del diritto, XXIV, 1974, 602.
[78] Sulla necessità che lo Stato impedisca ogni forma di discriminazione basata
sul fattore religioso, «mantenendo un atteggiamento di neutralità rispetto alle
diverse opzioni religiose senza ergersi a garante degli orientamenti ideologici
della maggioranza» vedi M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, cit.,
120. In termini più ampi vedi anche F. Rimoli, Laicità (dir. cost.), in
Enciclopedia giuridica Treccani, XVIII, 1995, 5, secondo il quale «devono
essere decisamente respinte quelle impostazioni che fanno leva sulla maggior
diffusione o tradizione di una singola prospettiva ideologica o culturale per
giustificare una sostanziale prevaricazione di questa su altre concezioni
concorrenti e minoritarie, talora anche in forma di imposizione più o meno
diretta sui comportamenti individuali (semmai un’attenta lettura dell’art. 3, 2°
co., Cost. dovrebbe far propendere, all’inverso, per un sostegno alle culture
deboli e minoritarie, anche in campo religioso, in ciò coniugandosi la laicità col
carattere sociale dello Stato, laddove questo sia sancito come nella nostra
Costituzione)» (corsivi miei). In termini più problematici, sulla difficoltà di
distinguere in modo netto tra una «sfera politico-istituzionale, dove l’argomento
della fede, conformemente al principio di laicità, non può essere speso [e] un
dialogo fra individui singoli o associati che può nutrirsi di reciproci
apprendimenti nel rispetto delle convinzioni di ognuno», vedi C. Pinelli,
Principio di laicità, libertà di religione e accezione di “relativismo”, in Diritto
pubblico, 3/2006, 829.
[79] La Corte costituzionale aveva inizialmente ritenuto che la posizione
privilegiata accordata alla religione cattolica trovasse fondamento nell’«antica
ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa
appartiene» (sentenza n. 125/1957) e «alla maggiore ampiezza e intensità delle
reazioni che suscitano le offese ad essa, in quanto religione professata dalla
maggior parte degli italiani» (sentenza n. 39/1965, punto 2 del Considerato in
diritto e, in termini analoghi, sentenza n. 14/1973, punto 3 del Considerato in
diritto). Tuttavia, con il venir meno del principio della religione di Stato in
seguito agli Accordi di Villa Madama, i giudici costituzionali hanno mutato
orientamento, giudicando «inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si
basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie
confessioni religiose» (sentenza n. 925/1988, punto 10 del Considerato in
diritto). La Corte, pertanto, ha infine affermato che il definitivo «abbandono del
criterio quantitativo […] significa che in materia di religione, non valendo il
numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona
che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di
appartenenza» (sentenza n. 440/1995, punto 3.2 del Considerato in diritto,
nonché sentenza n. 329/1997, punto del Considerato in diritto). Cfr. A.
Guazzarotti, Giudici e minoranze religiose, Milano, Giuffrè, 2001, 100 ss.
[80] Corte costituzionale, sentenza n. 329/1997, punto 2 del Considerato in
diritto e, analogamente, sentenza n. 508/2000, punto 3 del Considerato in
diritto.
[81] D’altro canto, le Regole penitenziarie europee varate nel 2006 affermano
che «[d]evono essere presi provvedimenti speciali per i bisogni dei detenuti
appartenenti ad una minoranza etnica o linguistica» e che «[p]er quanto
possibile, le pratiche culturali dei diversi gruppi devono poter continuare ad
essere osservate in carcere» (art. 38, commi 1-2).
[82] Sul punto si rinvia alle osservazioni problematiche di G. Azzariti, Il
costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, Laterza, 2013, 88
ss.
[83] L’idea di una laicità “positiva” era inizialmente affiorata nella sentenza con
cui la Corte costituzionale aveva assegnato alla laicità il rango di principio
supremo dell’ordinamento costituzionale, affermando che «l’attitudine laica
dello Stato-comunità […] risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di
estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti,
rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete
istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini» (sentenza n. 203/1989,
punto 7 del Considerato in diritto). Nella giurisprudenza successiva, tuttavia, i
giudici costituzionali si sono condivisibilmente allontanati dalla declinazione
“positiva” del principio di laicità, ponendo maggiormente l’accento su una
laicità intesa come «neutralità dello Stato nei confronti di tutte [le confessioni
religiose]» (sentenza n. 235/1997, punto 4 del Considerato in diritto, corsivo
mio) e dovere di «equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le
confessioni religiose» (sentenza n. 329/1997, punto 2 del Considerato in diritto,
corsivo mio).
In tal modo si intende invocare non un atteggiamento di rigida e fittizia
neutralità, che lasci l’appagamento delle varie istanze (religiose e non solo) ai
rapporti di forza, ma una laicità che, rinunciando ai privilegi finora accordati
alla religione dominante, sia in grado di rispondere ai problemi attuali posti dal
pluralismo religioso e culturale: cfr. E. Olivito, Laicità e simboli religiosi nella
sfera pubblica: esperienze a confronto, in Diritto pubblico, 2/2004, 560 ss.
[84] N. Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso
costituzionale, Bologna, il Mulino, 2006, 223.
[85] S. Angeletti, Le attività delle comunità islamiche a livello locale, cit., 151.
[86] Della necessità di una legge sulla libertà religiosa si parla, invero, da molto
tempo e diversi sono stati i progetti di legge presentati in Parlamento, senza
però che si siano mai raggiunti risultati apprezzabili. Cfr., tra i molti, i
contributi di Studi e opinioni sul progetto di legge sulla libertà religiosa, in
Diritto ecclesiastico, 1-2/2007, I; nonché V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi (a cura
di), Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà
religiose, Torino, Giappichelli, 2010. In senso favorevole all’uniformità di
regime per le confessioni religiose, nella prospettiva della separazione e della
libertà, vedi M. Luciani, La problematica laicità italiana, in Democrazia e
diritto, 2/2008, 118. Nel senso, invece, che una legge unilaterale sulla libertà
religiosa non si porrebbe come fonte alternativa alle intese, che conserverebbero
lo scopo di salvaguardare le differenze tra le confessioni religiose vedi B.
Randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, Milano,
Giuffrè, 2008, 410.
[87] Se ci si muovesse nella direzione indicata, peraltro, non meno importante
sarebbe un ripensamento dell’istituto del cappellanato, in modo da assicurare
un maggior rispetto del pluralismo religioso e della laicità delle istituzioni
pubbliche. Al riguardo, spunti di discussione interessanti potrebbero trarsi
dall’esperienza delle prison chaplaincy reforms del Regno Unito,
eventualmente anche al fine di orientare l’ordinamento penitenziario italiano
nella direzione opposta di una piena neutralizzazione degli istituti penitenziari
in quanto “spazi pubblici”. Il sistema penitenziario inglese, infatti, che pure
partiva «da una condizione analoga a quella italiana, ossia di monopolio
anglicano del cappellanato, […] è passato negli ultimi trent’anni circa attraverso
un processo di trasformazione, fortemente riflessivo, naturalmente a tratti
anche conflittuale, che ha fatto emergere una notevole capacità di
apprendimento dell’istituzione in questione, al termine del quale sono state
create strutture come il Chaiplancy Council, la cui composizione è multi-fede»:
L’assistenza religiosa in carcere, cit., 83. Nel Rapporto appena menzionato si
sottolineano, nondimeno, alcuni aspetti problematici di tale esperienza e le
diverse condizioni socio-culturali, che nel Regno Unito hanno portato a una
lenta trasformazione dell’istituto. Per le modalità di garanzia della libertà
religiosa dei detenuti, attraverso un servizio pluralistico di assistenza spirituale,
si veda il documento informativo del Ministry of Justice (National Offender
Management Service), PSI 51/2015: Faith and Pastoral Care for Prisoners,
2011,
rinvenibile
all’indirizzo
www.prisonreformtrust.org.uk/ForPrisonersFamilies/Informationbooks.
[88] Cfr. G. Casuscelli, Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche
comunali: le incognite del federalismo, in www.statoechiese.it, settembre 2009,
12. Sebbene a diversi fini, ma con argomentazioni valide anche per
l’ordinamento penitenziario, l’A. esattamente rileva che «[s]petta alla legge
“fondamentale” sulla libertà religiosa offrire al più presto un quadro unitario di
riferimento idoneo a dissolvere le incognite, a fugare i rischi di normative
(primarie e regolamentari) e di prassi amministrative locali che dilatino oltre
misura la discrezionalità “politica” di quanti sono chiamati a dare attuazione,
per la loro parte, alle libertà costituzionali, predisponendo un chiaro ed efficace
sistema di norme di garanzia, procedurali e contenutistiche» (ivi, 13-14).
Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni FERRARA
Direzione
Redazione
Direttore Gaetano AZZARITI
Alessandra ALGOSTINO, Marco
BETZU, Gaetano BUCCI, Roberto
CHERCHI, Giov anni COINU,
Andrea DEFFENU, Carlo
FERRAJOLI, Luca GENINATTI,
Marco GIAMPIERETTI, Antonio
IANNUZZI, Valeria MARCENO',
Paola MARSOCCI, Ilenia MASSA
PINTO, Elisa OLIVITO, Luciano
PATRUNO, Laura RONCHETTI,
Ilenia RUGGIU, Sara
SPUNTARELLI, Chiara
TRIPODINA
Francesco BILANCIA
Giuditta BRUNELLI
Paolo CARETTI
Lorenza CARLASSARE
Elisabetta CATELANI
Pietro CIARLO
Claudio DE FIORES
Alfonso DI GIOVINE
Mario DOGLIANI
Marco RUOTOLO
Aldo SANDULLI
Massim o VILLONE
Mauro VOLPI
Em ail: info@costituzionalism o.it
Registrazione presso il Tribunale di Rom a
ISSN: 2 03 6 -6 7 4 4 | Costituzionalism o.it (Rom a)