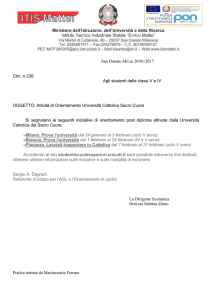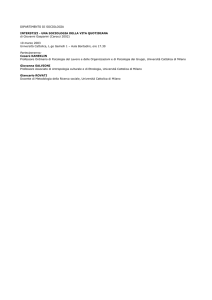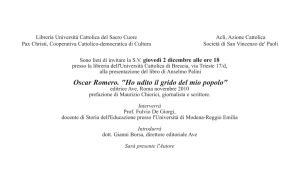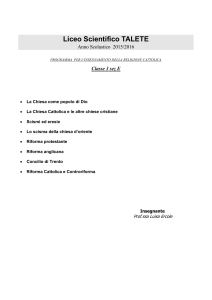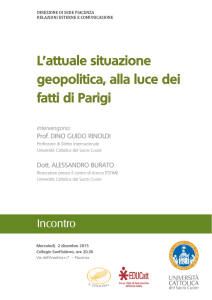Collana
Memorie
Paolo Pagnini
I ragazzi della via Bovio
La guerra e gli anni quaranta nei ricordi di un bambino
Collana
Memorie
Paolo Pagnini
I ragazzi della via Bovio
La guerra e gli anni quaranta
nei ricordi di un bambino
Illustrazioni di Francesco Morosini
2
Presentazione
Con la pubblicazione del libro “I ragazzi della via Bovio”,
la Banca di Credito Cooperativo di Gradara vuole dimostrare ancora una volta, la sua vicinanza al territorio e la sua
sensibilità nel valorizzare quelle che sono le espressioni
vere e tradizionali della sua gente. Abbiamo accettato la
proposta di pubblicare questo libro, perché Paolo Pagnini
è espressione delle nostre tradizioni, della nostra storia; è
un cittadino di Cattolica che ha raccolto storie e memorie
da trasmettere alle future generazioni; è uno di noi, che ha
voluto raccontare alla nostra comunità, le sue memorie, i
suoi ricordi, le sue esperienze giovanili; ha voluto riviverle con tutti noi e con i suoi coetanei. Ne viene fuori uno
spaccato della sua fanciullezza, e quella di un gruppo di
bambini, classe 1934-1937, ( quelli di via Bovio), che hanno
vissuto nel clima drammatico nel secondo conflitto mondiale e nel periodo immediatamente successivo. Attraverso
queste pagine emergono gli antichi giochi, lo sfollamento
per sfuggire ai bombardamenti, la loro paura nei confronti
dei soldati tedeschi, le bombe, l’arrivo degli alleati, la rivalità delle bande rivali, le tradizioni del lunedì di Pasqua, i
veglioni, i balli, i personaggi.
Seguendo l’evolversi degli eventi, così come vengono riportati, pur calati nella realtà attuale, ci ritroviamo facilmente
in quei ricordi, riusciamo ad individuare quei luoghi, ad
immedesimarci in quei giochi, in quegli atteggiamenti e
soprattutto in quei personaggi, dai contorni e dai volti ben
definiti. Riscopriamo una Cattolica che non è più quella di
3
allora, ma che è molto simile, e Pagnini ne è un testimone
importante. La valorizzazione delle memorie locali è una
peculiarità della BCC di Gradara; vogliamo conservarle,
perché determinanti a spiegare le caratteristiche di un luogo, di una località, a raccontare il pensiero della gente, a
conoscere meglio una comunità in un periodo storico ben
determinato, da confrontare con il presente. Credo che in
questa direzione, il nostro Istituto si sia impegnato moltissimo, e diverse sono le pubblicazioni di successo.
Dopo i tre importanti volumi: “C’era una volta Cattolica. Ricordi e immagini”, “Gradara, Gabicce, Cattolica. Luoghi e vicende del tempo passato fra battaglie finte e guerra vera” e
“C’era una volta un’altra Cattolica” del Prof. Guido Paolucci,
che abbiamo esaurito, ma che ancora ci richiedono anche
i turisti che amano Cattolica; dopo il libro di Peter Tonti:
“Da la Vantena in giù”, anch’esso esaurito; dopo i volumi di
Vincenzo Cecchini sulle poesie dialettali; dopo le splendide
pubblicazioni di storia locale della Prof.ssa Maria Lucia de
Nicolò e quelle sulla marineria, che hanno sensibilizzato i
lettori e gli appassionati oltre i confini nazionali, per l’importanza e la rigorosa valenza scientifica degli argomenti.
Siamo lieti di presentare questo lavoro di Paolo Pagnini
“I ragazzi della via Bovio” perchè cattura l’attenzione e ci
accompagna in un piacevole giro alla riscoperta di Cattolica: la Cattolica degli anni 40, prima bella e spensierata e
già stazione turistica conosciuta, poi sofferente, ma ricca di
entusiasmi e di iniziative che le fanno ritrovare, nel breve
giro di pochi anni, quel dinamismo e quella volontà che la
riportano ai giorni d’oggi.
Paolo Pagnini risveglia i nostri ricordi, ci porta indietro negli anni e con i suoi racconti ci rende ancor più consapevoli
del tempo che è passato, che ha cambiato i nostri pensieri,
le nostre convinzioni, ed i nostri volti, ma che ha sostanzial-
4
mente lasciato invariato la nostra città, con qualche cosa in
più, di cui siamo orgogliosi, con qualche cosa in meno, di
cui abbiamo il rimpianto. Attraverso questi appunti, l’autore
si sofferma sulla sua vita da bambino e di quella di altri coetanei, e cerca di fissare, in maniera quasi distaccata, quei
ricordi, ma soprattutto quelle sensazioni e stati d’animo
che lo hanno accompagnato, cercando, in questo modo,
di tramandare degli insegnamenti, alle nuove generazioni.
Rispetto a quegli anni forse Cattolica porta alcune cicatrici
ed alcune rughe in più; conta una popolazione diversa e
più numerosa, ma è sempre bella e affascinante, in attesa
di essere riscoperta e raccontata, lusingata dai complimenti, dalle manifestazioni di affetto che i suoi cittadini ed i
numerosi turisti continuano a darle.
Fausto Caldari
presidente della BCC di Gradara
5
Nell’ambito delle produzioni editoriali promosse in questi
ultimi anni dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara,
dopo le memorie autobiografiche del prof. Guido Paolucci,
la ‘cronaca in vernacolo’ di Giuseppe Tonti (Peter), i quadri
di quotidianità in poesia di Vincenzo Cecchini, si aggiunge con gli scritti di Paolo Pagnini un altro squarcio sul
passato più recente, messo in luce attraverso le avventure
di un gruppo di bambini, cresciuti a Cattolica nel clima
drammatico dell’ultimo conflitto mondiale e i primi anni
del dopoguerra. La trama, autobiografica, pone in un ruolo
protagonista la “banda dal Viel”, composta da un manipolo
di coetanei (classe 1934-1937), tutti residenti lungo la via
Bovio, al Viel, appunto, che rivive nel diario dell’autore,
immerso in un paesaggio familiare e in un insieme di divertimenti, anche pericolosi, e di birichinate dove spiccano
l’esuberanza, il desiderio di scoperta, lo spirito di avventura
e la solidarietà propri dell’infanzia, inseriti in uno scenario
di vita quotidiana minuziosamente descritta, che accoglie
anche altri personaggi, azioni e aneddoti. Al ricordo dei
giochi antichi (il cariol, i pallini di terracotta, i figurini, la
lippa, le spade, le cerbottane, la costruzione della ‘tana’ di
canne, quale punto di ritrovo della compagnia, le sfide fra i
ragazzi), si lega una serie di racconti, sull’esperimento dell’
“Idrolitina alcolica”, sulle presenze militari, su azioni di
guerra e ripercussioni nella vita della gente; su fatti tragici,
sull’abbandono di Cattolica per sfuggire ai bombardamenti;
sul rifugio nel casolare di campagna e conseguenti disagi;
6
sull’arrivo degli alleati e sui loro alloggiamenti; sui giochi
pericolosi quando Cattolica risultava un “deposito a cielo
aperto di armi e munizioni”. La penna dell’autore si cimenta nel ricostruire sulla carta una sequenza di visioni, con la
partecipazione di figure che gli furono care e che rivivono
in uno spazio temporale ripensato, quello di una fanciullezza che vive, negli anni dell’ultimo conflitto mondiale,
una sorta di crocevia di vita e di morte in cui si intrecciano
anche vicende private, di conoscenti e di stranieri. Questi
ultimi, soldati nemici e alleati, lasciano i bambini in uno
stato di confusione, rendendoli incapaci a distinguere ‘buoni’ e/o ‘cattivi’ fra i militari di diversa appartenenza che
si succedono in quel lasso di tempo. Assai significativa,
a questo riguardo, risulta la descrizione dei pantagruelici
rinfreschi assicurati ai militari inglesi, che si servivano “potendo scegliere tra ogni ben di Dio” nel giardino di Villa
Fulgida, mentre “tutti noi stavamo con il viso schiacciato
contro la cancellata a goderci con gli occhi ciò che gli altri
mangiavano”, per vedere poi che “le rimanenze erano buttate” senza tener conto che “molte famiglie … soffrivano
la fame”. Prima la paura dei soldati tedeschi, le bombe, lo
sfollamento, poi l’arrivo degli alleati con “l’enorme quantità
di derrate alimentari al seguito”, ma sempre stenti per la
popolazione civile, a dimostrazione che, indipendentemente dagli schieramenti, “la guerra mette in evidenza il lato
peggiore della nostra personalità”. Un efficace ammaestramento per il bambino spettatore! Il passaggio della guerra
aveva istruito anche su altro, essendo diventata Cattolica un
‘campo minato’ dove la curiosità dei bimbi poteva causare
tragedie: “sapevamo distinguere una cartuccia incendiaria
da una perforante o da una tracciante; sapevamo ciò che
potevamo trattare e ciò da cui potevamo stare alla larga come i proiettili con la spoletta”. Nel dopoguerra l’atmosfera
7
cambia, si rientra nella normalità e gli scontri ‘armati’ ritornano ad essere solo quelli fra le bande rivali dei bambini
che si fronteggiano, incuranti delle ‘guardie’ comunali: “i
ragazzi dal Viel, allora Principe di Piemonte”, contro quelli
“dal Guazz, via Dante e dintorni” o gli altri “d’la Piàza”
e “d’la Catòlga vecia”, a suon di “spade” costruite con ramoscelli e sughero, fionde e “toc dal barbet”, come sfida e
atto di derisione per l’avversario. Il ‘museo’ dei ricordi fa
scorrere le sfide, i nascondigli, fabbricati antichi come area
di conquista. È il caso della Torre abbandonata, già osservatorio meteorologico del dott. Angelo Ferri, dietro la casa
dell’ing. Giuseppe Attilio Balducci situata in via Umberto
I, ora via Cattaneo. Riaffiorano riti stagionali come la gita
a Castel di mezzo del lunedì di Pasqua con l’immancabile
scorpacciata di lupini “i luven”, i cortei “rossi” e “bianchi”
per la ricorrenza del 2 novembre in ricordo dei morti; la
descrizione di villa Rudi e della scimmietta, il macac d’la
Rudi, la moglie del dottore, donna generosa, anticonvenzionale e tanto amante degli animali. E ancora i veglioni, i
balli e i primi incontri con le ragazze, i personaggi “speciali… diversamente svegli”.
Paolo Pagnini insomma, suggerisce in queste pagine una
riflessione su un passato che coincide con lo svolgersi della
sua vita di bambino e adolescente insieme alle persone che
lo hanno cresciuto, accompagnato, formato e, al contempo,
ricompone un’immagine di quella fanciullezza che, attraverso i luoghi di percorrenza, offre il ritmo a tutta la scrittura e ai ricordi che risalgono in superficie. La riflessione è
determinata dal desiderio di fermare su carta “esperienze
di vita vera e reali” come pungolo anche per altri “testimoni
di storie passate” di raccontare “un sistema di vita” inimmaginabile ai giovani di oggi e che possa servire da monito. L’immagine invece è quella di Paolo bambino e della
8
‘banda’ spensierata di viale Bovio alla scoperta del piccolo
mondo che li circondava, quello di “una Cattolica che non
esiste più”, ammaestrati, loro malgrado, anche dagli eventi
drammatici della guerra, vista e sofferta. Il diario inizia con
pensieri sugli svaghi ed emergono poi vari soggetti, un
paese, una comunità semplice, schietta e collaborativa che
Pagnini osserva in casa e in strada, in riva al mare e nella
campagna, senza esprimere giudizi, ma con lucida attenzione. Fuoriesce una cronaca, presentata con ironia e con
garbo dall’autore che rivede distaccato se stesso bambino,
portandosi a riflettere sui comportamenti di allora suoi,
degli amici e degli adulti, ma anche su gente, ambiente,
abitudini e atmosfere oggi perduti, magistralmente tradotti
per il nostro godimento, in piccoli quadri pittorici dall’abile
pennello di Francesco Morosini.
Maria Lucia De Nicolò
9
Prefazione
Alla mia famiglia:
l’unica, vera, grande ricchezza
che ho su questa terra.
Cattolica, negli anni ’30 era un piccolo paese di mare, ma
per me che ci sono nato era ed è la più bella cittadina
del mondo. Al momento della notifica in Comune del mio
ingresso ufficiale nella comunità di Cattolica, di fronte a
mio padre ed a due testimoni, l’impiegato dell’anagrafe
annotò: alle ore tredici e trenta del giorno ventitre febbraio millenovecentotrentacinque, anno tredicesimo dell’era
fascista, è nato in Via del Porto in Cattolica, provincia di
Forlì, Paolo, Walter, Giorgio Pagnini, di Mario e Filippucci
Gina. Ero ufficialmente “arrivato”. Poco tempo dopo i miei
genitori rileveranno dalla famiglia Prioli (i Matiin), almeno così credo, l’osteria situata nella piazzetta in fondo a
Via Giordano Bruno. Il locale prese il nome di “Gina” che
insieme a quello della “Pepa” in Piazza Mercato e quello
della “Norina” in Via Pascoli angolo Via Saffi, formavano il
triangolo storico più gradito di molta povera gente. Con il
passare del tempo dopo varie vicissitudini e difficoltà, dopo la guerra e il dopoguerra, finalmente arrivò negli anni
’50-‘60 il cosiddetto miracolo economico. Il locale piano
piano si trasformò da vendita quasi esclusiva di vino in una
tradizionale trattoria romagnola. Mia madre ne era l’anima
vitale. Sue erano tutte le iniziative e le prelibatezze tipiche
11
accompagnate da una gentilezza, spontaneità ed un carattere estroverso che la portarono in breve tempo a diventare
un personaggio conosciuto anche all’estero, specialmente
fra i turisti svizzeri e tedeschi. Il sindaco Micucci, dopo la
sua morte, ritenne opportuno intitolare la Piazzetta a suo
nome: “Piazzetta della Gina”. Nei miei racconti e nei miei ricordi tuttavia sentirete nominare sempre gli “zii”. Questo è
dovuto al fatto che sono stato cresciuto fin dalla tenera età
di dieci mesi dal dott. Rudi e da sua moglie, che si presero
cura di me con amore per sottrarmi ad una situazione, a
quei tempi, di grosse difficoltà per chi nasceva gravemente
cagionevole di salute. Il primo motivo che mi ha spinto a
mettere per iscritto i miei ricordi è dovuto al fatto che non
volevo che esperienze di vita vera e reali, anche se di poco
conto, potessero essere dimenticate. Il secondo motivo o
meglio “aspirazione” forse un po’ presuntuosa, è che possa stimolare altri testimoni di storie passate a raccontare
le proprie vicende, per contribuire ognuno nella propria
individualità, a tramandare alle nuove generazioni la conoscenza di un sistema di vita non facilmente concepibile
dai giovani d’oggi. Nelle scelte del titolo, ho volutamente
parafrasato quello del celebre romanzo di Molnar: “I Ragazzi della via Pal”, in quanto ho ravvisato delle affinità
tra il romanzo ed i miei racconti. Nel suo libro, infatti,
l’autore racconta le disavventure di un gruppo di ragazzi,
impegnati in dure battaglie con una fazione avversaria per
la conquista di un terreno alla periferia di Budapest; una
storia commovente con un finale drammatico: la morte del
soldatino Nemecsek, nel vano tentativo di dar manforte
ai compagni nell’ultima battaglia. Ne “I ragazzi della via
Bovio” facendo naturalmente la dovuta tara, racconto, con
un po’ di ironia,storie di bambini, le loro scorribande i loro
scontri con le bande rivali e l’ambiente in cui si sono svolte.
12
Sarei uno sciocco se volessi fare un confronto con lo scrittore magiaro, ma penso che un piccolo riconoscimento il
mio racconto lo meriti comunque: mi sono sempre attenuto
scrupolosamente alla verità nel racco tare le avventure di
un gruppo di ragazzi in una Cattolica che non esiste più.
Colgo l’occasione per esternare la mia gratitudine ai cari
amici: Magda Gaetani, l’impareggiabile prof. che ha corretto tutti i miei errori.
Giuseppe Tirincanti, Ferdinando Montanari e mio figlio
Mario che hanno trasferito i miei brogliacci manoscritti su
supporti informatici.
In fatto di scrittura sono rimasto affezionato al cartaceo ed
alla vecchia penna biro servendomi al massimo, sporadicamente, di una vecchia macchina per scrivere.
Un ringraziamento speciale va a Francesco Morosini che
con i suoi disegni è riuscito a cogliere con bravura e ironia
lo spirito e l’anima dei miei racconti scritti.
Una particolare considerazione merita la cara amica Lucia De Nicolò, che nonostante i tanti gravosi e gratificanti
impegni, ha trovato il tempo anche per presentare questi
miei semplici racconti. Un grande onore per me, a lei un
commosso grazie.
Infine un grazie di cuore alla Banca di Credito Cooperativo di Gradara, al suo Presidente ed a tutta la dirigenza,
sensibili come sempre a tramandare ricordi e tradizioni del
nostro territorio. Grazie perché hanno permesso di concretizzare la mia aspirazione più grande: quella di veder
pubblicate in un libro le mie avventure di bambino.
A tutti costoro va la mia riconoscenza.
Paolo Pagnini
13
Gli anni della guerra
Solo l’affettuosa insistenza e l’incoraggiamento di famigliari
e amici carissimi mi hanno indotto, vincendo la mia ritrosia,
ma con una punta di presunzione, a scrivere queste righe
che non hanno la pretesa di essere un saggio storico. Esse
sono solo una semplice testimonianza, vista con gli occhi
di bambino, di una vita modesta e frammentaria; testimonianza di come si viveva in un periodo particolare lontano
anni luce dalla nostra opulenta società. Lungi da me il
pensiero di “mettere le mani avanti” ma mi corre l’obbligo
di scusarmi con il lettore se il racconto non avrà una trama
ma appena un filo logico. Questo è dovuto al fatto che esso
è il frutto di ricordi che vengono da un lontano passato in
cui la memoria fa fatica a dissipare la polvere dell’oblio che
si è sedimentata in ben più di 65 anni. Nella speranza di
non annoiarvi mi affido alla vostra comprensione e benevolenza se non sarò stato all’altezza delle vostre aspettative.
A mia difesa il fatto che non sono nemmeno uno scrittore
dilettante ma solo un vecchio, brontolone, ragioniere in
pensione.
15
La compagnia “dal Viel”
Era la tarda primavera del 1943 e per noi bambini una
come altre; non potevamo capire cosa ci capitava intorno
data la nostra età, la nostra spensieratezza e perché no, la
nostra incoscienza. Il pericolo faceva parte della quotidianità e noi lo accettavamo come fosse una cosa normale.
Parlando di noi intendo gli amici inseparabili: Enzo (Enzo
Benvenuti classe 1936), Fabio (Fabio Casicci classe 1936),
Manen ad Ciavarol (Mariano Semprucci classe 1936), Sandren ad Macaron (Alessandro Ercoles classe 1937) ed io,
Paolo Pagnini, al fiol dla Rudi classe 1935. I fratelli Cecchini, Tonino e Vincenzo, si uniranno a noi dopo il passaggio
del fronte. Abitavamo tutti a pochi metri l’uno dall’altro nel
“Viale”, allora Viale Principe di Piemonte ora Viale Bovio.
Alla mattina, quando si poteva si andava a scuola e il pomeriggio lo si passava giocando in strada. A seconda della
stagione si giocava con i pallini di terracotta, ai figurini, alla
lippa, con le spade, le cerbottane e così via. Sul far della
sera ci ritrovavamo in Piazza della Fontana dove gli appassionati di tamburello si davano appuntamento per partite
memorabili e tra quelli che ricordo c’erano Mario Tombari,
Nullo Rondini e Rico Galluzzi. Un giorno, avendo visto
alcuni bambini di una “banda” rivale girare per la strada
17
18
pavoneggiandosi con un “cariol” (carrettino) costruito da
loro, abbiamo deciso di farne uno anche noi in un modo
molto artigianale. Abbiamo inchiodato alle estremità di una
cassetta per il pesce fornita da Manen che apparteneva ad
una famiglia di pescatori due manici di scopa in modo che
sporgessero dai bordi per la lunghezza di circa 10 centimetri. Per le ruote, Bonci il falegname, ce ne fece quattro con
un bel buco al centro per la cifra di 5 lire. Tutto sembrava
andare per il meglio a parte la difficile governabilità del
mezzo! Per la prova andammo in “cima dla costa dal cumun” (la salita di Via Mancini) . Avendo pagato io le 5 lire
salii per primo; una bella spinta dagli amici e via a tutta
forza! A metà strada incominciai a sentire puzza di bruciato
ma non ci feci caso perché ero tutto preso dal “ demone
della velocità”. All’altezza dell’allora Teatro Zacconi (ora
complesso Ariston) alcune poco rassicuranti fiammelle e un
gran fumo mi fecero capire che la nostra opera d’arte stava
andando a fuoco. Puntai i piedi contro l’asfalto ma riuscii
a fermarmi solo dopo la Piazza Nettuno. I nostri sogni si
infransero contro il principio fisico dell’attrito, aiutato anche dal fatto che avevamo lubrificato le ruote con un po’
di petrolio.
19
Idrolitina ‘alcolica’
Era uno di quei pomeriggi di inizio estate del 1943 che
sembrava non avere nulla di particolare ma….un certo
qualcosa nell’aria, non saprei dire cosa, non faceva presagire niente di buono. Gli amici non li avevo trovati, lo zio
era uscito per le visite ai pazienti (allora usava così) e la zia
era andata a trovare delle amiche. Ero rimasto solo in casa
con le due donne di servizio, la Maria e l’Anna, intente a
svolgere le loro faccende. Nel tinello-veranda che divideva
la cucina dal garage, vicino al caminetto, era posto uno
strano mobile. Nella parte superiore racchiudeva un grammofono con relativo spazio per enormi dischi. Nella parte
centrale, dietro due ante di vetro bombato, si potevano
intravvedere diverse bottiglie di liquore che andavano in
quegli anni per la maggiore: Strega, Triple-sec, Maraschino,
Anisette ed il cognac Stock che allora si poteva chiamare così, ma dal 1947, con il trattato di pace, i francesi ci
imposero di non usare più quella parola tipica della loro
originale zona di produzione. Scartato il termine “Arzente”
che sapeva troppo del passato regime, si optò per “Brandy” di origine anglo-sassone entrato poi nell’uso comune.
Non volevo divagare ma mi vedo costretto ad una breve
dissertazione sull’”Idrolitina”. Questa era un prodotto che
20
21
serviva a trasformare la comune acqua in “acqua minerale
gassata”.A quei tempi quella addizionata di anidride carbonica non era in uso, esisteva solo il “Seltz” ma era appannaggio esclusivo dei bar, pardon delle “mescite” ( allora le
parole straniere erano bandite per ordine del governo)! Si
presentava in una piccola scatola gialla contenente venti
bustine, dieci di un colore e dieci di un altro, sufficienti per
dieci litri di acqua. Dopo averle versate una dopo l’altra, in
una bottiglia d’acqua subito chiusa ermeticamente, si aveva
“magicamente” dell’”acqua minerale frizzante”. Se non si
era veloci nella chiusura succedeva la fine del mondo con
conseguente fuoriuscita del tutto. Perché tutto questo preambolo? Perché è sempre stata mia intenzione raccontare
alla buona le mie storie, darvi notizia delle abitudini e del
contesto in cui, noi bambini, anche se tra mille difficoltà,
abbiamo avuto il privilegio di vivere. Quindi…. In quel pomeriggio pieno di noia, per dare una ventata di novità ebbi
una bella pensata! Perché non fare un po’ di bollicine con
tutti quei liquori? Detto-fatto. Con l’aiuto della fida Maria,
mia complice di tante birichinate, riempii una bottiglia e
aggiunsi le famose due bustine. Risultato? Una montagna di
schiuma! Di quell’intruglio ne bevvi purtroppo un bicchiere intero. La prima sensazione fu di euforia, con il passare
dei minuti si trasformò in nausea, poi in vertigini. Mi avviai
barcollando , verso l’orto. Le nostre due oche diventarono
ai miei occhi, tre o quattro. Capii che qualcosa nel mio cervello non funzionava bene. Mi diressi allora, non so perché,
verso la strada canticchiando la celebre canzone molto in
voga in quegli anni “Lili Marlene”: “tutte le sere sotto quel
fanal …” sedendomi alla base di un lampione. Intervennero
le mie badanti che con molta fatica cercarono di portarmi a
casa, ma io, malcerto sulle gambe, imperterrito continuavo
a straziare i timpani con “anche stasera aspetterò e tutto
22
il mondo scorderò con te Lilì Marlene …”.A questo punto
credo di avere perso i sensi. Arrivato lo zio, non sapendo
nulla e vedendomi in quello stato, ebbe il sospetto che
mi avessero fatto del male. Mentre mi portava in braccio
sul letto dell’ambulatorio, continuava a ripetere con voce
disperata:”me l’hanno avvelenato, me l’hanno avvelenato!”
Ad un più attento esame capì subito che, grazie a Dio,
anche se era una cosa seria non ero in pericolo di vita.
Naturalmente non ricordo nulla di tutto quel che accadde.
Mi dissero che avevo perso conoscenza per ben due giorni.
Quando mi svegliai le prime parole che dissi furono.”zia
non ti preoccupare, sto bene”! Nel mio lettino di degenza
ebbi praticamente l’affettuosa compagnia di tutto il viale:
dalle Gagie (sorelle Benvenuti) alla Rusnen (Rosina Tomassini), da Enzo a Manen, tutti cercavano a loro modo di
rincuorarmi e di essermi vicini. Quando mi alzai mi affacciai alla finestra, attratto da delle voci conosciute. Vidi nel
giardinetto che separava le due proprietà la Vanna Ballotta
abbandonata su uno sdraio; a quei tempi l’omonima farmacia era ubicata proprio lì, dove ora si trova il negozio
“la Brandina”. Chiesi alle persone che le facevano corona
cosa era successo; mi rispose suo zio Ennio (forse) che per
sbaglio la ragazzina aveva bevuto un sorso di vino! Poi continuò in dialetto:”Te cum stè, ho savù che t’è fat una bela
gata!” “Non c’è male” risposi, pensando tra me e me, ma
guarda un po’ cosa non farebbero le femmine per mettersi
in mostra! Per concludere anche quella volta mi andò bene.
Certo l’avevo fatta grossa! Posso assicurarvi che fu la prima
e ultima volta che feci la “gatta”!
23
I tedeschi in casa
Una notte, a casa, sentiamo dei grossi colpi contro il portone; mia zia intuisce il pericolo, prende la valigetta, che
è sempre a portata di mano con tutti i valori di famiglia,
la appende ad un gancio del muro esterno che serviva
a tenere ferma la persiana. Lo zio, il dottor Rudi, va ad
aprire e quattro o cinque tedeschi, visibilmente stanchi e
sporchi, con gli occhi fuori della testa e le armi spianate ci
intimarono di uscire subito facendosi capire in uno stentato italiano, che erano di ritorno dal fronte e che volevano
dormire in un letto. Così ci ritrovammo, in men che non
si dica, in mezzo alla strada con il solo pigiama addosso.
Mia zia, la signora Rudi non si perdette d’animo: chi l’ha
conosciuta sa che era una donna molto energica e dalle
mille risorse. Il caso volle che nello stabile accanto a casa
nostra, oggi Residence Suisse ed allora, se ben ricordo, era
la Pensione Augusta, ci fosse un comando tedesco. Lei andò a bussare in vestaglia e camicia da notte. Allo sbigottito
piantone cominciò ad urlare, metà in veneto e metà in italiano, di andare a chiamare subito un ufficiale. Nel giro di
pochi secondi ne arrivarono tre e il più alto in grado, forse
un colonnello, capito cos’era successo, si diresse subito
verso casa nostra seguito dai suoi colleghi. Aprì la porta,
24
vide i soldati e urlò come solo i tedeschi sanno fare qualche ordine a quei malcapitati che, raccolte le loro cose in
un battibaleno, si precipitarono fuori sparendo nella notte.
L’ufficiale ci salutò sbattendo i tacchi e anche lui uscì con
il suo seguito. Un giorno di mattina suona l’allarme (una
sirena ubicata nella torre del Comune con un lungo ululato
comunicava alla cittadinanza un pericolo imminente e con
25
due brevi il cessato allarme). Io ed Enzo, che giocavamo
in strada, ci precipitiamo a spiaggia; ci sdraiamo e volto
lo sguardo al cielo vediamo una dozzina di B27 (le famose fortezze volanti americane) sganciare il loro carico di
morte. Le bombe sembravano piccoli coriandoli luccicanti
che scendevano verso terra ad una velocità spaventosa. Il
bersaglio era il ponte ferroviario sul fiume Conca. Il risultato per gli aviatori era sempre sconfortante un po’ per
l’eccessiva altezza di volo degli aerei, dovuta al fatto che sul
monte Vici, in postazioni scavate nel tufo, c’erano diversi
cannoni antiaerei tedeschi e un po’, credo, per la scarsa
precisione dei puntatori americani. Sta di fatto che il ponte non lo “beccarono” mai nonostante le quasi quotidiane
incursioni. Cessato l’allarme tornammo nelle nostre care
per tranquillizzare i nostri famigliari. Verso sera, passo per
caso di fronte al Caffè Commercio ( ubicato nell’angolo tra
l’odierno Viale Bovio e Via Matteotti dove attualmente c’e la
filiale della Cassa di Risparmio. Allora era di proprietà della
famiglia Cavallucci: Angiulen ‘d Caplena, la moglie Erminia,
la madre Emilia Baldassari (Milia ‘d Caplena), i figli Tonino, Agostina ed Amedeo).Vedo Angiulen che seduto ad un
tavolo ascoltava il racconto concitato di due amici dei quali
non ricordo il nome e mi avvicino per ascoltare. “A simie
tla Conca quand d’un trat a santin dal Mont Vici a sparè a
tota forza e po’ l’inferne; li bombie li scupieva dimpartot,
tal mer, tal fiom, sora li colonie, nun an savimie andò ch’endè e l’oniche punt quert l’era al pont…..avin fat una gran
cursa e finalment ac sin pudù arparè sota un’archeda”. A
questo punto Angiulen non li fece continuare, si alzò e gli
disse: “A sì do pataca!” E se ne andò. Un altro giorno, nella
tarda mattinata, era appena suonato il cessato allarme e noi
eravamo a spiaggia per scavare una grande buca che nelle
nostre intenzioni doveva servire come rifugio durante i
26
bombardamenti. Alcuni battelli pescavano a poche centinaia di metri dalla riva e dal porto stava uscendo una chiatta
armata tedesca. All’improvviso vediamo sbucare dalle nubi
due caccia inglesi (forse Spitfire) di ritorno da uni dei tanti
bombardamenti su Rimini; avvistata la preda si avventarono su di essa come falchi e facendo zig-zag tra le vele dei
pescatori, tra varie cabrate e picchiate scaricavano le loro
mitragliatrici sull’imbarcazione nemica provocando centinaia di fontanelle nell’acqua così come avremmo potuto
vedere negli anni successivi nei film di guerra. I tedeschi
rispondevano come potevano al fuoco nemico. Il terribile
spettacolo durò non più di una manciata di secondi e poi
gli aerei sparirono così come erano venuti. Per me fu una
incredibile emozione non priva di un suo fascino crudele:
era la guerra ed io non avevo che nove anni. Sapemmo
poi che ci furono tra i militari tedeschi alcuni feriti ed un
morto, falciato da una raffica di mitraglia.
27
I disagi e le paure della guerra
In quei giorni era praticamente impossibile trovare qualcosa di decente da mangiare. Ci si doveva accontentare delle
scarse e pessime razioni che il tesseramento concedeva.
Quel poco che si poteva trovare al mercato nero aveva dei
prezzi esorbitanti. Così mia zia, per racimolare qualcosa di
commestibile, si mise d’accordo con un amico di famiglia,
Gino Tirincanti che aveva una “Topolino”, non so come,
funzionante e cosa ancora più incredibile, ancora con un
po’ di benzina. Si partì in tre: Gino, mia zia ed io. Il viaggio
in cerca di cose da mangiare, tra i casolari delle campagne
dell’entroterra, durò tutto il pomeriggio. Il risultato fu abbastanza buono: una bottiglia d’olio, qualche chilo di patate
ed un sacchetto di farina; c’era da esserne soddisfatti. Sulla
via del ritorno tra San Giovanni e Cattolica, seduto sul sedile posteriore mi godevo l’aria fresca avendo la macchina
la capotina abbassata. Ad un tratto “zia, zia” urlai “un aereo!” Un caccia inglese stava puntando su di noi. Facemmo
appena in tempo a fermare la macchina ed a buttarci nel
fosso che una sventagliata di mitraglia ci sfiorò di pochi
centimetri. L’aereo compì una virata e sparì tra le nuvole. Riprendemmo la strada per casa ringraziando in cuor
nostro tutti i santi del paradiso per lo scampato pericolo.
28
29
All’inizio dell’estate le cose incominciarono a peggiorare.
Il comando tedesco, nella previsione (poi risultata errata)
che gli inglesi avrebbero fatto uno sbarco a Cattolica per
aggirare la linea gotica che resisteva tenacemente agli attacchi degli alleati, ordinò a tutti gli abitanti dalla ferrovia al
mare di abbandonare le loro case e cominciò lo sfollamento. Nel giro di pochi giorni i miei zii riuscirono a pendere
in affitto una casa a Saludecio e vi si trasferirono in tutta
fretta. Trasportarono tutto ciò che poterono: mobili di valore, vestiario invernale, materassi, coperte e quant’altro.
Un baule intero di argenteria venne sotterrato nell’orto di
casa. Precauzione inutile perché alcuni mesi dopo verrà
trovato, con il “metal-detector”, da un soldato canadese in
cerca di mine. Non voglio certamente generalizzare ma, per
quello che ricordo, i canadesi erano i più buoni di cuore
verso la popolazione ma altrettanto “spensierati” per ciò
che riguardava la proprietà altrui. Infatti, dell’argenteria,
nonostante le nostre ricerche, non ne sapemmo più nulla.
Il mattino seguente io, la mia dada (ora si direbbe baby-sitter) e la donna di servizio avremmo dovuto precedere gli
zii e raggiungere la nuova abitazione ma un contrattempo,
la mancanza di un mezzo di locomozione, ce lo impedì. Fu
una grande fortuna per noi perché nella stessa giornata,
un bombardiere alleato colpito dalla contraerea, prima di
precipitare sganciò il suo carico di bombe senza curarsi
troppo di dove sarebbero cadute. Una finì a Saludecio proprio sulla casa che avevamo preso in affitto. Tutto andò
perduto; quel poco che si salvò fu “raccolto” dai vicini, ma
noi non potemmo recuperare niente! Le conseguenze le
avremmo patite nel freddo inverno che sarebbe seguito.
A questo punto i miei famigliari decisero che sarei stato
il primo mese con i miei genitori che si erano trasferiti a
Sant’Ansovino nella casa dei nonni materni, poi con gli zii
30
che nel frattempo avrebbero cercato un’altra sistemazione.
Mio padre Mario passò a prendermi in bicicletta; salii sulla
canna e ci avviammo verso la nuova dimora a circa 14 Km
di distanza. Alla prima salita dopo Morciano ci dovemmo
fermare in un’aia di contadini: un carro armato “tigre” ci
stava raggiungendo: era meglio cedergli il passo! Verso sera
arrivammo a destinazione e ci vennero tutti incontro: i nonni Augusto e Maria, due degli zii, Stella e Pino che aveva
solo quattro mesi più di me, mia madre Gina e mio fratello
Nereo. La casa faceva parte di un ghetto di 5-6 abitazioni
con in mezzo una piazzetta. Entrai. Al piano terra c’era una
stanza con il focolare, una madia, una credenza, un tavolo
con qualche sedia e in un angolo un secchiaio con un orcio
pieno d’acqua e al centro pendeva un lume a petrolio. Al
piano superiore si accedeva mediante una scala di legno;
c’erano due stanze: una per i nonni e gli zii e una per noi.
Dal soffitto pendeva un asse di legno trattenuto da quattro
cordicelle con sopra alcuni formaggi pecorini messi a stagionare. Chiesi a mia madre dov’era il bagno e lei mi prese
per mano e mi condusse nell’orto. Dietro ad una pozza
d’acqua che serviva per lavare i panni c’era un piccolo
recinto di canne alto più o meno un metro, con in mezzo
una buca semicoperta da una tavola di legno. “E’ questo”
mi disse. “E la carta igienica?” replicai nella mia ingenuità.
“Quella lì” mi rispose indicandomi una piccola pianta dalle
grandi foglie verdi. Quella sera, nel mio lettino di fortuna,
piansi. L’avvilimento, data l’età, durò poco. L’indomani mi
portarono a spigolare (termine che indicava la possibilità,
per le famiglia meno abbienti, di poter raccogliere le spighe di grano rimaste nei campi dopo la mietitura). Anch’io
ne racimolai un bel mazzetto che portai a casa tutto orgoglioso. Le giornate passavano apparentemente tranquille,
almeno per noi bambini, tra corse nei campi e giochi nuovi.
31
Di questi, quello che mi affascinava di più era “LA BOTA”,
nel senso di scoppio, esplosione, segno precursore del
“bombarolo” che sarei diventato da lì a qualche mese. Sotto
la guida esperta dello zio Pinen, di cui ero a pieno titolo
allievo e complice, diventò il mio passatempo preferito. Tra
i modesti strumenti di illuminazione di quei tempi c’era la
lanterna all’acetilene: una macchinetta dalla forma e grandezza di una caffettiera napoletana. Come combustibile si
usava il carburo, elemento usato allora anche per saldare
i metalli, elemento che aveva la peculiarità di sprigionare
un gas infiammabile al contatto con l’acqua, appunto l’acetilene. Il nostro arnese , miscelando opportunamente i
due elementi emetteva quel gas da un apposito beccuccio.
Una volta acceso, emanava una vivida e brillante fiammella.
Quando il materiale era esausto veniva gettato ma subito
recuperato da noi bambini per i nostri giochi: si modellava
una ciotola con della creta, lasciando un buco nel centro,
con la quale poi coprivamo accuratamente una piccola buca., riempita precedentemente con il carburo e dell’acqua.
Da debita distanza poi, servendoci di una lunga canna e di
un fiammifero, facevamo saltare la piccola mina; il risultato
era veramente appagante per noi: un sordo boato ed una
miriade di innocue schegge di fango sparse tutto intorno.
Mi stavo adattando bene al nuovo tipo di vita! Qualche
volta accompagnavo la zia Stella che con il solito orcio andava alla fonte a prendere l’acqua, bene prezioso e scarso
da usare sempre con parsimonia. I nonni possedevano due
pecore che i figli a turno portavano a pascolare. Ogni tanto
mi univo a loro, un po’ per fare compagnia e un po’ perché
mi piaceva camminare in quei luoghi immersi nella natura
e sempre nuovi per me. Al calar del sole, dopo una cena
sempre frugale, ci si riuniva con i vicini nella piazzetta. I
grandi mi affascinavano sempre con i loro racconti, le loro
32
storielle ed aneddoti. Specialmente mio nonno catturava
la mia attenzione quando parlava della sua gioventù e delle sue peripezie di emigrante in Svizzera. Tutto era così
sommesso, pacato. Quando si rientrava andavamo subito a
letto sia per la stanchezza, sia perché non c’era la luce ed
il petrolio per la lampada non si poteva sciupare perché
era caro ed era difficile da reperire.
33
Il tempo passato in campagna
Giorno dopo giorno arrivò il tempo di tornare dagli zii.
Questi nel frattempo avevano trovato una buona sistemazione nella casa colonica dei Giuvanton, che ancora oggi si
può vedere semi-diroccata di fronte al casello autostradale
di Cattolica. I Giuvanton erano una bella famiglia patriarcale composta da Matteo con la moglie Caterina, il figlio
Giulio sposato con Maria, la figlia Bruna appena più piccola di me, Luigi detto Bigion il più estroverso e simpatico,
la Pali una bellissima donna purtroppo sfortunata ed Enrico. Mi sistemarono in un lettino, trasformando opportunamente un’ottomana, nel corridoio del primo piano. Così
divenni membro a tutti gli effetti della nuova comunità
che comprendeva anche le famiglie Merli e Rifelli; queste,
meno fortunate di noi, avevano trovato una sistemazione
alquanto precaria in due cabine da spiaggia montate sotto una tettoia del deposito degli attrezzi agricoli. Queste
cabine (i capan) erano state requisite dal Comune e distribuite a chi ne faceva domanda. Al’’indomani mattina
notai che ferveva una certa attività proprio in mezzo ad
un campo di granturco e incuriosito mi avvicinai. Giulio e
Bigion avevano appena finito di scavare una grande fossa e la stavano coprendo con delle tavole. Qualcuno mi
34
spiegò che lo scopo di quella fatica era di nascondere il
maiale che altrimenti sarebbe stato requisito dai soldati in
ritirata. Quella stessa sera udimmo due enormi esplosioni:
i tedeschi avevano fatto saltare i bastioni ovest e nord del
porto, per renderlo inagibile al naviglio alleato. I tempi
stavano cambiando rapidamente e i pericoli aumentavano.
Nessuno me lo diceva ma lo percepivo dagli atteggiamenti
degli adulti che erano sempre più preoccupati, nervosi e
cupi in volto. Quel giorno che tutti aspettavano, il giorno
della liberazione, stava per arrivare. La Linea Gotica aveva
ceduto dopo scontri violentissimi e i tedeschi seppur lentamente si ritiravano. Era questione di ore. La notte seguente
non andammo nel rifugio che gli uomini avevano appron-
35
tato nel greto del Ventena ma restammo in casa in attesa
degli eventi. Si udivano rumori di cingoli, ordini secchi in
tedesco, spari isolati, qualche raffica di mitragliatrice, un
correre di soldati e poi la calma. Alle prime luci dell’alba
si sentì una voce gridare: “Sono arrivati, sono arrivati!” Mia
zia, presa dalla curiosità, si alzò da sotto il grande tavolo in
cui ci eravamo rifugiati, aprì un poco le persiane e vide, a
50 metri di distanza un carro armato sulla strada. Fece appena in tempo a chiudere la finestra e venire accanto a noi
che quattro colpi fortissimi, quattro cannonate colpirono la
nostra casa. Fu il finimondo: vetri, calcinacci, stoviglie, tutto
ci crollava addosso. La paura, le urla delle donne, poi, un
silenzio assurdo, irreale. Ci alzammo quasi contemporaneamente chiamandoci per nome. Eravamo delle maschere
di sudore, polvere e sangue ma miracolosamente, salvo
qualche escoriazione, illesi. Erano arrivati gli alleati ed era
il 2 settembre del 1944.
Gli Inglesi montarono un accampamento nelle vicinanze
con annessa cucina e così avemmo modo di notare l’enorme quantità di derrate alimentari di cui disponevano. Le
cannonate a noi procurarono, grazie a Dio, solo qualche
graffio ma nella stalla le cose andarono diversamente perché un bue fu ferito gravemente e dovette essere ucciso.
Nulla fu sprecato. Il giorno dopo, un poco probabile banco da macelleria sorse al centro dell’aia. I primi avventori
furono i soldati alleati ma come si sparse la voce ed anche amici, conoscenti e gente del vicinato venivano a fare
gli acquisti. Bigion, improvvisatosi macellaio, serviva tagli
molto approssimativi ma nessuno ci faceva caso. Una cosa però attirò la mia attenzione: ogni qualvolta una sposa
si avvicinava al banco, Bigion puntualmente con un gran
sorriso offriva in vendita due specie di “limoni” appesi con
una cordicella ad un paletto, aggiungendo scherzosamente:
36
37
“Toh! Compra anche quest’i chè; ma te a nal so mo mal tu
marid i farà ben ad sigur!” E tutto finiva in una risata. Nella
mia innocenza non capivo di cosa si trattasse ma pensando
di fare bella figura, all’avvicinarsi di una cliente, mi feci
avanti e le ripetei in italiano la frase di Bigion:”Compri
anche questi signora, non so a lei ma a suo marito faranno
bene di certo!” Non finii l’ultima parola che mia zia, celando malamente un sorriso, mi diede uno scappellotto dicendo:”Chiedi subito scusa alla signora!” Ubbidii senza capire
perché ciò che era permesso a Bigion non lo fosse per
me. L’ingiustizia dei grandi! Durante quel periodo l’amico
carissimo Enzo Benvenuti mi veniva a fare compagnia tutti
i giorni, avendo le zie e la nonna (le Gagie) trovato casa
nelle vicinanze e la mamma aveva trovato lavoro a Roma.
Si andava molto d’accordo, eravamo veramente affiatati e le
marachelle effettuate poi dalla nostra “banda” erano quasi
sempre imputate alle nostre iniziative. Un giorno, Enzo, la
Bruna (figlia di Maria e Giulio Fronzoni) ed io, stavamo
girando per i campi in cerca di uova. Qualche volta le galline avevano l’abitudine di non farle nel pollaio ma in giro
nei pressi dell’aia. Non trovando niente avemmo una bella
pensata! Ci dicemmo: invece di perdere tempo a cercare a
caso prendiamo una gallina, le facciamo una casetta e così
le uova le depone lì! Presto detto, presto fatto. Rimediati un
po’ di paglia, canne, sterpi e qualche mattone, riuscimmo
a costruire un piccolo recinto coperto. Il difficile fu però
prendere il pollo. I Giuanton avevano anche un certo numero di galline nane, meno veloci delle altre, così ci buttammo su di loro riuscendo a prenderne una, quella che
a noi sembrava più bella. La mettemmo in quella specie
di capanna con una ciotola d’acqua e un po’ di granaglie,
sperando nella sua buona volontà! Aspettammo: il giorno
dopo, niente! Sul far della sera la Maria, tutta preoccupata,
38
girava per i campi a cercare Chicco, il più bel gallo di razza
nana che era sparito. “Im l’ha rubè, im l’ha magnè” pensava
ad alta voce. Sentii e capii subito che avevamo fatto un “tragico” errore. Andai di corsa verso quella specie di piccola
prigione, prima che la scoprissero e liberai l’animale che
tutto giulivo si mise a correre verso il vero pollaio. Credo
che i “grandi” avessero capito i nostri intenti, molto probabilmente la Bruna si era fatta scappare qualche parola.
Per me non ci furono sgridate, almeno così mi ricordo, ma
solo qualche occhiata che mal celava un certo sorriso di
comprensione per la nostra marachella. L’iniziativa di noi
tre bambini, anche se i propositi erano buoni, non ebbe
successo. La nostra pretesa si scontrò inesorabilmente, anche questa volta, con una delle più importanti leggi della
natura: i galli non fanno le uova.
39
Ritorno a casa. Mesi pericolosi
A questo punto per andare avanti devo fare una premessa:
tutte le notti un aereo leggero tedesco veniva a ridosso
del fronte per sganciare qualche spezzone incendiario o
qualche piccola bomba. La sua presenza era diventata tanto
abituale che la gente lo chiamava scherzosamente “Pippo”.
Una sera mentre eravamo a tavola per la cena, Pippo arrivò,
silenzioso come sempre, sulla verticale della nostra casa e
lasciò andare uno spezzone. Uno schianto! L’ordigno aveva
colpito in pieno una sentinella inglese straziandone il corpo. Una scheggia trapassò la porta e colpì la Maria; la paura
fu tanta ma le conseguenze insignificanti: un buco nella
sottana ed una leggera bruciatura all’altezza del ginocchio.
Poteva andare peggio! Alcuni giorni dopo gli zii decisero
di tornare a Cattolica. Salutarono tutti calorosamente, caricarono le poche cose su un carro trainato da due buoi e
partimmo. Arrivati in paese ci si presentò uno spettacolo
desolante; la città era deserta, piena di reticolati, il nostro
bel viale ridotto in uno stato pietoso. I maestosi pini, tagliati
alla base e incrociati l’uno con il suo dirimpettaio, ostruivano il passaggio. La nostra casa era stata colpita da una
cannonata e non era abitabile. Anche per queste ragioni lo
zio accettò l’incarico di dirigere l’Ospedale Civile che si sta-
40
va predisponendo nell’albergo Gambrinus nell’attuale Viale
Mancini (nel fabbricato ove attualmente si trovano il caffe’
Gambrinus, negozi ed uffici). I mesi che seguirono furono
senz’altro difficili e pericolosi ma sicuramente indimenticabili, e lasciarono in me tanti ricordi che, se avrete la bontà
e la pazienza di seguirmi in queste note, dividerò con voi
i più interessanti. Nel frattempo gli amici di sempre erano
41
tornati nelle rispettive case e così la vecchia compagnia
si ricompose. Le strade erano state liberate dagli ostacoli
ma il paese non era stato ancora completamente bonificato
dalle mine. Conoscevamo le zone più pericolose avendo
fatto una certa esperienza e sapevamo dove mettere i piedi: comunque ce ne stavamo sempre ad una certa distanza!
Meno fortunato fu il nostro ex giardiniere Natale Facondini
che, alle dipendenze del Comune, nella sistemazione di Via
Fiume saltò in aria su una di esse perdendo la vita. Lasciò
la moglie e tre figli in tenera età. Cattolica era diventata un
deposito a cielo aperto di armi e munizioni; le si trovava
dappertutto ma in modo particolare nella “casa degli spiriti”, l’ultima villa di Via Carducci, lato mare, verso le colonie
all’altezza dell’odierno Hotel Luxor. Non ho mai saputo il
perché di questo nomignolo: forse perché era una casa isolata o forse perché qualcuno vi aveva visto aggirarsi qualche
“entità”. La terza ipotesi era quella che se saltava in aria
avrebbe reso tutto “puri spiriti”: a voi la scelta. C’erano tonnellate di cartucce, bombe fumogene e di mortaio, proiettili
d’artiglieria e bombe a mano. Quelle che andavano per la
maggiore fra di noi erano le bombe a mano incendiarie
che chiamavamo “a liquido” perché una volta tolta la sicura
e lanciate, dopo pochi secondi esplodevano provocando
una fontana, appunto di liquido, che al contatto con l’aria
si incendiava bruciando tutto ciò con cui veniva in contatto. Oggi può sembrare una cosa assurda ma a quei tempi,
tutto quell’arsenale era per noi bambini fonte di giochi e di
divertimento quotidiano. Tutto il tempo libero lo passavamo
a disinnescare, neutralizzare, sparare, far scoppiare tutto, ma
proprio tutto. Avevamo acquisito un’esperienza da fare invidia ad un artificiere dell’esercito. Sapevamo distinguere una
cartuccia incendiaria da una perforante o da una tracciante;
sapevamo ciò che potevamo trattare e ciò da cui dovevamo
42
stare alla larga come i proiettili con la spoletta. La nostra
simpatia andava ai proiettili inglesi perché a differenza di
quelli americani, la polvere da sparo in essi contenuta aveva
la forma di sottili spaghetti che noi, con un procedimento
particolare riuscivamo ad estrarre per poi adoperarli per fare
fuochi, mine o “zaganelle”,una specie di piccolissimi missili
che oggi potremmo chiamare “razzi stupidi a propellente
solido”: Per fabbricarli usavamo solo i nostri spaghetti, cannelli di canna o di qualsiasi tubo che riuscivamo a trovare.
Potevamo fare concorrenza a Von Braun! Un giorno, avendo
finito le scorte, andammo alla “casa degli spiriti” per fare
rifornimento. Eravamo Enzo, Tonino Fabio, Manen ed io.
Riempite le tasche e le mani, scendevamo le scale per uscire
quando ci si parò davanti un soldato americano che con la
pistola spianata ci fece alzare le mani e consegnare tutto il
nostro bottino. In quel mentre vidi scendere per le scale un
rivoletto di liquido…. Era Fabio che se l’era fatta addosso!
In quella scomoda posizione rimanemmo per una manciata
di secondi, che a noi parvero secoli.. Come vedemmo, però,
rimettere nel fodero quell’arma, intuimmo che ci avrebbe
lasciati andare e, prima che riuscisse a proferire una parola,
con un salto acrobatico ci gettammo dalle finestre (sotto, per
fortuna, c’erano grandi mucchi di sabbia) correndo con tutte
le nostre forze lontano da quel luogo “tristo e maledetto”.
Quell’avventura finì senza conseguenze, grazie a Dio, ma
solo con un po’ di paura.
43
Il materiale bellico con cui “giocavamo”
(per gentile concessione del Museo della Linea dei Goti di
Montegridolfo
44
45
Gli Alleati e i nuovi giochi
dei ragazzi
In quel periodo gli alleati avevano predisposto, presso l’hotel Kursaal, un ospedale da campo. Era sempre un viavai
di autoambulanze militari che venivano a depositare il loro carico di dolore. Una volta sentimmo uno strano odore, dolciastro e nauseante, venire dalla piazzetta a destra
dell’odierno Mc Donald’s. Ci avvicinammo e vedemmo ciò
che non avremmo mai voluto vedere: in un grosso bidone,
il famoso barile di petrolio, dei resti umani, frutto di diverse amputazioni, bruciavano lentamente tra garze, stracci
e benzina. Riuscimmo a scorgere nettamente una gamba
ed un braccio con la mano rattrappita che cedendo al calore stavano carbonizzandosi. Scappammo via perché era
troppo anche per noi. Meglio cambiare discorso e parlare di cose meno lugubri. Una banda che si rispetti come
la nostra, aveva bisogno di un covo. Lo trovammo adatto
alle nostre necessità: il mio pollaio! Era tanto grande che
poteva ospitarci tutti; dotato di una porta e di una finestra
faceva proprio al nostro caso. Da un recipiente di lamiera
ricavammo, con un po’ di ingegno, una stufetta che funzionava benissimo. Si andava verso l’inverno e un po’ di calore
46
47
ci avrebbe fatto bene. Inoltre potevamo cucinare qualche
vivanda, non ultime le patate americane, quelle dolci, per
noi una novità. Nel nostro vagabondare, in una casa ancora
non abitata dai proprietari, il nome dei quali non farò mai
neanche sotto tortura, trovammo sotto alcune mattonelle
sconnesse un vero tesoro per l’epoca: un bottiglione pieno
di chicchi di caffè che al mercato nero sarebbe costato una
fortuna! Invece di dividerci il bottino e far felici i nostri familiari decidemmo di goderci noi quella manna inaspettata.
Fabio rimediò un macinino tra i giocattoli della sorella e
trovare un pentolino fu un gioco da ragazzi. In men che
non si dica, seduti intorno alla stufa, con un certo orgoglio
bevemmo quel nettare prelibato precluso ormai da anni
alla stragrande maggioranza degli italiani. Fu la prima ed
ultima volta perché, vuoi per il profumo che si era sparso
nell’aria,vuoi perché qualcuno di noi aveva fatto la spia,
quando tornammo il giorno dopo nel nostro covo del caffè
nessuna traccia. Era sparito! Anche in questo caso il famoso
detto “la farina del diavolo finisce sempre in crusca” faceva
al nostro caso. Gli alleati, per meglio rifornire il loro enorme parco di automezzi, avevano costruito un oleodotto.
Non so da dove venisse ma attraversava tutta la spiaggia
da Est ad Ovest per arrivare, molto probabilmente, fino
a Rimini. Era composto da tubi con un diametro di una
quindicina di centimetri, imbullonati l’uno con l’altro. Gli
inglesi non avevano fatto il conto però con il tipico spirito
di iniziativa, chiamiamolo così, della gente italica. Dopo un
po’ di tempo, non si sa come, all’altezza della Villa Fulgida,
alcuni bulloni si allentarono. Il risultato fu che una grande
quantità di benzina era stata assorbita dalla sabbia, senza
contare quella asportata nelle ore notturne. Appena gli alleati se ne accorsero successe il finimondo: minacce, inchieste, interrogazioni, ma i colpevoli non furono mai trovati.
48
Dopo pochi giorni tutto si insabbiò e tornò come prima.
Solo il mercato nero dette segni di ripresa: circolava anche
la benzina! Noi ragazzi avevamo escogitato un mezzo molto semplice per recuperare “l’oro rosso” intrappolato nella
sabbia: facevamo una buca profonda quel tanto da far affiorare l’acqua, prendevamo una bottiglia che riempivamo
con quel liquido, poi la capovolgevamo tenendola chiusa
con il pollice e appena la benzina che era più leggera saliva in alto, spostando leggermente il dito si faceva uscire
l’acqua ed il gioco era fatto! Il tempo passava, la guerra
era finita e si tornava lentamente alla normalità. Sarà per
queste ragioni che il comando inglese fece approntare un
Luna Park sulla spiaggia di fronte all’ex cinema Arena Mare aperto a tutti. Era delimitato da un telone alto circa due
metri ed all’interno c’erano vari giochi ed intrattenimenti
per grandi e piccoli. Un gioco in particolare attrasse la
nostra attenzione: si doveva, calciando un pallone, colpire
una figura e chi ci riuscita vinceva un premio. La nostra
immaginazione non aveva limiti ed escogitammo un piano
per entrare in possesso del pallone che per noi, abituati a
giocare con una palla fatta di caucciù e stracci, sarebbe stato il massimo. La sera stessa lo mettemmo in azione. Entrai
al Luna Park, pagai il biglietto, l’inserviente mi consegnò
la sfera di cuoio che sistemata calciai con forza cercando
di far fare al pallone la traiettoria più alta possibile. Così
avvenne, il telone era stato sorvolato. Mentre io fingevo
con il soldato addetto tutta la mia costernazione per il mio
calcio maldestro, i miei complici l’avevano già recuperato
e stavano fuggendo a gambe levate.
49
Nuove disavventure
Era sicuramente la primavera del 1945: i miei amici andavano quasi tutti scalzi. I primi tepori allontanavano definitivamente i rigori di un inverno rigidissimo, affrontato da
tutti noi malamente, non avendo la possibilità di difenderci
dal freddo pungente con indumenti adeguati. Alcune famiglie più fortunate di noi, venute in possesso, non indaghiamo come, di qualche coperta militare, erano riuscite
a confezionarsi qualche capo di lana, materiale veramente
“pregiato” e introvabile a quei tempi. Ricordo che io indossavo un maglione di “lanital”, tessuto derivato da un
trattamento speciale della caseina del latte, ed un paio di
calzoni la cui stoffa derivava dalle fibre delle ginestre. Residui questi dell’autarchia (l’essere autosufficienti in tutti
i campi) voluta dal fascismo alla fine degli anni trenta, in
risposta alle “inique sanzioni” decretateci dalla Società delle
Nazioni per l’invasione dell’Etiopia. I tempi erano quelli di
“faccetta nera” . Quei tessuti, oltre a non proteggere dal
freddo, avevano l’inconveniente che ogni qualvolta si lavavano si allungavano vistosamente, tanto che mia zia, per
non farmi fare la figura di Pulcinella, doveva accorciarmeli
di una decina di centimetri! Ai piedi portavo un paio di
stivali militari, cedutimi da mio padre, che avevano però
50
un difetto, quello di essere un quarantatre ed io a dieci
anni calzavo a malapena un trentotto! Tutto questo era la
conseguenza della caduta di quella bomba sulla casa presa
in affitto a Saludecio e della conseguente perdita di tutti i
nostri indumenti invernali. A questo punto credo di aver
divagato un po’ troppo e chiedo scusa cercando di entrare
subito nel merito di quello che avevo in mente di raccontare. Casa mia era ancora disabitata e a volte, come in questa
occasione, diventava la sede di qualche nostra birichinata.
Un giorno in compagnia di Enzo, Fabio, Manen, Sandren
e forse anche uno dei fratelli Cecchini eravamo al primo
piano intenti a giocare con qualche cartuccia, quando arriva Mario Lorenzi, di qualche anno più grande di noi,
con in mano una specie di “spaghetto” enorme: almeno un
51
centimetro di diametro e circa 40 centimetri di lunghezza.
“L’ho preso da un bossolo di cannone” ci disse mentre noi
lo ammiravamo estasiati. Affacciandoci sul cortile notammo
4 o 5 galline che razzolavano pigramente. Ci guardammo
negli occhi: la medesima idea ci balenò nella mente! Mario
scagliò lo “spaghetto” violentemente verso il suolo…..e un
boato assordante ci investì e vedemmo quei poveri animali
che, starnazzando a più non posso, erano stati scagliati
verso l’alto in una nuvola di polvere e penne! Allibiti dallo scompiglio che avevamo combinato, non aspettammo
di vedere come sarebbe finita quell’avventura, in pochi
secondi scendemmo le scale e appena fuori, dandoci un
contegno di assoluta innocenza, con tutta la calma possibile ci allontanammo dal luogo del misfatto. Non abbiamo
mai saputo che razza di esplosivo avevamo lanciato. Molto
probabilmente si doveva trattare del detonatore di un proiettile di artiglieria. All’Hotel Fulgida gli Inglesi avevano
aperto una cucina per la truppa. Credo che fosse sempre
in funzione perché, bontà loro, servivano la colazione, lo
spuntino, il pranzo, il famoso the delle cinque e la cena.
Per noi bambini era un avvenimento per cui, se avevamo tempo, valeva la pena andare a curiosare, ma non era
così per altri che mossi soprattutto dalla fame speravano
di racimolare qualcosa da mangiare. I cuochi, con i loro
pentoloni, si disponevano nel giardino davanti all’entrata.
I soldati in fila indiana passavano davanti con i loro vassoi potendo scegliere tra ogni ben di Dio: carne, verdure,
insaccati, formaggi ed il famoso pasticcio dolce di riso per
non parlare delle enormi e bianchissime fette di pane. Tutti
noi stavamo con il viso schiacciato contro la cancellata a
goderci con gli occhi ciò che gli altri mangiavano! Quando
tutto era finito le rimanenze erano buttate in enormi bidoni. Se qualcuno, spinto a ragionare più con lo stomaco che
52
con la testa, attraversava il cancello per recuperare qualche
cosa rovistando tra i rifiuti, spesso veniva preso a calci nel
sedere, strattonato e buttato fuori. Bisogna sempre tenere
presente che quelli erano tempi duri e molte famiglie vivevano nell’indigenza più assoluta e soffrivano spesso la
fame. Questa mia testimonianza non vuole essere un atto
di accusa contro nessuno né voglio generalizzare il comportamento di qualche singolo soldato. Resta il fatto però
che il trattamento subito da quei bambini non era dei più
umani! L’unica attenuante è che la guerra mette in evidenza il lato peggiore della nostra personalità. Nell’estate del
1945, mia zia Venerina e la signora Rosina Francolini Binda
con le due figlie Gigina (Luisa) e Carla, coadiuvate da alcuni volonterosi dei quali purtroppo non ricordo il nome,
organizzarono nei locali dell’Arena Sole una sala da ballo.
L’iniziativa era a scopo benefico per cercare di aiutare, con
il ricavato, alcune famiglie veramente bisognose. Ci volle
tutta la loro buona volontà e tanto spirito di sacrificio ma
alla fine riuscirono nell’intento, Rimediarono un’orchestrina di 3 o 4 elementi; per il “buffet” riuscirono a racimolare
un po’ di vino, aranciata e qualche liquore. Con l’aiuto del
Sindaco (nominato dagli alleati) Gino Morbiducci, riuscirono a reperire le materie prime per cucinare in casa un po’
di biscotti e pasticcini. L’iniziativa ebbe successo nonostante i tempi bui, ma una sera, forse perché qualcuno aveva
esagerato con l’alcool, per futili motivi vennero alle mani
alcuni cattolichini e soldati inglesi. Spuntò un coltello ed
un militare cadde a terra ferito ad un fianco. Il colpevole,
noto ai presenti , riuscì a dileguarsi. La polizia militare non
riuscì mai a sapere chi era stato. Le conseguenze però furono gravi perché il locale fu dichiarato “off limits” e praticamente fu chiuso. Gli alleati oltre alla cucina, la cantina e
il luna park avevano pensato, tanto per non farsi mancare
53
niente, ad un campo da calcio. Il posto ideale era la zona
dietro al Municipio dove a quei tempi c’erano solo terreni
da semina. In men che non si dica, con i loro bulldozer
riuscirono a trasformarli in un campo da gioco, ma c’era
il problema che potevano usarlo solo loro. Qualche volta
la squadra inglese sfidava quella del Cattolica. Qui cominciavano i guai perché sia per il poco addestramento dei
nostri, sia per le assenze dovute alla guerra e alla prigionia la nostra compagine aveva pochi titolari. Tra questi mi
piace ricordare Gaudenzi (Mandulena) l’ala e Mazzocchi il
portiere. Tutti cercavano di supplire alla superiorità degli
avversari con tanta buona volontà. Se poi aggiungiamo il
fatto che gli Inglesi volevano vincere a tutti i costi, in questo aiutati spudoratamente dall’arbitro che era uno di loro,
c’erano tutti gli elementi perché gli animi si scaldassero e
la situazione diventasse ingovernabile. Si cominciava con
i soliti insulti, si continuava con qualche spintone e si finiva a botte e con l’invasione del campo. A questo punto,
precedute dal suono delle sirene, arrivavano le jeep della
polizia militare che con maniere un po’ spicce, con molte
manganellate e qualche colpo di pistola sparato in aria,
riuscivano a riportare la calma al prezzo di un fuggi-fuggi
generale. La domenica dopo, alla solita ora, si ricominciava
tutto da capo.
54
Immagini di morte e pericoli
In quel periodo si stabilì nel viale anche la famiglia Cecchini e così i figli Vincenzo e Tonino vennero a far parte della
nostra “banda”; Piero era appena nato. Nel frattempo, nella
parte nuova del Kursaal, gli alleati aprirono una “cantina” cioè
un ritrovo, una specie di bar per soli militari. La pasticceria,
sempre sotto controllo inglese, che la riforniva era ubicata in
quello che diventò il Caffè Nettuno. Tutti i giorni alla stessa
ora, un carretto pieno di ogni ben di Dio faceva la spola tra
l’una e l’altra. L’omino addetto al trasporto, arrivato ai piedi
della scalinata, prendeva una cassetta di dolciumi, saliva pigramente le scale, entrava ed esattamente dopo 40-45 secondi
riappariva per scaricarne un’altra. Il tempo era sufficiente e
non potevamo perdere questa occasione! Ci appostammo dietro l’angolo e quando il garzone della pasticceria, oltrepassò
la porta noi scattammo come molle e in pochi secondi …..via,
in una corsa sfrenata con il veicolo ed il suo prezioso carico
verso il luogo più lontano possibile da occhi indiscreti, dove,
in pochi minuti facemmo sparire ogni traccia del “corpo del
reato”! Ancora oggi fantastico sull’espressione che avrà avuto
il malcapitato,all’uscita, nel non ritrovare più né il veicolo né
il suo pregiato contenuto. Anche questa volta scoppiò una
grana. La polizia militare non si dava pace; interrogava, chie-
55
56
deva, minacciava … tutto inutile. I responsabili non furono
mai trovati. Forse solo il buon don Giocondo sapeva la verità! Un pomeriggio di non so quale giorno, eravamo nella
spiaggia antistante l’Hotel Fulgida intenti a disinnescare alcuni
proiettili, vedo un po’ appartato Tonino che giocherellava con
una bomba a “liquido”. Mi accorsi subito che non aveva più
la sicura e allora urlai: “buttala, buttala” ma non mi capì, mi
precipitai verso di lui, gli strappai l’ordigno dalle mani e lo
scagliai in mare. Fece appena in tempo a toccare l’acqua che
con un tonfo sordo scoppiò. Ci era andata bene! Tonino si ricorderà certamente di questo episodio! Verso le ore dodici di
una giornata, per quanto mi ricordo, d’inizio estate, ero con gli
zii seduto a tavola davanti ad un piatto di maccheroni quando
ad un tratto entra Enzo di corsa. “Paolo” dice tutto trafelato, “è
arrivato a terra un soldato morto!” Prima che i miei avessero il
tempo di fermarmi eravamo già in strada e correvamo verso il
mare. Arrivati, lo spettacolo che ci si presentò fu davvero pietoso ed impressionante: gonfio come un pallone, un aviatore
americano aveva spiaggiato, probabilmente precipitato con il
suo bombardiere molto tempo prima. Lo abbiamo riconosciuto
dalla sua uniforme, una spessa tuta di montone imbottito che
doveva ripararlo dal freddo polare delle alte quote, dalla quale
spuntavano solo il viso e le mani ma più che sufficienti per capire lo stato di deterioramento di quel povero corpo. Era rimasto solo lo scheletro con qualche brandello di carne putrefatta
che fluttuava nello sciabordio dell’acqua. Non vi dico del fetore
che lascio immaginare a voi. Stava arrivando gente e credemmo opportuno tornare a casa. Sapemmo poi che quei miseri
resti ebbero cristiana sepoltura nel cimitero di guerra inglese
a Gradara. Enzo non so, ma io mi rimisi a tavola a finire quel
piatto di pasta. Con queste righe si chiude la fase bellica. Poi
venne il periodo del dopoguerra non altrettanto interessante
ma ugualmente denso di avvenimenti ed aneddoti.
57
Il dopo guerra
59
Lentamente la vita riprende
Dopo la fine dei miei racconti sul periodo bellico, mi accingo a continuare la narrazione dei miei ricordi d’infanzia: le
vicissitudini di ragazzi come me, tutti poco più che bambini,
nei mesi successivi al periodo bellico. La guerra era finita.
Le truppe alleate vincitrici avevano lasciato l’Italia. La vita
pur tra mille difficoltà, cercava di riprendere il suo cammino
verso la normalità. La popolazione, umiliata e offesa per una
guerra che non era stata sua, aveva cominciato a rialzare la
testa. La resistenza, in questo contesto, aveva fatto scuola e
gli italiani, dando il meglio di sé, presero a ricostruire quello che era stato distrutto. Nacque così il “miracolo italiano”
degli anni cinquanta e sessanta. Con la guerra, per noi monelli era anche finita la possibilità di continuare a giocare
con quegli ordigni bellici che tanto avevamo apprezzato nei
mesi precedenti. La città era stata completamente bonificata. Così noi riprendemmo a divertirci e a trascorrere le ore
libere con i nostri vecchi, cari, tradizionali giochi. Le nostre
piccole marachelle erano però sempre a rischio, perché su
di noi incombeva la figura bonaria ma inflessibile di Bellini,
la guardia municipale. A dire il vero le guardie erano due,
Bellini e Casadei, meglio conosciuto con il soprannome di
“Pezzolina”. Ognuno controllava un determinato territorio.
61
62
Bellini era responsabile della nostra zona: il viale. Aveva una
figura alta e magra, i capelli brizzolati e l’eterna divisa nera
con scarponi e gambali di cuoio. Non si parlava di multe
per divieto di sosta o per eccesso di velocità perché non
c’erano automobili. I nostri vigili avevano anche lo sgradito compito di controllare le lattaie. Esse infatti, al mattino
presto, scendevano dalle campagne per via Macanno e superato il passaggio a livello, per via Cavour. Ad attenderle
c’era sovente un vigile che, con un apposito strumento, misurava la densità del latte contenuto nei recipienti. Se risultava troppo acquoso i contenitori venivano svuotati sulla
strada tra le comprensibili e vive proteste delle interessate.
All’inizio dell’autunno, dopo la pausa estiva, le “bande” si
ricompattavano. Le nostre più dirette rivali erano “al Guaz”
cioè via Dante e dintorni, “la Piaza” cioè piazza Mercato più
le zone circostanti la “Catolga Vecia” (la Cattolica vecchia,
via Pascoli e vie adiacenti). Noi eravamo la banda “dal Viel”
l’allora viale Principe di Piemonte oggi Viale Bovio. La domenica pomeriggio, qualche volta si andava in parrocchia
dove il professor Bellini ci intratteneva con uno spettacolo
di burattini. Noi bambini partecipavamo volentieri perché
era veramente bravo. C’era però il rovescio della medaglia:
alla fine dovevamo andare alla benedizione! La qual cosa alla
nostra banda non andava proprio a genio! Allora, quando le
scuse che con infinita immaginazione cercavamo di rifilare
al cappellano non sortivano nessun effetto, non ci rimaneva
altro che tentare una precipitosa fuga. La via di uscita era
tra il cortile della parrocchia e la proprietà dei De Nicolò,
dove uno squarcio nella rete divisoria poteva rendere possibile la nostra fuga. Ma il sagrestano “Pinen”, ammaestrato
dalle passate esperienze, era lì a braccia e gambe aperte
ad impedircela. La nostra destrezza e velocità ci consentiva nove volte su dieci di farla franca, inseguiti però dalle
63
minacce verbali di Pinen: “a vò arcnusù, al degh ma li vost
mà!” E rivolto a me:”am maravei ad tè che t’z’è al fiol dla
Rudi!” Ma noi ce ne infischiavamo delle minacce e, a gambe
levate, continuavamo la nostra corsa verso la … libertà! Con
i primi freddi cominciava anche la stagione dei giochi con
le spade. Non erano altro che semplici bastoni, del diametro
di circa un centimetro e mezzo e lunghi un’ottantina di centimetri. Venivano sbucciati con cura, tranne l’impugnatura
dove veniva inserito un paracolpi. Di solito era un dischetto
di sughero sempre gentilmente “offerto” dalla marineria di
Cattolica. Quegli stessi sugheri i pescatori usavano applicarli nella parte alta delle reti: ”ma la lima da sur” in contrapposizione ai piombi applicati alla parte inferiore delle
reti “la lima da piomb” per tenerle sempre tese durante la
pesca. Questi semplici bastoni dovevano avere però delle
caratteristiche particolari: essere dritti, duri, flessibili e non
avere nodi. Gli alberi che più si addicevano a questo scopo
secondo noi, si trovavano in Via Cesare Battisti, lato mare.
Queste piante poi, ci fornivano anche le “munizioni” per le
nostre cerbottane. Infatti quando era stagione, producevano
dei grappoli di pallini verdi che opportunamente staccati,
messi in bocca a decine, spinti con un forte soffio nel “cannello” a mo’ di mitragliatrice, si trasformavano in un nugolo
di piccoli, inoffensivi “proiettili”. Dovevamo però fare i conti
con due pericoli: gli abitanti della zona e…..Bellini! I primi
potevamo evitarli andando a raccoglierli verso mezzogiorno
quando tutti erano a tavola ma per il secondo facevamo affidamento….sulle nostre gambe! Nel malaugurato caso che
uno di noi venisse preso erano dolori: era sottoposto alla
umiliante “tasta” (perquisizione) atta a trovare la “sfrombla”
(fionda) che tutti avevamo e tenevamo nascosta all’altezza
della cintola dentro la maglia. Se veniva trovata era naturalmente requisita dopo una bella tirata d’orecchie e la solita
64
65
ramanzina tipo: “la prossima volta ti porto dai carabinieri!”
Poi il malcapitato veniva rilasciato. Tra le “bande” che imperversavano a Cattolica in quegli anni, vigeva un codice
d’onore da tutti rispettato: se nasceva una disputa, anche di
poco conto, tra le gang diverse e le parole non erano più
sufficienti a far prevalere le proprie idee e se uno nella foga
della discussione pretendeva di avere ragione a tutti i costi
e l’avversario non si ritraeva, come ultima ratio si ricorreva
alla sfida diretta alla quale l’antagonista doveva per forza
reagire: si trattava del “toc dal barbet”. Una specie di rito
pagano che ci tramandavamo di generazione in generazione e aveva lo scopo di far emergere una specie di vittoria
morale anche se si aveva la peggio. Consisteva nel bagnarsi
con la saliva i polpastrelli di una mano e cercare di toccare
con questa il mento dello sfidato. Se la cosa riusciva, era
l’umiliazione più grande che poteva subire uno di noi. Qui
non valeva l’età, la stazza, la robustezza, si doveva reagire
comunque anche se si era in evidente inferiorità! Reagire
voleva dire venire alle mani. Se i due sfidanti erano dello
stesso peso, li si lasciava fare (sempre che non eccedessero)
ma se uno era vistosamente inferiore i compagni potevano
correre in suo aiuto in due modi: a parole con le consuete
frasi del tipo “ant vargogn, ant ved chl’è un burgel, tfarè
mel”! Ma se questi discorsi non sortivano nessun effetto si
passava alle maniere forti e quasi sempre finiva in una lite
generale! Finché sopraggiungeva Bellini, la guardia, o qualche altro adulto che gridando “smitila burdel che ormai a si
grand e se av ciap av fac un cul com una panera” poneva
fine alla lotta furiosa. Poche parole e tanto bastavano a farci
smettere e a sparire di corsa nelle strade adiacenti. Ma una
cosa era certa: l’onore dello sfidato era salvo e con esso la
considerazione dei compagni.
66
Il campo giochi
Il nostro campo di giochi andava dal porto al Conca ma
frequentavamo in modo particolare: “la piattaforma” (il
pontile sulla spiaggia) che allora era molto più lungo di
oggi; seguiva l’edificio “dell’Avviamento” (Istituto per l’Avviamento Professionale) che era ubicato nei giardini davanti al Kursaal, a circa 10 metri dall’Hotel San Marco; poi la
“torre”; era una torre di avvistamento in disuso da tempo,
ubicata dietro mura fatte con sassi a vista (tipo di quelle di
Majani). Nelle sue vicinanze, se non ricordo male, faceva
bella mostra di sé anche un vespasiano. Se la nostra torre
fosse ancora in piedi si troverebbe nel parcheggio dietro
la farmacia di piazza Mercato. Era alta 7/8 metri, a pianta
quadrata. Tramite 4 gradini ed una porticina, si accedeva
all’interno dove una scala diroccata portava alla sommità.
Quando in competizione con quelli della “Piaza” (era il
loro territorio) a suon di spade, cerbottane e fionde ne
contendevamo il possesso, solo la nostra incoscienza ed il
nostro scarso peso ci permettevano di arrivare indenni, da
vincitori, alla sommità. Fino ai primi anni del Novecento
era stata il punto di riferimento per le barche senza motore.
Quando gli agenti atmosferici lo permettevano gli equipaggi, per non perdere tempo prezioso, stavano in mare decine
67
68
di giorni e non entravano in porto ma si fermavano al largo
in attesa che natanti più piccoli andassero a trasbordare il
pescato e portare nuove provviste. A questo punto entrava
in scena la nostra torre, che permetteva a quelli di terra, di
scorgere le sagome delle barche, il colore delle vele e capire di quale battello si trattasse. Con l’avvento del motore,
tutto questo mondo irto di difficoltà e di sacrifici finì e il
nostro manufatto perse d’importanza e divenne col tempo
solo un luogo “a rischio” per giochi di bambini. Ultima, ma
non ultima per importanza, zona di giochi era “la fontana
delle sirene”. Punta di ritrovo prima di iniziare qualsiasi
sarabanda. Da lì partivano tutte le nostre iniziative. Ricordo che, se si riusciva a rimediare un po’ di “malta” (creta)
per noi era una fortuna, infatti con questa preziosa materia
prima , battuta e ribattuta sul carapace delle tartarughe,
riuscivamo a plasmare aerei, navi, cannoni e carri armati.
e… con la solita inventiva, ci cimentavamo in fantastiche
battaglie. Con la corteccia dei pini, sempre a proposito di
fantasia, modellavamo piccole barchette alle quali applicavamo, quale motore, alcune gocce di pece nella poppa.
Non ci crederete ma messe in acqua si muovevano lasciando, dietro di sé, un piccolo alone iridescente! Con un misto
di piacere e nostalgia, ricordo anche alcune fredde serate
d’inverno, quando si poteva facilmente prevedere che nella
notte “l’avrìa giacè” (avrebbe ghiacciato): con della polvere reperita alla base dei “righin” (cordoli stradali) e della
sabbia, improvvisavamo dei piccoli argini a circa un metro
dal gradino della fontana, che riempivamo poi, con molta
cautela, d’acqua. A questo punto, come in un rito pagano,
tutti in circolo “maledicevamo” quelli che avrebbero potuto
rovinare il nostro lavoro e ci davamo appuntamento per il
giorno dopo. Il mattino seguente ci si alzava una mezz’ora
prima tra lo stupore de familiari e… via alla fontana. Se le
69
previsioni erano state esatte la nostra pista di pattinaggio
era pronta per la “lescia”, divertenti scivolate sul ghiaccio.
Fare un raffronto con gli iper-protetti bambini di oggi potrebbe essere istruttivo ma inutile….quindi “tirem innanz”!
Se non ricordo male il più veloce era Manen solo perché
portava i “zuclun”, gli zoccoloni: un tipo di scarponi molto
spartano, con il fondo di legno ed il legno si sa, scivola
meglio sul ghiaccio. A proposito di battaglie con le spade
il ricordo corre subito agli scontri che avevamo con la “Catolga vecia”. Un ragazzino, con la destrezza di un folletto,
ci metteva spesso in difficoltà; era Mario Ercoles soprannominato “Bado”, diminutivo di Badoglio, l’allora capo del
governo, per la sua spiccata propensione a voler a tutti
i costi essere riconosciuto capo di quella banda. Per chi
non lo sapesse si riusciva a mettere fuori combattimento
l’avversario solo se lo si colpiva con la punta della spada
nel corpo. Un colpo alle braccia o alle gambe feriva solamente. Con tre ferite si era spacciati, mentre la testa era
severamente proibito toccarla. Non posso dimenticare il
curioso episodio in cui, in un freddo pomeriggio d’inverno,
sono stato oltre che testimone anche parte attiva. Eravamo impegnati in un’aspra battaglia per la conquista della
piattaforma, tenuta saldamente dalla banda del “Guazz”. Ci
accorgemmo subito però, che avevano rinforzato le loro
file con un “oriundo”(abitava infatti in via Giordano Bruno): Sante Prioli detto “il contadino”, un ragazzo di due o
tre anni più anziano di noi. Il perché del soprannome mi
è sempre sfuggito visto che proveniva da un’antica famiglia di pescatori. Al prezzo di qualche “morto” riuscimmo
ugualmente a scalare e successivamente a conquistare la
maggior parte del pontile. Noi eravamo rimasti in quattro
e loro in due. Messo fuori combattimento uno, l’ultimo,
appunto “il contadino”, costretto in un angolo,sentendosi
70
perduto ma non vinto, al grido di “non mi avrete vivo,
marrani” si gettò in acqua, raggiunse la riva e fuggì. Quale
ispirazione teatrale o cinematografica l’avrà guidato? A quei
tempi furoreggiavano i film di cappa e spada. In quei giorni
era in programmazione al teatro Zacconi “Il corsaro nero”
tratto da un romanzo di Salgari, in cui il protagonista, in
una simile circostanza, si comportava nello stesso modo.
Parafrasando il Manzoni “fu vera gloria?”: a voi l’ardua sentenza. Ora vi potreste giustamente chiedere: “Ma voi vincevate sempre?” Penso proprio di no anche se avevamo nelle
nostre file un mancino formidabile, che….. per la modestia
che mi contraddistingue, non dirò mai chi era! Inoltre è più
facile raccontare le vittorie che le sconfitte!
71
Il ‘covo’ della banda, feste di
paese e nuovi amici
Dopo lo sfratto dal pollaio, quando con gli zii ritornammo
nella nostra villa, la banda restò, per così dire, “senza sede”.
Per noi avere un rifugio era indispensabile. Ottenemmo il
permesso dalle sorelle Benvenuti, zie di Enzo, di costruire
una capanna di canne nel loro cortile ai confini con l’allora
orto Gennari ora Residence Undulna. Visto che con l’aiuto
dei soliti amici ero riuscito a costruire un “cariol” questa
volta governabile (i progressi della meccanica!) con ben tre
cuscinetti a sfera forniti graziosamente a suo tempo da un
deposito inglese, per realizzare il nostro favoloso “covo” ci
mettemmo subito all’opera. La fatica fu molta: dovevamo
andare alla foce del Conca, tagliare un fascio di lunghe
canne, caricarle sul “cariol e portarle fino in Via Bovio dietro all’odierno negozio “King”. Dopo alcuni giorni e una
decina di viaggi avevamo il materiale necessario. Con solo
l’ausilio di qualche rotolo di spago, alcuni stracci e tanta
buona volontà, in poche ore riuscimmo nell’impresa. Di
fronte a noi si stagliava finalmente la nostra nuova tana.
Arredo spartano: una panca ed una stufa traslocata dal
vecchio pollaio. La sera stessa facemmo l’inaugurazione.
72
73
Menù:patate dolci lessate! Purtroppo una decina di giorni
dopo, un ritorno di fiamma della stufa mentre cucinavamo
non so cosa, si propagò al soffitto e in pochi secondi tutto
andò bruciato e della nostra bella capanna rimase solo il
ricordo e un po’ di cenere. “Sic transit gloria mundi!”. Il
lunedì di Pasqua, come da tradizione, noi ragazzi organizzavamo la solita gita a Castel di Mezzo, naturalmente a
piedi. Si partiva subito dopo pranzo portandoci la merenda: chi una mela, chi un pezzo di pane; i più fortunati una
fetta di pagnotta debitamente avvolta in un foglio di carta
gialla. La Via “Panoramica” ancora non esisteva. Si attraversava il Tavollo al Ponte; a valle c’era anche il traghetto, la
barca di “Macaron”, ma costava cinque lire e non tutti erano
disposti a spendere quella cifra. Si prendeva di petto la
collina, si costeggiava il cimitero, si aggirava l’abitato di
Gabicce Monte e si proseguiva lasciando sulla sinistra la
Vallugola., dopo circa un chilometro si arrivava finalmente
alla meta. Durante il tragitto era quasi un obbligo fermarsi
nei campi coltivati “a luvèn”, contadini permettendo, a raccogliere una vera ghiottoneria: i lupini. Per spiegare cosa
sono alle nuove generazioni passo la parola al Vocabolario:
“pianta erbacea commestibile, con fiori in grappoli, dal
biancastro al violaceo, utile come foraggio”. Era cibo per
animali ma molto apprezzato anche dal …genere umano!
Erano soprattutto le ragazze che si adoperavano a raccoglierne a mazzi; ne facevano poi gentile omaggio a conoscenti, parenti ed a certi amici “particolari”. Era una delle
poche occasioni che avevano per dimostrare che la simpatia era reciproca. Bisognava però fare attenzione a non
mangiarne troppi altrimenti un bel mal di pancia era assicurato. Nello spazio di poche decine di metri si svolgeva la
classica festa paesana: bancarelle, rivendite di dolciumi,
palloncini, bibite. Due cose erano quasi obbligatorie da
74
comprare: la pallina di panno e il fischietto rosso. La pallina di panno piena di segatura, legata ad un lungo filo elastico, si tirava, colpiva e ritornava indietro e dava la
possibilità di fare piccole battaglie tra di noi, ma soprattutto di colpire quei gruppetti di ragazzine che, a mo’ di invito, fuggivano ancor prima che noi facessimo trapelare le
nostre intenzioni. Facevano finta di irritarsi se noi le centravamo: ah! le femmine! Il fischietto rosso era di zucchero
filato e già dopo due o tre fischi veniva inesorabilmente
schiacciato con i denti e mangiato. Nella festa di Castel di
Mezzo va ricordata la sala da ballo. Era una stanza di circa
20 metri quadrati, aperta per l’occasione e attrezzata con
un grammofono e 3 o 4 dischi. Il biglietto costava, se non
vado errato, sulle 10 lire e dava il diritto di ballare per
un’ora. Come si faceva alla scadenza dell’ora a fare uscire
il cliente? Semplice! All’entrata si legava al passa-cinta dei
pantaloni (le donne non pagavano) un nastrino che cambiava colore a seconda dell’ora di ingresso. Ogni 60 minuti due uomini con un filo in mano steso da parete a parete,
partivano dal fondo verso l’uscita; chi aveva finito il tempo
veniva invitato a uscire e gli altri, passando sotto la cordicella, potevano continuare a ballare. Altri tempi! Si scendeva poi alla “Bassa”, poche case all’incrocio con la via
Flaminia e per la stessa strada si tornava a casa. I più spavaldi cercavano un passaggio sull’asse posteriore delle carrozze che facevano servizio per Cattolica. Quasi sempre
però il vetturino se ne accorgeva e con due schiocchi di
frusta faceva capire al “clandestino” che non era il caso.
Alla sera, stanchi morti ma felici, avevamo qualcosa di nuovo da raccontare. Se la frase “è ladro chi ruba come chi
tiene il sacco” è vera, penso però sia giusto concedere al
secondo almeno le attenuanti generiche. Non è stato così
nel mio caso. Anzi, condannato senza processo, ho dovuto
75
pagare i danni che non avevo arrecato: la giustizia umana!
Ma veniamo ai fatti. Era il 2 novembre del 1947 e la maggior parte dei cattolichini si era recata al cimitero in due
schieramenti ben distinti. La politica imperava su tutto anche sulla commemorazione dei defunti. Il corteo della sinistra, comunisti, socialisti e anticlericali partiva dal Comune
con la banda musicale in testa, sventolio di bandiere e
giunto al cimitero, Salvatore Galluzzi, presidente della Cooperativa dei pescatori, teneva con la sua prosa efficace un
breve discorso. L’altro gruppo formato da clericali e da
persone che oggi definiremmo di centro-destra, partiva circa un’ora dopo dalla Chiesa di S. Pio V con un crocifisso,
l’arciprete e due chierichetti. Giunto alla meta, nella chiesetta del cimitero veniva celebrata la S. Messa. Nel primo
gruppo il corteo era composto, salvo rari casi, tutto da
uomini. Nel secondo il gentil sesso era la maggioranza. Era
come detto il pomeriggio del 2 novembre: grigio, uggioso,
malinconico. Vincenzo Cecchini ed io vagavamo per le strade deserte in cerca di qualche avvenimento che potesse
ravvivare quella giornata. Arrivati in Piazza della Fontana
notiamo subito la nuova insegna al neon, tra i due leoni,
alla cancellata dell’Hotel Fulgida. L’amico mi dice mentre
cercava tra la ghiaia alcuni sassolini adatti allo scopo:
“Quanto vuoi scommettere che con due tiri ‘tiro giù’ quella
scritta?” Prima che potessi in qualche modo dissuaderlo,
tese la fionda e lasciò partire un colpo. Il caso o la sfortuna
volle che fece centro! Il rumore dei vetri rotti ci fece fuggire a gambe levate. All’ora di cena, la signorina Sormani,
proprietaria dell’Hotel Fulgida, bussò alla porta di casa mia.
La cameriera andò ad aprire. Lo zio, grazie a Dio, non era
ancora rientrato. Successe quel che voi certamente immaginerete: io che professavo la mia innocenza, la signorina
Sormani che accusava, qualche parola di troppo e la zia,
76
pur credendomi, per tacitare la cosa reputò opportuno pagare il danno richiesto: ventimila lire! Un’enormità per l’epoca. In quel periodo la famiglia Ponti, originaria di
Alfonsine, si trasferì a Cattolica. Prese casa in via Bovio al
numero 64 presso la famiglia Ferretti, stimati falegnami. Il
padre Otello, impiegato alla Montecatini di Ferrara, per
motivi di lavoro era sempre in viaggio. La madre, della
quale non ricordo il nome, era una piccola donna debole
ed inoffensiva, sempre alla ricerca del suo Davide, un ragazzo nostro coetaneo, troppo buono e docile per quei
tempi, ma soprattutto per la nostra banda. Capimmo subito
che sarebbe stato un ottimo pollo da… spennare, venne
quindi coartato nella compagnia: aveva un aspetto gradevole ma la testa risultava un po’ troppo coriacea…usando
un eufemismo: un giorno riuscì ad abbattere persino un
muro nella cancellata di cinta dell’Hotel Fulgida. Eravamo
intenti a giocare nel giardino di quell’albergo, avendo fatto
amicizia con il figlio del custode dal curioso nomignolo di
“spinaci”, quando ad un tratto apparve la sig.na Sormani:
fu un fuggi fuggi generale… il nostro Davide nel tentativo
di sottrarsi alla cattura, caricò a testa bassa un buco nel
muro pensando di riuscire a passare ma il risultato fu ben
diverso: il manufatto gli crollò addosso. La fortuna venne
in suo aiuto e ne uscì malconcio ma illeso. Le sue prime
parole furono: “meno male che ho usato la testa!”. La proprietaria non volle sentire ragione e pretese che fosse ricostruito ciò che era andato distrutto, la madre, data la non
felice situazione finanziaria, credette opportuno fare da
sola. Il giorno dopo, sotto la supervisione della Sormani, si
mise all’opera armata di cazzuola e calcina. Riuscì, non
senza fatica, nell’intento: il danno era stato riparato! A dire
il vero avemmo tante volte la possibilità di testare “in corpore vili” la durezza di quel cranio, ma per carità di patria
77
78
preferisco passare oltre. Vincenzo Cecchini, prodromo di
quello che sarebbe stato capace di fare in seguito, scrisse
in suo onore un componimento poetico, che recitava così:
Mato Popone aveva la testa dura,
più grossa di una angura
più forte ancor del ferro
ha rotto anche un cancello…
e qui la memoria non mi conforta oltre!
Nell’estate i fratelli Cecchini ed io avemmo una bella idea,
che se fosse andata a buon fine, avrebbe rimpinguato le
nostre scarse finanze: mandare Davide sulla spiaggia a vendere i nostri giornalini usati. A quei tempi andavano per
la maggiore Topolino, Mandrake, Cino e Franco, Gordon
e L’Uomo Mascherato, di quest’ultimo Vincenzo ne era un
accanito lettore. Alla nostra vittima avremmo riconosciuto
poi, un bonus dell’1 % sulle vendite, ma non avendo raggiunto le 100 lire dategli come obbiettivo (ne raggranellò
solo 80), non gli venne riconosciuto alcun benefit, in me
circolava già sangue “bancario”! Per racimolare comunque
qualche soldo passammo ad un’altra iniziativa , per noi
molto più impegnativa:era da poco passato a Cattolica un
“carro di Tespi” con i suoi spettacoli teatrali ambulanti. Ne
cogliemmo lo spunto culturale e, mettendo in pratica un
estro creativo senza uguali, riuscimmo a predisporre tutto
il necessario per il buon esito di una nostra rappresentazione. Nel giardinetto di casa Cecchini con quattro pali
ed un grande panno rosso montammo un qualcosa che
assomigliava ad un palcoscenico, aggiungendo poi 8 sedie
a disposizione degli spettatori paganti. Dopo poche prove
di un raffazzonato canovaccio, mettemmo in scena la prima in una domenica pomeriggio. I personaggi principali
79
erano: Topolino (Fabio), Pippo (Tonino), Gambadilegno
(Sante Bondi “l’oriundo”) e Davide nei panni di Paperino,
con la regia di Vincenzo. Il copione prevedeva che, dopo
poche battute, Gambadilegno prendesse a bastonate Paperino (che era sempre la nostra vittima). Il cattivo si immedesimò talmente nella parte che nella foga fece crollare le
impalcature sugli attori. Ne sorse un gran trambusto e la
“direzione” credette opportuno sospendere lo spettacolo.
L’unico spettatore pagante, se non sbaglio 5£, era Marzotto, al secolo Alessandro Silvagni, si alzò sconsolato dicendo:”Burdel, avì fat schiv,l’era mej se andeva a cumpré un
zled da Anto!”. Anche questa iniziativa a scopo di lucro fu
un insuccesso ma… mancò la fortuna non il valore. Col
senno di poi devo ammettere con rammarico che abbiamo
troppo spesso abusato della bontà e della mitezza di quel
ragazzo. A distanza di tanti anni, ricordando quegli avvenimenti, provo ancora un certo disagio non disgiunto da un
senso di colpa. Dopo pochi mesi la famiglia Ponti si trasferì
e di Davide non sapemmo più nulla.
80
Tragica burrasca
Era il giorno di ferragosto del 1947, mi sentivo ormai grande, avevo 12 anni e frequentavo le scuole medie dalle suore a San Giovanni in Marignano. Prendevo l’autobus per
il ritorno nella via principale di quel grazioso paese. Una
diceria, non provata da testimoni, racconta che nei tempi
andati avessero mangiato un tedesco! Da cui “sangianes
magna tedesch”, ma non tergiversiamo! Quell’automezzo
alquanto sgangherato, (la guerra era finita da appena due
anni) fermava proprio davanti al negozio di Nicola il cui
cognome non ricordo; era una di quelle botteghe molto in
voga fino alla fine degli anni sessanta, dove si poteva comprare un po’ di tutto: dai casalinghi ai generi alimentari e
merci varie. A me e agli amici della banda interessavano in
modo particolare, visto il nostro passato da “bombaroli”, le
bombette: piccoli fagottini di carta gialla legati strettamente con uno spago, con dentro un po’ di polvere pirica ed
alcune scagliette di pietra. Gettate a terra violentemente
scoppiavano con un gran frastuono. Noi avevamo imparato
a lanciarle con la fionda ed il risultato era entusiasmante!
Non altrettanto contenti, credo, dovevano essere gli abitanti
di quelle case i cui portoni erano, di notte, bersaglio dei
nostri tiri. Dunque….era il giorno di ferragosto, un pome-
81
82
riggio molto afoso ; Manen, Sandren, Fabio, Tonino ed io
decidemmo di andare a piedi fino a S. Giovanni per rimpinguare le scorte di bombette che si erano azzerate nelle
“incursioni” del giorno prima. Ci incamminammo di buon
passo ma giunti sotto il ponte di ferro si scatenò il finimondo: un vento violentissimo misto a polvere, stracci, sedie,
cartelloni e tutto quello che non era solidamente fissato ci
investì in pieno. Appena ripresi dalla sorpresa, riparandoci,
per quello che potevamo, la testa con le braccia, ci mettemmo a correre verso la Via Fiume. I miei amici presero poi
per Via Matteotti e andarono verso casa. Io continuai verso
la spiaggia perché, lì al pontile, era attraccato il cutter di
Savio Maestri che faceva servizio per i turisti. Enzo era a
bordo come mozzo e per questa ragione non era potuto
venire con noi. Purtroppo quello che avevo sospettato si
era avverato: Savio non aveva fatto in tempo ad ammainare
la vela stando per partire per una escursione. La barca si
era rovesciata di lato, i gitanti caddero in acqua, purtroppo
quella tempesta volle il suo tragico tributo: un bambino
non ce la fece ed annegò miseramente! Il mio amico se l’era
vista proprio brutta, aveva rischiato la vita! Ma si salvò aggrappandosi al pennone ed aspettando i soccorsi. Alla sera
mia zia, per cercare di sollevargli un po’ il morale e fargli
dimenticare quel triste episodio lo invitò a cena e poi ci
pagò l’entrata ad uno spettacolo di burattini che si svolgeva
nell’allora terreno retrostante all’odierno complesso “Nettuno” che poi divenne una sala cinematografica all’aperto
(p.s. Le bombette costavano 2 lire l’una).
Con queste ultime righe si chiude la stagione della banda di Via
Bovio. Altre “CURIOSITÀ” e altri “PERSONAGGI” calcheranno
ancora la scena del teatrino dei miei ricordi.
83
Curiosità
85
Ciccio, “al macàc dla Rudi”
Volevo iniziare queste mie brevi note che mi fanno tornare,
con grande nostalgia e tenerezza, ai tempi della giovinezza,
tempi, per molti, difficili, duri e di miseria quando calzare
perfino un paio di zoccoli d’estate era considerato un lusso
.Volevo iniziare con la frase “In quel tempo…” ma qualcuno
avrebbe potuto pensare che fossi un megalomane, allora ripiego su “C’era una volta….”ma anche in questo caso avrei
potuto porgere il fianco a delle critiche tipo “non sarà tutto
inventato?” A questo punto ho deciso: inizierò nel modo
più semplice. Era l’estate del 1942 in piena seconda guerra
mondiale. Avevo sette anni e già le prime avvisaglie della
catastrofe che si sarebbe abbattuta su di noi si incominciava ad intravvedere. Abitavo da diversi anni con gli zii, il
dottor Nereo Rudi e la signora Venerina Brancia Rudi nella
loro villa di Via Bovio che allora si chiamava Via Principe
di Piemonte. Una villa più che signorile, dotata di tutti i
comfort che l’epoca poteva permettere, dal riscaldamento
centrale al giardino anteriore tenuto a regola d’arte ornato
tra l’altro da due bellissime palme, al vasto cortile posteriore con garage per due macchine, lavanderia ed un ampio
spazio scoperto dedicato ad un piccolo frutteto, ad un orto
coltivato con professionalità dal nostro giardiniere il buon
87
88
Natale Facondini. Mia zia era conosciuta come una persona
che portava un affetto particolare per tutti gli animali al
punto che i vicini, se ne trovavano uno, di qualsiasi razza
o taglia abbandonato in strada, glielo portavano sapendo
che sarebbe stato curato e custodito. Le conseguenze furono che in questo periodo il nostro “zoo” comprendeva: 5
cani, 23 gatti, una voliera con decine di uccelli anche rari
ed esotici, galline, oche , anatre, un camaleonte, sì, proprio
quell’animale decisamente poco bello che può cambiare
colore a seconda di dove si trova, ed una scimmia….e qui
comincia la nostra storia.
Il figlio dei marchesi Campanelli, nostri amici di famiglia,
ufficiale pilota della Regia Aeronautica, in licenza dal fronte libico, ci portò, conoscendo il debole di mia zia, una
giovane scimmietta, un maschio di razza “cercopiteco grigioverde”, una cosina di appena 40 cm. di lunghezza, tutta
simpatia, intelligenza, furbizia, ma soprattutto dispettosa. Si
ambientò subito e per dimostrare la sua amicizia, quando le
era possibile si sedeva sulle nostre ginocchia e con quelle
manine che sembravano umane ci frugava tra i capelli cercando improbabili piccoli insetti.
Per dormire, Bonci il falegname, le aveva costruito una
piccola casetta in legno con un oblò ed una porticina che
si poteva chiudere dall’esterno. Le prime uscite della zia
con la scimmia al guinzaglio, che a differenza di quello dei
cani veniva messo sotto l’ombelico appena sopra l’attaccatura delle zampe al corpo, destava in tutto il viale una
curiosità quasi morbosa, un misto di sorpresa, meraviglia
e stupore:” Ven ven a veda, che i’è la sgnora Rudi che la
porta a spass al macac!”(Vieni a vedere che c’è la signora
Rudi che porta a spasso la scimmia) In casa, perché non
facesse troppi danni, qualche volta la legavamo con una
leggera catenella alla gamba di un tavolo o al filo dei panni
89
in cortile; ma spesso riusciva a liberarsi e allora erano guai
….per i vicini. Noi ce ne accorgevamo subito dalle grida
delle donne e dal tono della voce mia zia riusciva a capire
quale casa aveva “visitato” e allora mi chiamava e diceva:
“Va a prendere Ciccio, il nome che gli avevamo dato, che è
dalle Gagie (sorelle Benvenuti) oppure è dalle Baiuchinie
(signore Mecchi-madre e figlia ). I dispetti che faceva erano
all’ordine del giorno. Una volta seduto al caldo vicino alla
stufa, dove bolliva un cappone per il brodo, riuscì a prenderlo per una zampa che usciva dalla pentola, lo trascinò
alla finestra e con tutte le sue forze lo gettò in strada. Mia
zia lo venne a sapere solo quando suonò il campanello e
andata ad aprire la porta, apparve un uomo che disse: “Signora, è suo questo pollo? L’ho visto volare dalla finestra!”
Ciccio aveva una particolare antipatia per i biondi e quando
ne incontrava uno qualche dispetto ci scappava. A mio fratello gli saltava addosso e con le sue piccole dita, l’indice e
il pollice, gli strappava ad una ad una le ciglia degli occhi;
lui, impietrito, non osava ribellarsi e solo quando arrivavo
io il supplizio aveva termine con la fuga della bestiola che,
sapendo di avere fatto una marachella, si andava a rifugiare
nella sua casetta.
Circa due anni dopo, nell’inverno del 1944/45, appena passato il Fronte, gli inglesi allestirono un ospedale per la
popolazione civile, ubicandolo nell’albergo Gambrinus in
Viale Mancini dove attualmente c’è l’omonimo bar e altri
negozi, che era di proprietà della famiglia Pini Domenico
(Manghin). Mio zio era stato nominato primario e la prima
cosa che fece fu di disporre l’ambulatorio e la sala per brevi
degenze al piano terra ed ai piani superiori gli ammalati
che abbisognavano di cure più particolari. La mia famiglia,
gli zii, io e la scimmia, prese come abitazione una camera
al primo piano con balcone, che ancora esiste, proprio
90
sull’angolo dello stabile. Naturalmente Ciccio era sempre al
centro dell’attenzione. Una volta riuscì ad intrufolarsi tra gli
ammalati non certo avvezzi a veder saltare una scimmia tra
un letto e l’altro; alcune grida attirarono l’attenzione dell’infermiere, il bravo Mario Furiassi, che con la sua andatura
un po’ claudicante cercava inutilmente di prenderla. Arrivò
mia zia che la prese e dopo due sculacciate la rinchiuse
nella sua casetta che in quel periodo era nel corridoio del
primo piano. All’ora di cena eravamo tutti in cucina ad
aspettare che si scaldasse la solita scatoletta di carne fornita da un soldato irlandese con cui avevamo fatto amicizia. Ad un tratto un urlo!!!! Poi:” Manghin, Manghin,dutor,
dutor….”(Domenico,Domenico, dottore, dottore)Ci precipitiamo tutti su per le scale e vediamo un paziente con una
gambe ingessata e i capelli dritti per la paura che cercando
di scendere urlava:”i’è un fantasma, i’è un fantasma, andè
a ciamè al pret!”(C’è un fantasma, andate a chiamare il
prete) Manghin e lo zio si fecero coraggio, salirono in fretta
i pochi scalini rimasti e….si trovarono davanti Ciccio, che,
dentro la sua casetta, aggrappandosi con le mani all’oblò
e scuotendosi con tutte le forze, la faceva saltellare. Il malcapitato non sapeva cosa vi fosse dentro! Quella volta finì
tutto in una risata generale.
Di fatti curiosi e simpatici ce ne sarebbero tanti altri ma la
paura di annoiare il mio gentile lettore mi dice di fermarmi
qui. Di quegli episodi qualcosa è arrivato fino a noi, almeno per le persone di una certa età e che parlano ancora il
dialetto ed è la frase “tfè piò att tè ca ne al macac dla Rudi
(fai più smorfie tu che la scimmia della Rudi)” .
Per finire lasciatemi dire che di quella scimmietta mi è rimasto un gradito e nostalgico ricordo anche perché legato
alla più bella delle età della vita: la giovinezza.
91
Lo scherzo
Spesso andavo a trovare i miei genitori, come ebbi già modo
di accennare gestivano dalla metà degli anni ‘30 l’osteria “dalla
Gina” ubicata nella piazzetta ora intitolata proprio a lei, mia
madre. Il piccolo locale era frequentato da una clientela modesta principalmente di marinai e operai, gente umile con poca
cultura, ma di sani principi e tanta umanità. Questo però non
impediva a qualcuno di fare degli scherzi agli amici anche un
po’…..macabri! Ricordo un giorno appena dopo pranzo, all’appuntamento per bere “un quarten o un mez” e giocare, con
rara maestria, una partita a briscola e tresette. Capitato lì per
caso, fui spettatore di uno scherzo che Parelo, al secolo Angelo
Cerri, stava per fare a Battistini (il nome non lo ricordo) detto
Svezzera. Doveva il suo soprannome al fatto che aveva lavorato duramente per tanti anni nel paese elvetico. Tutto iniziò con
poche battute: “Svezzera, l’è riv al circle Togni!” “Embè?”rispose
il malcapitato.”Coh! An tal sé? I cerca i vec invurnid da dè da
magnè ma i liun; i pega ben: i dà diesmela french mai fiol e i
dà anche i pan indrè!” A questo punto intervenne un complice,
Chelotti (al zop ad Chicac): “L’è vera! Anche al mi bà al va so
dmena matena, v’è, i m’ha dè mille lire di caparra!” Disse la
cifra in italiano per dare maggiore enfasi alle parole, mentre
tirava fuori dalle tasche un po’ di soldi e aggiunse: “i pan ai vag
92
a tò dmena sera!” “Na, me an vag!” disse il poveretto. Parelo ripetè pronto:” Ant capes gnint! Intent t’avrè se e na qualche mes
da campè e po sa chi sold i tu fiol i magna per un mes. E i pan
indrè? It dà anche i pan indrè tla vo capì?” “Naaaaa! Me an vag.
An voi savè gnint!” rispose sempre più confuso il vecchio. “Tzè
propie na bamboza” replicò Parelo. A questo punto intervenne
mia madre:”Burdel, ades basta! Fela fnida!” disse, malcelando
un sorriso e facendo l’occhiolino al “gatto e la volpe”. “Se an vò
andè l’è afar sua. Smitila i chè!” Una sonora risata scoppiò tra
gli avventori che nel frattempo si erano avvicinati alla vittima
che non avendo capito lo scherzo, a testa bassa continuava a
ripetere “Intent me an vag, na an vag!”.
93
Il tritolo
Il tritolo, per chi non lo sapesse, era il più potente esplosivo di quei tempi. Non era adatto per i proiettili, ma indicato
soprattutto per fabbricare bombe, mine, sia terrestri che
marittime e far saltare in aria tutto quello che c’era bisogno in ambito militare. Nel 1945/46 veniva usato anche a
Cattolica, in piccoli panetti rivestiti di carta catramata del
peso di circa duecento grammi, dagli artificieri delle forze
armate italiane per far esplodere le mine che spiaggiavano
nel nostro territorio. Il procedimento era abbastanza semplice, innanzitutto si suonava la sirena situata nel palazzo
comunale (un lungo ululato) in modo che i cittadini che
abitavano nei dintorni si potessero allontanare, non prima
però di avere aperto tutte le imposte delle loro case, così
i vetri delle finestre non si rompevano per lo spostamento
dell’aria. A questo punto l’artificiere applicava all’involucro
esterno (ricordate quelle sfere d’acciaio di circa un metro
di diametro con tutti quegli speroni, i detonatori, viste in
tanti film di guerra? beh, erano quelle!) una carica di tritolo, poi con un comando a distanza, faceva esplodere tutto
causando un immane boato udibile a parecchi chilometri
di distanza! In una di queste occasioni, la mia villa, situata
nell’allora Via Principe di Piemonte 19, fu completamente
94
bagnata dall’acqua di mare scaraventata lì dallo scoppio di
uno di quegli ordigni ed una scheggia della grandezza di
un piatto si fermò davanti al portone di casa! Tutto questo
preambolo per raccontare che un giorno, Enzo ed io, al
porto, non dico né come né dove, riuscimmo a “rimediare” una dozzina di panetti. Il tritolo aveva una peculiarità:
esplodeva solo se era innescato con uno speciale detonatore. Noi non lo avevamo, provammo però in tutti i modi,
naturalmente con le dovute cautele, ma niente da fare. Lo
grattugiammo, lo riducemmo in scagliette, provammo con
la polvere da sparo, gli abbiamo dato anche fuoco, bruciava
lentamente facendo un fumo denso ed acre ma niente da
fare, non voleva esplodere! Finché ci siamo stancati e decidemmo di disfarcene. Lo avremmo venduto. Il tritolo aveva
a quei tempi un certo valore ed al mercato nero spuntava
un buon prezzo, veniva usato per la pesca di frodo. Trovammo subito un acquirente: un bagnino appartenente ad
una vecchia famiglia di pescatori. Per la cifra di 500 lire,
quella piccola santabarbara passò di mano. Enzo ed io ci
dividemmo poi in parti uguali il ricavato.
95
I capodogli
Il ricordo che più si addentra nei segreti meandri della mia
memoria, è senz’altro lo spiaggiamento di sette capodogli
ancora vivi , avvenuto il 12 Aprile 1938, a Senigallia. Allora
fu veramente un avvenimento, tutti ne parlavano e naturalmente ad ogni passaparola le gigantesche dimensioni
di quei cetacei crescevano a dismisura, perfino l’EIAR (la
RAI di allora) ne diede notizia nei suoi radiogiornali. Mia
zia, dato il suo amore per gli animali di qualunque genere,
non poteva lasciarsi sfuggire questa occasione. Mi prese
in braccio, mi sistemò sul sedile posteriore della Topolino
e partimmo. All’arrivo sul litorale di quella bella cittadina
marchigiana, lo spettacolo che ci si presentò fu veramente
affascinante: sette enormi bestioni giacevano ormai inermi
sulla spiaggia. Uno, il più grosso, aveva la grande bocca
spalancata, dalla quale spuntavano massicci denti minacciosi. Data la mia tenera età (avevo appena tre anni), ricordo solo quella bocca e quei denti. Il resto è il frutto dei
racconti della zia negli anni che seguirono. Quei miseri
resti, almeno così mi dissero, finirono in una fabbrica di
sapone. Come curiosità posso aggiungere che vi furono diversi spiaggiamenti di questi animali nell’Adriatico. I primi
di cui si abbia memoria risalgono al XVI secolo in Ancona,
96
gli ultimi nel dicembre del 2009 in Puglia. In definitiva un
sorprendente spaccato sul rapporto tra una delle specie di
cetacei più enigmatiche ed affascinanti (anche la celeberrima Moby Dick era in realtà un capodoglio) ed un piccolo
mare che sa sempre stupirci.
97
I veglioni
Nella nostra vecchia Cattolica avvenimenti speciali erano
anche i “veglioni”. Ho sempre creduto utile ed opportuno,
oltre a narrare le avventure di un gruppo di bambini, anche
raccontare le abitudini, il comportamento ed il modo di
vivere della gente in un contesto particolare come quello
della nostra cittadina in quei tempi. Allora quasi tutto era
vissuto in un’ottica politica. Il lavoro, il divertimento. Lo
svago erano spesso prerogative dei partiti politici. Questo
ovviamente per cercare consenso, fare presenza sul territorio ed al limite dimostrare la propria “forza”. Gli animi
erano inaspriti ed ogni occasione era buona per rimarcare,
anche rumorosamente, il dissenso nei riguardi di chi la
pensava diversamente. Questo accadeva anche nelle sale
cinematografiche. Al teatro Zacconi prima dello spettacolo
veniva proiettata “la settimana Incom”, il notiziario che precedeva sempre il film. Bene! Se appariva la figura di Papa
Pio xii o del Presidente del Consiglio Alcide de Gasperi,
iniziava una sarabanda di urla, fischi, invettive innominabili
all’indirizzo di quei personaggi obbligando, qualche volta,
il proprietario Adriano Binda ad accendere le luci e sospendere lo spettacolo finchè gli animi non si fossero placati.
Con questo non voglio certamente demonizzare tutta una
98
certa parte politica, che tra l’altro rappresentava allora ben
oltre il 60% dell’elettorato cattolichino . Era il frutto dei
tempi! Io ho solo l’immodestia di voler attestare, spero da
testimone super partes, certi avvenimenti. In questo clima
sociale spesso erano gestiti anche i veglioni. Erano serate
danzanti, la quintessanza del divertimento. Si svolgevano
solitamente dalla fine dell’anno alla Quaresima (in questo
periodo era oltremodo disdicevole partecipare a certi svaghi!) Anche i partiti partecipavano ben volentieri a questo
tipo di “business” per farsi notare, ma soprattutto per rimpinguare le loro sempre esauste casse. I più noti erano: “il
veglione dell’Edera” organizzato dal Partito Repubblicano
di cui Francesco Cermaria era l’anima. “Il veglione del Garofano Rosso” coordinato da Giovanni Gentilini, segretario
politico del Partito Socialista. “Il Veglione dello Sport” organizzato dalla locale Polisportiva. Quest’ultimo si svolgeva
o nella sala della parte nuova dell’Hotel Kursaal o, debitamente attrezzato allo scopo, al Cinema Cielo. Negli anni
cinquanta, a queste serate ho partecipato anche io con alcuni amici, eravamo infatti all’epoca le speranze del calcio
cittadino (gratis naturalmente). Mi piace ricordare anche
l’esclusivo “Veglione delle Mimose” e quello degli “Albergatori” dove le signore bene della nostra cittadina e dei paesi
vicini avevano modo di sfoggiare tutta la loro eleganza in
una atmosfera di buon gusto. Nei grandi capannoni dello
stabilimento Arrigoni, a farne memoria è rimasto solo l’enorme camino, si svolgeva invece a cavallo degli anni 40/50
il popolare veglione della “Stella Rossa”, organizzato dal
locale Partito Comunista. Qui si poteva toccare con mano la
grande forza organizzativa che riusciva a mettere in campo
quel partito. Per molti lavoratori, che prestavano gratuitamente la loro opera per predisporre tutto il necessario alla
riuscita della manifestazione, rappresentava più che una
99
fede politica una vera religione. Vi era la gigantografia di
Stalin o di Mao Tse Tung, ogni tanto due orchestre vi suonavano “Bandiera Rossa” e…..anche se non si era troppo
d’accordo, una capatina quella sera si doveva fare. La cena
e le bevande (ovviamente alcolici) si potevano portare da
casa. Il prezzo del biglietto era veramente “popolare”; si
può quindi facilmente immaginare l’enorme successo della
serata. Partecipavano famiglie intere. Preso posto, stendevano le tovaglie (chi le portava) sui tavoli e imbandivano
le mense con ogni ben di Dio: enormi tegami di brodetto
di canocchie, “garagul”, “bes”(lumachini ), ciambelloni, crostate ed una distesa di fiaschi di vino. Per una volta tanto
non si badava a spese! Era vera allegria e per una serata
si dimenticavano tutte le difficoltà della vita quotidiana.
Gente allegra, di cuore e di grande compagnia. Era bello
fermarsi, accettare l’ospitalità, ma soprattutto….il vino che
veniva offerto sempre con grande generosità. Se è vero
che tutti i salmi finiscono in gloria, è altrettanto vero che
dopo quelle abbondanti libagioni , alle quali non si poteva
dire di no, si finiva sempre con l’intonare a squarciagola
le belle canzoni della vita marinara. Era insomma più una
sagra paesana che non una serata danzante. La Democrazia
Cristiana credeva opportuno non organizzare eventi simili
anche perché la gerarchia ecclesiastica di quei tempi non
avrebbe certo approvato l’iniziativa. A questo punto permettetemi di fare una confessione, rimanga però tra noi,
visto il mio trascorso democristiano: ebbene sì … anche io
ho partecipato qualche volta al veglione della stella rossa!
100
Un pomeriggio da s…ballo
Quando si parla di balli, un piccolo salto con la memoria
nei primi anni cinquanta è d’obbligo. La compagnia era
cambiata, vuoi per gli studi che avevamo intrapreso, vuoi
per certi interessi che incominciavano a diversificarsi. L’amicizia nei riguardi della vecchia compagine era comunque
rimasta inalterata, solo la frequentazione ne aveva sofferto.
Si erano allontanati: Enzo, Manen e Sandren, ma avevamo
acquisito tanti nuovi amici, tra cui: Aldo Calbi, Lino Franchini (Limon), Giacomo Frontini (Peledo), Giancarlo Denicolò (Zafaren), Adelio Ercoles (Macaron), Andrea Molari,
Manlio, Marcello Morosini (Scucia) e Paolo Bondi. Eravamo
molto affiatati e il tmepo libero lo si passava principalmente sui campi da calcio (giocavamo nelle giovanili del Cattolica) o al bar della Domus Nostra, gestito dalla famiglia
Staccoli supportato dalla dirimpettaia Parrocchia. I maligni
asserivano, a quei tempi, che era nato anche in antitesi
al “Cremlino” di via Costa, di evidente diversa estrazione
politica. In proposito sono d’accordo con l’on. Andreotti
quando affermava che “a pensar male si fa peccato ma
spesso si indovina”. Con “l’altra metà del cielo” invece le
cose non andavano molto bene, avevamo la nomea di bravi ragazzi ma purtroppo timidi e impacciati e gli approcci
101
lasciavano sempre alquanto a desiderare. Per affrancarci
da questa imbarazzante situazione Lino e Peledo, i più intraprendenti tra di noi, pensarono bene di organizzare la
domenica pomeriggio qualche festa da ballo. Alla sera era
impensabile che le ragazze uscissero di casa! La “prima” si
svolse, se non ricordo male nella sala da pranzo dell’hotel
Corallo in via Carducci. Era gestito a quei tempi dalla famiglia Dei, la figlia Mara sposerà poi Vincenzo Cecchini. Tra
le ragazze invitate c’erano, oltre alla succitata Mara: Piera
Colosio, Enrica Galli, Ebe Bianchini e Olga Cervesi. Suppliva l’orchestra un vecchio grammofono a manovella portato
da Giancarlo. Era un regalo, coordinato con alcuni dischi,
fatto negli anni trenta dagli zii d’America. Al rinfresco voleva pensare sempre Peledo: due bottiglie di Vermotuh e due
vassoi di pasticcini, alcuni maligni asserivano che questa
incombenza gli permetteva di fare la cresta sulla spesa.
Anche in questo caso si trattava solo di invidia e malcelata cattiveria! Si arrivava verso le quattro e le ragazze erano ovviamente accompagnate, quasi tutte, dalle rispettive
madri. Le signore venivano fatte accomodare in un punto
strategico, da dove avrebbero potuto tranquillamente controllare che tutto si svolgesse secondo le regole. Il tavolo
lo avevamo già imbandito con una bottiglia di Vermotuh ed
un vassoio di pasticcini. Lasciavamo le signore mamme alle
loro chiacchiere di donne che, vertevano certamente, sul
nostro comportamento e sulle nostre persone, lo si capiva
benissimo dai loro sguardi! A onor del vero devo ammettere che riscuotevo un buon successo presso le madri!
Il bello veniva quando iniziavano le danze: nessuno di noi
sapeva ballare, ma, grazie a Dio, le ballerine erano tutte
molto comprensive, piene di consigli e suggerimenti. Questo non ci esimeva però, dato il nostro impaccio dal farci
assomigliare agli attori delle migliori scene di fantozziana
102
memoria. Per noi ragazzi c’era anche una incombenza: sederci a turno vicino al grammofono e girare la manovella
ai primi sintomi di rallentamento della musica, non ci si
crederà ma quello era il posto più ambito da noi maschietti! Sul far della sera le signore si alzavano, era il segnale
che la festa era finita e si doveva rincasare. Peledo con le
sue battute era veramente impareggiabile nei commiati,
riusciva a strappare un sorriso alle madri ed alle ragazze
la promessa di un prossimo incontro. Una cosa era certa
però: la mondanità non era il nostro forte!
103
Personaggi
Attori involontari della vita quotidiana di
un paese tranquillo
105
Il buon dottor Rudi
Nereo Rudi, cittadino benemerito di
Cattolica
La stragrande maggioranza dei cattolichini, dato il tempo
trascorso, non avrà certo conosciuto il dottor Nereo Rudi.
Qualcuno ne avrà forse sentito parlare. Tanti, in età venerabile, ricorderanno sicuramente la sua distinta figura,
la bonarietà, il sorriso, la battuta pronta rigorosamente in
veneto, il proverbiale appetito e le conseguenti, in certe ricorrenze, pantagrueliche mangiate con i suoi marinai.
Possedeva una strana bicicletta di cui si vantava, con i pedali che invece di fare il solito giro circolare avevano un
movimento avanti-indietro. Alle persone che lo conobbero
dedico questo piccolo ma vivo ricordo. Nato a Cazzano di
Tramigna (VR) il 24/08/1890, si laurea in medicina e chirurgia nel 1915. Richiamato quale ufficiale medico nella
prima guerra mondiale, viene congedato nel 1918 per una
ferita alla spalla sinistra riportata in zona di guerra. Vince
un concorso da medico condotto e si trasferisce con la
signora Venerina a Cattolica nello stesso anno. Si fa subito
notare per la sua umanità e bravura, diventando in breve
tempo il medico di tutti ma in particolare dei pescatori e
107
della povera gente; sempre a disposizione dei pazienti di
giorno e di notte, 24 ore su 24! Se doveva andare in visita
in casa di povera gente che aveva il problema di coniugare
il pranzo con la cena, spesso sotto la ricetta che lasciava sul comò metteva il denaro necessario per comperare
le medicine! Succedeva spesso che qualcuno cercando di
compensarlo per la sua consulenza, gli offrisse un filone
di pane o delle mele o altre piccole cose che lui accettava
gentilmente per non mettere in imbarazzo nessuno. Allora non c’era il servizio sanitario nazionale! Seppe entrare
nel cuore della gente. Sempre alla mano, quando il suo
lavoro lo permetteva, frequentava volentieri il Caffè Roma;
memorabili le sue partite a scopa con Piccioni, il padre di
Wilmo. Nella sua carriera ebbe tanti attestati di gratitudine
che purtroppo andarono distrutti in un incendio. Morì improvvisamente il 18/11/1949 all’età di 59 anni lasciando un
vuoto incolmabile in noi famigliari e un sincero cordoglio
in tutta la cittadinanza. Il funerale, che si svolse il giorno
dopo, fu una manifestazione impressionante di dolore e
di lutto; praticamente tutta Cattolica vi partecipò. La bara,
portata a spalla, era arrivata al ponte di ferro che la coda
doveva ancora muoversi davanti alla Chiesa di S. PioV! Le
sue spoglie riposano accanto a quelle dei suoi genitori nel
paese natale. A perenne ricordo la zia fece erigere un cippo
commemorativo nel cimitero di Cattolica lungo il vialetto
che porta alla chiesetta. Negli anni ottanta il consiglio comunale lo dichiarò, “post mortem”, “cittadino benemerito”
e gli intitolò una via nelle vicinanze del campo sportivo.
108
Viale Bovio – Villa Dr. Rudi (poi Caffè Sirenella e gelateria Nuovo
Fiore)
Novembre 1949 – Funerali Dr. Nereo Rudi
109
Gagiot (Domenico Candiotti)
Il motto latino “nemo propheta in patria” si addice perfettamente a questo nostro compaesano, forse dimenticato dai suoi concittadini. Era un genio incompreso, aveva
una straordinaria manualità, non disgiunta da una grande
inventiva. Alcune sue opere sono ancora oggi visibili, a
testimonianza della sua abilità: la meridiana che troneggia
al centro della spiaggia, porta la scritta, in altro sopra lo
gnomone, “CANDIOTTI 1938”. A dire il vero quella odierna
è una copia perfetta dell’originale, andata distrutta qualche
anno fa durante i lavori di restauro a causa di un improvviso fortunale. Sono sue creature anche alcune maestose
aquile, scolpite nel cemento in via Curiel, tre delle quali
fanno ancora bella mostra di sé nella villa situata all’incrocio con via C. Battisti: una stringeva negli artigli una manciata di tagliatelle, ora perdute, un’altra aveva un enorme
capitone. Erano il segno distintivo della Pensione Aquila,
il cui nome è poi passato all’odierna pizzeria. La quarta
oggi orna il l’ingresso dell’Hotel Belsoggiorno in via Carducci. Mi fa ancora piacere ricordare (ne fui giovanissimo
testimone oculare ) l’increscioso incidente in cui incappò
il nostro personaggio nel tentativo di …camminare sull’acqua! Un giorno dei primissimi anni quaranta, un gruppo di
110
persone stava camminando verso la spiaggia, quando una
di loro mi chiamò: “ven a veda Paolo, ui è Gagiot cal vò fé
una dli su matedie”. Così mi unii a loro e raggiungemmo il
pontile. Diversi curiosi si erano già radunati intorno al nostro eroe che, incurante dei consigli degli amici – sta bon,
nu fa al mat – era intento a infilarsi ai piedi una specie di
enormi scarponi di gomma, precedentemente gonfiati con
una pompa da bicicletta, dalla vaga somiglianza ad una
barchetta di moscone. Impugnate quindi due racchetti da
sci infilate in due palloni l’estroso Gagiot si inoltrò fiducioso nel mare; fatte poche decine di metri, qualcosa non
funzionò, perse l’equilibrio e si capovolse. In quella non
invidiabile posizione rimase solo per pochi secondi. Alcuni
volenterosi si precipitarono in acqua riuscendo a riportarlo
a riva, spaventato ma salvo…non tutte le ciambelle riescono col buco! Si distinse invece in America Latina, dove
emigrò alla fine degli anni venti. Nel nuovo mondo ebbe
modo di manifestare tutto il suo ingegno. Aveva trovato lavoro come custode presso una fabbrica di prodotti tossici.
Per ovviare ai molti incidenti che colpivano le maestranze,
riuscì ad inventare un congegno di allarme così ingegnoso da meritarsi l’apprezzamento dei superiori. La società
poi, intuendo l’importanza di quel dispositivo lo brevettò,
dandogli il nome di “DOMINGO” (Domenico in spagnolo).
Gagiot morì nel 1943.
111
Altri personaggi
Ogni paese che si rispetti, almeno fino a sessant’anni fa,
aveva un suo personaggio speciale, oggi diremmo “diversamente sveglio” che, a sua insaputa, almeno così spero,
era al centro dell’attenzione non sempre benevola dei concittadini.
Scherzi e burle, qualche volta feroci, erano la norma. Il
malcapitato, suo malgrado, era il “passatempo” preferito di
tanti bambini e giovani sfaccendati. Cattolica, per non venire meno alla sua fama di Regina dell’Adriatico ne aveva,
statisticamente parlando più del dovuto. Alcune rugginose
malelingue riccionesi asserivano che non era solo questione del caso, della fortuna o di coincidenze astrali, ma il
fatto era da imputare ad un terreno più fertile che in altre
zone “dai meli nascono le mele” dicevano. Ai cattolichini
non rimaneva altro che rimandare ironicamente al mittente
certe basse insinuazioni, infatti il campanilismo fra le due
cittadine era feroce e ogni occasione era buona per mettere alla berlina l’avversario e farsi poi quattro risate fra i
complici al bar.
112
“Tajulen”
Tra gli originali e colorati personaggi ricordo in particolare Tajulen (il vero nome non l’ho mai saputo), un omino
buono e tranquillo che, nonostante fosse analfabeta e non
conoscesse la musica scritta, aveva una dote particolare:
con la sua piccola e vecchia fisarmonica riusciva ad orecchio a suonare tutto quello che gli si chiedeva con vera
maestria. Nelle calde serate estive era conteso dalle osterie del tempo, perché con le sue canzoncine divertiva gli
avventori, specialmente tedeschi, che allora arrivavano in
massa sulla nostra riviera. Non chiedeva mai un soldo a
nessuno, si accontentava di un piatto di “tajulen in brod”
(tagliolini in brodo) perché diceva “a n’ho al stomaga bon
pla pasta sota”. Dal suo piatto preferito derivò poi il soprannome.
Pierino dei calcinelli
Altro personaggio di rilievo di quel piccolo mondo di
“figli adottivi paesani” era Pierino dei calcinelli, rigorosamente in italiano. Anche questo modesto protagonista di
quel tempo passato doveva il suo nome al mestiere che
praticava. Con il suo attrezzo a forma piramidale detto
“ smenacul” a metà strada tra un rastrello ed un vaglio,
setacciava la sabbia con l’acqua fino alla cintola per pescare i “calcinel”: le piccole telline bivalvi dal colore giallo
chiaro molto apprezzate per il loro sapore delicato, vere
prelibatezze per preparare gustosi sughi per gli spaghetti.
Pierino dei calcinelli aveva un suo codice deontologico:
pescava solo dall’autunno alla primavera inoltrata perché, come diceva lui, “d’instè i n’è bon, i’ha al latt”. Per
ripararsi dai rigori invernali, nella sua semplicità, faceva i
“terzarul” ai calzoni, si levava le scarpe ed entrava in acqua vestito! Se qualcuno passando gli domandava: ”Ma an
113
tzent fred?” Rispondeva sempre con quella sua particolare
voce nasale che denotava già abbondanti libagioni: “Na,
me a ho al riscaldament interne” toccandosi contemporaneamente la tasca della “sacona” dalla quale spuntava
il collo di una bottiglia di vino. Spesso il frutto delle sue
fatiche lo portava a casa nostra. Suonava il campanello e
alla donna di servizio che apriva la porta diceva, levandosi
il cappello: “Ho port un rigal mal dutor”. La risposta era
sempre la stessa “ Aspettate qui che chiamo la signora”.
Mia zia appariva pochi secondi dopo, ringraziava: “Grazie
e tieni questa mancia!” Questo era l’unico modo per fargli
accettare del denaro. Affettuosamente il valore della regalia era sempre superiore al prezzo del pescato.
“L’ Albena”
L’Albena era una piccola donna sempre vestita di nero,
una via di mezzo tra una perpetua e un sacrestano. Viveva in una stanzina ricavata alla base del campanile delle
suore. Una delle sue incombenze era quella di suonare
alle sei del mattino, la campana per annunciare la prima
messa (il campanile di S. Pio V verrà inaugurato solo nel
1950). L’Albena era analfabeta e non avendo un orologio,
faceva riferimento per l’ora all’apertura del panificio della
confinante famiglia Talacchi. Un giorno Giustin, il fornaio, famoso anticlericale e magnifico bestemmiatore, volle
farle uno scherzo: finse di aprire il forno alle tre di notte.
La povera donna, non sospettando nulla, come sempre
si alzò e incominciò a suonare la campana. Successe il
finimondo! Quei rintocchi a quell’ora volevano dire: o un
incendio o qualcosa di estremamente grave. Le finestre
di Via Pascoli incominciarono ad aprirsi e ad illuminarsi,
la gente preoccupata si chiedeva e interpellava i vicini
su cosa fosse accaduto, ma nessuno sapeva dare una ri-
114
sposta. Alla fine si venne a capo del mistero: la colpa era
“dla pora Albena”. Lascio immaginare tutte le contumelie
possibile e….irripetibili che dovette sorbirsi la poveretta.
Passati i bollori e il trambusto tutti tornarono a letto. L’unico ancora alzato che se la rideva con quei suoi dentoni
alla Fernandel era il vero colpevole: Giustin!
Mimmo
Racconto questo episodio solo quale testimonianza del
clima umano di un certo periodo della nostra esistenza,
più che una semplice cronaca di vita vissuta. Mimmo era
un giovane con gravi problemi mentali. Di lui non so il
vero nome né a quale famiglia appartenesse, ma ricordo
che si diceva che fosse molto modesta. C’era una cosa che
disturbava e sconvolgeva nel vero senso della parola, la
personalità di quel ragazzo: il fischio! Se sentiva qualcuno
fischiare, e c’era sempre un dispettoso o un incosciente
pronto a farlo, si trasformava da ragazzo tranquillo in un
essere violento e incontrollabile. Aveva due qualità che
per noi bambini erano grossi problemi: correva velocemente ed era bravissimo a tirare sassi. Se inavvertitamente
ci trovavamo nei paraggi del fischio dovevamo tenerci
sempre a debita distanza e alla prima occasione, possibilmente senza dare nell’occhio, darcela a gambe levate. Era
un essere umano e noi lo accettavamo per quello che era:
uno dei tanti rischi che dovevamo affrontare ogni giorno da soli. Anche in questo caso fare il raffronto con gli
iperprotetti bambini di oggi non sarebbe giusto ma solo
superfluo. Che fine avrà fatto quel ragazzo? Non l’abbiamo
mai saputo, molto probabilmente sarà stato rinchiuso in
uno di quei lager che allora chiamavano manicomi.
115
La strega
Questa donna era una povera mendicante: alta, magra, vestita di stracci che la coprivano fino alle caviglie. Camminava claudicando, facendo finta di essere storpia. Si aiutava
con una stampella che altro non era che un lungo bastone
con una forcella a “V” dove appoggiava l’ascella. Era vittima
purtroppo delle nostre “attenzioni” che finivano sempre allo stesso modo con il grido “strega….strega!” La sua reazione era sempre commisurata alla qualità dei nostri scherzi:
il lancio di un sasso o, nei casi più gravi, della sua stessa
gruccia. Noi non stavamo certo ad aspettare le sue reazioni,
ma alle prime avvisaglie lesti, fuggivamo in tutte le direzioni inseguiti dalle stregate maledizioni della vecchia donna.
Ora ripensando a quelle bricconate devo ammettere che mi
sento un po’ a disagio.
“Gianlori”
Esile, mite, inoffensivo, ma sempre ubriaco era Gianlori,
uomo dai piccoli occhi cisposi. Le sue sbornie rispecchiavano il suo carattere tranquillo. Di lui purtroppo non rammento neanche il vero nome, tantomeno qualche aneddoto
che lo possa riguardare direttamente. Perdere il ricordo di
qualcuno è sempre triste e quando questi ricordi servono
per far “rivivere” una persona, per me è ancora più triste,
quindi mi farebbe piacere sapere che qualche mio concittadino ha la possibilità di protrarre nel ricordo il personaggio
di Gianlori e scrivesse di lui.
Lo stagnino
Era un personaggio importante per quei tempi in cui non
si buttava via niente. Accomodava tutto: dai piatti ai tegami, dagli ombrelli a tutti i piccoli utensili utili in una casa.
Soldi non ne circolavano e bisognava risparmiare su tutto.
116
Il nostro amico, ancora ricordo il suo viso rubizzo e i suoi
modi gioviali e simpatici, passava mediamente in centro
una volta ogni quindici giorni. Con la sua bicicletta sgangherata, con il suo cesto di vimini per gli attrezzi (il servizio
era a domicilio!), con la sua voce stentorea annunciava alle
donne di casa il suo arrivo. La plastica non era stata ancora scoperta ed il coccio imperava in cucina, specialmente
nelle famiglie meno agiate. Se qualcosa si rompeva ci si
rivolgeva sempre al nostro artigiano che, con una manualità degna di miglior causa, con l’ausilio di un trapano ad
archetto, una spranga ed una specie di cemento a base di
cenere, riusciva sempre a rimediare al danno. Aggiustava
anche gli ombrelli, con il disappunto di noi bambini che
ambivamo alle stecche di acciaio flessibile per realizzare
degli ottimi archi e pericolosissime frecce per i nostri giochi non propriamente innocenti.
117
In conclusione
Alla conclusione di questi racconti permettetemi di fare una
proposta che metta fine ad una piccola ingiustizia perpetrata ai danni di quelli nati “prima”. Imperano tanti neologismi
tipo: diversamente abili, paramedici, collaboratori ecologici, collaboratrici familiari…..allora, al posto del vocabolo
“vecchio” che suona così male e che ha sempre un valore
negativo, non usiamo “diversamente giovane”? Naturalmente ogni riferimento alla mia persona è puramente casuale.
Dopo l’appello “urbi et orbi ”e queste ultime note si chiude
il ciclo della spensieratezza. Altri impegni, altre incombenze, altre responsabilità si affacceranno con il passare degli
anni, sul palcoscenico della vita di noi ragazzi. Così va il
mondo. In queste pagine ho cercato di raccontare quelle
cose che credevo più interessanti. Per me è stato oltre che
un piacere, l’occasione per ritornare con la memoria e un
pizzico di nostalgia a quei tempi passati. A voi (mi voglio
illudere) spero abbia offerto qualche momento di piacevole svago. Clio, musa della storia e dei racconti, non se ne
abbia troppo a male se mi sono permesso indegnamente
di invadere il suo campo. Capirà certamente, da buona
immortale dea, che la mia non aveva la pretesa di essere
una storia con la esse maiuscola, ma solo una semplice
testimonianza di avvenimenti vissuti da un bambino in un
periodo particolare. So per certo che l’immeritata fama di
bravo ragazzo che avevo a quei tempi verrà sicuramente
adombrata, ma sono altrettanto certo che chi mi conosce,
perdonerà di buon grado le marachelle narrate in queste
pagine e quelle….che non ho potuto raccontare!
A tutti i miei gentili lettori un grazie dal profondo del cuore.
118
I luoghi delle nostre
scorribande
Il pontile in tutta la sua magnificenza
119
I campi da tennis e la pista da pattinaggio sulla spiaggia
L’attracco al Pontile
120
Via Bovio (allora Viale Principe di Piemonte)
LE NAVI – colonia marina XXVIII Ottobre
121
Il porto canale
Il mitico Avviamento
122
… e la sua demolizione nel 1966
Cattolica negli anni ‘30
123
Indice
Presentazione..................................................................................3
Prefazione.....................................................................................11
Gli anni della guerra..................................................................15
La compagnia “dal Viel”................................................................17
Idrolitina ‘alcolica’.........................................................................20
I tedeschi in casa..........................................................................24
I disagi e le paure della guerra....................................................28
Il tempo passato in campagna.....................................................34
Ritorno a casa. Mesi pericolosi.....................................................40
Gli Alleati e i nuovi giochi dei ragazzi.........................................46
Nuove disavventure......................................................................50
Immagini di morte e pericoli.......................................................55
Il dopo guerra.............................................................................59
Lentamente la vita riprende..........................................................61
Il campo giochi.............................................................................67
Il ‘covo’ della banda, feste di paese e nuovi amici......................72
Tragica burrasca............................................................................81
Curiosità.......................................................................................85
Ciccio, “al macàc dla Rudi”...........................................................87
Lo scherzo.....................................................................................92
Il tritolo.........................................................................................94
I capodogli....................................................................................96
I veglioni.......................................................................................98
Un pomeriggio da s…ballo........................................................101
Personaggi.................................................................................105
Il buon dottor Rudi.....................................................................107
Gagiot (Domenico Candiotti).....................................................110
Altri personaggi..........................................................................112
I luoghi delle nostre scorribande...........................................119
124
125
Impaginazione e grafica: Michele Balducci
Finito di stampare nel settembre 2012 presso Tipolito La Grafica - Cattolica