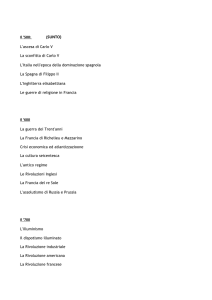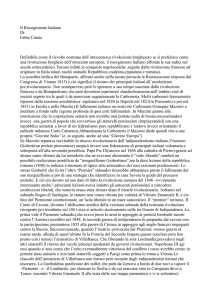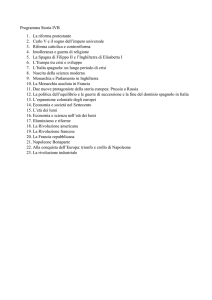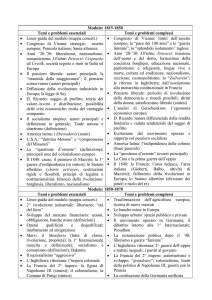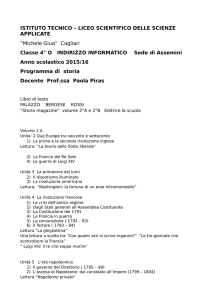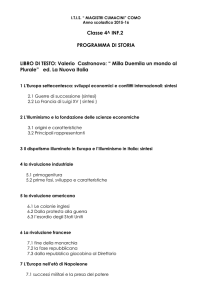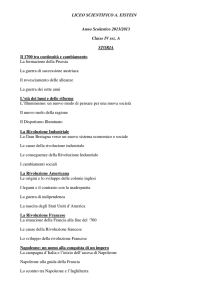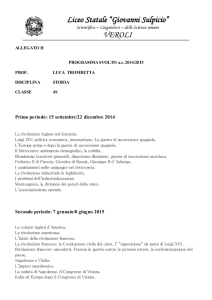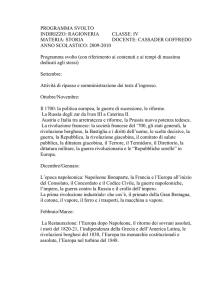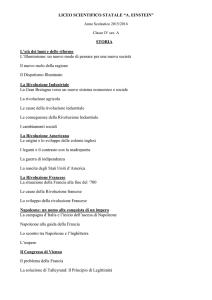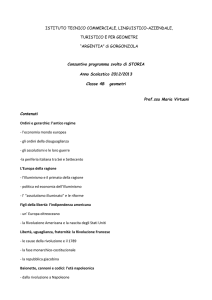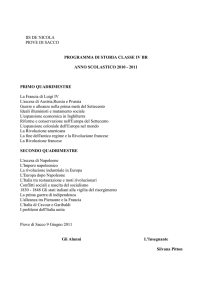unità
6
L’ordine di Vienna
Riferimenti storiografici
1
Nel riquadro un dipinto che raffigura i rappresentanti degli Stati europei riuniti a Vienna per il Congresso del 1814-1815.
Sommario
1
2
3
4
Le ragioni della vittoria inglese nel lungo
duello con la Francia
L’insurrezione in Italia: il dibattito sulla
strategia militare
Le radici economiche della rivoluzione
del 1848 in Francia
L’ascesa al potere di Luigi Bonaparte
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
5
6
7
8
Bismarck e l’idea di nazione
La nascita del Reich nella pittura
di corte tedesca
L’idea di martirio nella propaganda
politica di Mazzini
Il 1848 in Europa
UNITÀ 6
1
L’ORDINE DI VIENNA
2
Le ragioni della vittoria inglese nel lungo
duello con la Francia
L’Inghilterra combatté contro la Francia per più di vent’anni, dal 1793 al 1815. Si trattò di una prova pesantissima, ma la
Gran Bretagna ne uscì vittoriosa in virtù della potenza della sua
flotta e della sua economia. D’altra parte, la società britannica
non fu messa a dura prova dalla guerra, soprattutto negli anni
1810-1811.
Com’era stato possibile che la Gran Bretagna conducesse una guerra quasi ininterrotta dal 1793 al 1815
e ne uscisse infine vittoriosa? La risposta non sta evidentemente nell’ispirazione della direzione politica, in
una superba strategia congiunta o, nonostante le dimensioni dell’esercito nelle ultime fasi della guerra
(350 000 uomini) […], nella potenza delle forze di terra.
Considerando il conflitto nel complesso, i due principali
fattori materiali decisivi furono quello navale e quello
economico. Furono soprattutto i mari, la fonte sia della
ricchezza sia della grandezza inglese, a salvare il paese
e a garantire la vittoria finale.
La potenza navale organizzata, che aveva come
simbolo la flotta, «la difesa che ragione e natura ci indicano tanto chiaramente», fu utilizzata in maniera meno
drammatica e spettacolare dopo il trionfo di Nelson a
Trafalgar, ma la frequente inattività della flotta era di per
sé un segno di supremazia. Collingwood [l’ammiraglio
che sostituì Nelson a guida della flotta, n.d.r.] continuò
a difendere il Mediterraneo nel corso di sette anni di continua espansione militare francese, mentre le navi inglesi
ottennero oltremare vittorie in regioni tanto lontane
quanto la Martinica, San Domingo e il Senegal. La supremazia navale britannica non si basava su armamenti
navali superiori – la rivoluzione industriale non aveva
ancora toccato la costruzione navale né i suoi metodi –
e neppure su una disciplina e un morale superiori dei
marinai comuni. Gli strumenti del reclutamento in marina
– arruolamento forzato, oppure accordi con i magistrati
per costringere vagabondi e detenuti – non garantivano
affatto una forza affidabile. Erano piuttosto la quantità e
la superiorità qualitativa degli ufficiali inglesi e l’organizzazione dei comandi navali a differenziare le due flotte
nemiche. Fino alla morte in mare nel 1810, Collingwood
si distinse in particolare, nelle parole di Creevey, come
«il primo e unico ministro d’Inghilterra ad agire sul mare,
a tenersi in corrispondenza con tutti gli Stati circostanti
e a ordinare ogni cosa sotto la propria responsabilità».
Mentre la marina da guerra teneva sgombre le rotte
oceaniche, pattugliando le coste delle colonie e fornendo una forza di protezione alle navi mercantili, la marina mercantile, nel corso di tutte le vicissitudini della
guerra economica, gettò le fondamenta di una supremazia schiacciante in tempo di pace. Anche se i francesi
e i loro alleati catturarono in media 524 mercantili all’anno tra il 1795 e il 1810, questa perdita, persino negli anni peggiori, equivaleva soltanto al 3% del tonnellaggio complessivo inglese. Con il proseguire della
guerra, la paga dei marinai mercantili crebbe, mentre le
tariffe dell’assicurazione marittima scesero nettamente,
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
da un tetto del 25% negli anni 1790 a un minimo del 6%
nel 1810. Il commercio oltremare inglese continuò ad
espandersi, in netto contrasto con la stagnazione di
quello francese; si ebbe un aumento eccezionale delle
esportazioni dal 1812 al 1815, e, presagio del futuro,
una nave a vapore appena costruita giunse a Londra da
Glasgow nel 1815, dopo un viaggio di 1500 miglia.
La costante capacità di ripresa del commercio inglese
oltremare dipendeva naturalmente [anche] dalle capacità
produttive di una società industriale che si andava sviluppando. Mentre Napoleone non seppe sviluppare l’industria francese sotto la copertura del protezionismo fornita dalla guerra e dall’inevitabile abrogazione del trattato
di Eden [stipulato poco prima dello scoppio della Rivoluzione da William Eden, barone di Auckland, che nel governo inglese rivestiva una funzione simile a quella di ministro del Commercio, n.d.r.], l’industria inglese, immune
dalla concorrenza, continuò a espandersi. I suoi diversi
settori furono influenzati in modi diversi, ma almeno fino
alla formalizzazione del sistema continentale di Napoleone
(1806-1810) e alla promulgazione, per ritorsione, degli Ordini in Consiglio inglesi (del 1807), molte industrie ebbero
una crescita continua. […]
Mentre gli agricoltori continuarono a passarsela bene
durante gli ultimi dieci anni di guerra, gli industriali si trovarono ad affrontare tra il 1806 e il 1811 problemi ben
più complessi di quelli affrontati nel periodo precedente
delle ostilità. La serie di Ordini in Consiglio (ventiquattro
in tutto) emessi da Grenville e dal ministero di tutti i talenti e proseguita in misura molto più massiccia dal governo di Portland, era ritenuta la causa dei problemi degli uomini d’affari, ben più delle ordinanze di Berlino o del
sistema continentale di Napoleone. Considerati nel complesso, gli ordini stabilivano uno stato di blocco contro
la Francia e i suoi alleati, proibivano il commercio tra i
porti francesi e altri porti nemici e tra le colonie nemiche
e le loro madrepatrie e permettevano ai paesi neutrali di
commerciare con la Francia e i suoi alleati soltanto se
trasportavano merci inglesi o se le loro navi toccavano
prima un porto inglese, dichiarando il carico, scaricando
e ricaricando le merci imbarcate e pagando un dazio. In
altre parole, la parte restante del commercio estero che
non era già stata sconvolta o strangolata da Napoleone
era severamente controllata dal governo britannico. «Il
nemico aveva dichiarato che la Gran Bretagna non doveva avere commercio. La risposta fu che il nemico – e
il termine era usato nella sua accezione più ampia – non
doveva avere commercio se non attraverso la Gran
Bretagna» (A.F. Fremantle). […]
Ad accrescere le tensioni sociali contribuirono i cattivi raccolti del 1809 e 1811 […]. In tutti i grandi centri industriali, fabbricanti e mercanti chiedevano a gran voce
un’abolizione totale dei «disatrosi e stupidi» Ordini in
Consiglio. Cinquantamila abitanti di Manchester ne avevano domandato la revoca già nel 1808, un anno relativamente favorevole; nel 1810 e 1811 la pressione salì e
la guerra diventò largamente impopolare. A Birmingham,
città in cui si era calcolato che quasi la metà del volume
totale della produzione era prodotta per il mercato americano, nell’estate del 1811 erano 9000 le persone che
ricevevano il sussidio per i poveri, e «tutti gli industriali
sono sovraccarichi di scorte». […] Quando i raccolti inglesi si rivelarono disastrosi e i prezzi alimentari erano
cresciuti tanto che migliaia di persone rischiavano di restare affamate, Napoleone non seppe resistere alla pressione dei produttori francesi di cereali, che dopo una serie di buoni raccolti erano ansiosi di esportare le loro
eccedenze nell’affamata Gran Bretagna. Compiendo
nel 1810 un calcolo gravemente errato, sulla base di
un’analisi fondamentalmente sbagliata della situazione
politica, Napoleone giunse alla conclusione che se
avesse potuto costringere la Gran Bretagna a esportare
oro per comprare grano, un’inflazione disastrosa
avrebbe paralizzato la volontà di resistenza dell’Inghilterra. […] Sarebbe stato molto meglio per lui se nel
1810 avesse cercato – poteva anche non riuscirci – di affamare la Gran Bretagna o almeno di accrescere le tensioni sociali nelle regioni industriali inglesi. Invece, lasciò
passare il momento critico.
A. BRIGGS, L’età del progresso. L’Inghilterra fra il 1783 e il 1867,
il Mulino, Bologna 1993, p. 182, trad. it. D. PANZIERI
UNITÀ 6
Quali erano i veri punti di forza della flotta britannica? Lo sviluppo industriale dell’Inghilterra ebbe un ruolo importante
nella superiorità navale inglese?
Di che cosa era segno la diminuzione delle tariffe di assicurazione marittima?
Che cosa erano gli Ordini in Consiglio?
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
3
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
2
L’insurrezione in Italia:
il dibattito sulla strategia militare
UNITÀ 6
L’intero periodo risorgimentale, dal 1821 al 1860, fu attraversato da un serio dibattito in cui i motivi di ordine politico e
le argomentazioni di tipo strategico si intrecciavano in modo fittissimo. Quanti proponevano l’insurrezione popolare come
strumento per combattere contro l’Austria erano convinti non
solo della sua importanza civile (un popolo capace di liberarsi
dall’oppressione sarebbe poi stato capace, in futuro, di darsi un
ordinamento veramente democratico), ma anche della sua efficacia militare. In realtà, entrambi i postulati dovevano rivelarsi
dubbi, alla prova dei fatti.
L’ORDINE DI VIENNA
4
Da un esule del ’21, il piemontese Carlo Bianco,
conte di Saint-Jorioz, condannato a morte in contumacia [fisicamente assente in tribunale, al momento del
processo, n.d.r.], combattente in Spagna e poi esule a
Malta, si ha la prima appassionata indagine ed esposizione sistematica delle possibilità che l’Italia ha in sé
di risorgere: il famoso trattato sulla guerra insurrezionale per bande, composto fra il 1824 e il 1829 e stampato a Marsiglia nella prima metà del 1830, è un’appassionata rivendicazione del valore italiano e la sicura
affermazione che l’Italia avrà in sé, senza dover sperare
né nei suoi principi né negli stranieri, i mezzi della sua
resurrezione, i mezzi cioè per conquistare libertà, indipendenza, unità: l’insurrezione popolare, la guerra per
bande; una guerra tutta diversa da quella regolare,
ma che saputa combattere con ardore e tenacia, come
già fecero gli spagnoli contro Napoleone, è destinata
a trionfare dei più potenti e agguerriti eserciti stanziali
[legati in modo fisso a un determinato territorio, sul
quale hanno caserme, magazzini o fortezze, n.d.r.];
guerra di popolo che fraziona le forze perché siano più
mobili, più facili da occultarsi e da nutrire, e pronte
sempre a disperdersi e a riunirsi; guerra non legata a
magazzini, a basi e linee d’operazione o al possesso di
grandi centri. Guerra poi combattuta coll’aiuto crescente di tutta la popolazione, guidata da comitati segreti dapprima, palesi poi; e sempre più spietata, poiché le rappresaglie sanguinose e devastatrici del
nemico portano a nuovo sangue e a nuovo odio, e la
lotta tende ad assumere i suoi caratteri estremi di
guerra totale e guerra assoluta; e l’esercito nemico alla
fine dovrà abbandonare coi suoi laceri resti l’infausto e
tremendo paese. A dargli il colpo di grazia potranno
anche contribuire forze regolari, create via via coi combattenti meglio esercitati e allenati. In questo modo due
milioni d’italiani insorti finiranno coll’annientare non
cento, ma trecentomila soldati regolari, dell’Austria o di
qualsivoglia potenza.
L’errore del Bianco consisteva nel mettere in relazione numerica dei valori d’ordine differente e non commensurabili: eserciti armati, disciplinati, addestrati e ben
inquadrati da un lato; dall’altro un potenziale umano, in
gran parte arretratissimo, nel quale si doveva innanzi
tutto trovare un entusiasmo, un’abnegazione, un’energia, una ferrea tenacia quale solo l’opera d’un uomo di
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
genio, e ben coadiuvato da altri uomini superiori,
avrebbe potuto suscitare: a un possente e gravoso
dato di fatto [la potenza militare austriaca, n.d.r.] contrapporre un atto di fede nella recondita [nascosta, da
portare allo scoperto, n.d.r.] virtù della stirpe, un desiderio profondo, un’ardente speranza: a una mobilitazione regolare pretendeva opporre una mobilitazione
generale in base a un universale imperativo patriottico.
O, peggio ancora, contrapponeva la fredda convinzione
che l’insurrezione, col suo crescendo di reazioni militari
e di vendette popolari, avrebbe finito coll’assorbire nel
suo spietato ingranaggio tutta la popolazione in una
lotta senza quartiere per la vita e per la morte. Per di più
il Bianco sembrava voler ignorare che gl’insorti spagnoli non avevano agito da soli, ma coll’aiuto possente
dell’esercito inglese e dello stesso esercito regolare
spagnolo.
Il Bianco terminava il suo trattato alla fine d’agosto
1829 […]; poco dopo la stampa del trattato si aveva in
Francia, a Parigi, nel 1830, la rivoluzione di Luglio, con
le sue ripercussioni al di qua delle Alpi e con la cosiddetta rivoluzione dell’Italia centrale. […] A Parigi il Buonarroti mira a legare l’insurrezione italiana al gran moto
rivoluzionario europeo, e Carlo Bianco sotto la sua alta
ispirazione è a capo dei Militi Apofasimeni (disperati,
pronti allo sbaraglio), cui conferisce un carattere strettamente militare, elemento di punta della prossima vera
grande rivoluzione. Ed essi si diffondono sempre più in
Piemonte, in Romagna, in Toscana, e alla società si
iscrive nell’aprile 1831 anche Giuseppe Mazzini. Ma
due mesi dopo il genovese fonda a Marsiglia la Giovine
Italia, nella quale affluiscono gli Apofasimeni. Verso la fine
del ’32 appare nel quinto fascicolo della «Giovine Italia»
il noto scritto di Mazzini Della guerra d’insurrezione conveniente all’Italia, che costituisce la dottrina militare del
nuovo movimento rivoluzionario. Nella parte tecnica il
giovane apostolo s’attiene al trattato del Bianco, ripetutamente ricordato con molta lode; ma nell’insieme ne
attenua la durezza, […] vede nella lotta e come elemento
di questa, pur restando molto nel generico, la rigenerazione delle plebi agricole, afferma la necessità d’un nucleo di forze regolari e d’un organo direttivo centrale. I
tentativi della Giovine Italia naufragano miseramente,
già nella fase preparatoria cospirativa, nella spietata repressione di Carlo Alberto, e i tentativi della Savoia e di
Genova falliscono quasi prima d’essere iniziati; né valgono a risollevare pel momento il prestigio del Mazzini i
suoi sforzi d’allargare il movimento con la creazione
della Giovine Svizzera e della Giovine Europa.
P. PIERI, Storia militare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni,
Einaudi, Torino 1962, pp. 789-791
Quale episodio militare del recente passato, che veda
come protagonista il popolo, è presentato come
esemplare dell’efficacia della guerra per bande?
Nel suo classico studio intitolato Come nascono le rivoluzioni, lo storico francese Ernest Labrousse propone un modello teorico che, a suo giudizio, si ripeté nel 1789, nel 1830 e nel
1847. In questi tre casi, la rivolta politica è preceduta da una
crisi economica, che viene direttamente imputata al governo,
alla sua negligenza o alla sua inettitudine. Questo clima arroventato spiega la partecipazione popolare ai moti, guidati da intellettuali o figure borghesi che hanno progetti politici e sociali di più vasto respiro.
Ed eccoci alla crisi del 1847. La cui caratteristica è
data dalla permanenza, nel suo seno, del vecchio meccanismo generatore della tensione, ma anche dalla comparsa di un nuovo meccanismo. Abbiamo intanto l’accumulo degli squilibri: squilibrio naturale [provocato dai cattivi
raccolti, notevolmente influenzati dalle piogge e dal clima,
n.d.r.] della vecchia economia delle granaglie e del tessile;
squilibrio artificiale della nuova economia metallurgica. In
primo luogo, pertanto, crisi di vecchio tipo; ossia crisi sostanzialmente agricola, e crisi del tessile: ve l’avevo detto
che il 1847 sembrava una ripetizione del 1830. Infatti la
faccenda comincia con una malattia della patata, di una
patata che occupa ora un posto assai più considerevole,
rispetto al 1830, nell’alimentazione popolare. La malattia
si manifesta nel 1845-46. Il raccolto cerealicolo del 1846
è cattivo. Ci vuole poco a rendersi conto dell’importanza
di questa accoppiata: il prezzo elevato della patata, alimento popolare, si ripercuote sul prezzo del pane, alimento popolare sostitutivo. L’aumento di un prodotto di
grande consumo popolare quale la patata, comporta,
anche quando non si registri un cattivo raccolto delle granaglie, un notevole aumento del prezzo di queste ultime.
Quando poi il raccolto sia cattivo, come appunto nel
1847… Ne consegue che, nella Francia del 1847, assistiamo alla replica pressoché identica degli avvenimenti
economici della Francia del 1830 e del 1789. […]
Insomma, sotto questo aspetto, vediamo profilarsi
una crisi di vecchio tipo. Ma, come vi avevo avvertito, la
rivoluzione del 1848 scoppia un po’ alla confluenza tra
crisi di vecchio e di nuovo tipo. Alla crisi dell’economia
delle granaglie e del tessile si sovrappone la crisi dell’economia metallurgica. L’economia francese fa la sua
prima conoscenza con una crisi metallurgica. Ricordiamo
alcune date peraltro note: il 1847 è piuttosto vicino al
1841, ossia alla data della grande legge sulle espropriazioni, quella che istituisce e sancisce le espropriazioni indispensabili alla costruzione della nostra [francese, n.d.r.]
rete ferroviaria. Inoltre, il 1847 è piuttosto vicino al 1842,
anno in cui vede la luce la Carta, lo statuto, di questa rete.
Naturalmente è stato varato anche un piano di costruzione; concepito nell’illusione di un periodo di prosperità
proprio quando, nel 1846, i tempi facili volgevano alla fine.
Ma chi era così ingenuo da credere a una crisi alle porte?
Riunendo credito privato, credito locale e credito statale,
il piano doveva consentire la rapida costruzione delle ferrovie. L’età del ferro e dell’acciaio era inaugurata. La metallurgia moderna, col coke, è già lanciata. Ma con lo
scoppio della crisi non ci sono più disponibilità finanziarie; non c’è più credito: il piano viene sospeso. E con esso
si aggiornano lavori pubblici per quasi un miliardo di franchi; insomma bisogna rinunciare a circa 500 milioni di
giornate lavorative a due franchi al giorno. È il crollo della
metallurgia. Lo stesso per le miniere. Tra il 1847 e l’inizio
del 1848, la produzione metallurgica diminuisce di un
terzo in termini di valore. Non ci metterà molto a diminuire
della metà. Per quanto riguarda la produzione mineraria
lo scivolone è del 20 per cento. […]
L’ondata degli alti prezzi si è abbattuta sul paese
come un’inondazione e, come succede quando le inondazioni defluiscono, si è lasciata alle spalle una popolazione di sinistrati, priva di risparmi. Spessissimo, lo testimoniano i Monti di Pietà, è la stessa mobilia a essere
impegnata. Siamo al dramma della disoccupazione. La
rivoluzione scoppierà in un mondo economicamente disastrato. […] Di solito le crisi sono imputate al governo.
Cioè si imputa al governo un cattivo raccolto? – mi chiederete stupiti. Evidentemente non il fatto in sé del cattivo
raccolto. Si afferma però: se c’è stato aumento dei prezzi
vorrà dire che il governo ha esportato troppo grano negli anni precedenti; oppure che non ne ha importato a
sufficienza nel corso di quest’annata deficitaria. Se l’industria metallurgica stagna, se c’è una crisi tessile, sarà
perché le materie prime sono state troppo tassate all’importazione; e anche perché l’esportazione non è
stata sufficientemente incentivata. […] Insomma: ritrovo
questa concezione antropomorfica della crisi, nella persona di un ministro o di un ministero, puntualmente: per
spiegare l’origine delle nostre tre rivoluzioni. […] Ma la
crisi non ci si limita a imputarla al governo; spesso si mira
più in alto, al regime stesso. Consentitemi di citarvi un discorso emblematico di Ledru-Rollin: fu tenuto in occasione del dibattito sull’Indirizzo inaugurale al parlamento
nel 1847. Come tratteggia la situazione economica? A
chi ne imputa la responsabilità? «Se le nostre industrie,
il nostro commercio e il nostro credito – dichiara alla Camera – si trovano in simile stato allarmante, e potrei dire
di imminente rovina, a chi va attribuita la colpa? A chi imputare la responsabilità, se non a quel sistema che ci
grava così pesantemente ormai da sedici anni? […] Le
debolezze in politica estera, al pari degli errori governativi in politica interna, bastano e avanzano per spiegare
le difficoltà in cui si dibattono commercio e industria!».
E. LABROUSSE, Come nascono le rivoluzioni. Economia e politica
nella Francia del XVIII e XIX secolo, Bollati-Boringhieri,
Torino 1989, pp. 222-226, trad. it. A. ZANARDO
Quali fattori producevano, negli anni Quaranta dell’Ottocento, l’aumento dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità
(cereali e patate)?
Che cosa distingue la crisi economica del 1847-1848 da quelle che l’hanno preceduta?
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
UNITÀ 6
Le radici economiche
della rivoluzione del 1848 in Francia
5
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
3
4
L’ascesa al potere di Luigi Bonaparte
UNITÀ 6
Nel confuso quadro della politica francese dei mesi e degli anni seguenti i moti parigini del 1848, Luigi Bonaparte seppe muoversi con maggiore abilità dei suoi avversari. Il successo
si deve in primo luogo al suo «interclassismo demagogico»: ogni
francese – di qualsiasi classe sociale – si sentì rivolgere un messaggio capace di gratificarlo. Ai contadini e agli operai fu promesso un miglioramento delle condizioni di vita, ai borghesi l’abolizione delle proteste dei lavoratori, mentre i cattolici ottennero
che l’esercito francese intervenisse a Roma per ripristinare l’autorità del papa e sopprimere la Repubblica democratica.
L’ORDINE DI VIENNA
6
Nel ’48 Luigi Bonaparte aveva quarant’anni ed una
discreta esperienza politica alle spalle. È un vezzo [una
cattiva abitudine, n.d.r.] della cultura di sinistra stabilire
un’antitesi, e un abisso, tra il grande e il terzo Napoleone. […] In realtà, il carattere dominante del bonapartismo – cioè l’interclassismo demagogico, seduttivo,
quasi irresistibile verso le masse meno politicizzate e al
tempo stesso saldamente ancorato ad un rapporto di
mutua assistenza coi ceti possidenti – è già tutto presente nel primo «imperatore dei francesi». Dalla riduzione
drastica del suffragio al ripristino della schiavitù, dalla
creazione di un nuovo ceto di notabili alla censura ferrea: tutto è già nel Primo Impero, anzi già nel 18 brumaio. Alla drastica distinzione tra il primo e il terzo Napoleone ha contribuito ovviamente anche il tono
sprezzante dei pamphlets [scritti polemici, n.d.r.] sferrati
contro Luigi Napoleone: dal Napoleone il piccolo di Victor Hugo al 18 brumaio di Luigi Bonaparte di Marx. Ma
tutto ciò ha finito per offuscare la sostanza: la nascita,
cioè, ben precoce, dal seno stesso della rivoluzione,
della cosiddetta terza via tra democrazia e reazione, cioè
il bonapartismo, che in realtà altro non è che la stessa
seconda via (la reazione) in forme moderne e pseudorivoluzionarie. […] Facendo tesoro delle vicende, certo
istruttive, dell’illustre congiunto, Luigi Bonaparte, falliti i
tentativi putschisti [dopo il fallimento di due progetti di
colpo di Stato (putsch), n.d.r.] del 1836 e del 1840 (ma
allora i possidenti non avevano bisogno di lui, Luigi Filippo era saldamente al potere), elesse come stelle polari della sua azione tre cardini: il populismo [lo sforzo ottenere il favore e il consenso del popolo, n.d.r.],
l’ostentata deferenza verso la Chiesa cattolica, il costante legame con ambienti economicamente forti che
potessero sorreggere il suo ingresso nell’agone [scontro, n.d.r.] politico. […]
Nel 1844, aveva scritto un libretto, La liquidazione
della povertà (Extinction du paupérisme), nel quale si offriva come «amico» delle classi lavoratrici. In questo
scritto, Luigi Bonaparte pone l’accento sull’equilibrio agricoltura/industria; inoltre, attacca l’industrialismo selvaggio […]. In un’epoca in cui l’orario di lavoro nell’industria
era di dodici ore al giorno, il lavoro minorile imperversava,
e oltre Atlantico, negli USA, i difensori della schiavitù delle
piantagioni avevano buoni argomenti per indicare come
più umano tale arcaico rapporto di dipendenza rispetto
alla feroce durezza della vita in fabbrica, le proposte del
nuovo Bonaparte si offrivano come particolarmente attraenti: soprattutto nel mondo provinciale e agricolo. Una
delle proposte dell’opuscolo era la creazione di comunità
agricole che mettessero a frutto i nove milioni di terre incolte (era questo il dato delle statistiche ufficiali). Questa
immensa rete di colonie agricole non solo avrebbe fornito
alimento ad un gran numero di famiglie povere, ma
avrebbe offerto un approdo alle masse di operai disoccupati buttati fuori dal ciclo produttivo a causa della stagnazione economica (fortissima in quei mesi, e tale sarebbe stata ancora fino almeno all’inverno 1848-49). I
profitti – e qui il libretto diventa un vero manifesto dell’interclassismo – sarebbero stati divisi tra lavoratori e datori
di lavoro. «Attualmente – scriveva – la retribuzione del lavoro è affidata al caso e alla violenza. Il padrone opprime, e l’alternativa è l’operaio che si ribella». La proposta avanzata era: «un salario regolato non sulla base del
rapporto di forze ma secondo giustizia, tenendo conto
delle necessità di chi lavora e degli interessi di chi crea lavoro». Questo – incalzava – dovrebbe essere l’obiettivo di
un governo efficiente. […]
Quando fu resa nota la sua candidatura per le elezioni
di dicembre [le elezioni presidenziali del 1848, n.d.r.],
qualcuno protestò; egli si difese vari giorni più tardi, con
l’argomento ch’era doveroso accettare una candidatura
che gli veniva offerta con insistenza e dopo tanti successi
nelle elezioni a deputato. […] Del resto il risultato elettorale è eloquente di per sé: cinque milioni e mezzo al Bonaparte, un milione e quattrocentomila voti al principale
antagonista (Cavaignac); ma ancor più indicativo è il risultato quasi nullo dei candidati ufficialmente socialisti (36
329 voti a Raspail, e 370 719 a Ledru-Rollin!). Il nuovo
Bonaparte aveva mangiato tutte le opposizioni e tutti gli
scontenti del governo Cavaignac, e insieme aveva attinto
al suo stabile e vasto serbatoio elettorale provinciale. Il
suo programma elettorale era, a suo modo, perfetto.
Prometteva di difendere l’ordine, di proteggere la religione, la famiglia, la proprietà, di volere la pace, la decentralizzazione [la concessione di un ampio margine di
autonomia alle singole province; la tradizione francese,
invece, era di tipo centralistico, cioè concentrava a Parigi la maggior parte delle decisioni importanti, n.d.r.], la
libertà di stampa, l’abolizione delle leggi di proscrizione
(e i proscritti erano, in quel momento, le migliaia di operai deportati dopo le giornate di giugno), di proporsi la riduzione delle tasse più onerose per il popolo, di voler incoraggiare le imprese capaci di dar lavoro ai disoccupati,
di voler instaurare strumenti volti al sostegno dei lavoratori anziani; in una parola di mirare al benessere di ciascuno fondato sulla prosperità di tutti. […] La leggenda,
mai esausta, del primo Bonaparte fece il resto.
L. CANFORA, La democrazia. Storia di un’ideologia,
Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 120-126
Spiega le espressioni «interclassismo demagogico, deduttivo» e «terza via tra democrazia e reazione».
Spiega l’affermazione «Il suo programma elettorale era, a suo modo, perfetto».
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
Nella Germania nazista, era prassi corrente istituire un parallelo tra Hitler e Bismarck e presentare il cancelliere prussiano
come un precursore del Führer. In realtà, Bismarck era assai poco
sensibile al tema della nazione. Egli ragionava in termini freddi, lucidi, di potenza: il suo valore supremo era lo Stato, non la
nazione germanica. Inoltre, Bismarck sperava di riuscire a conservare buone relazioni con l’impero zarista, mentre Hitler (mosso dal razzismo antislavo) voleva cancellare l’esistenza stessa
della Russia e trasformarla in dominio tedesco.
Il vero architetto dell’unità italiana fu Cavour. Mentre
a Bismarck i parlamenti non piacevano, Cavour credeva
nel libero gioco degli interessi e delle idee. Gli piaceva il
gioco della politica parlamentare e riteneva che l’unità
potesse essere raggiunta soltanto attraverso la riconciliazione degli interessi e non attraverso un governo assoluto. A ciascun gruppo bisognava dare la sua giusta
possibilità e ciascun individuo doveva avere fiducia nella
ragione che avrebbe prodotto il consenso senza abolire
la libertà. Questa era una visione completamente liberale
del nazionalismo, e doveva essere ripresa più tardi da
Clemenceau [nella Francia del primo Novecento, n.d.r.].
Nella pratica Cavour fu meno liberale che in teoria, comunque in Italia fu un liberale che divenne l’architetto
dell’unità. Come Mazzini, sebbene in modo completamente diverso, egli fece sì che il nazionalismo italiano
combinasse le idee liberali di libertà con l’accento sulla
coscienza nazionale. In Germania nessuno svolse una
funzione analoga. […]
Dopo il 1848, tuttavia, ci fu anche un’altra forma di
realismo nuovo nell’impostazione del problema nazionale rappresentato non solo da Cavour ma anche da Bismarck. Come abbiamo già detto, era ancora possibile
avere una visione territoriale della nazione invece che
una visione culturale. Bismarck ne fu un esempio. Non
gli interessava lo stato in quanto organismo che comprendeva tutto. Egli era molto disposto a lasciare che le
minoranze presenti in Germania, come i polacchi a est,
conservassero la propria identità e la propria lingua. Né
Bismarck pretese una nazione unitaria che avesse un’unica visione culturale. Gli stati tedeschi meridionali conservarono il controllo dei loro affari culturali. La Germania fu unificata soltanto fino al punto che Bismarck
ritenne necessario alla sua esistenza in quanto stato fra
gli altri stati. Egli era un federalista, una posizione alquanto incompatibile con ogni genere di nazionalismo
culturale. Per Bismarck, lo stato era uno strumento di
potere. Quel potere non era aggressivo quanto piuttosto diretto a mantenere la nazione al sicuro da disordini
interni ed esterni. Per lui il pericolo interno non era rappresentato dalle minoranze polacche o ebree, bensì dal
programma rivoluzionario del marxismo. Perciò, sop-
presse il Partito socialdemocratico tedesco. Ma al
tempo stesso tentò di legare le classi più povere allo
stato, non attraverso un nazionalismo esasperato ma attraverso una legislazione assistenziale. […]
Bismarck era soprattutto un tecnico del potere. Il che
non vuol dire mancanza di ideologia o concezione cinica
del mondo. Anzi, per Bismarck, questo voleva dire
senso di responsabilità verso Dio. Questa responsabilità veniva giustificata con la necessità di mantenere la
nazione sicura una volta che era stata costituita e, prima
di allora, con l’impegno a lavorare alla sua fondazione.
Certamente, si poteva ricorrere a quelli che venivano
chiamati metodi machiavellici; anche Cavour era convinto di questo. Ma simili metodi, dopo tutto, erano
stati sempre usati dagli statisti nel corso della storia ed
erano anche stati sempre collocati in un più ampio quadro ideologico. Per Cavour questo quadro era il liberalismo, la conciliazione degli interessi; per Bismarck era
il senso di responsabilità verso Dio che gli consentiva di
operare sulla terra macchiata dal peccato. «Sangue e
ferro» potevano essere usati, ma soltanto in casi estremi,
quando l’esistenza dello stato era in pericolo. Certo,
dopo il fallimento del 1848 egli pensò che la Germania
corresse il grave pericolo di non diventare mai uno stato.
Il concetto di nazionalismo di Bismarck era più vecchio del nazionalismo culturale dei suoi tempi. Egli pensava in termini di stato, della salvaguardia del suo territorio e del suo potere, ma respingeva l’unità culturale e
l’aggressività in nome del Volk. Tuttavia, questo concetto
di nazionalismo non venne raccolto dai suoi successori.
Il nazionalismo culturale divenne dominante nella maggioranza delle menti, compresa quella dell’imperatore
Guglielmo II. Sebbene questo fosse dovuto principalmente alla forza del nazionalismo culturale dopo il 1848
[il concetto corrisponde a quello che, nell’Unità V è stato
da noi definito sentimento nazionale o idea di nazione,
n.d.r.], quella non fu la sola ragione. La fine del secolo assistette a una ripresa del romanticismo, che rafforzò ulteriormente la concezione della nazione in termini di cultura e di razza. In realtà, il nazionalismo culturale in
Germania diventò nazionalismo razziale […] e doveva
portare direttamente al nazionalsocialismo. Queste considerazioni non devono far pensare che Bismarck sia
stato un precursore del nazionalsocialismo; anzi, il suo
nazionalismo risaliva a un’epoca ignara di quella combinazione di romanticismo e di nazionalismo che doveva
dar vita al nazionalismo culturale che avrebbe caratterizzato il futuro della Germania.
G.L. MOSSE, La cultura dell’Europa occidentale nell’Ottocento
e nel Novecento, Mondadori, Milano 1986, pp. 103-106,
trad. it. S. D’AMICO
Quali erano, per Bismarck, i veri e pericolosi nemici della nazione?
Quale influsso esercitò l’atmosfera culturale romantica sul nazionalismo di Bismarck?
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
UNITÀ 6
Bismarck e l’idea di nazione
7
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
5
6
La nascita del Reich nella pittura
di corte tedesca
UNITÀ 6
Subito dopo la vittoria ottenuta contro i francesi, il pittore
Anton von Werner ricevette il prestigioso compito di celebrare
la nascita del nuovo impero tedesco. Werner era presente a Versailles il giorno dell’incoronazione di Guglielmo I a Kaiser del
neonato Reich e raffigurò quell’evento in numerosi dei suoi quadri. Nonostante l’apparente realismo quasi fotografico, in
realtà il dipinto è un condensato di simboli finalizzati a trasmettere
ai tedeschi un preciso messaggio nazionalistico.
L’ORDINE DI VIENNA
8
L’immagine più nota dell’unificazione tedesca è il
quadro di Werner intitolato Die Proklamierung des
Deutschen Kaiserreiches (detto anche Die Kaiserproklamation) [La proclamazione dell’Impero tedesco o La
proclamazione imperiale, n.d.r.]. Werner ne ha dipinto
diverse versioni: quanto segue si riferisce alla Schloßfassung, la prima versione terminata nel marzo 1877
ed esposta nella sala del trono del castello reale di Berlino. La scena si svolge il 18 gennaio 1871 nella grande
Galleria degli specchi della reggia di Versailles. Gli
eserciti tedeschi sono alle porte di Parigi e hanno trasferito il loro quartiere generale da Ferrières, dove occupavano il castello dei Rothschild, a Versailles. Al
centro dell’azione c’è ovviamente Guglielmo I, l’ormai
anziano re di Prussia ed ora imperatore tedesco. […]
In prima fila c’è Bismarck, l’architetto dell’unificazione
nazionale, che raccoglie i frutti di una strategia annunciata nel suo primo discorso da cancelliere prussiano.
Allora, nel settembre 1862, aveva sfidato in parlamento gli eredi della tradizione nazional-liberale con
frasi destinate a rimanere famose: «La Germania non
guarda al liberalismo della Prussia, ma alla sua potenza… le grandi questioni del tempo non si risolvono
con i discorsi e le delibere a maggioranza – questo è
stato il grande errore del 1848 e del 1849 –, ma con il
ferro e con il sangue». […] Birmarck sorregge il testo
del proclama che ha appena terminato di leggere, ma
tiene bene in vista – come del resto lo stesso imperatore – l’elmo chiodato, il simbolo per eccellenza della
potenza militare prussiana. Tutt’attorno si affollano soldati, ufficiali e comandanti tedeschi, che sollevano elmi
e sciabole a salutare l’avvenuta proclamazione. […]
Non a caso, il quadro si estende verso l’alto sino al
punto da comprendere esattamente quella parte della
volta (sopra la finestra centrale) dove compare il titolo del
grande affresco Passage du Rhin en présence des ennemis [Passaggio del Reno alla presenza dei nemici,
n.d.r.] di Charles Le Brun, l’allievo di Poussin divenuto
«premier peintre du Roi» [primo pittore del re, n.d.r.]. In
questo caso, la scelta compositiva di Werner va ben oltre la nota tecnica dell’«immagine nell’immagine». Il collegamento tra la gloria militare di Luigi XIV e la vittoria tedesca che porta alla fondazione del Reich, produce infatti
un «gioco di specchi» degno della grande galleria degli
specchi in cui si svolge la scena. […] I contemporanei di
Le Brun leggono sulle volte di quelle sale di Versailles la
propria storia, al di là di ogni analogia storica o allegoria
mitologica. Nel Salone della Guerra, la Francia trionfa
sulla Spagna e sull’Olanda, nel Salone della Pace, cioè
dopo la Galleria degli Specchi, Luigi XIV offre la sua pace
all’Europa. I contemporanei di Werner, invece, recepiscono l’«immagine nell’immagine» in maniera ben diversa, data dal mutamento dell’orizzonte storico. La memoria storica tedesca è ora dominata dal ricordo di
Napoleone, per cui collega l’attraversamento del Reno
soprattutto alle invasioni napoleoniche ed alle guerre di liberazione (Befreiugskriege). Ben pochi degli spettatori del
quadro di Werner mettono in primo piano l’attraversamento del Reno del 12 giugno 1672 e tanto meno pensano all’evento del 334 a.C. – l’attraversamento del Granico che consente ad Alessandro Magno di penetrare in
Asia – che rimane il principale riferimento storico-epocale
di Le Brun [il pittore francese si era sforzato di presentare
Luigi XIV come un nuovo Alessandro Magno, n.d.r.].
Adesso la visione retrospettiva ha una funzione unificante, per cui le vittorie tedesche su Napoleone III annullano, oltre all’espansionismo di Luigi XIV, il predominio
continentale imposto all’Europa da Napoleone e l’avanzata verso Parigi diventa l’atto conclusivo di un «passaggio del Reno» in direzione contraria.
L’altro motivo del quadro che accoglie sentimenti
molto diffusi nel pubblico tedesco è la Waffenbrüderschaft, la fratellanza d’armi che si è affermata e consolidata nel corso della guerra. Alla campagna di Francia partecipano infatti anche eserciti – dalla Baviera alla Sassonia
– che ancora nel 1866 hanno combattuto a fianco dell’Austria contro la Prussia. Non a caso il comando della
terza armata, che raccoglie le truppe degli stati meridionali, è stato affidato al principe ereditario Federico Guglielmo, che si è distinto a Königgrätz, ma che soprattutto
è considerato il più adatto per favorire il processo di fusione tra le truppe meridionali e quelle prussiane. La
guerra contro il comune nemico diventa una nationaler
Kreuzzug, una crociata nazionale destinata a risanare le ferite del 1866 ed anzi, ad unire saldamente i vecchi avversari in un nuovo patto di solidarietà nazionale. Werner
esprime questo motivo in modi diversi. Inserisce molti rappresentanti degli stati meridionali, del Baden e soprattutto
della Baviera, per lo più raggruppati nella parte destra del
quadro. Vengono utilizzati anche i dettagli, per cui (al centro del quadro e in primo piano) un capitano della cavalleria leggera bavarese volge il busto verso lo spettatore in
modo da far vedere chiaramente che è stato decorato con
la croce di ferro, cioè con l’onorificenza prussiana.
M. FERRARI ZUMBINI, Le radici del male. L’antisemitismo
in Germania da Bismarck a Hitler, il Mulino,
Bologna 2001, pp. 14-20
Che giudizio esprime Bismarck sul liberalismo?
Quale fratellanza d’armi era importante mettere in risalto, nel nuovo Reich?
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
Mazzini riprese da Robespierre e dalla tradizione giacobina della Rivoluzione francese il culto degli eroi che avevano dato
la vita per la patria e per la vittoria della giustizia. Inserendosi nella più ampia corrente romantica, Mazzini descrisse la morte eroica come un trionfo dell’individuo e della sua libera volontà, che non deve essere rifiutata come sterile sconfitta, bensì perfino ricercata con entusiasmo.
Attingendo ampiamente al culto giacobino dei santi
caduti, Mazzini edificò un pantheon [un elenco di figure
venerabili, come in passato erano stati oggetto di culto
gli dei e i santi, n.d.r.] di eroi martiri nel quale trovarono
posto uomini come i fratelli Bandiera, giustiziati a Cosenza dopo aver tentato di liberare la Calabria dai Borboni. Senza farsi scoraggiare dalle critiche rivoltegli
per il ruolo che aveva avuto nella preparazione della disastrosa spedizione, Mazzini pubblicò immediatamente
un articolo sul “People’s Journal” di Londra nel quale
celebrava quell’eroico sacrificio. Per lui, i fratelli Bandiera erano «vittime consacrate» dell’oppressione, che,
impazienti di testimoniare la loro fede nell’Italia, si recarono verso il luogo della loro esecuzione dopo una
notte di tranquillo riposo, vestiti con curata eleganza,
e «supplicarono i soldati di risparmiare il viso, fatto a
immagine di Dio». Alla miscela giacobina di passione
religiosa e di dignità classica egli aggiunse poi una
predilezione per la morte e il sacrificio di sé che proveniva dalla cultura romantica. Nonostante respingesse
l’atteggiamento melanconico dei romantici, per orientarsi piuttosto verso l’attivismo politico, egli ne seguiva
l’esempio quando esaltava la morte come atto di ribellione e di redenzione dopo un’esistenza condizionata dalle convenzioni, dalla monotonia e da un sentimento di delusione. Così, i fratelli Bandiera ebbero «lo
scopo evidente… di morire. Aperti com’erano a tutti i
grandi pensieri, furono soprattutto uomini d’azione.
Ciò traspirava da tutte le loro manifestazioni…; cercarono da ogni lato l’arena nella quale slanciarsi». E realizzarono infine la loro aspirazione morendo per l’Italia.
La narrazione che Mazzini propose della storia dei
fratelli Bandiera evidenzia i tre elementi chiave della sua
costruzione di un culto dei martiri rivoluzionari italiani.
In primo luogo, egli mirava a conferire un’aura di sacralità alla propria idea di Italia, e ad affermarsi pubblicamente, assieme ai martiri (e ai futuri martiri) aderenti
alla sua stessa causa, in veste di nuovo mediatore fra
il mondo umano e la dimensione divina. […] In secondo
luogo, nel culto del martirio Mazzini scorgeva una strategia funzionale alla comunicazione politica. La forza
del martirio come simbolo collettivo era innegabile, e
anche in questo senso Mazzini poteva rifarsi a una più
antica consuetudine religiosa. All’epoca della Riforma,
i cattolici inglesi avevano utilizzato il tema del martirio
come un «potente simbolo della persecuzione», e la figura del martire era per essi diventata «un vessillo, un
elemento di identificazione e di aggregazione, un simbolo della loro adesione alla fede cattolica», attorno al
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
quale rafforzare un senso condiviso di appartenenza.
[…] Infine, nel rappresentare la propria vita e quella dei
suoi seguaci (i martiri italiani da lui definiti Apostoli),
Mazzini prese le distanze dalla tradizione cristiana. In
particolare, operò una fusione fra una più recente e romantica idea dell’individuo libero («Non temono né dolore, né pericolo; li fronteggiano intrepidamente; non
devierebbero d’una sola linea dal loro cammino per evitarli») e più antiche raffigurazioni della santità. […]
Per realizzare quegli obiettivi, Mazzini si dedicò a
una instancabile opera di propaganda, riuscendo a
fare in modo che la figura del martire venisse associata
più a un atto di combattiva rivolta che a una rassegnazione passiva come quella di Silvio Pellico Mazzini
credeva che un manipolo di eroi coraggiosi potesse
produrre la scintilla capace di innescare un’esplosione
rivoluzionaria; e considerate le scarse possibilità di
successo, il coraggio di fronte alla morte e la fede
nelle virtù del martirio erano ingredienti essenziali dell’atteggiamento eroico. Da questo punto di vista, il
culto dei martiri del Risorgimento implicava non tanto
il tormento cattolico quanto un appello all’azione politica, e poteva avere alcuni aspetti in comune con la militanza protestante e il culto dei martiri protestanti che
manteneva una sua popolarità nell’Inghilterra vittoriana, paese nel quale il rivoluzionario genovese viveva. Per Mazzini, l’eroe martire santificava la nazione,
ma la incarnava anche come una causa degna di essere condivisa, e per la quale valeva la pena combattere e morire. […]
L’uso del culto dei martiri da parte di Garibaldi e dei
garibaldini esemplifica la strategia politica elaborata
da Mazzini. […] Nella loro ricerca di simboli riferibili all’appartenenza nazionale i rivoluzionari continuavano
ad affidarsi ad un’iconografia [un’immagine, una modalità di raffigurazione, n.d.r.] derivata dal cattolicesimo. […] Tuttavia, allo stesso tempo, l’iconografia del
martirio cristiano si fondava con quella più recente
dell’eroe romantico, dando vita all’immagine meno tradizionale di una vicenda sacrificale dai tratti virili e vigorosi. Il martire del Risorgimento era tipicamente un
uomo giovane o abbastanza giovane, bello e intenso,
che riuniva nella propria persona la virtù classica («gli
allori alle chiome») e la passione romantica («La fiamma
ed il nome d’Italia sul cor»), e si lanciava incontro alla
morte accogliendola come momento culminante della
propria esistenza e compimento del proprio destino.
Con Garibaldi, il martire risorgimentale divenne, forse
più di ogni altra cosa, un soldato, le cui battaglie in Uruguay, a Roma, in Sicilia, sull’Aspromonte e Mentana
rappresentavano anche un viaggio alla scoperta della
nazione che si voleva consolidare. Il culto del martire diventò così un elemento centrale per la creazione di
un’altra forma di culto, quella dedicata all’eroe soldato, e per affermarlo come simbolo nazionale della
virtù, del coraggio e della bellezza, associato a sua
UNITÀ 6
L’idea di martirio nella propaganda
politica di Mazzini
9
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
7
volta alla rivoluzione e alla ribellione. Si trattò di un processo che ebbe anche conseguenze sul piano pratico,
in quanto il soldato-martire, e tutto quello che in esso
era simboleggiato, entrò a far parte, in occasione delle
guerre del Risorgimento, dell’appello alle armi promosso e gestito da Garibaldi. In breve, il martire risorgimentale rappresenta una sorta di modernizzazione
del sacrificio eroico, ed esalta un rapporto con la morte
e con la violenza basato su motivazioni più immediate
e terrene. Nell’epoca di Mazzini e Garibaldi, il martirio
divenne un atto di impegno politico, che implicava la ribellione attiva oltre che un atteggiamento di paziente
rassegnazione.
L. RYALL, Il culto della morte eroica nel Risorgimento,
in O. JANZ, L. KLINKHAMMER (a cura di), La morte per la patria.
La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica,
Donzelli, Roma 2008, pp. 26-28 e 41-43, trad. it. D. SCAFFEI
UNITÀ 6
In che cosa l’idea del martirio mazziniano si distingue da quella cristiana?
Che differenza c’è tra il culto del martire e quella dell’eroe soldato, nel Risorgimento italiano?
L’ORDINE DI VIENNA
10
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
La rivoluzione del 1848 esplose a Parigi ma, in pochissimo
tempo, si propagò a gran parte dell’Europa. Nel complesso, però,
i risultati di quella improvvisa crisi rivoluzionaria furono minimi: in pratica, l’unica novità significativa fu l’abolizione della servitù della gleba nell’Impero austriaco.
La storia del mondo moderno aveva conosciuto
molte rivoluzioni di maggior portata, e molte di maggior
successo. Nessuna però si diffuse più rapidamente e
in un raggio più vasto, correndo come un fuoco di sterpaglia al di sopra di frontiere, paesi e perfino oceani. In
Francia, centro naturale e detonatore delle rivoluzioni
europee, la proclamazione della repubblica avvenne il
24 febbraio: il 2 marzo la rivoluzione aveva già guadagnato la Germania di sud-ovest, il 6 la Baviera, l’11
Berlino, il 13 Vienna e subito dopo l’Ungheria, il 18 Milano e quindi l’Italia (dove un’insurrezione indipendente
aveva già investito la Sicilia). All’epoca, il più veloce servizio d’informazioni disponibile a chiunque (quello della
banca Rothschild) non poteva portare le notizie da
Parigi a Vienna in meno di cinque giorni. Nel giro di una
settimana, nessun governo restava in piedi, in una superficie dell’Europa ora occupata in tutto o in parte da
dieci Stati – prescindendo da ripercussioni minori in un
certo numero d’altri paesi. Il 1848 fu inoltre la prima rivoluzione potenzialmente estesa a tutto il globo, di cui
si può discernere l’influenza nell’insurrezione del 1848
a Pernambuco nel Brasile e, qualche anno dopo, nella
remota Colombia. In un certo senso, fu il paradigma [=
il modello di riferimento – n.d.r.] del tipo di «rivoluzione
mondiale» che da allora dovevano sognare i ribelli, e
che in rari istanti, come all’indomani di grandi guerre,
dovevano credere di poter riconoscere. In realtà, il fenomeno di esplosioni continentali o mondiali simultanee è estremamente raro. In Europa, quella del 1848
è la sola che abbia inciso sia sulle aree «sviluppate» sia
su quelle arretrate del continente. Fu insieme la più
estesa e la meno fortunata di questo genere di rivoluzioni: a sei mesi dal suo scoppio, se ne poteva tranquillamente prevedere la sconfitta su tutta la linea; a diciotto, i regimi da essi abbattuti, salvo uno, erano tutti
restaurati, e l’eccezione (la Repubblica francese) prendeva il più possibile le distanze dal moto insurrezionale
cui doveva la propria esistenza. [...] Un mutamento costituzionale di portata maggiore v’era stato, ma uno
solo: l’abolizione della servitù della gleba nell’impero
asburgico. Eccetto quest’unica conquista, certo importante, il 1848 ci appare come la sola rivoluzione
nella storia moderna che alle maggiori promesse, al più
vasto orizzonte e al successo più immediato, unisca la
disfatta più rapida e completa. [...]
Tutte le rivoluzioni ebbero in comune qualcos’altro,
che spiega in larga misura il loro fallimento. Furono, nel
fatto o nell’anticipazione immediata, rivoluzioni sociali
degli operai comuni. Perciò spaventarono i liberali moderati che avevano spinto al potere e in posizioni di prestigio – e perfino dei politici più radicali – almeno quanto
i sostenitori dei vecchi regimi. Il conte di Cavour, futuro
architetto dell’Italia unita, aveva messo il dito su questo
punto debole alcuni anni prima (1846): «Se l’ordine sociale fosse davvero minacciato, se i grandi princìpi sui
quali riposa, corressero davvero un pericolo reale, si vedrebbero – ne siamo pesuasi – molti fra gli oppositori più
determinati, fra i repubblicani più esaltati, presentarsi per
primi nelle file del partito conservatore.»
Ora, quelli che avevano fatto la rivoluzione erano indiscutibilmente i «poveri che lavorano» (labouring poor).
Erano stati essi a morire sulle barricate; a Berlino, fra le
trecento vittime degli scontri di marzo v’erano stati appena quindici rappresentanti delle classi colte e circa
trenta maestri artigiani; a Milano, fra i 350 morti delle Cinque Giornate, solo dodici studenti, impiegati o proprietari
fondiari. [...] La rivoluzione di febbraio [...] fu una rivoluzione sociale cosciente, il cui obiettivo non era una repubblica come che sia, ma la «repubblica democratica e
sociale». I suoi leader erano socialisti e comunisti; del suo
governo provvisorio faceva parte un operaio autentico, un
meccanico noto come Albert; e, per qualche giorno, rimase incerto se la sua bandiera sarebbe stata il tricolore
o la bandiera rossa della rivolta sociale. [...] Trascinati nel
vortice della rivoluzione dalle forze dei poveri e/o dall’esempio di Parigi, i moderati cercarono naturalmente di
trarre il massimo profitto da una situazione che non si
erano aspettati fosse tanto favorevole. Ma, in ultima analisi, e spesso fin dall’inizio, si preoccuparono assai più
della minaccia da sinistra, che dei vecchi governi. Il fallimento del Quarantotto trasse origine dal fatto che lo
scontro decisivo non fu, in ultima analisi, fra i poteri costituiti e le «forze del progresso», ma fra l’«ordine» e la «rivoluzione sociale». La sua battaglia cruciale non fu quella
del febbraio [1848 – n.d.r.], ma quella del giugno a Parigi,
quando gli operai lanciatisi in una insurrezione isolata
vennero sconfitti e massacrati: combatterono duramente,
e duramente morirono. I caduti nelle battaglie di strada furono circa 1500 – due terzi o poco meno da parte governativa –; ma è tipico della ferocia dell’odio dei ricchi per
i poveri che circa tremila insorti vennero passati per le armi
dopo la sconfitta, altri dodicimila arrestati, e i più deportati in campi di lavoro in Algeria.
E.J. HOBSBAWM, Il trionfo della borghesia 1848-1875,
trad. di B. MAFFI, Laterza, Bari 1979, pp. 12-20
Presenta sinteticamente i caratteri della rivoluzione del 1848, mettendone in luce:
a) la velocità di diffusione a livello mondiale;
b) i protagonisti dei moti;
c) imento dei moti stessi;
d ) l’unico significativo mutamento che la rivoluzione riuscì a provocare.
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
UNITÀ 6
Il 1848 in Europa
11
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
8