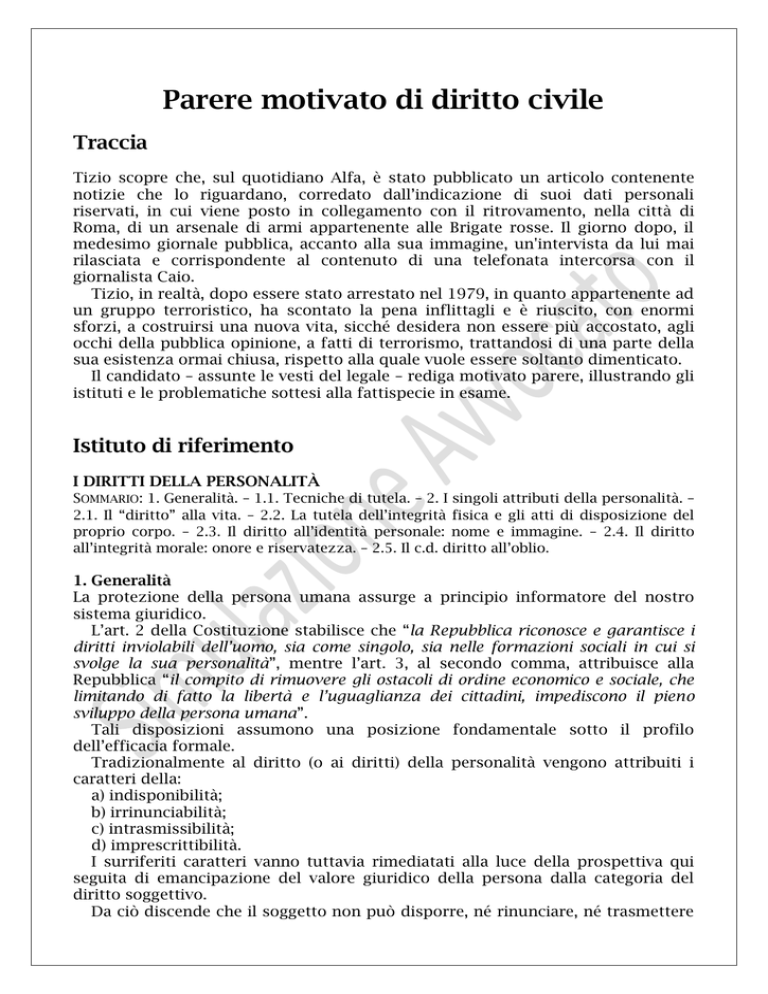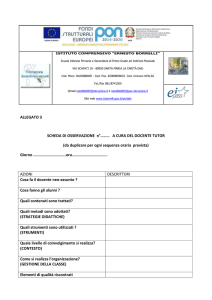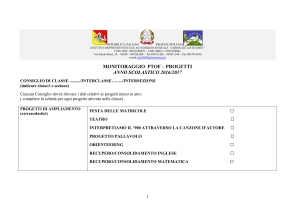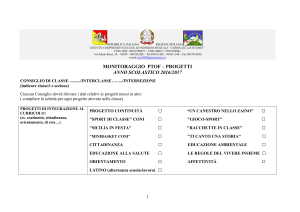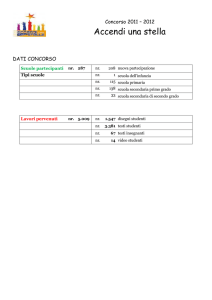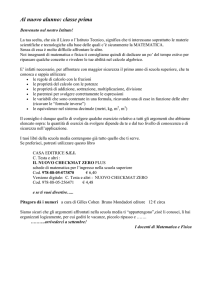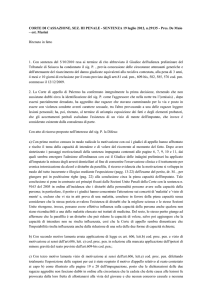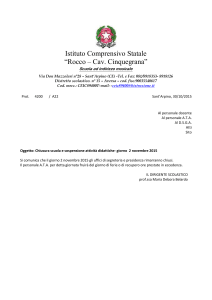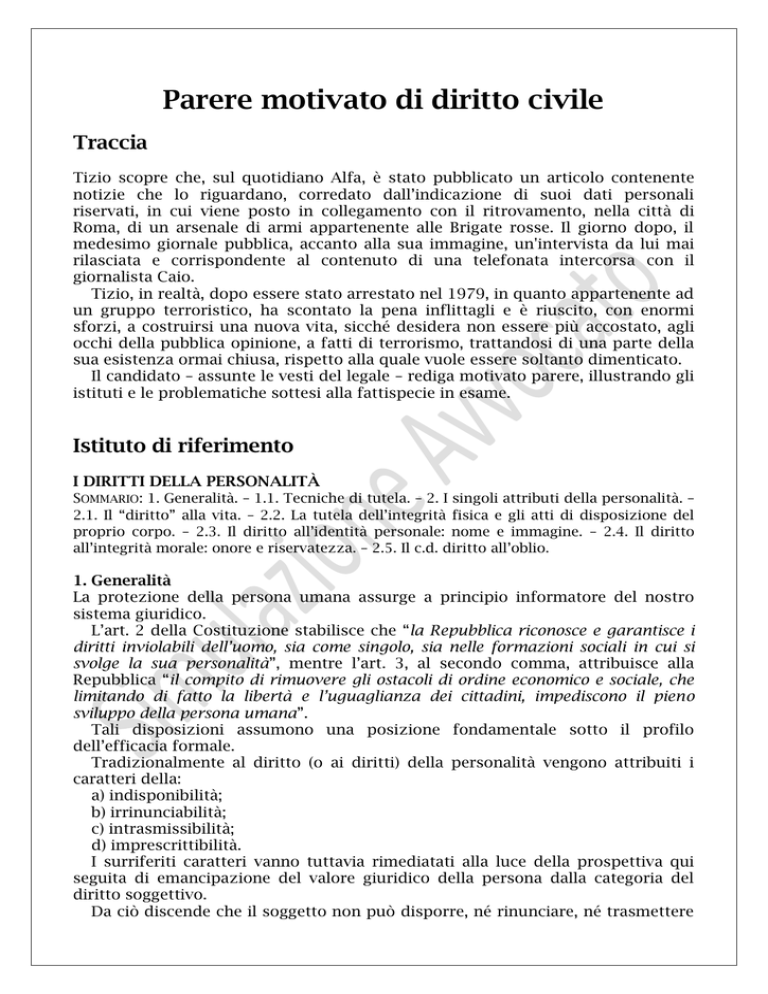
Parere motivato di diritto civile
Traccia
Tizio scopre che, sul quotidiano Alfa, è stato pubblicato un articolo contenente
notizie che lo riguardano, corredato dall’indicazione di suoi dati personali
riservati, in cui viene posto in collegamento con il ritrovamento, nella città di
Roma, di un arsenale di armi appartenente alle Brigate rosse. Il giorno dopo, il
medesimo giornale pubblica, accanto alla sua immagine, un'intervista da lui mai
rilasciata e corrispondente al contenuto di una telefonata intercorsa con il
giornalista Caio.
Tizio, in realtà, dopo essere stato arrestato nel 1979, in quanto appartenente ad
un gruppo terroristico, ha scontato la pena inflittagli e è riuscito, con enormi
sforzi, a costruirsi una nuova vita, sicché desidera non essere più accostato, agli
occhi della pubblica opinione, a fatti di terrorismo, trattandosi di una parte della
sua esistenza ormai chiusa, rispetto alla quale vuole essere soltanto dimenticato.
Il candidato – assunte le vesti del legale – rediga motivato parere, illustrando gli
istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
Istituto di riferimento
I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
SOMMARIO: 1. Generalità. – 1.1. Tecniche di tutela. – 2. I singoli attributi della personalità. –
2.1. Il “diritto” alla vita. – 2.2. La tutela dell’integrità fisica e gli atti di disposizione del
proprio corpo. – 2.3. Il diritto all’identità personale: nome e immagine. – 2.4. Il diritto
all’integrità morale: onore e riservatezza. – 2.5. Il c.d. diritto all’oblio.
1. Generalità
La protezione della persona umana assurge a principio informatore del nostro
sistema giuridico.
L’art. 2 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si
svolge la sua personalità”, mentre l’art. 3, al secondo comma, attribuisce alla
Repubblica “il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana”.
Tali disposizioni assumono una posizione fondamentale sotto il profilo
dell’efficacia formale.
Tradizionalmente al diritto (o ai diritti) della personalità vengono attribuiti i
caratteri della:
a) indisponibilità;
b) irrinunciabilità;
c) intrasmissibilità;
d) imprescrittibilità.
I surriferiti caratteri vanno tuttavia rimediatati alla luce della prospettiva qui
seguita di emancipazione del valore giuridico della persona dalla categoria del
diritto soggettivo.
Da ciò discende che il soggetto non può disporre, né rinunciare, né trasmettere
il valore di cui non è titolare, né la sua inerzia può comportare l’estinzione dello
stesso per prescrizione.
1.1. Tecniche di tutela
La particolare struttura del valore giuridico di persona e la sua ontologica
diversità rispetto al modello del diritto soggettivo si riverbera anche sul piano
delle tutele.
I rimedi esperibili in caso di violazione del valore giuridico di persona sono:
1) l’azione inibitoria, che costituisce il rimedio elettivo volto a reprimere
comportamenti che si sostanzino nella negazione di un valore giuridico, in quanto
offre una reazione immediata contro l’antigiuridicità di un comportamento in
atto. Come autorevolmente osservato, “il valore giuridico, tutelato attraverso il
dovere di astensione altrui, spiega da sé la necessità che vengano a cessare i
comportamenti da cui viene trasgredito” (MESSINETTI)
2) l’azione risarcitoria, che, con riferimento al valore giuridico di persona
assume un carattere peculiare rispetto al modello canonico di cui all’art. 2043
cod. civ. Tale norma nasce, infatti, per la riparazione di quei pregiudizi di natura
patrimoniale connessi alla lesione di posizioni di diritto soggettivo assoluto.
Secondo una parte della dottrina deve ritenersi, che, la risarcibilità del danno
consistente nella lesione del valore giuridico di persona, quale danno non
patrimoniale, trovi esclusivo fondamento nella disposizione di cui all’art. 2059
cod. civ., letto in combinato disposto con la disposizione costituzionale che
formalizza al massimo grado il valore stesso: l’art. 2 della Cost.
A differenza di quello inibitorio, il rimedio risarcitorio, quale che sia il suo
fondamento, implica una specifica valutazione della condotta tenuta da altri ed
esige un elemento soggettivo, senza il quale la qualificazione di antigiuridicità
non basterebbe a fondare una sanzione ulteriore rispetto all’inibitoria.
2. I singoli attributi della personalità
Il valore giuridico di persona è suscettibile di manifestarsi in diverse forme che
possono essere fatte oggetto di autonoma considerazione e tutela da parte
dell’ordinamento.
A grandi linee può operarsi una fondamentale distinzione tra gli aspetti:
a) c.d. “materiali” della personalità, che si specificano nel “diritto” alla vita, alla
salute e all’integrità psicofisica;
b) c.d. “morali” dei quali costituiscano manifestazione, i “diritti” al nome,
all’immagine, all’identità personale, all’onore e alla riservatezza.
2.1. Il “diritto” alla vita
Una fondamentale manifestazione del valore giuridico di persona, espressamente
tutelata tanto a livello interno quanto a livello internazionale, è la vita, quale
fenomeno naturale dell’esistenza fisica.
La vita è tutelata:
a) tanto nei confronti dello Stato che non può violare la vita della persona,
neppure in caso di gravi condanne penali (l’Italia ha infatti abolito la pena di
morte, sostituendola con l’ergastolo, anche nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra);
b) quanto nei confronti dei privati che, in caso di attentati alla vita altrui,
incorrono in aspre sanzioni di carattere penale.
Non deve credersi tuttavia che le problematiche inerenti al c.d. “diritto alla vita”
siano residuali in seno al dibattito privatistico, dovendosi anzi rilevare la sempre
più viva attenzione alla quale ultimamente alcune di esse sono state sottoposte.
Ci si riferisce in particolare alle questione della titolarità del diritto al
conseguimento della vita da parte del nascituro, e a quella, assai penosa, della
sussistenza di una libertà individuale di autodeterminazione in ordine alla
cessazione della vita stessa, qualora si versi in gravi condizioni di dolore e
sofferenza fisica a causa di un male incurabile.
Quanto al primo aspetto, ci sembra di poter dire che lo sganciamento della
personalità dagli angusti confini del diritto soggettivo possa condurre ad un
superamento della tesi formalistica in base alla quale al nascituro, in quanto privo
di capacità giuridica, non spetterebbe il diritto alla vita.
Si ritiene, invece, che proprio l’inquadramento della persona umana quale
valore fondamentale tutelato in quanto tale dall’ordinamento debba condurre ad
una sua protezione anche a prescindere dall’esistenza giuridica del soggetto sul
quale esso si appunta.
In tal senso, peraltro, depongono anche i dati normativi offerti:
– dall’art. 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (sull’interruzione volontaria di
gravidanza) che attribuisce allo Stato il compito di tutelare la vita umana dal suo
inizio;
– dall’art. 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 che, con terminologia impropria
e ai limitati fini della procreazione medicalmente assistita, prende in
considerazione “i diritti di tutti” i soggetti coinvolti compreso il concepito.
Ciò posto, peraltro, occorre considerare che il valore (potenziale) della vita del
nascituro può entrare in conflitto con altri valori in atto di pari rango quali
certamente sono la tutela della salute e della vita stessa della madre, ai quali
l’ordinamento con una scelta condivisibile, attraverso un bilanciamento di
interessi, accorda preferenza sia pure entro determinati limiti.
In particolare la legge consente alla madre l’interruzione della gravidanza:
a) entro i primi 90 giorni qualora la prosecuzione della stessa, il parto o la
maternità comportino un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in
relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o
familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di
anomalie o malformazioni del concepito (art. 4, L. 194/78);
b) anche dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un
grave pericolo per la vita della donna, ovvero quando siano accertati processi
patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della
donna (art. 6, L. 194/78).
Una questione sulla quale si è recentemente sviluppato un fervente dibattito
tanto in dottrina, quanto nella giurisprudenza, è quella della sussistenza
nell’ordinamento di un diritto a non nascere ove il nascituro sia affetto da gravi
malformazioni o anomalie che possano compromettere le condizioni e la qualità
della vita dopo la nascita (c.d. “diritto a non nascere se non sano”).
Il c.d. diritto a non nascere se non sano deve essere preliminarmente distinto
dal c.d. “diritto a nascere sano”, che costituisce invece una variabile del diritto alla
integrità psicofisica e del diritto alla salute, di cui agli artt. 5 cod. civ. e 32 Cost., e
che viene riconosciuto anche al nascituro, sia pure subordinatamente all’evento
della nascita.
L’opinione prevalente non riconosce in capo al concepito un diritto a non
nascere per diverse ragioni. Il diritto “a non nascere se non sano” non viene
riconosciuto al nascituro.
Il diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata compete ad altri
soggetti i quali, da tale nascita, abbiano subito un nocumento; la casistica
giurisprudenziale si riferisce, in particolare, ai casi di sterilizzazione (maschile o
femminile) e di aborto (anche terapeutico) non riusciti e di errata o mancata o
incompleta diagnosi prenatale in relazione ad eventuali malformazioni del feto.
L’inesatta informazione medica, infatti, preclude alla madre l’esercizio del
diritto di scelta, sia nel caso di intervento di aborto o di sterilizzazione non
riuscito, sia anche nel caso in cui essa dipenda da una errata diagnosi prenatale
sulle condizioni di salute del feto.
La mancata diligente preventiva comunicazione ai genitori sui rischi e sulle
condizioni del nascituro, nonché l’omissione di controlli ed esami più
approfonditi, attengono, dunque, alla
responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale del professionista e della struttura sanitaria nei confronti dei
genitori.
I genitori chiedono, infatti, la riparazione di un danno derivante non solo e non
tanto dalla nascita di un figlio non voluto, ma dal fatto stesso che è stata violata
la loro decisione di non averlo.
Peraltro, il risarcimento del danno per mancato esercizio del diritto
all’interruzione
della
gravidanza
non
consegue
automaticamente
all’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione se il professionista sia
stato interpellato dopo il novantesimo giorno dal concepimento. In questo caso
occorrerà, infatti, anche accertare che sussistano le due condizioni previste dagli
artt. 6 e 7 della L. 194 del 1978:
– un processo patologico, fisico o psichico, in atto;
– l’impossibilità di una vita autonoma, al di fuori dell’ambiente materno, per il
feto.
In altri termini, il giudice chiamato ad accertare la responsabilità del
professionista dovrà stabilire, con valutazione da compiersi ex ante, e quindi con
riferimento al momento in cui il medico ha omesso la corretta informazione, se la
conoscenza della reale situazione patologica del feto avrebbe ingenerato nella
donna un processo patologico, fisico o psichico, con pericolo grave per la salute
della stessa, ovvero se la sussistenza dell’errore diagnostico abbia o non abbia
privato la madre dell’esercizio del suo diritto all’interruzione della gravidanza a
causa della malformazione del figlio.
Nel caso in cui, invece, l’inadempimento all’obbligo di esatta informazione
intervenga sino al novantesimo giorno dal concepimento, sussiste pacificamente
l’obbligo del professionista di risarcire il danno.
Altra questione particolarmente controversa è quella della sussistenza in capo
al soggetto di un diritto di morire, ponendo volontariamente fine alla propria vita.
Si discute, in particolare, in merito alla esistenza di una facoltà di suicidio;
secondo la prospettiva tradizionale, che disegnava i c.d. “diritti della personalità”
sul modello dominicale, non poteva che addivenirsi ad una qualificazione di
liceità del suicidio quale esplicazione della autodeterminazione dell’individuo
spinta al limite estremo della soppressione di se stesso.
Un problema assai delicato si pone peraltro nelle ipotesi in cui il malato, che
sopravviva esclusivamente grazie a dei trattamenti sanitari volti a sopperire alla
carenza di alcune funzioni vitali (si pensi all’alimentazione tramite un sondino
naso-gastrico per i pazienti che non siano in grado alimentarsi autonomamente),
scelga deliberatamente di sospendere detti trattamenti. Tale scelta rientra nella
piena disponibilità del soggetto dato che, giusto il disposto dell’art. 32, secondo
comma, Cost. “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge”; “la legge” – prosegue la norma – “non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Elemento caratterizzante dei trattamenti sanitari è, dunque, salve le eccezioni
espressamente disciplinate dalla legge nell’interesse pubblico (c.d. “trattamenti
sanitari obbligatori”), il consenso libero e informato dell’interessato che si rende
necessario anche se l’attività del medico è a vantaggio della salute del paziente.
Il consenso informato deve essere:
1) personale;
2) basato su informazioni mediche esaustive;
3) esplicito;
4) consapevole;
5) prestato da soggetto capace di intendere e volere.
Solamente quando il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà
il medico può intervenire in situazione di bisogno mediante il ricorso allo stato di
necessità.
Il consenso prestato dal paziente è manifestazione del diritto di
autodeterminazione, che trova la sua espressione nella libertà costituzionale di
scelta terapeutica.
L’attività medico-chirurgica, infatti, è un’attività socialmente utile che trova il
proprio limite negli artt. 13 (che tutela la libertà personale) e 32 (che pone un
limite al carattere socialmente utile dei trattamenti sanitari vietandoli in assenza
di consenso del paziente) Cost., nonché nell’art. 33 della L. 833/1978, che
regolamenta l’acquisizione del consenso informato nelle ipotesi di impossibilità
psico-fisica del paziente.
Questione strettamente connessa è quella del testamento biologico,
intendendosi con ciò una dichiarazione scritta di volontà di un soggetto nel pieno
delle facoltà mentali relativamente ai trattamenti sanitari da somministrargli
nell’ipotesi in cui egli dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere
il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per
malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, che costringano
a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali.
Le disposizioni contenute nel testamento biologico sono revocabili in ogni
momento dal testatore ancora nel possesso delle capacità cognitive senza alcun
onere formale: la primarietà e l’assolutezza del diritto in gioco inducono, infatti,
ad escludere il richiamo di limitazioni per analogia con altri istituti e in
particolare con quello delle revocazione delle disposizioni testamentarie (artt. 679
ss. cod. civ.).
2.2. La tutela dell’integrità fisica e gli atti di disposizione del proprio corpo
Un aspetto materiale della personalità di fondamentale rilevanza per
l’ordinamento è anche l’integrità fisica.
Essa è oggetto di specifica protezione da parte di diverse disposizioni
costituzionali e di legge tra cui meritano particolare menzione:
a) l’art. 32 Cost., che tutela la salute quale diritto fondamentale dell’individuo e
interesse della collettività;
b) l’art. 5 cod. civ., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo ove
cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica;
c) l’art. 2087 cod. civ., che obbliga l’imprenditore ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di
lavoro;
d) l’art. 1 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale destinato “al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica
di tutta la popolazione”.
Deve pertanto ritenersi, alla luce di un’interpretazione evolutiva del dato
letterale di cui all’art. 5 cod. civ. che nell’ordinamento viga un generale divieto di
“disporre” del proprio corpo, quando l’atto dispositivo possa recare nocumento al
valore giuridico di persona.
Devono comunque ritenersi lecite in virtù di un fondamentale principio di
solidarietà sociale le donazioni di organi necessari per l’altrui salute. La legge
prevede espressamente la donazione di un rene di persona vivente, il trapianto
parziale di fegato, la donazione di cellule staminali, midollari e periferiche a
scopo di trapianto. In particolare, per la donazione del rene (l. 458/1967) sono
previsti controlli e l’autorizzazione del giudice. La l. 592/1967 regola la
donazione di sangue a scopo terapeutico sottoposta a controllo e prelievo medico.
La l. 164/1982 disciplina la liceità del trattamento medico finalizzato al
mutamento di sesso, previa autorizzazione all’intervento da parte dell’autorità
giudiziaria.
Il divieto di cui all’art. 5 cod. civ. non riguarda le parti staccate del corpo
(unghie, denti e capelli) che al momento del distacco diventano beni autonomi
suscettibili di godimento e di scambio.
Quanto al cadavere, deve ritenersi che, a seguito della morte, il corpo dell’uomo
diventi res extra commercium, stante l’evidente lesione della dignità umana e del
sentimento di pietà verso i defunti che deriverebbe da una commerciabilità dello
stesso.
Una disciplina peculiare è, infine, dedicata agli espianti di organi da cadavere a
fine di trapianto (L. 1 aprile 1999, n. 91). Tale disciplina consente l’espianto di
organi o tessuti, all’esclusivo scopo di provvedere a trapianti terapeutici, da un
soggetto del quale sia stata clinicamente accertata la morte e che abbia
previamente assentito. Il consenso, tuttavia, si presume nelle ipotesi in cui il
soggetto pur debitamente informato non abbia espresso volontà contraria.
2.3. Il diritto all’identità personale: nome e immagine
Uno degli aspetti della personalità oggetto di attenzione da parte della dottrina e
della giurisprudenza fin da tempi risalenti è certamente il nome della persona.
Il nome rappresenta il segno identificativo e distintivo della persona.
È costituito da:
– un prenome, scelto dai genitori al momento della nascita;
– un cognome, quello del padre, che si acquisisce automaticamente con il
rapporto di filiazione.
Al figlio legittimo e adottivo è attribuito il cognome del padre; al figlio naturale
è attribuito il cognome di chi lo riconosce.
Il Codice civile, agli artt. 7, 8 e 9, tutela il diritto al nome, impedendone l’uso
indebito con l’azione inibitoria.
L’art. 7 cod. civ. protegge il nome sotto un duplice aspetto:
1) come diritto all’uso del proprio nome ovvero come diritto di essere
identificati e di identificarsi con il proprio nome (diritti protetti con l’azione di
reclamo);
2) come diritto all’uso esclusivo del proprio nome, protetto tramite l’azione di
usurpazione, contro chi usi il nome altrui per identificare se stesso o per indicare
una cosa (per es., come marchio di un prodotto) o ne faccia comunque indebito
uso.
In entrambi i casi l’azione tende ad ottenere dall’autorità giudiziaria una
sentenza che ordini la cessazione del fatto lesivo del diritto e, se del caso, la sua
pubblicazione su uno o più giornali; per questo non occorre che l’attore provi di
aver subito un danno, essendo sufficiente che provi una potenzialità di
pregiudizio.
L’azione di cui all’art. 7 cod. civ. può essere proposta anche da chi, pur non
portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un
interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette (art. 8 cod. civ.).
Ai sensi dell’art. 9 cod. civ. viene tutelato anche lo pseudonimo, quando abbia
acquistato la stessa importanza del nome.
La tutela del diritto al nome non spetta solo alle persone fisiche ma anche alle
persone giuridiche, in riferimento alla denominazione della società o
dell’associazione o della fondazioni.
La tutela dell’immagine riceve una protezione analoga a quella del diritto al
nome. In questo caso deve ricercarsi, però, un punto di equilibrio fra le due
esigenze opposte:
1) della riservatezza, come desiderio di sottrarre la propria vita privata alla
curiosità altrui;
2) del diritto alla libera manifestazione del pensiero (di cui è espressione la
libertà di stampa).
L’art. 10 cod. civ., integrato con gli artt. 96 e 97, L. 633/1941 (legge sulla
protezione del diritto d’autore), dispone che, qualora l’immagine di una persona o
dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in
cui la legge lo consente, ovvero con pregiudizio della reputazione e del decoro
della persona stessa e dei menzionati congiunti, il giudice può disporre che cessi
l’abuso, salvo il risarcimento del danno, tutto questo a meno che non si tratti di
soggetto notorio (attore, atleta famoso ecc.) o che l’immagine sia stata pubblicata
nel contesto di un avvenimento pubblico (cerimonia, manifestazione sportiva ecc.)
e comunque sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della
persona. Non è permessa, perciò, la pubblicazione dell’immagine, neanche se di
persona notoria, ripresa durante la vita intima. Secondo l’opinione più accreditata
la tutela del nome e dell’immagine sarebbero espressione di un ben più ampio
diritto alla tutela della propria identità personale.
2.4. Il diritto all’integrità morale: onore e riservatezza
A differenza dei diritti al nome e all’immagine, il diritto all’onore, ovvero alla
dignità personale, al decoro e alla considerazione all’interno della società, non ha
una specifica protezione civilistica. Tuttavia, esso si desume dalle norme del
Codice penale che incriminano fattispecie quali l’ingiuria (art. 594 cod. pen.),
definita come un’offesa all’onore e al decoro, e la diffamazione (art. 595 cod.
pen.), che protegge la reputazione, lesa attraverso comunicazioni con due o più
persone.
Il diritto all’onore può entrare in contrasto con altri diritti di pari rango quale il
diritto alla libera manifestazione del pensiero, del quale costituiscono espressioni
il diritto di cronaca, di critica e di satira.
La tutela civile del diritto all’onore si esplica attraverso i rimedi inibitorio e
risarcitorio (anche in forma specifica, ad es., mediante pubblicazione della
sentenza a mezzo stampa). Un particolare rimedio, previsto dalla legge sulla
stampa è la rettifica, consistente nel diritto della persona lesa dalla pubblicazione
di far pubblicare, sullo stesso periodico, con peculiari modalità, risposte,
rettifiche o dichiarazioni inerenti all’articolo lesivo della reputazione.
In continua espansione è poi la tutela accordata al diritto alla riservatezza o,
con termine mutuato dai paesi di Common law, alla privacy, contemplato anche
dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui ogni
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio
(art. 14 Cost.) e della sua corrispondenza (art. 15 Cost.); ne consegue che ogni
individuo ha diritto di non vedere pubblicate o divulgate, attraverso la stampa, la
televisione o altri mezzi di comunicazione di massa, notizie attinenti alla propria
vita privata, anche se vere e non lesive della dignità e dell’onore. Il diritto in
questione è protetto, per certi aspetti dall’art. 617-bis cod. pen. che punisce
chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge, installa apparati o strumenti volti a
intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche.
La grande diffusione dei mezzi informatici ha inoltre portato come
conseguenza la possibilità da parte praticamente di chiunque di creare e gestire le
cosiddette banche dati, ossia raccolte sistematiche e sempre più complete di
informazioni che, in certi casi, possono essere a carattere oggettivo, riguardando
notizie di pubblico dominio, e altre volte, e più spesso, a carattere soggettivo,
ossia sul conto di persone, imprese, enti.
Il diritto alla riservatezza nel nostro paese ha conosciuto solo di recente una
regolamentazione da parte del legislatore. Precedentemente all’entrata in vigore
della prima legge ad esso appositamente dedicata (la legge 675/1996), tuttavia,
era stata la giurisprudenza, in accoglimento della concezione monista con
riferimento alla struttura dei diritti della personalità, ad accordare tutela alla
riservatezza, per l’appunto quale attributo di un unico diritto della personalità.
Attualmente la materia è regolata dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, che ha dettato una normazione generale diretta a
garantire che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale” e, altresì, a
tutelare “i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione” (art.
2, co. 1).
2.5. Il c.d. diritto all’oblio
Di creazione giurisprudenziale è il c.d. diritto all’oblio: collocato tra i diritti
inviolabili menzionati dall’art. 2 Cost. (norma dinamica), è il diritto di un
individuo ad essere dimenticato, o più correttamente, a non essere più ricordato
per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.
La terminologia trae origine dalla traduzione della formula “droit à l’oubli”,
coniata dalla dottrina francese nel 1965.
La giurisprudenza di legittimità lo ha definito come “interesse di ogni persona a
non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore
e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato
legittimamente divulgata” (Cass. sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679).
In base all’esercizio del diritto di cronaca vengono narrati alcuni fatti
considerati di interesse della collettività nel momento in cui accadono, con
conseguente, e legittima, restrizione della sfera della riservatezza e della
reputazione dei soggetti coinvolti negli avvenimenti di interesse pubblico.
Quando però i fatti risultano acquisiti definitivamente dalla collettività, i
protagonisti di questi possono nutrire il giusto desiderio di rientrare
nell’anonimato ed essere dimenticati dal pubblico, una volta che tutto ciò che
poteva essere detto in quanto socialmente utile è stato detto. In questi casi infatti
non vi è più una notizia e la nuova diffusione sarebbe non solo inutile, visto che
non sussisterebbe un reale interesse del pubblico ad essa, ma anche dannosa per i
protagonisti della vicenda;la lesione della loro reputazione pertanto, anche se
inizialmente è scriminata, non lo è più una volta che la collettività sia stata
ampiamente informata.
A partire dalla completa acquisizione della notizia, sorge dunque il
presupposto del diritto all’oblio, consistente nell’affievolimento dell’interesse
della collettività una volta che essa sia stata informata: la questione sta nello
stabilire quale sia il momento a partire dal quale questo diritto possa ritenersi
prevalente.
Il diritto all’oblio è anch’esso di creazione giurisprudenziale, e il suo
fondamento normativo può essere individuato tra i diritti inviolabili menzionati
nell’art. 2 della Costituzione, ripercorrendo l’iter seguito per l’affermazione di
altri diritti della personalità, quali quello alla riservatezza e quello all’identità
personale. Intendendo l’art. 2 Cost. quale clausola aperta infatti, è possibile farvi
rientrare non solo i diritti espressamente elencati, ma anche tutti quelli che
costituiscono esigenze fondamentali della persona umana, le quali emergono di
un passo con l’evoluzione dei costumi e della sensibilità sociale, e trovano tutela
venendo ricondotti nell’alveo di tale articolo, tramite un procedimento c.d. di
costituzionalizzazione successiva.
Il diritto all’oblio viene ricondotto anche all’art. 27, terzo comma, della
Costituzione in base al quale le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato, poiché contribuisce a renderne effettivo l’esercizio: le pene non
devono avere soltanto la funzione di punire, ma anche (e soprattutto) quella di
favorire il reinserimento sociale del condannato, la sua restituzione alla società
civile.
In quest’ottica la riproposizione di un fatto remoto inciderebbe negativamente
sulla funzione rieducativa della pena, rinsaldando nella collettività il ricordo di
quanto il condannato ha fatto, anche una volta espiata la sua pena; chi ha
scontato una condanna, chi ha già patito la riprovazione della società e sta
faticosamente cercando di reinserirsi in essa, ha un interesse specifico a che, ove
ciò non corrisponda a un interesse pubblico alla conoscenza prevalente, fatti del
passato non siano nuovamente divulgati senza giusta causa.
Compito del diritto all’oblio è quindi anche quello di tutelare dalla riprovazione
sociale evitando che avvenimenti del passato possano ostacolare la
risocializzazione del reo.
Per quanto riguarda le leggi ordinarie infine, nel Codice in materia di
protezione dei dati personali, sono presenti due articoli tramite i quali si tutela il
diritto all’oblio: l’art. 7, terzo comma, lett. b) tutela il diritto dell’interessato di
richiedere al titolare del trattamento la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima delle sue informazioni personali, se trattate in violazione alla legge o se
non è più necessaria la loro conservazione in base agli scopi perseguiti; l’art. 11,
primo comma, lett. e), stesso Codice prevede che le informazioni non siano
conservate in una forma che consenta l’individuazione dell’interessato per un
periodo superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali
erano state raccolte.
Indicazioni giurisprudenziali
Dati
personali
–
Anche
in
caso
di
memorizzazione in Internet, deve riconoscersi,
al soggetto cui pertengono i dati personali
oggetto di trattamento, il diritto all'oblio come
controllo a tutela della propria immagine
sociale, idoneo a tradursi nella pretesa alla
contestualizzazione e aggiornamento dei
medesimi e, se del caso (avuto riguardo alla
finalità della conservazione nell'archivio e
al'interesse che la sottende), alla relativa
cancellazione (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012,
n. 5525).
Diritto all’informazione (bilanciamento) – Nel
bilanciamento tra il diritto all'informazione ed
il diritto all'oblio deve essere accordata
maggiore tutela a quest'ultimo ogni qualvolta i
fatti
narrati
nell'articolo
oggetto
di
contestazione
non
corrispondano
integralmente a verità, ed altresì difetti
integralmente
il
requisito
dell'interesse
pubblico
alla
conoscenza
della
notizia
(Tribunale Milano, sez. I, 26 aprile 2013).
Lesione dell’onore e della reputazione – In
tema di diffamazione a mezzo "mass media" fermo restando che la libertà di stampa,
espressione del diritto di manifestazione del
pensiero sancito dall'art. 21 Cost., comporta la
compressione
dei
beni
giuridici
della
riservatezza, dell'onore e della reputazione,
peraltro,
anch'essi,
aventi
dignità
costituzionale, ex art. 2 e 3 Cost. - il riferimento
a distanza di tempo, in sede di c.d. talk show
televisivo, dello sviluppo di indagini di polizia
giudiziaria, consentito in chiave storica
dell'evento nonché di critica all'operato degli
inquirenti, comporta che l'obbligo deontologico
del giornalista deve parametrarsi a criteri di
rigore ancora maggiori dell'ordinario, nel senso
che, ove permanga o si riattualizzi l'interesse
pubblico alla relativa propalazione - che, in tal
caso, deve essere bilanciato con il diritto
all'oblio - ed esigenze di ricostruzione storica o
artistica lo richiedano, la notizia deve essere
accompagnata dalla doverosa avvertenza che le
tesi investigative rimaste a livello di mera
ipotesi di lavoro, non hanno trovato alcuna
conferma o addirittura sono state decisamente
smentite dal successivo sviluppo istruttorio, in
quanto incombe sul giornalista il dovere
giuridico di rendere una informazione completa
e di effettuare, all'uopo, tutti i controlli
necessari per verificare gli esiti di una data
indagine (Cass. pen., sez. V, 17 luglio 2009, n.
45051).
Archivio storico della rete internet – L'editore
di un quotidiano che memorizzi nel proprio
archivio storico della rete internet le notizie di
cronaca, mettendole così a disposizione di un
numero potenzialmente illimitato di persone, è
tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione
di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto
all'oblio delle persone che vi furono coinvolte.
Pertanto, quando vengano diffuse sul web
notizie di cronaca giudiziaria, concernenti
provvedimenti limitativi della libertà personale,
l'editore è tenuto garantire contestualmente
agli utenti un'informazione aggiornata sullo
sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che
essa possa essere reperita "aliunde". (Nella
specie, la società editrice di un noto quotidiano
aveva messo "on line" il proprio archivio
storico, nel quale era contenuta altresì la
notizia dell'arresto, avvenuto venti anni prima,
di un amministratore locale, poi assolto) (Cass.
civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525).
Intervento del Garante della privacy – Con una
recente decisione il Garante della Privacy ha
riconosciuto ad un operatore pubblicitario il
diritto all'oblio, previsto dal Codice in materia
di protezione dei dati personali, disponendo
nei confronti di un ente pubblico gli opportuni
accorgimenti per interrompere quella che il
ricorrente riteneva una perpetua "gogna"
elettronica. In particolare sul sito internet
istituzionale dell'ente pubblico sono presenti le
decisioni sanzionatorie riguardanti l'interessato
ormai risalenti nel tempo. Il Garante ha
stabilito che le pagine web del sito contenenti le
decisioni in questione dovranno essere escluse
dalla diretta reperibilità dei comuni motori di
ricerca, per evitare che, come lamentato dal
ricorrente, i primi risultati della ricerca riferiti
al proprio nominativo non riguardino le notizie
sulla sua attuale o più recente attività
professionale, ma i datati provvedimenti
(Garante Privacy, newsletter 21 marzo 2005).
Atto giudiziario di diritto penale
Traccia
Il 25 giugno 2011 Tizio, a bordo del ciclomotore Honda, percorre la SS1 in
direzione Roma mantenendo una velocità costante di 100 km/h, superiore di 40
km/h rispetto al limite previsto per quel tratto stradale.
Giunto in prossimità del Km 21, Tizio si accorge della presenza, in una piazzola
di sosta, di agenti della Polizia stradale i quali, in divisa e con l’auto di ordinanza,
rilevata l’elevata velocità mediante telelaser dotato di microdigicam per
l’acquisizione delle immagini (ultima omologazione del 30 luglio 2012), gli
intimano l’“alt” al fine di contestargli l’infrazione. Tizio, tuttavia, temendo il ritiro
della patente, non ottempera all’ordine di fermarsi impartito in particolare
dall’agente Mevio, che, a tal fine, si era sporto sul ciglio della strada mostrando
apposito segnale distintivo, e prosegue la propria marcia ad alta velocità,
sottraendosi così al controllo di polizia.
Le indagini successive, condotte sulla targa del motociclo Honda, consentono di
pervenire alla individuazione di Tizio il quale, all’esito di giudizio immediato,
viene condannato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all’art. 650
cod. pen. per non aver adempiuto all’ordine di arrestarsi impartito dall’agente
Mevio.
Tizio si rivolge pertanto al suo legale di fiducia al quale chiede di proporre
impugnazione avverso la sentenza di condanna.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto giudiziario ritenuto più
opportuno.
Istituto di riferimento
IL CONCORSO APPARENTE DI NORME
SOMMARIO: 1. Il concorso apparente tra norme e il principio del ne bis in idem sostanziale.
– 2. Il principio di specialità e gli altri criteri volti a identificare i casi di concorso
apparente tra norme.
1. Il concorso apparente tra norme ed il principio del ne bis in idem
sostanziale
Si ha concorso apparente tra norme nelle ipotesi in cui una o più condotte materiali appaiano, prima facie, astrattamente riconducibili a diverse fattispecie
sanzionatorie, pur risultando poi in concreto applicabile una sola di esse (si pensi
al caso del comproprietario che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si
impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, il cui contegno
sembrerebbe indifferentemente riconducibile alla fattispecie del furto comune di
cui all’art. 624 cod. pen. ovvero a quella della sottrazione di cose comuni di cui
all’art. 627 cod. pen.).
Il fondamento normativo del concorso apparente tra norme è costituito
dall’art. 15 cod. pen. che contempla il c.d. principio di specialità: “Quando più
leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa
materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla
disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
Per quanto previsto dall’art. 15 cod. pen., dunque, qualora più disposizioni
regolino la stessa materia, deve prevalere, salvo che sia diversamente stabilito, la
norma speciale che descrive la condotta con maggiori particolari.
In sostanza, il principio di specialità è espressione del divieto per cui uno
stesso fatto possa essere posto a carico dell’agente più di una volta (così,
nell’esempio fatto, il comproprietario risponderà del solo delitto di sottrazione di
cose comuni e non anche del furto comune, in quanto il primo delitto è speciale
rispetto al secondo). Invero, esigenze di equità sostanziale e di certezza giuridica
impongono di evitare che l’autore del fatto debba rispondere dello stesso
mediante l’applicazione di due o più norme incriminatrici e ciò in ossequio al
principio generale del ne bis in idem sostanziale. Si tratta, cioè, di una esigenza
razionale ed equitativa di non proliferazione della risposta punitiva dello Stato
che, anche in relazione ai principi di proporzionalità e di finalità rieducativa della
pena, sarebbe nociva. D’altronde, l’alternativa tra concorso apparente tra norme e
concorso (reale) di reati ruota proprio attorno alla suddetta esigenza ed il
legislatore, con la codificazione del principio di specialità, se n’è fatto carico,
anche se il criterio logico della specialità si è mostrato, per certi versi,
insoddisfacente, inducendo la dottrina prevalente all’elaborazione di criteri di
valore utilizzati, peraltro, anche in ambito giurisprudenziale.
Si è così passati da una concezione monistica a una concezione pluralistica dei
criteri per risolvere il problema della suddetta alternativa tra concorso apparente
e concorso reale tra norme incriminatrici.
Secondo la teoria monistica, per stabilite se il concorso è apparente o reale, è
sufficiente il solo criterio di specialità espressamente codificato dal legislatore.
Nondimeno i fautori di tale teoria, consci dell’inadeguatezza del solo criterio
logico in discussione a risolvere le questioni applicative relative alla
riconducibilità di un dato fatto storico a una ovvero a due o più norme
incriminatrici, ampliano il concetto di specialità, contaminandolo con soluzioni
che prescindono dalla sussistenza tra le norme di un rapporto di genere a specie.
Secondo la teoria pluralistica, invece, l’insufficiente criterio logico della
specialità va integrato con criteri di valore che, sintetizzando le varie posizioni
emerse in argomento, possono ricondursi a quelli di sussidiarietà e assorbimento
o consunzione.
2. Il principio di specialità e gli altri criteri volti ad identificare i casi di
concorso apparente tra norme
Le relazioni intercorrenti tra le norme penali, soprattutto quelle inerenti ai loro
rapporti nell’ambito sanzionatorio, sono regolate certamente dal criterio di
specialità di cui all’art. 15 cod. pen. Questo criterio, tuttavia, come appena visto,
non è l’unico, in quanto un rapporto apparente tra norme, come si avrà modo di
studiare, è ipotizzabile anche tra disposizioni magari del tutto diverse tra loro per
struttura oggettiva ed elemento soggettivo, che tutelino però lo stesso interesse
giuridico.
È importante, quindi, analizzare in modo distinto i criteri impiegati per la
regolamentazione dei diversi casi di concorso tra norme, tenendo separati quelli
che tengono conto di eventuali relazioni logiche tra norme da quelli improntati su
rapporti di valore.
Il principio di specialità valorizza il rapporto di genere a specie tra norme. Ne
costituisce immediato precipitato logico la prevalenza della norma speciale
rispetto a quella generale (lex specialis derogat legi generali).
Detto principio postula che una determinata norma incriminatrice (speciale)
presenti in sé tutti gli elementi costitutivi di un’altra (generale), oltre a quelli c.d.
specializzanti. È necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due
cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé
quello minore, e abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i
requisiti aggiuntivi della specialità.
Gli elementi possono essere specializzanti per aggiunta ovvero per
specificazione. Nel primo caso si parla di specialità per aggiunta, poiché la norma
speciale prevede un elemento ulteriore rispetto al o agli elementi comuni con la
norma generale, mentre nel secondo caso si parla di specialità per specificazione,
poiché l’elemento specializzante si caratterizza non per aggiungere un ulteriore
elemento rispetto alla norma generale ma per specificare un concetto generale
contenuto in tale ultima norma.
Il principio di specialità, dunque, esige una pluralità di norme regolatrici della
stessa materia – intendendo per stessa materia non l’identità del bene giuridico
tutelato, bensì il settore o l’aspetto dell’attività umana che la legge interviene a
disciplinare – e, nel contempo, la presenza in una di esse di elementi peculiari che,
per la loro specificità e per la loro immediata riferibilità al caso concreto, siano da
ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente che resta esclusa o
assorbita.
In applicazione del principio di specialità sancito dall’art. 15 cod. pen. e del
principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell’agente una
seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa
mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a sé o ad altri l’impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina
impropria, di cui all’art. 628, primo capoverso, cod. pen. valutato dal legislatore
per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una
seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista
dall’art. 576, n. 1, cod. pen. in relazione all’art. 61, n. 2, cod. pen.
Si pensi, altresì, alla fattispecie di infanticidio di cui all’art. 578 cod. pen. che
sanziona un fatto (l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)
riconducibile, in astratto, anche sotto la norma sanzionatoria generale di cui
all’art. 575 cod. pen., la quale però, nel limitarsi a punire la semplice condotta di
chi cagiona la morte di un uomo, non prende in considerazione una serie di
elementi, che connotano invece la norma speciale [elementi specializzanti della
fattispecie di cui all’art. 578 cod. pen. individuabili nel soggetto attivo (la madre),
nelle particolari condizioni in cui agisce (condizioni di abbandono materiale e
morale connesse al parto), nelle circostanze di tempo in cui ha luogo la condotta
(immediatamente dopo il parto .. o durante il parto), nel soggetto passivo (il
neonato, immediatamente dopo il parto o il feto, durante il parto)].
Analogamente, in tema di falsità materiale in atto pubblico, si realizza un concorso apparente di norme tra le disposizioni di cui agli artt. 469 cod. pen.
(contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione e certificazione) e 476
stesso codice (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
nel caso in cui la falsificazione concerna un atto notarile. Questo perché la
fattispecie ex art. 476 cod. pen., avendo carattere più generale, coinvolge quella di
cui all’art. 469 cod. pen. che ha per oggetto solo un aspetto del documento
falsificato e cioè l’impronta del sigillo notarile.
Per il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., non è configurabile il
delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per
uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di
persona, posto che il reato di cui all’art. 610 cod. pen., avente carattere
sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso
specificamente previsto dalla legge.
Sempre in forza del principio di specialità il delitto di ricettazione deve
ritenersi assorbito nel reato previsto dall’art. 453, n. 3, cod. pen., che punisce la
condotta di chi, senza essere concorso nella falsificazione, detenga monete
falsificate di concerto con l’autore della stessa o con un intermediario.
L’elemento specializzante può anche essere costituito da una circostanza. Al
riguardo, esempi ricorrenti sono forniti dalla disciplina del reato di furto ex art.
624 cod. pen. rispetto alle ipotesi speciali di cui all’art. 624-bis e 625 cod. pen., le
quali ne ripetono la fattispecie, aggiungendo ulteriori elementi che ne connotano
la condotta aumentandone il grado di disvalore.
Superata è la concezione per cui, ai fini dell’applicazione della disciplina del
concorso di norme, ex art. 15 cod. pen. (con la conseguente necessità di
individuare la norma speciale che deroga a quella generale), è l’identità della
natura delle norme, nel senso che si deve trattare di norme penali. Si è, infatti,
autorevolmente sostenuto che il rapporto di specialità intercorre anche tra norme
penali incriminatici e norme penali c.d. “di liceità” .
Inoltre, l’art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, disciplina il concorso di
norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative. In base a tale norma, se
uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che
prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale. Quindi,
la relazione di specialità tra norme eterogenee, penali da un lato e sanzionatorie
amministrative dall’altro, non è preclusa, anzi è prevista espressamente dal
legislatore. È stato così fugato ogni dubbio sull’ammissibilità del concorso tra
sanzione penale e violazione amministrativa.
La norma in esame non prevede la clausola di riserva prevista, invece, dall’art.
15 cod. pen. La diversa formulazione, rispetto a tale ultima disposizione, non
preclude comunque al legislatore di prevedere espressamente la clausola nei
singoli casi (si veda, ad esempio, l’art. 214, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, nuovo codice della strada), ma vale sicuramente a dettare un criterio
interpretativo restrittivo in quelli che potrebbero essere considerati casi di riserva
implicita ampliando inevitabilmente l’area del concorso apparente in un percorso
di valorizzazione di questo principio che certamente il legislatore ha voluto
perseguire con l’eliminazione del riferimento alla clausola di riserva.
Altra differenza tra le citate norme è nel testo. L’art. 9, invece, di parlare di
“stessa materia”, fa riferimento allo “stesso fatto”. Non è, però, da ritenere, come
affermato da parte della dottrina, che con questa formula il legislatore abbia
inteso fare riferimento alla specialità in concreto dovendosi, al contrario, ritenere
che il richiamo sia fatto alla fattispecie tipica prevista dalle norme che vengono in
considerazione evitando quella genericità che caratterizza l’art. 15 cod. pen. con il
riferimento al concetto di materia.
Secondo l’opinione preferibile, infatti, nel caso di concorso tra fattispecie penali
e violazioni di natura amministrativa, il confronto deve avvenire tra fattispecie
tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete. Il che, del resto, è confermato dal
tenore dell’art. 9 che, facendo riferimento al “fatto punito”, non può che riferirsi a
quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto
naturalisticamente inteso.
Indicazioni giurisprudenziali
Concorso apparente di norme e concorso di
reati – Perché si possa configurare un concorso
apparente
di
norme,
risolvibile
con
l’applicazione di una sola di esse, è necessario
che vi sia una stessa situazione di fatto cui
corrisponda una convergenza delle singole
norme ciascuna delle quali apparentemente la
regola, e ciò perché la situazione di fatto, negli
stessi suoi dati, è capace di integrare gli estremi
di più fattispecie legali. Quando invece una
situazione di fatto corrisponda per parti
diverse a più fattispecie è esclusa la
ipotizzabilità del concorso apparente di norme
e si ha concorso di reati (Cass. pen., 8 giugno
1982, n. 5669).
Individuazione della stessa materia – Il
requisito della stessa materia ricorre in primis
quando, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., due
norme qualifichino uno stesso contesto fattuale
nel senso che una delle suddette comprenda in
sé gli elementi dell’altra oltre ad uno o più dati
specializzanti: in questo caso dovrà prevalere,
salvo che sia altrimenti stabilito, la previsione
speciale ossia quella che descrive la situazione
con maggiori particolari. Poiché il citato criterio
presuppone una relazione logico-strutturale tra
norme, ne deriva che la locuzione “stessa
materia” va intesa come fattispecie astratta –
ossia come settore, aspetto dell’attività umana
che la legge interviene a disciplinare – e non
quale
episodio
in
concreto
verificatosi
sussumibile in più norme, indipendentemente
da un rapporto di genere a specie tra queste.
All’uopo, il richiamo alla natura del bene
protetto
–
effettuato,
con
divergente
valutazione, sia dalle sentenze che affermano
una situazione di specialità, sia da quelle che la
negano - non pare decisivo (Cass. pen., sez. un.,
7 novembre 2000, n. 27).
Il criterio strutturale – Sussiste concorso
fittizio di norme qualora una pluralità di
disposizioni sia apparentemente applicabile nei
confronti di una determinata condotta, mentre
in effetti una sola di esse può operare perché
altrimenti verrebbe addebitato più volte un
accadimento unitariamente valutato dal punto
di vista normativo, in contrasto col principio
del ne bis in idem sostanziale posto a
fondamento degli artt. 15, 68, 84 cod. pen. Una
tale convergenza ricorre in primis quando, ai
sensi dell’art. 15 cod. pen., due norme regolino
la “stessa materia”, ossia qualifichino un
identico contesto fattuale nel senso che una
delle suddette comprenda in sé gli elementi
dell’altra oltre ad uno o più dati specializzanti:
in questo caso dovrà prevalere, salvo che sia
altrimenti stabilito, la previsione speciale ossia
quella che la situazione con maggiori
particolari. Poiché il citato criterio presuppone
una relazione logico-strutturale tra norme ne
deriva che la locuzione “stessa materia” va
intesa come fattispecie astratta - ossia come
settore, aspetto dell’attività umana che la legge
interviene a disciplinare - e non quale episodio
in concreto verificatosi sussumibile un più
norme, indipendentemente da un astratto
rapporto di genere a specie tra queste (Cass.
pen., sez. un., 9 gennaio 2001, n. 23427).
Rapporto tra illeciti
penali e illeciti
amministrativi: l’impossessamento abusivo di
acque – In virtù dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152
del 1999, che ha sostituito l’art. 17 del R.D. n.
1775 del 1933 - integra esclusivamente un
illecito amministrativo ed è attualmente punito
solo con la sanzione amministrativa di cui al
predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex
art. 624 cod. pen. Tra le norme in
considerazione (art. 23 D.Lgs. n. 152 del 1999 e
624 cod. pen.) sussiste, infatti, un’ipotesi di
concorso apparente - a fronte dell’omogeneità
della
materia
regolata
(sottrazione
e
impossessamento di un bene altrui per proprio
vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere
speciale rispetto alla disposizione codicistica disciplinata dall’art. 9 della legge n. 689 del
1981, che afferma anche nell’ipotesi di
concorso tra norme penali ed amministrative il
principio per il quale la norma speciale prevale
su quella generale (Cass. pen., 7 marzo 2007, n.
25548).
Tutela del diritto d’autore – La condotta di chi
acquista
supporti
audiovisivi
fonici
o
informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni legali, se non costituisce concorso
in uno dei reati previsti dagli artt. 171, 171
octies, legge 22 aprile 1741, n. 633, integra
l’illecito amministrativo di cui all’art. 16, legge
18 agosto 2000, n. 248, che in virtù del
principio di specialità previsto dall’art. 9, legge
n. 689 del 24 novembre 1981, prevale sulla
disposizione penale che punisce lo stesso fatto
(Cass. pen., 3 marzo 2005, n. 8761).
Formula
Al ...................
di ..................
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. ..................., del foro di ..................., con studio in ..................., via
….., n. …., nella qualità di difensore di fiducia, giusta nomina in atti, di...................,
nato il …, a ................... e residente in …., alla via …., n. ….., imputato nell’ambito
del procedimento penale recante n. ................... R.G.N.R. - n. …. R.G. Dib., per il
reato di cui all’art. ...................,
PREMESSO CHE
il proprio assistito è stato condannato, dal ...................di ..................., con sentenza
n. ..................., emessa in data ................... e depositata in data ..................., alla pena
di ................... per il reato innanzi indicato;
tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti
MOTIVI
(indicare le ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda il gravame,
specificando i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione);
I) ASSOLUZIONE DELL’IMPUTATO PERCHÉ ...................
II) RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
In ogni caso, la pena applicata appare assolutamente eccessiva e sproporzionata
rispetto all’effettivo disvalore delle contestate condotte penali, atteso che
...................
tanto premesso, con il presente atto
PROPONE
APPELLO
avverso la sentenza di condanna n. ..................., emessa dal ................... di
................... in data ................... e per l’effetto
CHIEDE
che ..................., sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio
precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia
assolvere il sig. ................... dal reato ascrittogli perché ................... (indicare la
formula di assoluzione più appropriata), ovvero, in via del tutto subordinata,
voglia rideterminare la pena irrogata determinandola nella maniera seguente:
................... (riduzione pena, applicazione circostanza attenuanti, ecc.).
N.B.: La richiesta in via subordinata deve essere formulata solo se dalla traccia
emergono elementi che consentono di motivarla.
Luogo e data
Avv. ...................