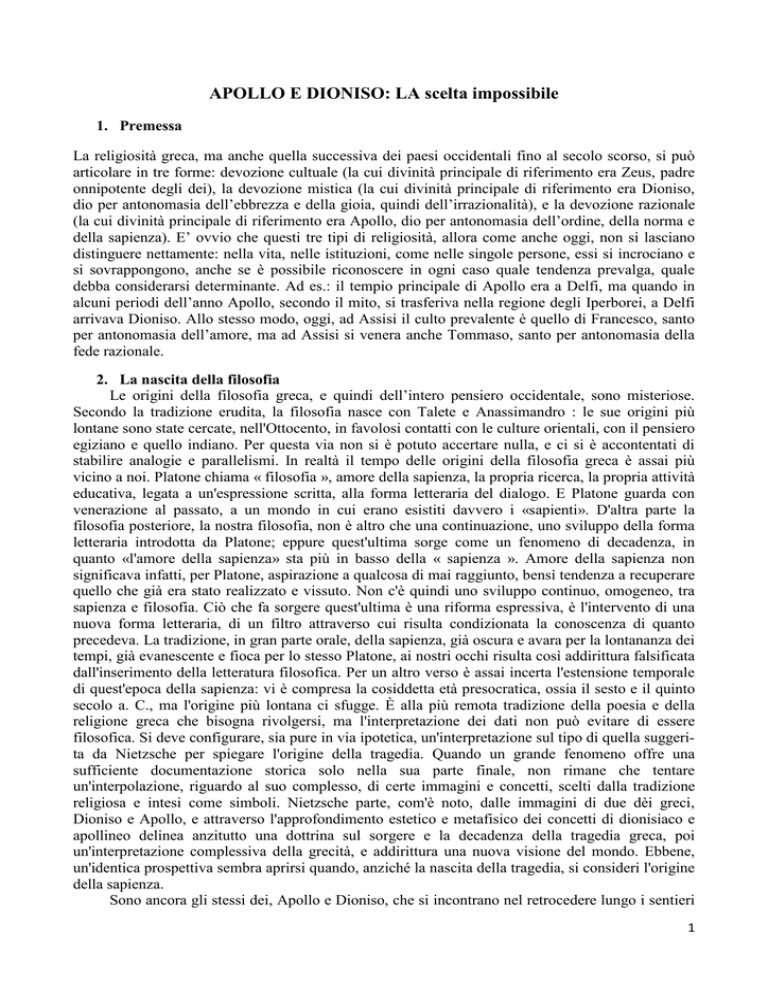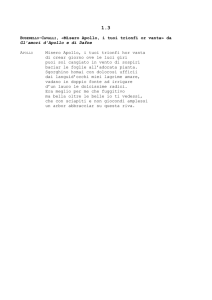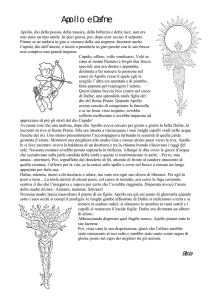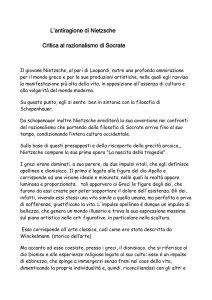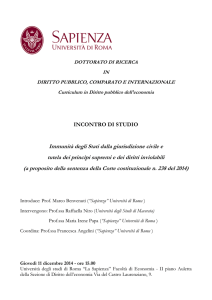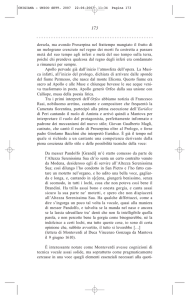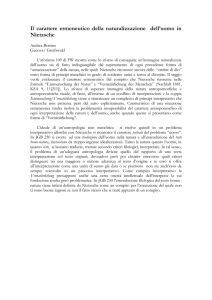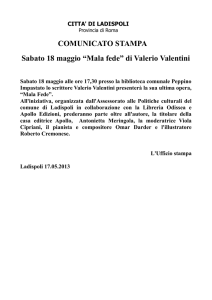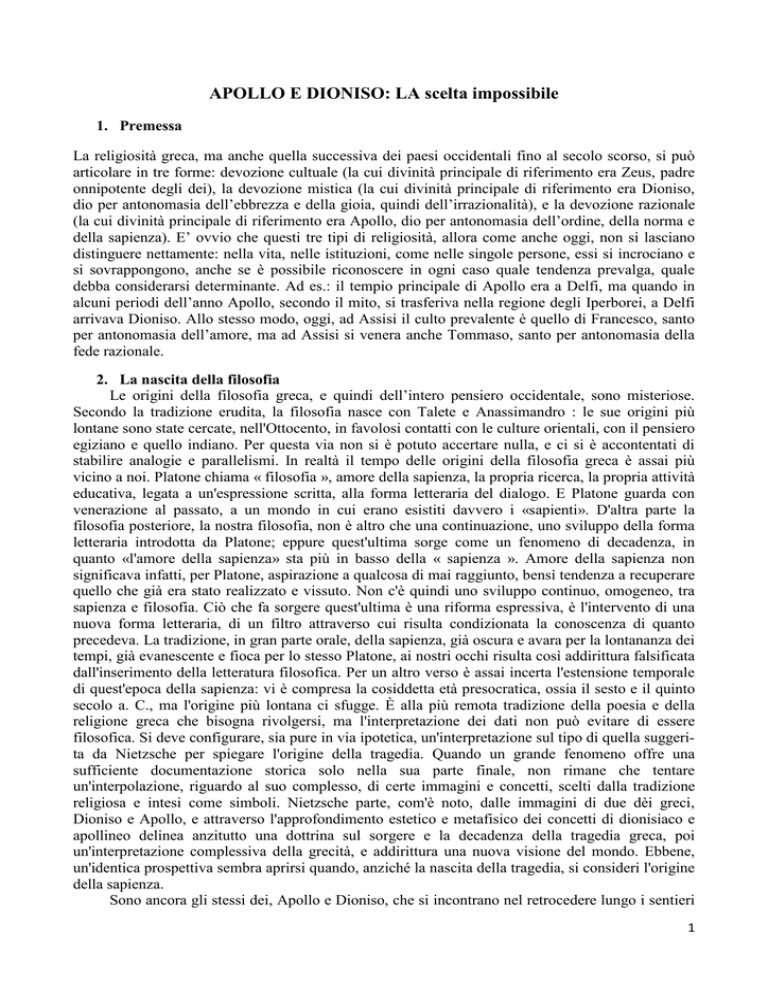
APOLLO E DIONISO: LA scelta impossibile
1. Premessa
La religiosità greca, ma anche quella successiva dei paesi occidentali fino al secolo scorso, si può
articolare in tre forme: devozione cultuale (la cui divinità principale di riferimento era Zeus, padre
onnipotente degli dei), la devozione mistica (la cui divinità principale di riferimento era Dioniso,
dio per antonomasia dell’ebbrezza e della gioia, quindi dell’irrazionalità), e la devozione razionale
(la cui divinità principale di riferimento era Apollo, dio per antonomasia dell’ordine, della norma e
della sapienza). E’ ovvio che questi tre tipi di religiosità, allora come anche oggi, non si lasciano
distinguere nettamente: nella vita, nelle istituzioni, come nelle singole persone, essi si incrociano e
si sovrappongono, anche se è possibile riconoscere in ogni caso quale tendenza prevalga, quale
debba considerarsi determinante. Ad es.: il tempio principale di Apollo era a Delfi, ma quando in
alcuni periodi dell’anno Apollo, secondo il mito, si trasferiva nella regione degli Iperborei, a Delfi
arrivava Dioniso. Allo stesso modo, oggi, ad Assisi il culto prevalente è quello di Francesco, santo
per antonomasia dell’amore, ma ad Assisi si venera anche Tommaso, santo per antonomasia della
fede razionale.
2. La nascita della filosofia
Le origini della filosofia greca, e quindi dell’intero pensiero occidentale, sono misteriose.
Secondo la tradizione erudita, la filosofia nasce con Talete e Anassimandro : le sue origini più
lontane sono state cercate, nell'Ottocento, in favolosi contatti con le culture orientali, con il pensiero
egiziano e quello indiano. Per questa via non si è potuto accertare nulla, e ci si è accontentati di
stabilire analogie e parallelismi. In realtà il tempo delle origini della filosofia greca è assai più
vicino a noi. Platone chiama « filosofia », amore della sapienza, la propria ricerca, la propria attività
educativa, legata a un'espressione scritta, alla forma letteraria del dialogo. E Platone guarda con
venerazione al passato, a un mondo in cui erano esistiti davvero i «sapienti». D'altra parte la
filosofia posteriore, la nostra filosofia, non è altro che una continuazione, uno sviluppo della forma
letteraria introdotta da Platone; eppure quest'ultima sorge come un fenomeno di decadenza, in
quanto «l'amore della sapienza» sta più in basso della « sapienza ». Amore della sapienza non
significava infatti, per Platone, aspirazione a qualcosa di mai raggiunto, bensì tendenza a recuperare
quello che già era stato realizzato e vissuto. Non c'è quindi uno sviluppo continuo, omogeneo, tra
sapienza e filosofia. Ciò che fa sorgere quest'ultima è una riforma espressiva, è l'intervento di una
nuova forma letteraria, di un filtro attraverso cui risulta condizionata la conoscenza di quanto
precedeva. La tradizione, in gran parte orale, della sapienza, già oscura e avara per la lontananza dei
tempi, già evanescente e fioca per lo stesso Platone, ai nostri occhi risulta così addirittura falsificata
dall'inserimento della letteratura filosofica. Per un altro verso è assai incerta l'estensione temporale
di quest'epoca della sapienza: vi è compresa la cosiddetta età presocratica, ossia il sesto e il quinto
secolo a. C., ma l'origine più lontana ci sfugge. È alla più remota tradizione della poesia e della
religione greca che bisogna rivolgersi, ma l'interpretazione dei dati non può evitare di essere
filosofica. Si deve configurare, sia pure in via ipotetica, un'interpretazione sul tipo di quella suggerita da Nietzsche per spiegare l'origine della tragedia. Quando un grande fenomeno offre una
sufficiente documentazione storica solo nella sua parte finale, non rimane che tentare
un'interpolazione, riguardo al suo complesso, di certe immagini e concetti, scelti dalla tradizione
religiosa e intesi come simboli. Nietzsche parte, com'è noto, dalle immagini di due dèi greci,
Dioniso e Apollo, e attraverso l'approfondimento estetico e metafisico dei concetti di dionisiaco e
apollineo delinea anzitutto una dottrina sul sorgere e la decadenza della tragedia greca, poi
un'interpretazione complessiva della grecità, e addirittura una nuova visione del mondo. Ebbene,
un'identica prospettiva sembra aprirsi quando, anziché la nascita della tragedia, si consideri l'origine
della sapienza.
Sono ancora gli stessi dei, Apollo e Dioniso, che si incontrano nel retrocedere lungo i sentieri
1
della sapienza greca. Soltanto che in questa sfera la caratterizzazione di Nietzsche va modificata, e
inoltre la preminenza va concessa ad Apollo, piuttosto che a Dioniso. Al dio di Delfi , infatti, se mai
a un altro, è da attribuirsi il dominio sulla sapienza. A Delfi si manifesta la vocazione dei Greci per
la conoscenza: sapiente non è il ricco di esperienza, chi eccelle in abilità tecnica, in destrezza, in
espedienti, come lo è invece per l'età omerica. Odisseo non è un sapiente. Sapiente è chi getta luce
nell'oscurità, chi scioglie i nodi, chi manifesta l'ignoto, chi precisa l'incerto. Per questa civiltà
arcaica la conoscenza del futuro dell'uomo e del mondo appartiene alla sapienza. Apollo
simboleggia questo occhio penetrante, il suo culto è una celebrazione della sapienza. Ma il fatto che
Delfi sia un'immagine unificante, un'abbreviazione della Grecia stessa, indica qualcosa di più, ossia
che la conoscenza fu, per i Greci, il massimo valore della vita. Altri popoli conobbero, esaltarono la
divinazione, ma nessun popolo la innalzò a simbolo decisivo, per cui, nel grado più alto, la potenza
si esprime in conoscenza, come ciò accadde presso i Greci. In tutto il territorio ellenico vi furono
santuari destinati alla divinazione; questa rimase un elemento decisivo nella vita pubblica, politica
dei Greci. E soprattutto l'aspetto teoretico connesso alla divinazione è caratteristico dei Greci.
Divinazione implica conoscenza del futuro e manifestazione, comunicazione di tale conoscenza.
Ciò avviene attraverso la parola del dio, attraverso l'oracolo. Nella parola si manifesta all'uomo la
sapienza del dio, e la forma, l'ordine, il nesso in cui si presentano le parole rivela che non si tratta di
parole umane, bensì di parole divine. Di qui il carattere esteriore dell'oracolo: l'ambiguità, l'oscurità,
l'allusività ardua da decifrare, l'incertezza.
Il dio dunque conosce l'avvenire, lo manifesta all'uomo, ma sembra non volere che l'uomo
comprenda. C'è un elemento di malvagità, di crudeltà nell'immagine di Apollo, che si riflette nella
comunicazione della sapienza. E difatti dice Eraclito, un sapiente: «Il signore, cui appartiene
l'oracolo che sta a Delfi, non dice né nasconde, ma accenna». Di fronte a questi nessi, la
significazione attribuita da Nietzsche ad Apollo appare insufficiente. Secondo Nietzsche, Apollo è il
simbolo del mondo come apparenza, sulle tracce del concetto schopenhaueriano di
rappresentazione. Questa apparenza è al tempo stesso bella e illusoria, cosicché l'opera di Apollo è
essenzialmente il mondo dell'arte, inteso come liberazione, sia pure illusoria, dalla tremenda conoscenza dionisiaca, dall'intuizione del dolore del mondo. Contro questa prospettiva di Nietzsche si
può obiettare anzitutto, quando la si consideri come chiave interpretativa della Grecia, che la
contrapposizione tra Apollo e Dioniso come tra arte e conoscenza non corrisponde a molte e
importanti testimonianze storiche riguardanti questi due dei. Si è detto che la sfera della conoscenza
e della sapienza si connette assai più naturalmente ad Apollo che non a Dioniso. Parlare di
quest'ultimo come del dio della conoscenza e della verità, intese restrittivamente come intuizione di
un'angoscia radicale, significa presupporre in Grecia uno Schopenhauer che non vi fu. Dioniso
piuttosto si collega alla conoscenza in quanto divinità eleusina: l'iniziazione ai misteri di Eleusi
difatti culminava in una «epopteia», in una visione mistica di beatitudine e purificazione, che in
qualche modo può venir chiamata conoscenza. Tuttavia l'estasi misterica, in quanto si raggiunge
attraverso un completo spogliarsi dalle condizioni dell'individuo, in quanto cioè in essa il soggetto
conoscente non si distingue dall'oggetto conosciuto, si deve considerare come il presupposto della
conoscenza, anziché conoscenza essa stessa. Per contro la conoscenza e la sapienza si manifestano
attraverso la parola, ed è a Delfi che viene pronunciata la parola divina, è Apollo che parla
attraverso la sacerdotessa, certo non Dioniso.
Nel tracciare il concetto di apollineo, Nietzsche ha considerato il signore delle arti, il dio
luminoso, dello splendore solare, aspetti autentici di Apollo, ma parziali, unilaterali. Altri aspetti del
dio allargano la sua significazione e la connettono alla sfera della sapienza. Anzitutto un elemento
di terribilità, di ferocia. L'etimologia stessa di Apollo, secondo i Greci, suggerisce il significato di «
colui che distrugge totalmente ». In questa figura il dio viene presentato all'inizio dell'Iliade, dove le
sue frecce portano la malattia e la morte nel campo degli Achei. Non una morte immediata, diretta,
ma una morte attraverso la malattia. L'attributo del dio, l'arco, arma asiatica, allude a un'azione
indiretta, mediata, differita. Qui si tocca l'aspetto della crudeltà, cui si è accennato a proposito
dell'oscurità dell’oracolo: la distruzione, la violenza differita è tipica di Apollo. E difatti, fra gli
2
epiteti di Apollo, troviamo quello di « colui che colpisce da lontano » e di « colui che agisce da
lontano». Non è chiaro per ora il collegamento tra questi caratteri del dio, azione a distanza,
distruttività, terribilità, crudeltà, e il configurarsi della sapienza greca. Ma la parola di Apollo è
un'espressione in cui si manifesta una conoscenza; seguendo i modi in cui nella Grecia primitiva le
parole della divinazione si congiungono in discorsi, si sviluppano in discussioni, si elaborano
nell'astrattezza della ragione, sarà possibile intendere questi aspetti della figura di Apollo come
simboli illuminanti l'intero fenomeno della sapienza.
Un altro elemento debole nell'interpretazione di Nietzsche è il suo presentare come antitetici
l'impulso apollineo e quello dionisiaco. Gli studi più recenti sulla religione greca hanno messo in
evidenza un'origine asiatica e nordica del culto di Apollo. Qui emerge una nuova relazione tra
Apollo e la sapienza. Un frammento di Aristotele ci informa che Pitagora un sapiente appunto – fu
chiamato dai Crotoniati Apollo Iperboreo. Gli Iperborei erano per i Greci un favoloso popolo
dell'estremo settentrione. Di là sembra provenire il carattere mistico, estatico di Apollo, che si
manifesta nell'invasamento della Pizia, nelle parole farneticanti dell'oracolo delfico. Nelle pianure
nordiche e dell'Asia centrale è testimoniata una lunga persistenza dello sciamanesimo, di una
particolare tecnica dell'estasi. Gli sciamani raggiungono un'esaltazione mistica, una condizione
estatica, in cui sono in grado di operare guarigioni miracolose, di vedere l'avvenire e pronunciare
profezie.
Tale è lo sfondo del culto delfico di Apollo. Un passo celebre e decisivo di Platone ci illumina
al riguardo. Si tratta del discorso sulla «mania», sulla follia, che Socrate sviluppa nel Fedro. Subito
all'inizio si contrappone la follia alla moderazione, al controllo di sé, e, con un'inversione
paradossale per noi moderni, si esalta la prima come superiore e divina. Dice il testo: «i più grandi
fra i beni giungono a noi attraverso la follia, che è concessa per un dono divino... infatti la
profetessa di Delfi e le sacerdotesse di Dodona, possedute dalla follia, hanno procurato alla Grecia
molte e belle cose, sia agli individui sia alla comunità». È dunque posto in evidenza sin dal
principio il collegamento tra « mania » e Apollo. In seguito si distinguono quattro specie di follia, la
profetica, la misterica, la poetica e l'erotica: le ultime due sono varianti delle prime due. La follia
profetica e quella misterica sono ispirate da Apollo o da Dioniso (sebbene quest'ultimo non sia
nominato da Platone). Nel Fedro in primo piano sta la «mania » profetica, al punto che la natura
divina e decisiva della «mania» è testimoniata per Platone dal costituire il fondamento del culto
delfico. Platone appoggia il suo giudizio con un'etimologia: la «mantica», cioè l'arte della
divinazione, deriva da « mania », ne è l'espressione più autentica. Quindi la prospettiva di Nietzsche
non solo deve essere estesa, ma anche modificata. Apollo non è il dio della misura, dell'armonia, ma
dell'invasamento, della follia. Nietzsche considera la follia come pertinente al solo Dioniso, e
inoltre la circoscrive come ebbrezza. Qui un testimone del peso di Platone ci suggerisce invece che
Apollo e Dioniso hanno un'affinità fondamentale, proprio sul terreno della «mania»; congiunti, essi
esauriscono la sfera della follia, e non mancano appoggi per formulare l'ipotesi - attribuendo la
parola e la conoscenza ad Apollo e l'immediatezza della vita a Dioniso - che la follia poetica sia
opera del primo, e quella erotica del secondo.
Concludendo, se una ricerca delle origini della sapienza nella Grecia arcaica ci porta in direzione dell'oracolo delfico, della significazione complessa del dio Apollo, la «mania» ci si presenta
come ancora più primordiale, come sfondo del fenomeno della divinazione. La follia è la matrice
della sapienza.
3. Una testimonianza di Plutarco (Diatriba isiaca e Dialoghi delfici)
I Greci, piuttosto che zelanti di proselitismo, erano, invece, desiderosi di sempre nuove ed
esotiche esperienze religiose. Qualche nota sulle due grandi divinità, pur essendo persuasi con
Pfister , che la diade, sia nella forma del contrasto sia in quella della conciliazione, possa apparire
piuttosto come un mito letterario, nato dal genio ancora acerbo del Nietzsche, all'epoca in cui
apparve, succinta come una greca Artemide, Die Geburt der Tragedie, piuttosto che una necessaria
congiunzione mitologica storica. Il libro del Nietzsche è figlio legittimo del periodo goethiano e si
3
ricongiunge alla poesia del Faust. Eschilo ed Archiloco, Euripide e Socrate, rappresentati dal
Nietzsche sono vere dramatis personae.
Del Kant, non vide se non il Kant della prima critica. Dello Hegel non sapeva niente di diretto
ed esatto. Se l'avesse conosciuto, avrebbe trovato un suo fratello spirituale che amò la tragedia greca
e come lui fu volto a cercare una congiunzione dell'elemento apollineo col dionisiaco. Eppure, il
mito nietzschiano, decantato così dal Croce, aveva avuto un remoto precorrimento in un fatto
storico di suprema importanza attestato concordemente dagli storici antichi e, in specie, da Plutarco.
E non sarebbe anzi strano parlare di «dialettica» in un senso che oltrepassi il platonismo se si
ponesse mente, ad esempio, a un testo come il seguente: “Uno potrebbe domandare: Che c'entra
tutto questo con Apollo? Ma per me, tutto questo c'entra benissimo non solo con Apollo, ma anche
con Dioniso, il quale partecipa non meno di Apollo alle cose delfiche. Basti udire i teologi che, in
versi o in prosa, inneggiano e insegnano che il dio è, sì, per natura incorruttibile ed eterno, eppure è
soggetto, in forza di una fatalità e di una legge ineluttabile, a trasformare se stesso; a volte arde, in
fuoco, la sua essenza, e assimila tra loro tutte le cose; altre volte entra nel divenire trasformandosi in
forme d'ogni sorta, in condizioni e potenze diverse - ed è l'attuale situazione - ed allora si chiama
«mondo», per usare il termine notissimo. Ma i saggi, per nascondere alla folla il loro pensiero,
danno al fenomeno della trasformazione in fuoco il nome di Apollo per la sua unicità, e il
nome di Febo per la purezza e incorruttibilità; ma quando il mutamento del dio trapassa in
aria e acqua e terra e stelle e nascita di piante e di animali e si esprime in ordinamento
cosmico, i saggi parlano per enimmi di questo accadimento e cambiamento come di un certo
spasimo e smembramento; e fanno i nomi di Dioniso, di Zagreo, di Nyctelio e Isodete, per
esprimere questo divenire; e parlano di morti e sparizioni, e poi di risurrezioni e rinascite:
tutti veli e favole, che celano le suddette trasformazioni. Cantano, anzi, a Dioniso, i
ditirambi, canti colmi di passione e frenetici di contorcimenti, che esprimono il
vagabondaggio e lo sviamento, ond'è che Eschilo dice:
A Dioniso s'addice il ditirambo
che l'accompagni ognora tripudiante.
Ad Apollo, invece, è dedicato il peana, musica ordinata e sapiente. Mentre Apollo è
rappresentato, in pitture e sculture, immune da vecchiezza ed eternamente giovane, Dioniso,
invece, si presenta in molteplici aspetti e forme. Insomma Apollo è considerato uguale,
ordinato, attento, puro; Dioniso, per contro, disuguale e irregolare con una punta di scherzo,
d'insolenza, di serietà e di follia, è invocato:
Evoé, Dioniso fiorente di rito orgiastico,
che eccita le donne” .
E’ una dialettica in nuce, fondata su una eziologia mitologico-storica risalente ai
primordi del tempio delfico allorché il tripode mantico fu sovrapposto al tripode funebre di
Dioniso ivi venerato , come per congiungere in un ritmo di dialettica mitologica, il mito solare e
il mito ctonio.
Dionisio è «ein heiliger Name und ein unendliches Symbol». Figlio di madre mortale, secondo
una tradizione, fu dato, in questa, come figlio a Zeus, ma secondo un frammento di Eschilo, era
Hades suo padre e Persefone sua madre; ed era, anch'egli, dio chthonios «sotterraneo». Ma, poiché,
della sua misteriosa origine storico-mitologica non è qui il luogo di parlare, a noi preme solo
stabilire che Dioniso, molto probabilmente dio straniero, non riuscì mai a grecizzarsi
completamente né nella forma segreta dei misteri né nell'aspetto luminoso della religione di Omero
e di Apollo. Quando la nostra informazione storica comincia, la frenesia dionisiaca è stata già
domata dalla sopraggiunta attività ed autorità dello stato e dell'oracolo delfico.
4. Ambivalenza del dionisiaco: da Schopenhaur a Nietzsche
Nello Schopenhauer l'irrazionalismo si fermava, se così si può dire, al contenuto della filosofia,
4
ma non ne intaccava la forma. La filosofia seguitava ad essere anche per lui sistema organico di
concetti, discorso limpido e distinto, ancorché l'oggetto, cui concetti e discorso si riferivano, restava
in sé qualcosa di oscuro e di insondabile. Il compito dell’intuizione si limitava a quell'atto originario
di conoscenza in cui, squarciatosi il velo dell'apparenza e gettato lo sguardo al di là, il filosofo
veniva in possesso della «chiave» che gli avrebbe permesso il «deciframento » dell'intera realtà
fenomenica. All'inizio occorreva dunque un'esperienza in certo modo mistica, in cui la conoscenza
si atteggiasse non già nelle guise consuete della costituzione di un oggetto, ma come una sorta di
auscultazione interiore, un sentirsi vivere in cui il conoscente non emergesse sul conosciuto; ma,
ove si fosse rimasti fermi a questo stadio, senza pervenire ad una interpretazione e sistemazione
razionale, ne sarebbe nata la religione e non la filosofia. Compito di quest'ultima è la spiegazione
concettuale, ond’è che quello stesso atto primitivo di intuizione viene chiarito da una formula
razionale: conoscenza che il soggetto acquista di sé, non già come soggetto conoscente, perché in
questo caso in quanto conosciuto si convertirebbe in oggetto, ma soltanto come soggetto volente.
Perciò l'intera sistemazione utilizza schemi eminentemente razionalistici e non disdegna di valersi
perfino del contributo delle scienze della natura. Se infatti, come è noto, la prospettiva soggettiva è
tutta fondata sull'interpretazione kantiana della conoscenza, quella oggettiva non soltanto si vale
della dottrina platonica delle Idee, ma fa continuamente ricorso ai risultati della fisica, della chimica
e della biologia.
Nello schopenhauerismo di Nietzsche invece, anche se restano le formule della ragion
sufficiente, del principium individuationis, dello spazio-tempo-causa, esse vengono completamente
svuotate di ogni significato kantiano, delle Idee platoniche non si fa parola alcuna e in definitiva è
l'intera prospettiva soggettiva, e cioè l'impalcatura di base di tutto il pensiero di Schopenhauer, che
viene spazzata via. Con il ripudio di ogni sistemazione razionale, la filosofia viene interamente a
risolversi nella religione o almeno nel mito e, anziché esprimersi in concetti, si manifesta in figure,
quali quelle di Apollo e di Dioniso, di Edipo e di Prometeo. Secondo Nietzsche chi si affida ai
concetti nella trama dei concetti si chiude e, prigioniero del velo di Maia, ricercando il che cosa e il
perché, da fenomeno viene rimandato a fenomeno, senza fine alcuna.
Se perciò lo stesso Nietzsche tiene a ricondurre la coppia apollineo-dionisiaco alla dualità
schopenhaueriana rappresentazione-volontà, l'analogia, che pure sussiste, non deve farci trascurare
le radicali differenze.
Schopenhaueriana è la definizione dell'apollineo: soggettivamente, pura teoresi priva di ogni
riferimento alla vita pratica e perciò svuotata da ogni emozione; oggettivamente, mondo
dell'esistenza ricondotto a semplice parvenza e perciò ridotto a mere figurazioni.
Ma, mentre la soppressione della dottrina delle Idee viene a spezzare ogni legame con quella
tradizione di classicismo platonico, che ancora si conservava in Schopenhauer, l'assenza del minimo
riferimento ad un processo di universalizzazione dell'oggetto, parallelo alla pura teoresi, toglie
all'intera concezione ogni base metafisica, riducendola ad una semplice esperienza psicologica.
Destituita insomma di ogni fondamento realistico, né platonico universale ante rem e nemmeno
kantiana costituzione dell'oggetto, la rappresentazione diventa nulla più che un fatto di coscienza,
ancorché Nietzsche seguiti ad identificarla, inesplicabilmente, con il fenomeno.
Ancor più radicale è la trasformazione che subisce, nel passaggio dall'uno all'altro filosofo, la
concezione della volontà. Ed infatti in questo caso si dovrebbe parlare piuttosto di rovesciamento, di
qualcosa di analogo a quanto avviene nel trapasso da Hegel a Marx, perché anche qui si tratta in
definitiva di un passaggio dal religioso al mondano, dalla trascendenza all'immanenza. La volontà,
nel trapasso, cambia di segno, facendosi da negativa positiva, e, lungi dal condurre alla propria
negazione nella noluntas, si esalta invece nella volontà di potenza. L'annientamento della volontà di
conseguenza, anziché essere ritenuta unica esperienza di salvezza, è vista come una tentazione da
cui l'uomo debba liberarsi e dalla quale lo libera l'arte. Ma, per comprendere quanto poco Nietzsche
si rendesse conto dell'estremo distacco dal suo maestro, basta osservare il fatto che in questo passo,
così decisamente polemico, Schopenhauer non venga per niente nominato e la noluntas sia
contrassegnata soltanto come « buddistica ».
5
Nasce anche di qui, da questa posizione equivoca in cui, senza rendersene conto, il Nietzsche si
trova nei confronti di Schopenhauer, la caratteristica ambiguità del concetto di dionisiaco.
L'ambivalenza non costituisce un vero problema sul piano psicologico, potendosi agevolmente
intendere uno stato d'animo in cui piacere e dolore siano frammisti assieme. Del resto lo stesso
Nietzsche dà di questo fatto una spiegazione molto chiara, interpretando le due emozioni opposte
come momenti distinti e successivi di un'unica esperienza, che è quella del trascendimento della
molteplicità fenomenica, del superamento dei limiti individuali, del ricongiungimento con l'Urein.
Giacché, fino a quando perdura l'estasi, il dionisiaco è «consolazione metafisica», avvertimento del
carattere «potente e dilettoso» che la vita conserva «nel fondo delle cose, nonostante qualunque
vicenda dei fenomeni» . Ma allorché da questa condizione estatica si faccia ritorno al piano della
vita ordinaria, la consapevolezza del distacco dall'unità, avvertito come tragico smembramento della
Natura nella parzialità e limitatezza degli individui, la coscienza del peccato di origine che sta a
fondamento dell'esistenza, donde l'ineluttabilità del male e del dolore, conducono alla disperata
sapienza del Sileno, alla inerzia tragica di Amleto, al radicale pessimismo del filosofo.
Quel che invece riesce ben più difficile da comprendere è come questa ambiguità possa
conservarsi anche sul piano etico; eppure proprio in questa contraddizione sta l'essenza stessa del
concetto. Il dionisiaco è per un verso come un'addensarsi dell'umano-corporeo nell'animalesco,
scatenamento degli istinti, unione di crudeltà e di lussuria, per un altro verso è come un rarefarsi
dell'umano-spirituale nel celestiale, partecipazione ad un'universale armonia, ad una comunità superiore, da una parte il satiro, dall'altro il dio; sembra quasi che, nella stessa condizione, si trovino
uniti quegli stati opposti, infraumano l'uno e sovrumano lo altro, che Aristotele aveva chiamati
bestialità e virtù eroica.
Simbolo di questa duplicità è Edipo, l'eroe la cui sapienza nasce dal male, e sia pure da colpe
inerenti a situazioni oggettive che non implicano, anzi escludono, deliberazioni della volontà. Ma il
parricidio e l'incesto, i delitti più orrendi di cui un uomo possa macchiarsi, sono in certo modo le
condizioni del terzo fatto fondamentale del mito e spiegano l'Edipo veggente, il risolutore
dell'enigma della Sfinge, quasi che, per penetrare nei segreti più riposti della natura, se ne debbano
violare le leggi più sacre. «Giacché, come mai si potrebbe costringere la natura a rivelare i propri
segreti, se non combattendola vittoriosamente, e cioè con mezzi innaturali?».
Ci troviamo qui di fronte al motivo romantico-decadentistico della via mistica del male: il fondo
ultimo delle cose può essere attinto, il passaggio dal fenomeno al noumeno, dal naturale al
soprannaturale può essere compiuto non soltanto mediante altezza suprema di bene, ma anche
mediante bassezza infima di male, allo stesso modo che, non soltanto nella crescita, ma anche nella
corruzione, la sostanza organica rivela il misterioso disegno della propria struttura. Si tratta sempre
di due forme di esistenza autentica che, anche se opposte tra di loro, si contrappongono egualmente
alla condizione banale e superficiale del bene rispettato per consuetudine o per paura.
Questo concetto, nella forma del tema della superiorità della malattia sulla salute, compare già
nelle pagine iniziali della Nascita della tragedia. “Al passare del corteo tripudiante e orgiastico
degli invasati non mancano uomini che, imbaldanziti dal senso della propria sanità, beffano o
lamentano, per difetto di esperienza o per stupidità, siffatti fenomeni, considerandoli come «
malattie popolari »: codesti poveri di spirito non sospettano neppure fino a qual punto appaia
cadaverica e spettrale la loro «sanità », quando passa rombando vicino a loro la vitalità ardente dei
tripudianti dionisiaci”. Chi non riconosce, in questo passo, la fonte prima di un tema che sarà poi
caro a T. Mann, dalla Montagna incantata al Dottor Faust, a quel T. Mann che a Schopenhauer, a
Wagner, a Nietzsche ha dedicato tre dei suoi saggi più simpatetici?
L'ambiguità del dionisiaco si riflette sullo stesso apollineo, tramutandone la composta serenità
da misura etica a indifferenza al bene e al male. L'esaltazione indiscriminata della Vita in tutti i suoi
aspetti accomuna oramai dionisiaco ed apollineo, anche se permane, a differenziare il primo dal
secondo, l'atteggiamento del distacco teoretico. Soltanto in un breve accenno, in cui utilizza antiche
categorie estetiche, Nietzsche tenta una differenziazione all'interno dell'apollineo: se gli aspetti
positivi dell'esistenza sono quelli che danno luogo alla bellezza vera e propria, gli aspetti negativi, il
6
terribile e l'assurdo, si decantano rispettivamente nel sublime e nel comico.
5. Interpretazioni contemporanee
a. Terra e acqua di Vito Mancuso
Penso sia opportuno, a questo punto, che io chiarisca che cosa intendo per ragione e per
sentimento e come considero il loro ruolo nella vita di un essere umano. La mia opinione è che
molto prima della ragione (che potrei paragonare alla terra) c'è la ben più vasta zona del sentimento,
ovvero emotività, pulsioni, fobie, passioni, istinto, inconscio e tutte le altre dimensioni che
contribuiscono a formare ciò che Alessandro Manzoni chiamava «questo guazzabuglio del cuore
umano», le quali nel loro insieme rappresentano la forza primigenia e caotica dell'essere dentro di
noi (che potrei paragonare all'acqua). Esattamente come la superficie del nostro splendido pianeta,
ognuno di noi è soprattutto acqua; lo è a livello corporeo, dove l'acqua com'è noto costituisce circa
il settanta per cento del nostro organismo, e lo è a livello psichico per la liquida fluidità del
sentimento e delle sue forze che sfuggono molto spesso al controllo razionale. Per la gran parte noi
siamo acqua-sentimento, mentre solo per una piccola parte siamo terra-ragione. Ciò che noi
chiamiamo ragione è come una specie di isola che si appoggia su una dimensione molto più vasta e
molto più fluida costituita dalla sfera del sentimento.
Ne viene che per una piccola parte del nostro essere noi dominiamo, ma per una parte molto
maggiore noi siamo dominati dalla corrente della vita. Certo, lo scopo della spiritualità è giungere a
«mettere ordine nella propria vita» e quindi in un certo senso a dominare esercitando la ragione, ma
il pensiero razionale può comandare efficacemente sulla globalità della vita solo nella misura in cui
si pone al servizio della globalità della vita, un servizio tanto più autentico e liberante quanto meno
mira a razionalizzare, chiudere, restringere, vietare, e quanto più mira a vivificare, energizzare,
illuminare, generare. Ciò che scriveva Bacone della natura in generale vale esattamente anche per il
nostro essere natura: «Non si comanda alla natura se non obbedendole».
La vita di ognuno di noi in quanto flusso di energia vitale può essere paragonata a un corso
d'acqua: l'attimo in cui il seme di nostro padre fecondò il seme di nostra madre è la sorgente, una
sorgente sotterranea venuta alla luce al momento del parto; da qui ebbe inizio l'esistenza, sotto
forma di esile ruscello durante l'infanzia, di torrente impetuoso durante la giovinezza, di placido
scorrere nell'età adulta quando il corso d'acqua acquista propriamente il nome di fiume, di
necessario annullamento nel più vasto mare dell'essere al momento della morte.
In mezzo a questo fiume della vita la ragione rappresenta un lembo di terraferma, o forse
sarebbe meglio dire che a noi piace pensarla così, perché in realtà guardando ai nostri pensieri li
vediamo talora mutati rispetto al passato, senza peraltro poter prevedere se un domani saranno
ancora diversi, così che in realtà anche la ragione si muove. La si potrebbe quindi paragonare
meglio a una sorta di imbarcazione, dotata sì di fondamento solido su cui poggiare i piedi, ma insieme esposta alla forza dei venti .e delle acque.
Da qui due conclusioni: 1) la necessità del pensiero razionale, perché c'è bisogno di terreno
solido sotto i piedi, di principi, orientamenti, norme, divieti; 2) la necessità di un pensiero come
sistema aperto, perché altrimenti si blocca la circolazione della mente sulle acque della vita e la
mente priva di energia vitale produce un pensiero devitalizzato (esattamente come un dente privato
del nervo che diventa marrone e tende a decomporsi, e tale purtroppo è l'impressione che mi suscita
un certo "pensiero" cattolico). Ovvero, per tradurre il tutto nel linguaggio di casa nostra: abbiamo la
necessità di una dottrina e di un'etica, ma di una dottrina e di un'etica come sistema aperto. Per
sistema aperto intendo il rifiuto del dogmatismo, cioè di quell'abito mentale che sa rendere conto
delle proprie affermazioni solo ricorrendo al principio di autorità ("sta scritto così") e minaccia chi
non si adegua con la sanzione della scomunica (anathema sit), e la coltivazione al contrario di un
discernimento continuo per capire come operare in ogni situazione nel miglior modo possibile in
favore del bene del mondo.
7
b. Geometria delle passioni di Remo Bodei
1. A lungo le passioni sono state condannate come fattore di turbamento o di perdita
temporanea della ragione. Segno manifesto di un potere estraneo alla parte migliore dell'uomo, lo
dominerebbero, distorcendone la chiara visione delle cose e sviandone la spontanea propensione al
bene. Agitato, lo specchio d'acqua della mente si intorbiderebbe e si incresperebbe, cessando di
riflettere la realtà e impedendo al volere di scorgere alternative alle inclinazioni del momento.
Obbedire all'imperioso richiamo degli impulsi, arrendersi alle lusinghe sinuose dei desideri
significherebbe abbandonarsi inermi a stati d'animo imprevedibili e contraddittori, rinunciare alla
libertà, alla consapevolezza e all'autocontrollo a beneficio di un padrone interiore più esigente di
quelli esterni.
Di fronte alle molteplici strategie elaborate per estirpare, moderare o addomesticare le passioni
(e, parallelamente, per conseguire la signoria su se stessi, rendendo coerente l'intelligenza, costante
la volontà, robusto il carattere) pare tuttavia lecito chiedersi se l'opposizione ragione/passioni sia in
grado di render conto dei fenomeni a cui si riferisce e se sia giusto, in generale, sacrificare le
proprie "passioni" in nome di ideali che potrebbero essere veicolo di immotivata infelicità.
Quando il cammino compiuto potrà essere osservato a distanza — rivelando in maniera più
chiara la sua direzione — sarà possibile constatare, per linee interne, come "ragione" e "passioni"
facciano parte di costellazioni di senso teoricamente e culturalmente condizionate, anche se a noi
familiari e ormai difficili da sostituire. "Ragione" e "passioni" sono cioè termini pregiudicati, che
occorre abituarsi a considerare come nozioni correlate e non ovvie, che si definiscono a vicenda
(per contrasto o per differenza) solo all'interno di determinati orizzonti concettuali e di specifici
parametri valutativi. Le combinazioni e le configurazioni a cui danno luogo sono certo molteplici e
varie: tutte però subordinate alla natura delle mosse e alle mappe mentali di partenza.
Alla loro base si rinviene l'assunto per cui le passioni rappresentano "alterazioni" di uno stato
altrimenti neutro e non perturbato dell'animo o della abituale composizione degli "umori" nel
carattere di ciascun individuo. Si confonde così quello che semmai è il risultato storico di sforzi tesi
all'imparzialità e alla tranquillità dell'animo con una premessa naturale. Nulla impedisce tuttavia di
pensare le "passioni" (emozioni, sentimenti, desideri) quali stati che non si aggiungono dall'esterno
a un grado zero della coscienza indifferente, per intorbidarla e confonderla, ma che sono costitutivi
della tonalità di qualsiasi modo di essere psichico e persino di ogni orientamento cognitivo. Perché
non concepirle dunque - al pari della musica, che unisce la più rigorosa precisione matematica alla
più potente carica emotiva - come forme di comunicazione tonalmente accentuata, linguaggi mimati
o atti espressivi che elaborano e trasmettono, nello stesso tempo, messaggi vettorialmente orientati,
modulati, articolati e graduabili nella direzione e nell'intensità?
Le passioni approntano, conservano, memorizzano, rielaborano ed esibiscono i "significati
reattivi" più direttamente attribuiti a persone, cose, eventi dai soggetti che le esperiscono entro
contesti determinati, di cui evidenziano forme e metamorfosi. Lasciano in realtà che sia la "ragione"
stessa - a posteriori presentata come provvisoriamente travolta o sedotta - a stabilire l'obiettivo e il
raggio della loro azione, individuando oggetti su cui riversarsi, misurando il punto in cui arrestare
l'impeto, dosando la virulenza di atteggiamenti dissipativi.
Dall'eventuale verifica di una simile ipotesi potrebbero discendere alcune importanti
conseguenze. Verrebbe, in particolare, incrinata l'idea di una energia intimamente opaca e incolta da
asservire e disciplinare. La passione apparirebbe in tal modo come l'ombra della ragione stessa,
come un costrutto di senso e un atteggiamento già intimamente rivestito di una propria intelligenza
e cultura, frutto di elaborazioni millenarie, mentre la ragione si rivelerebbe, a sua volta,
"appassionata", selettiva e parziale, complice di quelle medesime passioni che dice di combattere.
Si scoprirebbe così l'inadeguatezza del concetto di passione intesa come mero accecamento. Ciò
renderebbe meno plausibile tanto la sua demonizzazione, quanto il conseguente appello
all'esorcismo e all'asservimento di essa (simmetricamente, però, anche la sua esaltazione come
opposto speculare della ragione). Diventerebbero pertanto sfocate e parzialmente inattendibili le
ricorrenti, austere figure della ragione quale "auriga", "pastore", domatore e educatore delle passioni
8
(dell'anima e del corpo, dello spirito e della carne). Presupporre energie selvagge e brancolanti nel
buio ("passioni"), che dovrebbero essere dirette e tenute a freno da un'istanza ordinatrice illuminata
("ragione"), significa infatti spesso prefigurare un alibi polemico per reprimerle o canalizzarle.
Decretandone la pericolosità e l'incapacità a guidare se stesse, negando loro un intrinseco
orientamento e discernimento, si legittima automaticamente la liceità di delegare all'inflessibile
potenza imperiale o alla persuasiva severità paternalistica della "ragione" interventi esterni di
censura e di tutela correttiva.
Se proprio si vuol restare nell'ambito concettuale di una dualità tra ragione e passioni,
bisognerebbe almeno - lasciando ai tempi lunghi l'elaborazione di un nuovo lessico e di una nuova
sintassi delle loro relazioni - abbandonare l'immagine di questo rapporto come arena dello scontro
fra logica e assenza di logica (fra ordine e disordine, trasparenza e oscurità, legge e arbitrio, unità
monolitica della "ragione", che non è altro che il nome per una famiglia di strategie differenti, e
pluralità delle passioni). Si potrebbe interpretare questo rapporto, semmai, quale conflittualità tra
due logiche complementari, che operano secondo lo schema del "né con te, né senza di te". Legate
da una solidarietà antagonistica, esse opererebbero secondo strutture d'ordine funzionalmente
differenziate e incongruenti, giustificabili (ciascuna al rispettivo livello) in riferimento a principi
propri, dalla cui contrapposizione rispetto a quelli della ragione nascono le zone di opacità
dell'intelligenza, i nodi e le fluttuazioni del volere, assieme al senso di ineluttabile passività, di
azione preterintenzionale e di involontaria impotenza che sembrano definire la "passione".
Conoscere le passioni non sarebbe altro che analizzare la ragione stessa "contro pelo", illuminandola con la sua stessa ombra presunta.
2. Malgrado tutto, le passioni non si riducono però soltanto a conflitto e a mera passività. Esse
tingono il mondo di vivaci colori soggettivi, accompagnano il dipanarsi degli eventi, scuotono
l'esperienza dall'inerzia e dalla monotonia, rendono sapida l'esistenza nonostante disagi e dolori.
Varrebbe la pena vivere se non provassimo alcuna passione, se tenaci, invisibili fili non ci
avvincessero a quanto - a diverso titolo - ci sta "a cuore", e di cui temiamo la perdita? La totale
apatia, la mancanza di sentimenti e di ri-sentimenti, l'incapacità di gioire e di rattristarsi, di essere
"pieni" di amore, di collera o desiderio, la stessa scomparsa della passività, intesa quale spazio
virtuale e accogliente per il presentarsi dell'altro, non equivarrebbero forse alla morte?
c) Conversazione con Vittorio Gallese (2010)
Emanuel Derman, analista finanziario sudafricano e professore alla Columbia University di
New York ha pubblicato una mappa delle emozioni basata sull'Etica di Spinoza (1677). Derman
osserva a ragione che si tratta di una classificazione estremamente dettagliata e realistica, dunque
sotto il profilo della descrizione delle emozioni non molto è cambiato, come del resto ci insegnano
secoli di arte e letteratura. Ciò che è cambiato moltissimo è la conoscenza dei meccanismi fisiologici delle emozioni, e il riconoscimento del ruolo positivo che giocano nella formazione della
decisione razionale. Tanto che oggi si direbbe che il campo elettivo in cui si affrontano le emozioni
non sia più l'arte, ma la scienza. Ne abbiamo parlato con Vittorio Gallese, dell'università di Parma,
uno dei maggiori neuroscienziati contemporanei, scopritore negli anni Novanta, insieme ad altri
ricercatori dell'università di Parma coordinati da Giacomo Rizzolatti, dei "neuroni specchio", forse
la scoperta italiana recente più citata nella letteratura internazionale (la ricerca di "mirror neurons"
su Google dà più di mezzo milione di risultati).
GALLESE: La teoria delle emozioni di Spinoza è per molti versi modernissima. Soprattutto
quando afferma che il pensiero è intimamente incarnato nel corpo. Spinoza attribuisce al corpo vivo
dell'esperienza un ruolo determinante nella generazione dell'attività mentale, considerata come
l'idea pensata del corpo, secondo un'impostazione ripresa oggi da molti neuroscienziati come
Antonio Damasio o come il sottoscritto. Le neuroscienze e la psicologia hanno dimostrato che
l'essenza dell'intelligenza umana non si comprende escludendo le emozioni. Oggi sappiamo che
quando le nostre scelte sono dissociate dalle emozioni e dall'affettività sono del tutto "irrazionali" e
ci rendono asociali. Il mito di una razionalità assoluta svincolata dal corpo delle passioni è
9
definitivamente tramontato, anche se forse molti fanno ancora fatica ad ammetterlo. In più, abbiamo
scoperto che le emozioni degli altri le comprendiamo anche perché condividiamo i meccanismi
neuronali che le sottendono. Il nostro cervello-corpo risuona con le emozioni dell'altro
rispecchiandole. Questo è un aspetto fondamentale di ciò che chiamiamo empatia.
FERRARIS: Tra le molte applicazioni della scoperta dei neuroni specchio una riguarda il
cosiddetto "paradosso della finzione". Non è vero che chi piange leggendo la morte di Hanno
Buddenbrook "non piange davvero" perché Hanno non è mai esistito, proprio come le emozioni
provocate dalla realtà virtuale sono emozioni del tutto genuine.
GALLESE: I neuroni specchio si attivano sia quando agiamo sia quando osserviamo agire gli
altri. Un simile meccanismo è stato dimostrato anche per le emozioni come il disgusto o la rabbia, e
per sensazioni come il tatto o il dolore. Per certi versi comprendere l'altro significa simularne
l'essere e il fare. La stessa logica si applica alla finzione, sia essa cinematografica, teatrale, narrativa
o delle arti visive. Il nostro cervello-corpo simula anche quel tipo di immagini. I neuroni specchio si
attivano di più quando l'azione osservata è realmente eseguita di fronte all'osservatore da una
persona in carne e ossa. Ma si attivano anche quando la presenza dell'altro è solo virtuale,
apparendo su di un monitor. Credo che sia per questo che la morte di Hanno Buddenbrook può
commuoverci come quella di una persona reale. Le emozioni che suscita sono altrettanto "reali".
Questa secondo me è un'altra grande scoperta delle neuroscienze: nel nostro cervello la differenza
tra reale e immaginario è molto meno netta di quanto ci appaia sulla base del nostro quotidiano
rapporto con la realtà. Paradossalmente, come dici tu, talvolta la finzione è più emozionante della
realtà. In questi casi si parla di "sospensione dell'incredulità". Credo ci sia dell'altro. Credo che di
fronte alla finzione artistica, possiamo abbassare le difese e "liberare" le nostre simulazioni. Nella
"finzione" artistica la nostra inerenza all'azione narrata è totalmente libera da coinvolgimenti
personali diretti. Siamo liberi di amare, odiare, provare terrore, facendolo da una distanza di
sicurezza. Fruire dell'arte, in fondo, significa liberarsi del mondo per ritrovarlo più pienamente.
FERRARIS: Ci sono delle ottime ragioni per sostenere che se piango tagliando le cipolle non
"piango davvero'', perché potrei essere allegrissimo. Ma ci sono situazioni più complicate. Per
esempio, si può sensatamente sostenere che chi ha paura di una allucinazione ha davvero paura? A
mio avviso, sì. E c'è anche un senso in cui il fremito che si prova quando si è innamorati e quello
che si prova quando si fanno le scale di corsa hanno qualcosa in comune. Su questo punto le
neuroscienze possono dare risposte importanti, anche se non surrogano né la riflessione
tradizionale, filosofica e psicologica (da Aristotele a Foucault passando per Cartesio e Hume), né
le descrizioni e analisi di emozioni che ci vengono fornite da Shakespeare, Proust o Henry James.
GALLESE: L'allucinazione è effettivamente un caso complicato, perché non è una percezione
senza oggetto, ma una percezione senza oggetto sociale, cioè non condivisa. Ma è altrettanto reale
per chi la prova di una percezione condivisa anche dagli altri. Questo perché ogni mia azione,
percezione, emozione o sensazione lo è sempre per me che la faccio o la provo. L'emozione d'amore
e l'affanno che ci assale dopo avere scalato cinque piani di scale condividono delle modificazioni
del nostro corpo. Il respiro si fa più frequente, il cuore batte più forte, la pressione arteriosa sale, ma
questo non basta a renderli uguali. E la presenza dell'altro, reale o anche solo fantasmatica, a
segnare la differenza. Le neuroscienze ci aiutano a comprendere meglio di cosa sono fatti gli affanni
del cuore e quelli della salita al quinto piano, ma i neuroni non bastano per spiegare cosa sia
l'amore. La difficoltà del dialogo tra neuro-scienze e scienze umane talvolta deriva anche da una
certa "neurohybris" secondo cui tutto può essere spiegato in termini neuronali. Non è così
ovviamente. Ma ciò non significa che quello che le neuroscienze possono dirci non sia rilevante,
tutt'altro. L'importante è non confondere i linguaggi di descrizione.
FERRARIS: A proposito di neurohybris, credi possibile che uno scienziato - non saprei dire
se saggio o pazzo - riesca a conservare le emozioni ma a liberarle dalla tendenza a soggiacere a
illusioni e a mitologie?
GALLESE Quello scienziato, riuscendoci, temo che avrebbe realizzato qualcosa di molto
diverso dall'essere umano, e non necessariamente migliore. È l'uomo che non può che soggiacere a
10
miti e illusioni. Siamo fatti così. Però abbiamo anche la capacità di riconoscere le illusioni e i miti
in quanto tali. Basterebbe forse sforzarsi un po' di più di smascherare le illusioni. Gli strumenti non
mancano. Le neuroscienze aggiungono a questo proposito un nuovo e importante livello di
descrizione. Sarebbe un esercizio per esempio utilissimo nell'Italia di oggi.
11