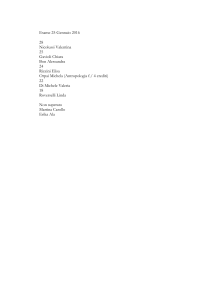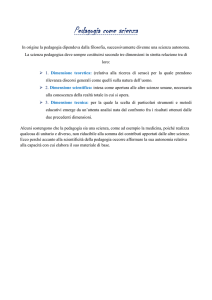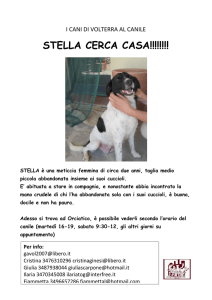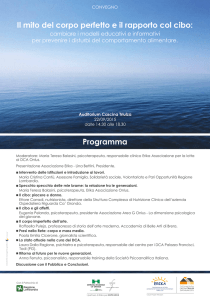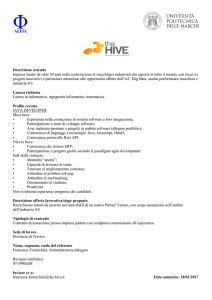caricato da
erika.bonfante.eb
Riassunto affermazione e ricerca di senso

lOMoARcPSD|4790068 Affermazione e ricerca di senso f nuvoli Pedagogia e Didattica Speciale (Università degli Studi di Cagliari) StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 AFFERMAZIONE E RICERCA DI SENSO di Felice Nuvoli Presupposti antropologici dell’educare Nozioni di avvio. L’uomo educa e si educa. Non c’è popolo né civiltà senza educazione. Essa appartiene alla nostra vita ed è determinante soprattutto per la crescita. Ognuno di noi ha ricevuto un’educazione più o meno completa ed è stato oggetto di cura e sollecitudine orientative per la sua crescita personale e per il suo inserimento nella società. Attraverso un processo di inculturazione, familiare e civica, ha preso forma la sua umanità individuale e sociale. L’educazione inizia con l’uomo: già l’azione protettrice dei genitori, tendente a garantire e favorire lo sviluppo dei figli, ha una valenza educativa; così pure la premura perché il piccolo che si inoltra nella vita eviti dannose esperienze negative. Sicuramente è educazione lo sforzo perché chi viene al mondo sia messo in condizione di conoscere nozioni, attitudini, abilità e disposizioni idonee a formare la sua personalità. Nel linguaggio corrente, si parla di Educazione per intendere una serie di attività volte alla crescita umana, generalmente attribuite ai genitori, ai maestri, agli insegnanti. A queste figure vengono riconosciuti la responsabilità e il ruolo di nutrire, curare, formare le nuove generazioni. Non può sfuggire il fatto che non esiste situazione umana in cui non si svolgano attività educative, ovvero una trasmissione di disposizioni, di abilità e di contenuti culturali. Vivere in una condizione sociale tale da non poter educare i fili significa stare in una società malata che mostra l’assenza di giustizia e vitalità di tutto il corpo sociale. L’educazione esiste fin dal momento in cui l’uomo è diventato uomo. L’uomo non nasce già adulto e maturo ma lo diventa mediante l’educazione che forma la persona e la integra nella società. L’inserimento sociale non conclude, ma continua il compito educativo, perché se l’uomo non frequentasse i suoi simili, altri uomini in grado di comunicargli delle conoscenze già acquisite, pregiudicherebbe il suo sviluppo. Nessun uomo singolo basta interamente a se stesso. Ognuno di noi è irripetibile solo in rapporto all’altro: io non potrei comprendere neppure me stesso senza un tu con cui comunicare, vivrei senza parola, e quindi con una ragione dormiente. Il bisogno di educazione emerge nei momenti cruciali delle varie fasi di crescita personale e sociale, non è perciò creato dall’educatore. A lui spetta il compito di rendere la persona più cosciente delle sue risorse e saper pertanto riconoscere i suoi valori. Nessuno può bastare da solo alla sua educazione; in realtà essa è per l’uomo una delle principali forme di aiuto reciproco. Se l’educazione fa parte dell’uomo, negargliela significa impedirgli di diventare se stesso. 1 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Nell’atto di educare si sviluppa, si arricchisce, si compie l’uomo in quanto uomo. Il rapporto educativo è un rapporto di generazione che scaturisce da un atto d’amore, chi educa stabilisce con l’educando una vera e propria relazione di paternità e figliolanza. L’uomo non è qualcosa di già fatto, ma anche un compito e un dovere. Per designare la crescita propria dell’uomo non basta parlare di cambiamento; il suo divenire è umano se è uno sviluppo perfettivo di tutte le sue facoltà sino alla loro piena maturazione. Grazie a tale sviluppo l’uomo si affina, si arricchisce in senso fisico, affettivo, intellettuale, morale, religioso. Posto che l’educazione, dal punto di vista antropologico, è l’insieme di progetti, azioni e mezzi per far pervenire l’uomo alla sua maturità personale e sociale, è chiaro che l’educatore non si può limitare a insegnare due o tre cose. Chi educa non deve mai perdere di vista la finalità formativa dell’uomo in quanto uomo. Una somma di specifiche abilità tecniche non garantisce di per sé la formazione della persona. Educare è molto più di un esercizio tecnico, è consapevolezza di rivolgersi a qualcuno dentro un rapporto che stabilisce la parola offerta e raccolta nel più intimo e originale centro vitale, qual è la libertà chiamata col suo nome proprio. Nello stesso punto avviene l’incontro tra verità e responsabilità, che apre le strade alla maturità umana. Per educare bisogna: favorire il vigore della volontà (così da permettere allo sguardo della ragione di cogliere il senso delle cose) e alla libertà la capacità di decidere e di agire e spingere la vita verso “l’ideale” , da non intendersi come un sogno evasivo ma come l’esigenza più profonda per cui il cuore dell’uomo si sente fatto: comprendere ciò che bisogna fare nella vita per agire rettamente. L’ideale è una norma per l’azione. Per un educatore il criterio della fedeltà all’ideale è un riferimento obbligato, ma nello stesso tempo il meno garantito, il meno propenso a lasciarsi definire e a cristallizzarsi in regolamenti astratti. La necessità dell’educazione nella formazione dell’uomo non è presente solo a un certo livello della sua vita, ma attraversa l’intera esistenza. Senza tralasciare il valore dell’infanzia e dell’adolescenza occorre saper stimare tutte le età della vita. Vero che quanto l’educazione ha trascurato negli anni della nostra infanzia non potrà essere ripreso a piacimento. Ogni età ha bisogno di cure educative. Se a un certo punto l’opera di un educatore può dirsi conclusa, non è così per il compito personale di educarsi il quale durerà tutta la vita. Educarsi ed educare non sono doveri reversibili e alienabili, né attività che interessano solo alcuni privilegiati o alcune fasi della vita. Si potrebbe dire che ogni uomo è sempre educatore ed educando, perché ognuno è sempre posto in rapporto con gli altri, e procura e subisce comportamenti altrui. 2 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Poiché si tratta di guidare lo sviluppo dell’individuo fino alla pienezza propria della personalità, l’educazione è di tutto l’uomo e riguarda tutto l’io nella sua intera singolarità, in tutti i suoi aspetti (fisici, psichici, biologici ecc) nessuno escluso. Ogni età dell’uomo ha il suo kaipos, il suo splendore, il suo momento privilegiato per decidere della propria pienezza. L’uomo è sempre educabile: chi ha questa consapevolezza conviene che vivere e formarsi sono un tutt’uno. Consapevolmente o meno, l’uomo si educa e a sua volta educa nel corso di tutta la sua esistenza, la chiusura dello slancio formativo, sono il segno, non si un’avvenuta compiutezza e completezza dell’uomo, ma di un’anomalia, di una de-formazione, di un’esistenza che non procede più. Si osserva, invece, che il processo educativo passa con il trascorrere degli anni, da una fase iniziale di massima intensità a fasi progressivamente meno intense, senza mai concludersi, in tutto l’arco dell’esistenza ci saranno tra gli uomini reciproche influenze educative che concorreranno a un incremento di formazione. Natura, cultura e pedagogia. Uno dei paradossi più interessanti dell’uomo è nel suo evidente limite, posto com’è in un punto dello spazio e in un momento del tempo, esprime una tensione verso l’infinito eccedente le sue condizioni naturali. La concretezza della persona è la sua universalità e la persona può dirsi “l’universale concreto”. Tutto nell’umano testimonia di un incontro tra natura e cultura. Il cervello con cui pensiamo, la bocca con cui parliamo, la mano con cui scriviamo, sono organi biologici e totalmente culturali. L’uomo è spazio biologico di vita e storia personale di libertà, natura e cultura elementi dati o da acquisire. Natura significa “ciò a cui un essere è destinato dalla sua nascita” , si osserva che proprio nell’orizzonte dell’educazione il rapporto dell’uomo col mondo e con la realtà sociale può stabilirsi secondo la forma dell’umano; la quale unisce natura e cultura. L’uomo ha una natura di cui nelle sue azioni non può non tenerne conto, egli si trova anche coinvolto in un passato dategli in antecedenza e in un avvenire che viene a lui riservandosi l’imprevisto della fine, al punto da prendere coscienza di sé soltanto se si considera come il risultato di un processo storico. In questo modo, attraverso la cultura, l’uomo cambia se stesso configurando la sua natura. Spesso si afferma che l’educazione è anche un atto culturale, un atto in grado di produrre un certo affinamento del soggetto umano sia nella sua espressione fisica sia in quella psichica e spirituale. “Cultura” dal latino colere che significa “coltivare” e curare, in questo caso la cura dell’uomo. L’educazione è da comprendere come la promozione di un corretto rapporto tra natura e cultura, tra struttura e storia, tra dimensione personale e dimensione sociale. 3 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Tenendo conto che la cultura non esclude la natura, ma è il nostro modo specifico di essere, l’educazione si realizza come espressione coerente e formativa della natura umana. Riconosciuta la “cultura” come il fattore distintivo dell’uomo, si dovrà anche comprendere l’educazione come l’insieme dei processi e dei comportamenti che permettono all’uomo di accedere alla cultura. Meglio intendere per cultura un complesso non solo di nozioni, ma anche di norme, tecniche, creazioni caratterizzanti un determinato livello di civiltà. È mediante la cultura che l’uomo raggiunge un livello di vita pienamente umano. La cultura può essere inoltre “l’esercitazione delle facoltà spirituali, mediante la quale queste sono poste in condizioni di dare frutti più abbondanti e migliori che la loro natura consenta”, allora si comprende come educazione e cultura tendano a identificarsi. Non esiste un modello culturale in cui non vi siano attività educative. L’educazione è di certo cultura, infatti senza la cultura l’uomo non raggiunge la propria “forma”, se non al termine di un processo di formazione necessario per umanizzare le molteplici esigenze ed esperienze della vita, informando e trasformando il diverso materiale di cui l’esistenza è fatta. L’uomo non può essere quello che è, se isolato dagli animali, dalle piante, dal vento e dall’acqua, dal cielo e dalla terra: l’uomo e la natura costituiscono un mondo che deve essere compreso nella necessaria interdipendenza di tutti i suoi aspetti. La stessa esperienza della libertà dipende, oltre che dall’ambiente psichico, dall’ambiente fisico e persino dall’ambiente chimico, ossia dalle abitudini elementari. L’uomo e il mondo non sono semplicemente posti l’uno accanto all’altro e neppure opposti l’uno all’altro come due zone separate. Sebbene i due termini non si identifichino, non bisogna cambiare la loro reciproca tensione in una separazione. Neanche si può evitare al termine mondo di assumere un significato antropologico. Grazie all’uomo il mondo prende nuova forma, si costruisce, ma si deforma anche e si scompone. Perché l’uomo faccia in modo che la natura non sia deformata dal potere della tecnica, ma sia resa più umana e familiare, molto consiglia che si prenda distanza dalla consuetudine, favorita anche dalla scienza moderna, secondo cui l’uomo deve considerarsi come padrone indiscusso della natura; ma la “signoria” dell’uomo sul mondo non lo autorizza a saccheggiarlo, a sfruttarlo arbitrariamente, ma richiede una cura responsabile, ormai urgente per la sua stessa sopravvivenza. Il rispetto dell’uomo richiede la salvaguardia della natura; un uomo che non rispetta la dimensione della natura assume un comportamento innaturale. Rendere sempre più profondo lo scisma tra natura e umano è l’errore da cui un’adeguata educazione deve difenderci. 4 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 La presa di coscienza del congiungimento tra natura e cultura è alla base del problema educativo nella storia dell’uomo e del suo progredire. Nel tempo, educare, da semplice prassi empirica, giunge a farsi arte consapevole. In cosa l’educazione consista e come si debba impartire è un’interrogazione continua; è importante volgere uno sguardo alla pedagogia la quale non si limita a rilevare e a descrivere i processi educativi, né a dare delle precisazioni occasionali e frammentarie, ma produce una solo valutazione ricercandone i principi, le cause, i fini, i mezzi e le istituzioni. Ammesso che è compito della pedagogia mostrare sul piano della consapevolezza e della riflessione critica come natura e cultura si completano nell’uomo in un’originale figura, è logico domandarsi se non si possa e non si debba migliorare quanto ricevuto dalla tradizione e dalla consuetudine. Non basta ripetere le usanze tramandateci, né è possibile dedurre un valore normativo dalle sole regolarità empiriche. La pedagogia riflette sull’opera educativa ma non coincide con essa. L’educazione, infatti, è una vera e propria azione pratica. In pedagogia prevale lo studio sul fare, nell’educazione il saper fare sul pensare. Se è giusto dire che la pedagogia è la teoria dell’educazione e l’educazione è la pratica della pedagogia, è anche vero che il pedagogista non può essere un educatore. La pedagogia ha le sue radici nella vita dell’uomo e la fonte del suo sapere è l’esperienza vissuta del reale. Essa è una vera e propria teoresi volta a fondare criticamente i principi e le norme della pratica educativa, a chiarirne i problemi e tentare di oltrepassare i limiti delle soluzioni inadeguate. All’educatore, che nella sua azione unisce i principi ideali e la cura del particolare, la dottrina e la vita, la pedagogia offre uno studio su quanto si fa e si deve fare per educare. La pedagogia fissa obiettivi, orienta, formula direttive al fine di guidare la formazione dell’uomo. La descrizione e l’interpretazione dei processi educativi si completano con l’analisi critica delle teorie pedagogiche, la lettura e l’ermeneutica degli autori, lo studio delle istituzioni educative. L’educazione prima di essere una teoria o una scienza, è un’attività e un vissuto quotidiani. L’azione pratica di educare è certo un momento di decisione e di scelta che nessuna riflessione potrà mai sostituire. Anche all’educatore giova pensare, per non lasciare che l’agire educativo si spezzi in un coacervo di condotte disparate. Non si educano gli altri senza educare se stessi: si passa da soggetto a soggetto, per suscitare il soggetto della propria crescita. Chi vuole essere cosciente del compito educativo dovrà riflettere sulla razionalità propria di tale agire. Chi si dispone a imparare cosa sia l’educazione presto dovrà misurare la difficoltà di stabilire un equilibrio tra la riflessione teorica e la pratica educativa. 5 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Una famiglia di processi: opera della pedagogia precisare la natura e il valore del nostro sviluppo perfettivo. All’educazione viene affidato il compito di favorire le facoltà fisiche, intellettuali e morali dell’educando, e quello di assegnarle un fine e cioè sapere cosa si può e si deve fare dell’educando. Per certi autori l’educazione deve perseguire fini individualisti, per altri, ha carattere esclusivamente sociale. Nel linguaggio attuale il termine “pedagogia” significa arte di condurre, di guidare il fanciullo, più che la pratica di educare indica la teoria dell’educazione; invece l’etico greco richiama direttamente un’azione educativa e non un discorso logico. Nelle città ellenistiche il nome di pedagogo si dava allo schiavo, il cui ruolo consisteva nell’accompagnare il figlio del suo padrone dalla casa alla scuola, e custodirlo dai pericoli della strada. Si riconosce che il fanciullo finiva per ricevere dal pedagogo non poco della sua educazione morale. Chi vuole esplorare con serietà il problema educativo deve prepararsi a esaminare una questione di non facile soluzione, perché intricata di connessioni tra credenze e valori sociali, culturali e politici, che l’uomo adotta come norme supreme di vita. Assumersi i problemi della formazione, penetrarli e risolverli criticamente richiede un accurato lavoro e un personale coinvolgimento. Alla domanda: Che cos’è l’educazione? Non si può rispondere con una definizione a priori e limitarsi poi a commentarne i termini. L’intelligenza del processo formativo ed educativo non si dà come una dottrina rigidamente definita fin dall’inizio, ma si forma in un discorso che si potenzia in grado sempre maggiore, attraverso una continua verifica empirica e filosofica. L’impazienza di definire contraddice e blocca la necessaria fiducia creatrice della ricerca. Per questa ragione non pare sia cosa utile proporre da subito una definizione tale da pregiudicare in partenza ogni ulteriore ricerca, e quindi costituire, una petizione di principio. Non tutti gli elementi della dottrina pedagogica possono dirsi da subito chiari e precisi; alcuni di essi esistono da principio come in germe, e solo col tempo potranno essere perfezionati e definiti. L’educazione non è qualcosa che si lascia predeterminare una volta per tutte; come la vita, essa è in continuo divenire. Sempre aperta a eventuali correzioni. Se il formarsi della persona non può prescindere dalla vita in atto e dalla sua concretezza storica, allora l’educazione si rivela attraverso un lungo e progressivo lavoro di riflessione che non si limita ad affermazioni astratte e universali, ma si congiunge all’effettivo dinamismo dell’agire umano. È innegabile che si può educare in diversi modi. C’è un’educazione quasi “istintiva”, semplicemente empirica, non consapevole della sua interna unità logica e povera di riflessione critica. Si pensi alla normale educazione che la famiglia impartisce: essa procede per intuito e per tradizione, sovente si dimostra occasionale e varia. Talvolta può presentarsi molto liberale, altre 6 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 volte assai rigida. Nessuna meraviglia allora che si facciano rientrare nell’idea di educazione le cose più eterogenee, senza riuscire a vedere il loro collegamento. È innegabile che una certa educazione può nuocere allo sviluppo fisico dell’uomo, un’altra ostacolare la sicurezza del suo giudizio e l’apertura delle sue facoltà intellettuali. Basta poco perché ciò che dovrebbe essere strumento perfettivo dell’umano diventi occasione di degenerazione. Solo attraverso l’educazione l’uomo, assumendo la coscienza e la responsabilità di sé, si eleva dall’individualità empirica della sua dimensione di essere personale, allora riflettere su questo aspetto della vita può non essere un’esigenza minima, di efficacia ridotta, discutibile. L’educazione non è una cosa puramente teorica, ma, perché la sua partica non si riduca a pura reattività, deve esplicitarsi in consapevolezza, indicare i suoi fini e rendere ragione del suo senso autentico. Il carattere precario e artificioso di molte prescrizioni, e più in generale di molti comportamenti educativi, non è imputabile semplicemente alla leggerezza o all’ipocrisia degli educatori, ma talvolta risale a un’insicurezza dovuta all’incapacità di scorgere nella coscienza indicazioni univoche a sostegno della propria responsabilità. Nonostante si ammetta che lo studio non sia sufficiente per fornire in maniera univoca e definitiva l’imperativo concreto di come si educa, bisogna convenire sulla necessità della riflessione per aprire e delimitare il campo all’interno del quale è possibile e ha un senso una decisione educativa. L’educazione infatti è termine dal campo referenziale ampio: essa è processo, interazione, evento. Molto difficile trovare una formula soddisfacente per dire cosa sia l’educazione nei suoi riferimenti, nella sua tensione, evitando di oggettivarne il dinamismo in uno schema statico. Tuttavia ancora non si trova un concetto perfettamente in grado di dominare la complessità dell’educazione. Per vedere più chiaramente la realtà dell’educare nei suoi diversi aspetti e percepire maggiormente le relazioni altrimenti intraviste soltanto in modo oscuro e vago, sono necessarie accurate distinzioni. Non può esserci una scienza dell’educazione senza una scienza della diseducazione. Qualsiasi “progetto” positivo in favore dell’uomo non può evitare di fare i conti con ciò che minaccia l’umano. Il pensiero per il poter raggiungere un obiettivo arduo molto spesso deve attraversare una molteplicità di progetti frammentari e contradditori, e quindi procedere per mezzo di scarti e negazioni. Il fatto che l’educazione possa essere studiata sotto aspetti diversi accredita il carattere composito del processo educativo. Il termine “educare” potrebbe derivare da ex-ducere, oppure da educare. Ancora si discute sul termine latino prevalente del termine. Nel primo caso, il verbo può significare tanto trarre fuori, quanto avanzare, elevare, condurre da un punto all’altro; frequentemente si cita il significato di “trarre fuori” e quindi di promuovere la crescita dell’educando, nel senso di agevolare lo sviluppo di un seme fino alla sua maturazione. Nel secondo caso è preminente il senso di nutrire, allevare, 7 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 curare, ma anche formare o istruire. L’originale polisemia della parola richiama a una pluralità di dimensioni operative innegabilmente presenti nell’educazione. Assai stimolante l’icona dell’educare come “condurre via” , efficace l’immagine di educazione come un portare all’aperto, essa suggerisce di intendere l’educazione come un condurre l’uomo verso la sua manifestazione. Il nostro io presto si rivela un angolo aperto all’infinito, incapace di chiudersi resta chiuso in un qualsiasi recinto. Si potrebbe pertanto dire che l’educazione è aiuto nello sviluppo, e quindi “coltivazione” del vivente; ma è anche passaggio dalla natura alla cultura, attraverso la trasmissione di un patrimonio di conoscenze e stili di vita che richiedono di essere accolti e sviluppati. Bisogna sempre rispettare l’originale interiorità della persona, che nessuna educazione può produrre dal di fuori, ma solo contribuire a risvegliare. Al riguardo, chi educa deve saper “colpire” l’educando nel punto focale della sua responsabilità, per provocare il coinvolgimento consapevole e libero nella formazione della sua persona. Educere ed educare possono rivelarsi come concetti chiave che aprono sull’intero del processo formativo; sono differenti, ma, quando li si comprende rimandano l’uno all’altro. Perciò, senza rinunciare alla loro distinta funziona, nel corso del divenire perfettivo della persona riescono sia a coesistere l’uno accanto all’altro sia a succedersi l’uno all’altro, in modo tale che l’uno possa schiudere la comprensione dell’altro e viceversa. Siamo dunque alle prese con un fenomeno estremamente variegato, perché si possa dare una rapida e univoca definizione del problema posto dall’educazione. “l’educazione non è un processo, ma una famiglia di processi, di attività, di risultati, la cui qualità educativa si definisce in base a criteri di valore che sono anche i criteri della sua unità”. 8 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Si tratta dell’uomo. L’educazione è un’opera dell’uomo per l’uomo; la sua costante premura è il rispetto attivo dell’uomo, e quindi la promozione nell’uomo di tutto ciò che lo fa veramente uomo. Tale sviluppo perfettivo passa attraverso una serie di eventi, azioni e mezzi, che favoriscono la realizzazione delle capacità proprie dell’educando. L’educazione è sempre in vista della libera formazione dell’uomo a divenire veramente se stesso; perciò tutto il resto o vive di tale realtà o non ha ragione d’essere. La moralità della pratica educativa consiste nel non contraddire il valore della persona. Prima di pensare a fare acquisire all’educando abitudini considerate indispensabili a conformarlo alle convenzioni sociali, occorre permettergli di manifestare ed esprimere la propria unicità; solo allora ci si sforzerà d’incivilirlo. Bisogna mirare a costruire facendo leva sull’originalità concreta dell’educando, piuttosto che intervenire a nome di costrizioni sociali. Solo una presa di coscienza di cosa sia e debba essere l’umano fa risaltare in modo soddisfacente l’obiettivo dell’educazione, e quindi le possibilità e i limiti del suo agire specifico. Sempre, a questo livello, la poliedricità dell’educazione scopre la complessa ricchezza della sua problematica. Discutere sulla natura dell’uomo e su quali siano le sue capacità e possibilità apre il problema di cosa si possa e si debba fare di tale dote e a quale fine si debba orientarla. Se l’uomo deve riconoscersi come un essere personale, capace di determinarsi individualmente, benché cosciente di essere come un atomo nel cosmo, legato alla terra che lo porta e vincolato all’interno della società umana, allora la questione antropologica è anche questione pedagogica. Una volta ammesso che il termine “educazione” conduce al termine “uomo” e viceversa, allora il termine pedagogia è senz’altro correlativo al termine antropologia. In realtà una pedagogia che vuole essere comprensiva dei vari campi dell’essere riguardanti la nostra formazione è essenzialmente un impegno antropologico. Vale anche: un’antropologia integrale è intimamente pedagogica. Poiché l’educazione sottintende sempre una determinata concezione dell’uomo, si capisce assai presto come la ricerca antropologica costituisca un momento tra i più significativi del nostro studio. Se si considera che il problema pedagogico è il problema stesso dell’uomo nel costituirsi della sua personalità, si fa chiaro come neanche possa esserci una definizione di educazione indipendente dalla concezione dalla concezione di uomo propria di chi educa. L’incontro tra pedagogia e antropologia spinge a riconoscere come senza educazione non si avrebbe niente di specificatamente umano: non si darebbero, per esempio, le tecniche, il linguaggio, i costumi. Queste realtà investono il problema pedagogico e tendono a definire l’ambito concreto in cui l’educazione si svolge. La pedagogia non ha altro centro e altro scopo che la persona e il suo valore assoluto. Il concetto di persona indica che ogni uomo è unico, inconfondibile, insostituibile, senza equivalenti e perciò 9 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 avente sempre dignità di fine, ma di mezzo. Un’educazione che non faccia perno sul bene della persona, considerata come “ciò che vi è di più perfetto in tutta la natura”, meglio non sia chiamata educazione. Nessuna scienza può pretendersi “neutra”, cioè indifferente al destino dell’uomo e ciò vale in particolare per la pedagogia, dove persino le questioni di carattere metodologico sono tali da coinvolgere un interesse morale. Impossibile che il suo discorso sia neutro o che ritorni in uno stato puramente “naturale”. Poiché si tratta di aiutare l’uomo a entrare con sicurezza nella propria vita, in educazione anche un atteggiamento cosiddetto neutro non è mai “neutro”. La sfida dell’educazione chiede a chi l’accoglie di proporsi e coinvolgersi in prima persona nell’esperienza dell’humanum. Ciò non significa incuranza del rigore critico, ma, al contrario, assunzione attenta e responsabile della cultura pedagogica in un pensiero comunicabile, se è il caso dialettico, sempre pronto a qualsiasi paragone che ne arricchisca le ragioni interne al processo educativo. Il mito di una pedagogia “neutra” è un’illusione superficiale e acritica. Una disciplina che miri all’intelligenza della formazione della persona non può limitarsi a giustificare delle tecniche, ma si pronuncerà sui valori e, in relazione a questi, renderà ragione del metodo educativo giudicato migliore. L’essenziale orientamento dell’educazione non può non dipendere dall’idea dell’essere, del compito e del destino di chi deve essere educato. Per questa ragione, il problema fondamentale della pedagogia investe in pieno la necessità di rispondere all’interrogativo sul senso specifico dell’esistenza umana. L’efficacia dell’educazione è sempre proporzionata all’effettivo valore che l’educatore attribuisce alla vita dell’uomo. Ogni ricerca costruisce il suo metodo, lo forma e lo trasforma adottandolo via via al suo oggetto di studio. Il metodo non è il pensiero che ricerca, ma la strada su cui cammina; esso è un procedimento che dispone di adeguati mezzi al fine di raggiungere una determinata meta. Cogliere la logica che sorregge il metodo significa cogliere la correlazione tra mezzi e fine; senza la precisazione del fine e dei mezzi adeguati, anche l’intelligenza del metodo rimane oscurata. In linea di principio, si deve convenire che fini e mezzi sono inseparabili. Ogni fine poi non si limita a indicare un punto d’arrivo, ma segnala anche un procedimento per giungervi; in qualche modo, misura anche le possibilità di raggiungerlo. Non perdere di vista il fine permette di trovare la via per eventuali mutamenti dei nostri progetti. 10 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Definire a priori una metodologia, significa limitare arbitrariamente la libertà inventiva della ricerca medesima. Il metodo non è uno strumento che l’educatore ha già acquisito prima di iniziare la sua opera; piuttosto è uno strumento che si crea, si affina, si perfeziona con l’uso. In educazione si deve rilevare che i mezzi adottati in definitiva si giustificano in conformità al fine da raggiungere. Infatti, anche i metodi educativi sempre rispondono a una determinata idea di uomo e delle qualità che egli deve possedere per essere veramente tale. Alla valutazione complessiva della realtà umana, dei suoi valori, delle sue leggi, dei dinamismi e condizionamenti della sua migliore realizzazione, fa capo anche la scelta del metodo educativo come pratica traduzione di quanto si è stabilito come fine dell’educazione. Sotto questo profilo , la problematica pedagogica è anche una problematica metodologica. Sarebbe un errore giudicare invalido un metodo senza tener conto del fine che lo giustifica; proprio come non è ragionevole negare l’opportunità di una divisa senza conoscerne una funzione. In pedagogia conviene rimarcare che la scelta di un metodo dipende, almeno implicitamente, da una preferenza teoretica o ideologica orientante verso un determinato tipo di uomo. Lucien Laberthonnière, agli inizi del 900’, ha introdotto la sua opera “teoria dell’educazione” ancora efficace, per rimarcare che l’educazione esige la nozione preliminare di chi è colui che si deve o intende educare. Laberthonnière crede che l’educazione richieda un’adeguata considerazione anche dei condizionamenti storici, economici, sociali e politici, in cui la soggettività vive, e certo fa appello a molte risorse, oltre alle idee relative al senso della vita umana e al suo destino ultimo. Eppure, perché la pratica educativa possa avvalersi utilmente di una teoria che ne determini i fini e i metodi, cioè della pedagogia, la questione antropologica può dirsi la prima quaestio. Si tratta di conoscere la singolare peculiarità dell’uomo, la sua natura biologica e la sua configurazione spirituale, la sua contingenza storica e il suo destino ultimo, la sa aspirazione all’amore e all’eternità la realtà dell’odio e della morte. Soprattutto alla pedagogia occorre la consapevolezza dei caratteri propri della nostra specie. La riflessione pedagogica non può non essere segnata dall’interrogazione sull’uomo. Quindi all’uomo è destinata come al suo fine la teoria volta a chiarire il processo attraverso cui la persona si realizza gradualmente, traendo da sé ( ex-ducere) tutta se stessa. La pedagogia può dirsi critica solo perché incessantemente disposta alla verifica offerta dall’esperienza che l’uomo ha di sé e del mondo. 11 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Educazione e storia: Per l’uomo il presente è il momento di una decisione consapevole; agendo nel presente si assume una responsabilità nei riguardi del futuro. Quando poi l’uomo riflette sul passato, può distinguervi il ripetersi di un ciclo di eventi molto simili, ma anche un tutto organico come un processo diretto a un fine, lo scomparire di un mondo per dare luogo a un mondo nuovo. L’uomo vive nella storia ed è protagonista di storia. Vivere in questo modo è possibile soltanto a chi, mentre il tempo scorre, può con una parte del suo essere innalzarsi al di sopra del movimento in cui è inserito e quindi scoprire nel trascorrere degli avvenimenti una struttura intelligibile, in una parola: un senso. Così l’uomo prende coscienza di avere una storia (passato), il cui significato legge alla luce del suo destino (futuro) ed è presente in ogni istante del tempo. La consapevolezza della propria situazione e dell’orizzonte temporale che include la situazione stessa fa dell’uomo un essere storico, cioè aperto a comprendere la situazione presente nella prospettiva o nel progetto della realtà futura. Di tutto ciò che esiste al mondo soltanto l’uomo è un essere storico: soltanto di lui si scrive la storia, perché solo l’uomo è in grado di assumere liberamente il passato e d’inventare un nuovo avvenire. Pur vivendo nel tempo, come ogni altra cosa, l’uomo è l’unico capace di pensare il tempo, di misurarlo di dargli un senso. Egli è il solo per cui il tempo esiste. La sua storia, gli sfugge. In realtà, i fatti e gli eventi storici non si sentono, né si percepiscono, si offrono solo a un capire intelligente, cioè alla luce del giudizio. Solo l’uomo può comportarsi nel presente muovendo dal passato verso il futuro, ma anche viceversa. Il passato può inibirci e deprimerci, come pure rafforzarci e spingerci in avanti; il futuro ci può attrarre stimolandoci, oppure opprimerci e impaurirci. 12 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Il tener conto della necessaria discontinuità tra passato e futuro distingue la prospettiva dalla semplice previsione. Se ogni epoca dell’umanità dovesse ripartire da zero, sarebbe la fine della storia perché non basta che la nuova generazione ripeta i gesti della precedente. In molteplici campi, le nuove generazioni dovranno inventare i propri gesti, tracciare vie nuove al fine di realizzare una più autentica umanizzazione del mondo. Ciò richiede un’intelligente capacità di riprendere quanto si riceve dalle “evidenze” dell’abitudine. Lo sviluppo di cui l’uomo è capace deve intendersi come una trasformazione qualitativa che interessa la mentalità dell’uomo, e quindi le strutture medesime della sua vita personale e sociale. La storia a lungo termine rende evidente che in profondità essa è mossa dalla cultura, cioè da soggettività ricche di una precisa identità culturale. Occorre saper giudicare il vissuto, ordinare l’esperienza per levarla ed estenderla oltre i limiti della consuetudine empirica, vagliarne il valore e tramandarlo agli altri. Se l’uomo possiede la privilegiata capacità di fare tesoro dell’esperienza propria e altrui, trasmessa di generazione in generazione, in questo processo l’educazione assolve una funzione essenziale, perché si realizzi una continuità storica quale condizione per accumulare un patrimonio di cultura. Così ogni uomo può nutrirsi di una conoscenza antecedente al suo esistere. Quanto l’uomo apprende dalle esperienze altrui può a sua volta essere trasmesso ad altri con la parola, la scrittura, i modelli di vita. Se l’apprendere può dirsi comune all’uomo e a molti animali, l’insegnare è una prerogativa peculiare della nostra specie. Alcuni animali superiori aiutano i loro piccoli a compiere azioni utili alla loro sopravvivenza, ma solo l’uomo è in grado di trasmettere cultura e civiltà. Ecco perché spesso il termine “educare” è sinonimo di civilizzare: trasmettere l’eredità culturale, della quale la società è portatrice, significa adoperarsi per costituire una civiltà. Senza l’educazione l’umanità non sarebbe che una sequenza, nel tempo, di generazioni sempre allo stato primitivo. Tuttavia, allo scopo dell’educazione importa, più che il punto di partenza, il fine ideale cui tendere. Il centro gravitazionale dell’educazione non si trova nel passato, ma nel futuro. L’unità, nel rapporto educativo, non viene tanto da ciò che sta alle spalle dei protagonisti quanto dal destino al quale essi tendono. La categoria di “apertura al mondo” supera il semplice apprendimento come imitazione e ripetizione e introduce nel processo formativo la necessità di imparare il mutamento e la trasformazione come aspetti decisivi dell’esistenza umana. Solo là dove il mutamento viene compreso come valore essenziale, la libertà si esprime come una responsabilità non passiva o semplicemente reattiva. L’uomo nel tempo produce una molteplicità di culture, valori e strutture, eventi e storia; con la sua opera egli genera valori che hanno una portata reale per lui stesso e per il mondo. L’autocoscienza è un elemento talmente essenziale della nostra natura che c’è in noi un aspetto variabile con il mutare 13 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 continuo e inevitabile della nostra storica autocomprensione, e, in una certa misura, col variare della autocomprensione che il gruppo sociale ha di se stesso. Si afferma così una precisa volontà di valorizzare la singolarità specifica dell’uomo, il solo in grado di compiere delle esperienze che superano le cognizioni acquisite in precedenza, il solo cui la verità si palesa per successive manifestazioni, e quindi il solo capace di distinguere il futuro dal presente. L’uomo non solo può apprendere la propria esperienza ma raccoglie il frutto di esperienze altrui. A sua volta, egli stesso può trasmettere ad altri uomini i risultati e le riflessioni delle esperienze proprie di vita e di pensiero. L’uomo non solo è in qualche modo dipendente da chi si prende cura di lui, ma è anche debitore di cure altrui favorendo la trasmissione di apprendimenti, intuizioni, elaborazioni personali e storiche ecc di cui consiste il patrimonio civile e culturale dell’umanità. L’uomo è legato alla sua specie non solo biologicamente ma anche culturalmente, è un essere sociale, e quindi educabile ed educatore. Il formarsi dell’uomo è segnato da una naturale solidarietà con gli altri, e non è adeguatamente comprensibile se il fenomeno non si accosta al modo in cui si sviluppa il suo comportamento sociale. L’uomo diventa sempre più se stesso incontrando gli altri e apprendendo nel dialogo valori personali, sociali, etici e religiosi. Perché nasciamo bambini? L’uomo non nasce già pienamente maturo, ma in uno stato ancora di effettiva formazione. Nessun altro essere vivente ha un periodo di sviluppo tanto lungo da potersi paragonare, anche solo lontanamente, a quello dell’uomo. Alla sua nascita le sue principali funzioni si presentano in uno stato indifferenziato; solo in seguito si differenziano grazie a un processo di maturazione. L’uomo viene al mondo come la creatura più bisognoso di cure. Durante il primo periodo della sua vita, il bambino appare come il più disarmato, il più fragile soprattutto da un punto di vista fisico; egli vive una lenta fase di maturità. 14 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Non è errato dire che l’uomo non arriva mai a essere pienamente compiuto; soprattutto nel corso dei suoi primi anni egli è alle prese con un corpo delicato privo di autonomia. Mentre molti esseri viventi nascono già “adulti”, il neonato non è fisicamente né psicologicamente già costruito o completo. Se osservato che un animale lasciato a se stesso può sopravvivere; il bambino, invece, qualora venga abbandonato muore. Anche il progredire della vita umana è molto più lento di quello degli esseri umani. Giunto alla vita come il più delicato e indifeso degli esseri viventi, se a il piccolo dell’uomo mancasse un’assistenza adeguata la sua crescita verrebbe annullata o compromessa. Il suo sviluppo dipende da varie cure materiali. Quanto inizialmente manca al bambino da un punto di vista biologico e istintuale potrà essere in seguito da lui recuperato grazie alla sua intelligenza e volontà. L’esito dello sviluppo compenserà il bisogno iniziale. Confrontandosi con la natura che lo circonda l’uomo sa di condividere con il mondo animale molte delle sue funzioni vitali; ma presto i afferma l’emergere della su singolarità. Prendendo coscienza del contesto in cui egli è situato (famiglia, società, tradizione), realizza come tutto ciò possa essere un potentissimo strumento per inoltrarsi nella scoperta del mondo e nella possibilità di adattarlo ai suoi desideri. Mentre la vita animale non sporge oltre l’orizzonte della necessità, l’uomo, mediante l’educazione, supera l’esperienza istintiva, introduce risultati nuovi rispetto alle sue disposizioni native, progredisce continuamente le sue abilità. La necessità di adattarsi nell’uomo fa affidamento sulla sua vasta e profonda capacità di apprendere. La determinazione istintiva nell’uomo può essere sottoposta a controllo; egli può agire contro di essa per migliorare le condizioni della sua vita e proteggersi contro le avversità della natura. Così, nel caso dell’uomo, quello che a prima vista può sembrare ovvio si complica e si intrinseca. Tutto si fa problematico, perché qui entra in gioco la forza originale dell’intelligenza, che trova la sua espressione sintetica nell’atto del giudizio. L’uomo supera la specializzazione animale grazie alla possibilità di usare la ragione. È significativo che il fanciullo, nella ricerca di comportamenti più vantaggiosi, tenda ad affrancarsi il più presto possibile dall’istinto per seguire le vie della ragione; certo, in ciò è facilitato e perfino sospinto dalla convivenza sociale. L’animale adulto è dato; l’uomo adulto deve farsi. Qui l’educazione trova la sua ragione fondamentale. Nell’uomo la razionalità (che è insieme intelletto e volontà) è soltanto una potenzialità e un’esigenza, e non un’attualità. Poiché il suo stesso sviluppo biologico dipende dal modo in cui egli cresce entro un ambiente storico-umano, anche la necessaria e prolungata protezione del bambino deve considerarsi educazione vera e propria. 15 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 La formazione della persona è un fine che chiede il rispetto complessivo di molteplici interessi. Se si vuole che il piccolo dell’uomo cresca umanamente la sua protezione deve essere “umana”, cioè deve offrire un quadro di sollecitudine amorosa che sospinge il bambino ad affermare se stesso. Sono tanti gli aspetti negativi del mancato sviluppo della personalità dei figli, che debbono essere addebitati all’assenza o ai contrasti dei genitori. Questa semplice osservazione dovrebbe bastare per comprendere come la mutua collaborazione del marito con la moglie non ha solo una funzione coniugale, ma anche pedagogica. Allevare, nutrire, curare, sono azioni necessarie perché il bambino sopravviva, ma si rivelano anche come una funzione ontogenetica, strutturante cioè la forma della sua esistenza. La peculiare dipendenza del piccolo dell’uomo si chiama “neotenia”. Il termine indica la sua lenta crescita, fatta di nutrizione, allevamento, compagnia ecc. tutte cose che rendono il piccolo dell’uomo dipendente da figure essenziali per la sua “salvezza”. La neotenia, scrive Rita Fadda, la lenta crescita, l’estrema fragilità dell’essere umano appena venuto al mondo e la sua dipendenza dalla cura degli altri, sono il prezzo che egli deve pagare proprio per la straordinaria potenzialità realizzativa che è tipica della forma-umana, e che non è comparabile con nessuna forma vivente. Proprio la lentezza dell’inizio, peraltro, permette la realizzazione di un proficuo scambio tra persona e persona, tra comunità e persona e viceversa. Per converso, la socialità dell’uomo esige che la verità della sua realizzazione si cerchi e si sveli alla sua coscienza attraverso l’insegnamento e l’educazione, passi attraverso la comunicazione e il dialogo: esperienze che esigono molto tempo. La grande ampiezza del mondo umano, la sua ricchezza d attività esigono una lunga infanzia che metta in grado di esercitare un complesso apprendimento. L’uomo compie degli atti comuni anche agli animali, ma ne compie altri, che procedono dalla sua ragione e volontà, di cui egli solo può dirsi padrone. Nel bambino la mancanza di specializzazione favorirà una maggiore plasticità e capacità di trasformare i suoi limiti in nuove possibilità. La sua più debole determinazione istintiva non è l’indicatore di una minorità, ma della presenza dell’intelligenza; in effetti, “costringe” a passare ad attuazioni coscienti e responsabili. Che un soggetto vivente possa decidere qualche cosa senza essere determinato dalla situazione è una via d’accesso privilegiata per la comprensione dell’uomo. L’originale rapporto che intercorre tra determinismo biologico e indeterminazione della libertà è il luogo in cui l’umano rivela se stesso. Solo nell’uomo, il determinismo biologico, pure presente, si coniuga con l’agire conscio e libero: ed è solo su questo piano che si può parlare di atti di specificamente umani. Anche negli atti umani notevole è il ruolo dell’istinto, ma nell’uomo esso si trova portato a un’altezza tale da renderlo molto differente dalla semplice reattività animale: la 16 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 presenza influisce sull’istinto e lo perfeziona, in modo tale che si parli di istinto umano e non animale. Edouard Claparede, pedagogista svizzero, osserva come la natura abbia predisposto per l’uomo un lungo periodo di sviluppo dalla nascita alla maturità, propone una spiegazione positiva suggerendo di “ammettere che se questo periodo di giovinezza si è così affermato, è perché ha per l’individuo o per la specie una certa utilità. L’infanzia ha perciò una sua funzione, perciò è utile ed è un bene. Mentre si riconosce che l’infanzia è interamente polarizzata verso l’età adulta, si deve anche difendere la sua specifica ricchezza di vita. Nel suo celebre homo ludens, Johan Huizinga sostiene che il ludico è l’elemento fondamentale della storia e della civiltà, perché la cultura deriva dal gioco. In questo senso conviene intendere anche le parole di Schiller: “l’uomo gioca solo quando è uomo nella piena significazione della parola, ed è interamente uomo solo allorché gioca”. L’equazione funzionalismo=educazione non può essere un assoluto, perché l’educazione è anche gratuità. L’uomo non vive di solo pane, ma anche di bellezza, che restituisce alla vita il suo gusto; l’uomo ha bisogno del bello come ha bisogno di aria e di luce. Friedrich Froebel dichiara che “il gioco è il più alto grado dello svolgimento umano”. Se considerato da un punto di vista gnoseologico, il gioco è la forma tipica della conoscenza dell’infanzia. Il gioco coglie l’aspetto simbolico della realtà; spontaneamente ne afferma la sua unità interiore. Si può rilevare che la fenomenologia del ludico penetra in tutte le attività umane. Il gioco non è solo un trastullo arbitrario, ma è espressivo dell’intelligenza specifica dell’uomo e della sua libertà. Il gioco ha una grande valenza educativa: in esso si mettono in atto e si esercitano, promuovendone lo sviluppo, quelle funzioni e attività generali attraverso le quali il soggetto forma la sua personalità. Razionalità e autocoscienza. Come ampiamente e con vigore è stato rilevato da Arnold Gehlen, l’uomo è un essere biologico “mancante”, sempre in fase di strutturazione, mal provvisto e bisognoso di tante protesi. L’uomo appare con un essere debole, un “essere di carezze”; i suoi sensi e i suoi istinti non sono in lui abbastanza precisi e perfetti da permettergli un adattamento spontaneo all’ambiente. Nonostante la sua inferiorità biologica, l’uomo prevale sugli altri animali in forza di una dote specifica che chiameremo “razionalità”, e con una terminologia moderna autocoscienza. L’uomo può attingere dalla ragione delle cose e alla coscienza della vita. Grazie alla ragione, la sfida con le leggi biologiche fondamentali vede l’uomo più che vincitore. Poche cose come il mito di Prometeo, esposto da Platone nel Protagora, riescono a esprimere con efficacia la condizione peculiare dell’uomo nel mondo, e quindi la natura e il valore antropologico dell’educazione. Il mito narra che all’inizio, gli dèi incaricarono Epimeteo (colui che vede dopo) e 17 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Prometeo (colui che prevede) di distribuire fra le varie specie animali le facoltà convenienti alla loro sopravvivenza. All’uomo, grazie a Prometeo, venne offerto il fuoco, l’arte tecnica e da qui le risorse per procurarsi protezione, difesa, armi, mezzi per avere il cibo necessario. Con l’intervento di Zeus, infine, il quale mandò Hermes tra gli uomini, venne donato il rispetto reciproco e la giustizia. Il mito mostra come l’uomo non può conservare l’esistenza senza abilità tecniche e senza la necessaria sapienza per vivere insieme. Entrambe le cose non sono istinti o impulsi naturali, ma si devono imparare, e quindi trasmettere e apprendere. Tale necessità spiega perché l’uomo ha un’infanzia molto più lunga e complessa di quella degli altri animali. L’educazione e il linguaggio assicurano all’uomo la sua sopravvivenza “l’educazione è l’istinto di conservazione per gli animali, e l’educazione è sostenuta dalla parola”. Il linguaggio non solo permette un’efficace comunicazione tra gli uomini, ma il suo uso consente anche le astrazioni e generalizzazioni indispensabili alla formazione delle tecniche stesse. l’uomo è dotato della capacità di intelligere e di riflettere, e quindi di afferrare il suo atto e se stessa. Razionalità significa potersi innalzare al di sopra del sensibile, fino all’universalità del concetto. L’oggetto del conoscere reso libero dai caratteri individuali, grazie all’astrazione, può essere applicato a un numero indefinito di casi particolari della medesima natura. Poter “astrarre” da un oggetto di conoscenza una o più proprietà, e quindi estendere questa proprietà ad altri oggetti, cioè generalizzare, permette di stabilire rapporti fra le idee e gli oggetti concreti e particolari. Da questa possibilità, integrata con quel modo di procedere per composizione e divisione che caratterizza il giudicare proprio della nostra ragione, nasce la conoscenza scientifica, in quanto le conoscenze del particolare e del concreto vengono subordinate alla norma e al tipo, grazie alla scoperta del simile nel dissimile, dell’identico astratto nella varietà concreta. La nostra prerogativa di astrarre, riflettere e giudicare, non trova alcuna traccia corrispettiva negli animali. Noi siamo differenti agli animali non solo per complessità organica e psichica, ma anche per natura. Tra noi e l’animale non c’è uno scarto di grado, bensì una differenza di condizione. Il bambino, ancor prima dell’uso della ragione è “persona” , il cui termine può essere scelto proprio perché propizio per indicare la radice ontologica della dignità dell’uomo, la cui vita propria è vita interiore all’io. La razionalità è l’elemento specifico dell’umano, ma, perché l’uomo sia tale, non si esige che essa sia presente come esercizio in atto, basta sia presente come capacità essenziale. “Nel pensiero sta la grandezza dell’uomo” scrive Pascal, “l’uomo è una canna, la più fragile della natura; ma una canna che pensa. Non occorre che l’universo intero si armi per annientarlo; un vapore, una goccia d’acqua bastano a ucciderlo. Ma anche se l’universo lo schiacciasse l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di 18 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 quel che uccide, perché sa di morire, e la superiorità che l’universo ha su di lui; mentre l’universo non ne sa nulla”. Solo in noi la natura esprime la possibilità sia di conoscere le cose, sia di passare da queste all’autocoscienza, cioè di rendersi conto di ciò che esse significano per il soggetto conoscente. L’uomo, grazie alla sua capacità di riflessione, supera gli animali e tutti gli altri esseri di questo mondo nel pensiero, nella libertà, nella parola, nel lavoro, nel gioco, e in innumerevoli altre cose. Nell’animale la coscienza stabilisce un rapporto col mondo, ma non è in rapporto con sé stessa. Occorre possedere spirito per uscire da sé, ex-sistere, e quindi per ritornare di nuovo a sé: andando oltre se stessi è insieme un ritorno dell’uomo in se stesso. Secondo l’originale analisi fenomenologica propostaci da Martin Heidegger, l’essere dell’uomo, di un “io”, il quale, può dirsi “un rapporto che si rapporta a se stesso”. Grazie a questa autocoscienza, l’uomo sa di essere uomo, apprende se stesso come operante e attivo, come unità individuale, nel senso che si sente identico a sé e attua il suo essere senza mai rompere o mutare la sua unità. Il possesso di un’unità cosciente rende l’uomo protagonista di una progressiva liberazione dai determinismi, ereditati o acquisiti, attraverso la novità della conoscenza e della libertà. Così, l’incontro dell’uomo col reale prosegue fino alla presa di coscienza di sé dei propri atti. L’uomo non si limita a registrare passivamente quanto accade; intende e comprende. Un’altra frontiera si varca quando si passa dall’animale all’uomo. Per Tommaso d’Aquino l’uomo è il fine di tutto il generare; le creature inferiori all’uomo sono per lui e si dispongono al suo servizio. Poiché sintetizza in sé le proprietà di tutto l’universo, l’uomo è un microcosmo. Nella scala degli esseri, la gerarchia del vivente s’impone con evidenza progressiva: se la pianta denota una certa sensibilità, l’animale ne possiede un grado maggiore; più profonda è la sua “interiorità”. Il vertice di questa superiorità è raggiunto dall’uomo: la sua supremazia peculiare e lo sviluppo della sua originale coscienza si sottraggono a una classificazione puramente biologica. L’uomo si presenta come il grado supremo dell’evoluzione cosmica. Il mondo trova nel suo “essere per l’uomo” la sua dimensione propria, dato che solo l’azione dell’uomo lo completa. Qui tutto può trovare la sua forma e coerenza, il suo senso autentico. La coscienza della nostra incompletezza e imperfezione sollecita la necessità di superarci continuamente. Pascal dice “la grandezza dell’uomo sta in questo: che esso ha coscienza della propria miseria. Conoscere di essere miserabile è un segno di miseria ma anche un segno di grandezza”. Pur restando sensibilità, impulso animale, l’uomo può prendere coscienza di sé e della realtà. Vale la pena fare notare che destare l’io dal sonno di sé in cui stranamente cade è un fine dell’educazione. 19 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Il binominio io-mondo è correlativo: non basta dire che non esiste coscienza della totalità; occorre anche aggiungere che nessuna coscienza della totalità può darsi senza riferimento all’io. Senza me le cose che mi circondano non sanno neppure di esistere. Solo incontrandomi trovano la coscienza che a loro manca; così, giungono al loro significato. Se l’uomo fosse soltanto un prodotto biologico, egli non avrebbe una dignità inviolabile, ma sarebbe esposto alla manipolazione. Invece, l’apertura costitutiva all’orizzonte illimitato dell’essere, propria della persona, pone innanzi una misteriosa inattingibilità, che tutti devono rispettare nella sua trascendenza. Egli è l’unico essere dell’universo in grado di sollevare la domanda sul senso dell’esistenza propria e di ogni altra cosa, e quindi di orientare la materia e la vita al servizio del senso che egli ha riconosciuto. La personale comprensione del senso della vita varia col variare del proprio autocomprendersi. Ripresa in un accordo d’insieme. Kant dichiara che “l’uomo è la sola creatura che deve essere educata. A differenza dell’animale l’uomo ha bisogno della sua ragione perché non ha alcun istinto e deve da sé tracciare il piano della sua condotta. Poiché egli non è subito in grado di farlo necessita dell’aiuto altrui”. Poiché l’educazione è un’esigenza fondamentale e una proprietà peculiare degli esseri intelligenti e liberi, non è possibile comprenderla adeguatamente, se non ci si rende conto della dinamica che fa uomo l’uomo. Ciò significa che non riuscirà a penetrare la ricchezza del significato proprio dell’educazione soltanto richiamandoci alla nostra esperienza personale come luogo in cui intuire l’orientamento e il senso profondo della vita. 20 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Più si promuove una presa di coscienza attenta e conseguente del problema umano perché emerga una sua considerazione più esatta più si valorizza il compito dell'educazione come mezzo fondamentale del suo sviluppo. Senza l'educazione il bene personale e sociale della nostra umanità non si mantiene, ma è destinato a deperire. In sua assenza, chiunque prenderebbe soltanto nel limite della sua individuale esperienza e con il venir meno di quanto ha preso con lui, sparirebbe dal mondo e dalla storia anche la poca scienza e sapienza che gli fosse riuscito ad acquisire. In effetti l'educazione nella sua essenza più profonda è sempre in funzione del valore della persona come protagonista di cultura e civiltà per la medesima ragione ogni civiltà alla sua pedagogia o meglio le sue pedagogie. L'uomo è suscettibile di educazione, perché gli solo può giungere a governare a se stesso, e quindi diventare una persona responsabile. L'educazione è inerente a questa sua specifica peculiarità, grazie alla quale l'uomo è il sol o soggetto in grado di guidare un processo formativo che coinvolge l'integralità dei fattori concorrenti a costituire la sua umanità. L'uomo ha bisogno di ricevere educazione e di educare a sua volta. Educare vorrà dire svolgere, esplicitare, rendere efficienti tutte le funzioni, le possibilità, i valori della persona umana considerata nella sua unità fisico- psichicospirituale, agire per portarla alla sua pienezza, al compimento del suo fine costitutivo. Il compito dell'educazione non raggiunge il suo scopo se non quando rende l'uomo capace di esprimere tutta la propria umanità nella dinamica della sua attività. È innegabile che l'ambiente eserciti sulla vita di ogni persona molteplici influssi; la sua varia e continua influenza su di noi a questa importanza nel determinare anche il nostro destino. Tuttavia l'ambiente non è per noi una predeterminazione rigida piuttosto è un mezzo indispensabile per l'attuazione della personalità. Anche per l'uomo sicuramente il contesto ambientale ha una funzione modificatrice; ma le conseguenti trasformazioni sono accolte e riequilibrate dalla sua originale creatività. Mentre nell'animale l'impulso e la spinta ad agire risalgono all'ambiente, nell’uomo entra in gioco il fattore “libertà” cioè la realtà della possibilità come non-necessità. L'agire dell'animale può dirsi automatico; quello dell'uomo non è solamente tale perché ha in più la coscienza e la volontà del fine. Per la sua peculiare forma di conoscenza, l'uomo in qualche modo si appropria del mondo, si serve delle acquisizioni fatte, interviene modificando quanto lo circonda. L'azione umana è l'effetto conseguito portano l'evidente segno di una presenza singolare e privilegiata. Mentre l'animale, statico nel suo comportamento sensibile, ha delle reazioni motorie che mutano solo in funzione di uno scopo sempre identico, precisamente quello della risoluzione di un bisogno, senza progredire né porsi in una condizione è superiore a quella della sua esigenza momentanea e dello stimolo della 21 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 specie, l'uomo, invece, esprime una inesauribile volontà di indipendenza. Mai interamente sazio, tale volontà lo lancia verso un progresso incessante mai del tutto soddisfacente. A differenza dell'animale, l'uomo non si adatta a stare in un ambiente intoccabile, né si rassegna a muoversi semplicemente grazie alle stampelle degli istinti ereditati. Quando si osserva l'uomo in azione in vista della sua realizzazione si vedrà come gli sa di dover decidere personalmente l'orientamento fondamentale della sua vita e di non doverlo fare semplicemente affidandosi alla corrente degli istinti biologici, naturali, evoluzionistici questi infatti non sono in grado di gettare una luce soddisfacente sul senso della sua libertà davanti al destino. Gli istinti non sono in sé cattivi; in realtà, dipendono dalla direzione ideale che l’uomo imprime alla propria impostazione. Anche l’uomo mentre si forma non può evitare di conformarsi a tanti stimoli esterni: perfino i nostri concetti e il nostro ragionare sono segnati dalla dipendenza che lega l’intelligenza all’ambiente fisico e sociale. L’animale anche nel suo grado più alto manca di un salto qualitativo necessario per ottenere quanto invece l'uomo raggiunge con la sua intelligenza e libertà. Il punto è che la dimora dell'uomo non è affatto l'ambiente; neanche l'universo intero contiene il suo slancio. L'uomo si rivolge a una totalità aperta all'infinito come essere che interroga, pensa, configura, pianifica. Non si può pensare al mondo senza l’uomo e viceversa. Egli non può rimanere inerme davanti alla pressione delle varie e molteplici esigenze emergenti nel tempo, ma costruire la propria esistenza, dare un senso e una forma caratteristica alla propria realtà ordinandosi volutamente e coscientemente verso un fine prescelto. Perché le cose esistano non è necessario che qualcuno le sappia guardare. Non così, però, quando si tratta di un paesaggio. In questo caso vedere non è tanto vedere questo, quanto vedere come. Il paesaggio richiede lo sguardo di qualcuno che sappia vederlo e, vedendolo, apprezzi il suo ordine, quasi lo componga e gli dia un senso, facendolo rinascere in sé con una sua nuova prospettiva. Noi non creiamo il mondo, ma lo pensiamo: il pensiero porta la luce che permette di scorgere il valore effettivo di quanto esiste. Tra l’uomo e il mondo vi è un’interazione reciproca. La questione si presta spontaneamente a dilatarsi su un piano coinvolgente un aspetto decisivo dell'esistenza umana, cioè il suo progredire nella storia. Congiungendo le fila delle osservazioni fatte, si dovrà dire che l'uomo non vive semplicemente immerso è sprofondato in un ambiente chiuso e immodificabile che lo vincola e meccanicamente gli impone le proprie leggi ma è costitutivamente spalancato sul mondo. La parola mondo assume qui un significato umano, non indica la natura bruta, ma la realtà che il lavoro umanizza, la situazione che il linguaggio narra. Il mondo che si dà a noi è una realtà odologica cioè piena di strade nel senso di rapporti tesi a una meta così che ogni cosa sia verso un'altra ed è anche una realtà poetica, 22 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 cioè ricca di innumerevoli cose da comunicare. Certo il mondo è anche la realtà che ci interroga e sollecita la nostra azione: essa si da come scopo e oggetto dei nostri progetti. L'uomo rappresenta un sistema aperto, una soglia che permette una continua comunicazione tra interiorità ed esteriorità. L'uomo è nel mondo e il mondo è nell'uomo come un insieme strutturato di situazioni e compiti. Perciò, egli può fare esperienze sempre nuove e di nuovo genere. La nostra posizione davanti al mondo non è di pura reazione né di semplice consenso o di rassegnazione, ma di libertà e di trasformazione. Ciò fa dire a molti che l'uomo non è minacciato dalla natura, ma dall'uomo stesso. Soltanto l'uomo è soggetto di educazione perché pur non potendo dirsi Sufi gente a se stesso, in quanto bisognoso di molte cose, soprattutto degli altri uomini, è fatto in modo da potersi auto governare e quindi di venire il libero e responsabile. Le facoltà conoscitive e affettive della persona la sua natura sociale non rimangono inerti ma sono creatrici di valori capaci di esprimere una soggettività originale e di estenderne e la presenza a tutto l'universo. Spetta all'educazione portare alla luce il valore di tale dinamica e guidarne lo sviluppo peculiare. Ciò non avviene una volta per tutte, né sulla base di automatismi meccanici più o meno complicati: nessuna delle sue concrete espressioni culturali realizza pienamente l'uomo. Riconoscere l'altro in se stesso e per sé stesso, rispettare il suo essere, il suo poter essere, costituiscono la condizione e l'esigenza dell'educazione. Nello stesso tempo tutto ciò vale per ricordare come la realizzazione di sé non è un mero dato, un fatto empirico o materiale, indipendentemente dalla pratica della libertà, ma è un compito personale e sociale. Anche nel suo modo peculiare di diventare se stesso, l'uomo manifesta non soltanto un suo naturale bisogno, ma anche quella sua singolare spinta ad auto trascendersi che lo muove continuamente e lo porta sempre più avanti. La capacità di coscienza e di auto possesso nella libertà costituiscono una ricchezza peculiare per l'uomo, la condizione necessaria per essere educato, la dote che gli permette di educare e infine il motivo per cui solo all'uomo si rivolge l'atto educativo. L'uomo non può limitarsi a essere semplicemente impulsivo, istintivo e spontaneo, egli deve determinare se stesso inserendosi in una storia che parte da precedenti realizzazioni per costruirne delle altre; in lui l’intelligenza del presente si protende alla ricerca di un rinnovamento, per traguardarlo sul futuro e sul possibile. Nell'uomo, infatti, natura e cultura formano un binomio inscindibile, così che il naturale è sempre dentro un processo culturale coevo alla sua esistenza. Ciò spiega perché l'uomo è allo stesso tempo essenza ed esistenza, natura e progetto, determinazione e apertura. Come ogni in realtà profondamente vitale la polarità natura-cultura non può in alcun modo essere ridotta a un solo elemento dell'essere o un'unica dimensione dell'agire. Non si da sviluppo 23 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 veramente umano che non passi attraverso la scoperta della ragione e quindi della riflessione e della conseguente volontà libera. Infatti, lo sviluppo dell'uomo include contemporaneamente lo sviluppo della ragione, del senso morale, del senso della libertà e della responsabilità. Perchè possa realizzarsi uno sviluppo armonico della nostra umanità, non basta l'abitudine seriale degli istinti, ma occorre una vera e propria cura educativa rivolta a una natura propria e specifica che progredisce secondo un suo processo formativo e una problematicità peculiare. Solo una persona può educare un'altra persona. Grazie alla sua razionalità e libertà, la vita personale è educazione e autoeducazione. Parlare di sviluppo senza educazione non è sufficiente per promuovere l'avvenimento di una personalità capace di attivare come si deve le sue funzioni, inserire creativamente il suo protagonismo a società, partecipare ai valori della cultura e della civiltà elaborati nel corso della storia. Capitolo secondo CHIUSURE DELL’IDEOLOGIA E APERTURE DELLA METAFISICA La vita umana non si rivela come un’entità autosufficiente , un blocco chiuso su di sé, ma come una processualità formativa di sviluppo e di differenziazione che muove verso una destinazione. Come tale è aperta a possibilità ulteriori, il cui ultimo termine non è dato fissare in anticipo. Se nella vita quanto prevale è il movimento e non la stasi, la ricerca dell’ulteriore sull' esito già raggiunto, allora per il vivente presto è impossibile calcificarsi in una forma definitiva. La continua creatività di forme nuove è in un certo senso sinonimo di vita, mentre al morire corrispondono i processi della pietrificazione e della dissoluzione. Non è affatto realistico chiedere soluzioni facili per risolvere i numerosi conflitti che presenta l’educazione volta alla formazione della persona. Si 24 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 tratta di riflettere attentamente per trovare una modalità adeguata per riconoscere in ogni uomo la singolarità che gli spetta. Convincersi di poter sottoporre tutto il reale alla disciplina razionale dell’esattezza fa perdere una dimensione essenziale dell’esistenza. “L’uomo supera infinitamente l’uomo” cit. Pascal. Uno studio sulla natura essenziale e sul senso esistenziale della propria umanità è certo reso acutamente problematico per il fatto che qui l'interrogante è l'interrogato costituiscono lo stesso soggetto: l'uomo che ricerca il senso della sua umanità è interprete e interpretato, soggetto e oggetto di ermeneutica. La volontà di conoscere la propria umanità costituisce un forte invito a non vivisezionare l'unità concreta della persona, per classificarla in ordinate descrizioni dei processi biologici, psicologici oppure in chiare definizioni dei comportamenti sociali, ma chiede di scendere dentro le profondità ontologiche di un essere esperto a un continuo superamento di sé. La pretesa di capire tutto dell'uomo, purché gli oggetti di osservazione siano metodicamente piegati e catalogati, è una chimera. La riflessione critica su noi stessi non è mai in grado di comprenderci del tutto. Più l'uomo approfondisce la conoscenza di se, più è costretto ad andare oltre quanto le sue mani stringono, perché la sua interiorità si apre a un orizzonte ulteriore. La trascendenza dell'uomo rispetto a qualsiasi nozione adoperabile è un esigenza inerente in tutto ciò che fa, dice, pensa, vuole e desidera: mai l'uomo è pienamente soddisfatto dei traguardi raggiunti. L'esperienza a testa come nessuna determinazione e fisica spaziale riesce a esaurire l'intima essenza dell'uomo che, all'interno di queste coordinate, non può definirsi se non come indefinibile. Viviamo in un epoca di antropologia scientifica, non più mitologica, né soltanto filosofica; grazie a ciò l'uomo ha appreso su di sé molte conoscenze dapprima ignorate. Ogni giorno nuove ricerche asseriscono qualcosa in più su di lui, le molteplici "scienze dell'uomo" forniscono una conoscenza così ampia e dettagliata quale non si era mai raggiunta nel passato. Biologia, psicologia, sociologia e via dicendo, analizzano l'uomo variamente e secondo metodi specializzati. Una valutazione realistica dell'uomo non può prescindere dall'interazione esistente tra i suoi condizionamenti biologici e sui comportamenti psicologici e sociologici. Non possiamo ridurre la vita umana è l'insieme delle sue condizioni fisico-chimiche, senza con ciò perdere inevitabilmente di vista l'uomo nella sua concretezza. Così facendo, infatti, non si parlerà più di questo uomo quei suoi desideri e le sue paure, le sue gioie e le sue speranze, i suoi slanci affettivi, le sue intuizioni intelligenti, la sua volontà di vivere e la sua angoscia di morire, la sua aspirazione, più o meno Chiara, ha una salvezza possibile. Le innumerevoli risposte della scienza non riescono a colmare l'abisso di domanda di senso che dalla vita, dal lavoro, dalla sofferenza, dalla solitudine, dalla morte, sorge e risorge. La pedagogia neanche accettare lo scetticismo 25 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 dogmatico di chi pretende per sè una fedeltà scrupolosa alla metodologia delle scienze umane, solo perché nega a priori una risposta a tutte le domande sulla natura essenziale e sul destino esistenziale dell'uomo,giudicate, peraltro, prive di un senso intelligibile. Anche tale atto di scetticismo dichiarato, il restringe il problema dell'uomo dentro un residui sempre più ristretti di senso, sopporta ancora per sempre il peso di una certezza indiscussa e fondamentale. Delle scienze vogliono porsi come guida delle condotte pratiche dell'uomo, dovranno riconoscere che la libertà umana ultimamente è incomprensibile nei termini della pura biologia;essa, senza aiuto della fantasia, per ora neanche si lascia iscrivere nella tua accogliente teoria dell'evoluzione. In realtà, le scienze cercano quel che possono determinare, mentre alla pedagogia ultimamente interessa una sapienza capace di liberare il senso delle effettivo progredire della libertà fisica, psichica, spirituale dell'uomo nel suo sviluppo. di fronte alla tentazione di cedere la soggettività personale alla generalizzazione scientista, si può sempre osservare come, rispetto alle più attendibili descrizioni scientifiche dell'evoluzione biologica, la specie umana presenta una serie di comportamenti culturali, altrettante prove inequivocabili di un essere capace di scegliere liberamente, di un soggetto che non è possibile descrivere secondo un puro determinismo. Il tempo delle nostre scrupolose esperienze non riesce a spiegare tutta la vita, né tutto suo destino. Scrive Malraux nella sua biografia "ma l'uomo non arriva al fondo dell'uomo, non trova la sua immagine nello spazio delle cognizioni che acquisisce, trova un'immagine di se nelle domande che pone. Ed è possibile che nel campo del destino l'uomo valga più per l'approfondimento delle proprie domande, che per le risposte date". Con ciò il filosofo viennese mostra come il senso dell'umano sfugge alla logica scientifica. La pretesa di spiegare tutto l'uomo, di analizzare tutte le sue forze, giunge a u n irriducibile "non so che" in cui l'essenziale sembra nascondersi come un'estrema e inaccessibile profondità. Da una parte la scienza permette alla conoscenza una grande lucidità, dall'altra apre dei vuoti incolmabili; mette davanti all'impotenza dell'ineffabile, alla critica consapevolezza dei limiti, e quindi all'impossibilità di risolvere scientificamente il problema fondamentale del senso della vita. Nessuna scienza in grado di dire compiutamente chi è l'uomo, da dove viene e dove va. Senza escludere che molte scoperte sono possibili grazie allo studio dei rapporti tra cervello e mente. Dichiarare insensato un problema solo perché inverificabile con le misurazioni delle scienze esatte non è una conclusione scientifica, ma una decisione ideologica. Vietare le domande metafisiche e religiose sul destino in nome della scienza non significa attenersi alla ricerca scientifica, ma rifiutare pregiudizialmente una problematica che non si lascia ridurre a puro calcolo. Il problema del senso dell'umano non é risolvibile sul piano della pura ricerca scientifica; ma è irragionevole credere che la scienza costituisca la sola forma valida di sapere. Se è vero che non è possibile dare 26 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 alcuna parola definitiva sull'uomo al termine di un'analisi scientifica, e neppure alla fine di accurate introspezioni, è anche vero che non si può disconoscere il necessario e attuale bisogno di verità su noi stessi. Forse occorre ammettere che la verità può darsi in un incontro su sentieri diversi da quelli praticati dalle analisi dei nostri laboratori. L'impegno della ricerca induce ad accettare, non a sacrificare, una pluralità differenziata di forme conoscitive. Non è ragionevole imporsi di pensare che il progresso colmerà l'abisso portato allo scoperto dalla coscienza del problema umano. La credenza nella ricerca scientifica, come l'unica luce possibile applicabile alle domande della vita, sottrae al giudizio razionale. Karl Rahner spiega perché nonostante la grande quantità di scoperte sull'uomo, non siamo in grado di definirlo in maniera esatta punto dell'uomo è più sicuro dire che la "indefinibilità ritornante e riflettente su se stessa". L’uomo affonda le radici del suo enigma in un abisso che nessuna formula racchiude in un sistema di coordinate, entro il quale assegnargli un posto preciso. Affermare questa radicalità significa riferire la domanda di un fondamento e di un destino sostanziali per quanto costituisce il proprium della nostra esperienza umana. negare un'origine e uno sviluppo che disponga e muova al raggiungimento di un fine si può, ma al costo di una disintegrazione della vita come storia, per sostituirla con una incomprensibile cronaca di una congerie di cose che si succedono. contro le facili schematizzazioni di chi si illude di avere in mano il proprio maestro con cui dare la sua misura definitiva, vale sempre la cute e concisa osservazione di Paul Ricoeur: "quello che io sono e incommensurabile con quello che io so". in questo modo, il filosofo francese richiama l'attenzione verso una solida constatazione e quindi apre a un'intuizione filosofica descrittiva del nostro desiderio il limitato e della nostra finitezza: in noi esistenza ed essenza non riescono a sovrapporsi, a coincidere. L'uomo reale custodisce un mistero che poco si presta a qualsiasi definizione formale. Egli non coincide con quanto di lui si riesce a oggettivare e con quanto può essere studiato scientificamente. Quando la ricerca mette insieme tutte le sue analisi scientifiche, resta ancora qualcosa di sensato da dire, di cui le analisi non riescono a parlare, perché non sembrano in grado di giungere al nucleo stesso della nostra esistenza. Le definizioni da manuale, se interrogate a fondo, si rivelano frasi di circostanza, talvolta innegabilmente utili, ma mai esaustive. La delusione che accompagna ciascun provvisorio traguardo mostra chiaramente come ogni nostro singolo desiderio veli e sveli un altro desiderio, inestinguibile esigenza che ci spinge ad andare sempre più avanti. Il fatto che fin dall'inizio l'uomo sia orientato verso una profondità assoluta spiega bene da una parte perché il suo essere trascende la sua stessa capacità di conseguire obiettivi, dall'altra conferma quanto con il linguaggio asciutto della filosofia si può dire: il per sé (quello che il mio atto riesce a fare) non si pone mai in equazione con l' in sé (quello che io sono nella mia identità e singolarità 27 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 personali). rilievo critico vale anche per la classica e generalissima definizione di uomo quale animale razionale. Quando si accosta l'essere umano, si scopre che il riconoscimento della sua essenza chiede di essere sempre più profondamente precisato; ciò impone un costante ritorno della riflessione anche sulle definizioni classiche. Esse si devono sostanzialmente mantenere, ma non devono ripetersi in modo tale da impedire una progressiva profondità, capace di integrarle in senso relazionale, estetico, etico, e quindi pedagogico. Aristotele medesimo, del resto, non ignora che l'uomo è certo più della sola ragione e intelligenza. A differenza della prospettiva platonica, per cui le emozioni sono semplicemente irrazionali, non può non colpire come per Aristotele anche le emozioni siano compenetrate dalla ragione. In realtà, l'uomo deve essere ritrovato nel complesso dei fattori che effettivamente fanno la sua esistenza singolare. Egli è uno per sua costituzione, ma è anche immerso nei diversi gradi dell'essere. Il mistero, lo si dovrà più volte il ricordare, non è da intendere come un segreto non ancora rilevato, bensì come ciò che possiede una profondità inesauribile. Quando si parla di quanto fa sì che l'uomo sia uomo, è un errore voler ridurre l'ampiezza e la profondità del suo mistero a Termini minimi, al gioco sistematico delle nostre idee, poco o tanto sempre incomplete. Il paradosso intrinseco della nostra condizione costringe a prendere atto che l'uomo è soggetto e oggetto, spirito e natura, libertà e determinazione. L'uomo non si può definire unilateralmente, egli è sempre al di là del mondo stesso in cui vive è opera. Nella realtà, così come l'uomo la sperimenta, c'è un punto di fuga non del tutto imprigionabile nel tempo e nello spazio. È l'esperienza del mondo come segno. Per segno si intende qualcosa che sta per qualcosa d'altro, che indica qualcosa di diverso da sé stesso. Non si deve trascurare il fatto che il segno, poiché rimanda ad altro da sé, ha bisogno di essere interpretato, e quindi nel suo riferimento ad altro da sé, ha bisogno di essere interpretato, e quindi nel suo riferimento ad altro da sé può anche non essere compreso. Ci si esprime con più precisione introducendo il termine simbolo. Affermare che il nostro universo è simbolico significa considerare la realtà visibile partecipe di una realtà più elevata, più profonda, con la quale è stata una non convenzionale corrispondenza analogica. Cogliere come delle realtà immediatamente percettibili rendano in qualche modo presenti altre realtà, più nascoste, di un ordine valoriale più alto, è possibile sia sul piano argomentativo sia su quello intuitivo. Il simbolo raccoglie in sé antinomie fondamentali che la ragione raziocinante e il linguaggio abituale non sono in grado di spiegare del tutto. Contro il positivismo scettico, che riduce l'uomo ai dati scientificamente accessibili, la ragione si trova in rapporto a una realtà che infinitamente la supera, e quindi la pone in un costante rapporto di interrogazione, secondo un procedimento caratterizzato da una dialettica sui generis. tale dialettica 28 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 non è oggetto di prima evidenza né di calcolo, piuttosto di un originale presentimento che apre davanti a sé una vasta possibilità di ricerca, la cui fonte di alimentazione non sarà altro che l'esperienza umana vissuta integralmente. Se non si è disposti non sapere che non sia pura misurazione, per aprirsi alla libertà sorprendente del mistero, la conoscenza dell'uomo è destinata a cadere nel vuoto, perché gli enunciati che conferiscono un senso alla nostra vita sono coerenti con se stessi solo in un processo di auto superamento radicale. Il dominio della tecnica invade anche il campo dei comportamenti individuali e collettivi, generando conflitti sempre più gravi e irrisolvibili. In realtà, il punto di vista del razionalismo non è il solo, nel primo né il più comune, che si possa assumere sull'uomo e sul mondo. Non bisogna perdere la giusta fiducia nella ragione, nessun metodi di ricerca, nessun immanente criterio di verità; anzi, bisogna educare al coraggio critico di tale fiducia, perché non si può dire che la condotta umana sia spontaneamente razionale. L’ “Ideologia” totalitaria della “dea” Ragione, se coerentemente svolta, immette un fattore patogeno nelle fibre dell’organismo del nostro pensare personale e sociale, una sorta di agente capace di calcificarne le arterie fino a mummificare i tessuti più propri della vita personale. Accantonato il mistero dell'essere per fare spazio al controllo della pura e semplice fatalità, si restringe pericolosamente il concetto di verità e si chiude in un fraintendimento il valore dell'esperienza. d'altro canto, l'apporto che le osservazioni scientifiche danno anche allo studio della pedagogia deve considerarsi indiscutibile: non si comprende il processo di formazione di una personalità se signora il dinamismo delle disposizioni del soggetto che si forma (psicologia), oppure se non ci si cura delle condizioni ambientali in cui esso vive e interagisce (sociologia). A ciò bisognerebbe aggiungere anche ulteriori motivazioni riferibili ad altre discipline di natura e applicazione diverse, quali la biologia, la pediatria, la psichiatria, che interagiscono in un rapporto di reciproco vantaggio con le iniziative e le realizzazioni pedagogiche. Tuttavia, rigettare come "mitico" tutto ciò che non è scientifico tradisce una discutibile mentalità scientista, non idonea a comprendere il linguaggio del concreto le categorie dell'esperienza vissuta. La scienza dell'uomo si rivelano utili per meglio comprendere la nostra umanità solo se sanno salvaguardare una ragionevole consapevolezza dei limiti del loro metodi. Perché non esiste una scienza unica che comprenda in sé tutte le altre, riconoscere che le forme della conoscenza sono molteplici e non riducibili tra loro non significa cedere alle equivoco o al caos dell'anarchia, ma solo prendere atto della realtà. Accettare il principio che non si dà scienza se non del misurabile significa concludere che la matematica esaurisce tutto quanto vi ed intelligibile nella realtà. L'errore è evidente: il fatto stesso che una cosa esista mobilità profondamente l'interesse dell'intelligenza, benché sfugga alla matematica. In realtà, il metodo che appartiene alla matematica funziona bene 29 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 quando si tratta di numeri e di quantità; se lo si trasferisce al regno della qualità, della vita organica, e ancor più al campo della storia e della cultura, presto per della sua scientificità di precisa esattezza per diventare invenzione o, in ogni caso, opera di fantasia. Non si può fare dell'uomo un oggetto di studio e dimenticare la presa di coscienza della tradizione moderna secondo cui egli, in ogni rappresentazione oggettiva della realtà, è soggetto e quindi protagonista attivo. Come un errore porre l'uomo al di fuori dell'umanità, e altrettanto erroneo porre l'umanità al di fuori della vita e la vita al di fuori dell'universo. La conoscenza dell'uomo deve servirsi del contributo della Ragione teorico scientifica, di quella pratico-tecnica, della ragione poetico-espressiva propria dell'arte, della ragione speculativa propria della metafisica, non necessariamente di un determinato sistema metafisico ma pur sempre di una riflessione sul senso unico dell'essere. In particolare, non si può applicare una misurazione di puro calcolo quando si tratta di comprendere la realtà di una soggettività libera qual è l'uomo. Quando si parla dell'uomo, non si può dare alla parola oggettività l'identico significato che assume nelle scienze naturali. L'astrattezza delle formule che enunciano le leggi naturali non si rivela in grado di esaurire la concreta complessità della persona. Soprattutto non risolve la questione del senso della vita: giunti al bivio tra finalità e assurdità, ci lascia dubbiosi tra senso e non-senso. Non si discute la ragione ma il razionalismo. Chi avverte la necessità di conoscere il senso ultimo della sua vita di un uomo non tarda ad accorgersi degli effetti negativi che porta con sé l'ostinazione a stare sul puramente misurabile. In realtà la ragione non è in grado di risolvere adeguatamente il problema dal quale prende le mosse c'è qualcosa di più di quanto la ragione il lucida riesce a misurare. L'errore non consiste nell'uso rigoroso del calcolo, né nel mettere tra parentesi quanto non si lascia calcolare, ma non credere che quanto non è calcolabile semplicemente non esista. L'osservazione coincide con la presa di coscienza che sapere scientifico e tecnologico, per quanto scaltrito sia, non riesce a sviscerare il fenomeno umano nella sua complessità e varietà. Averlo creduto è dimostrato un errore. In alzare la scienza ha una nuova gnosi in grado di liberare l'uomo da ogni ombra è un mito debole, incapace di rispondere all'obiezione e di fatto la scienza può essere utilizzata tanto per distruggere l'uomo quanto per salvarlo. La scienza non è tutto; oltre la scienza di ancora i pensiero. L'uomo non si riduce i vari processi catalogati dallo studio. 30 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Oltre il dato empirico. La verità scientifica, come la verità strettamente controllabile, porta con sé i segni di un’autolimitazione. La scienza positiva, nei suoi metodi oggettivi, può tener conto soltanto degli aspetti oggettivamente verificabili della verità; non raggiunge, invece, tutto ciò che non è oggettivabile, so che non è sennò meno sensibile e universalmente verificabile. Ne consegue ovviamente che certi lati della realtà sfuggono per definizione alla ricerca scientifica. non la scienza decide del valore della vita, della dignità della persona, del significato della Libertà, nel fondamento ultimo dell'essere e del bene. Correggendo la prospettiva di studio rigidamente cognitiva, proprio di un approccio logico epistemico troppo angusto, Karl Jaspers ha potuto giustamente ribadire che la conoscenza scientifica del mondo non è una conoscenza scientifica dell'essere umano. Egli fa osservare come nell'esperienza del nostro essere vi è qualcosa cioè, indagato scientificamente, sarebbe perduto. L'uomo non si lascia ridurre a biologia, nella sua anima al risultato di un processo neurobiologico 31 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 regolato da un gruppo di cellule cerebrali. Altro raccogliere informazioni sulla vita, altro è comprendere la persona che vive e agisce. La profondità del nostro io non si lascio analizzare, osservare, sperimentare dal di fuori; essa resta una realtà sulla quale la scienza non riesce a fare una presa. Il problema riguarda la pedagogia soprattutto nel momento in cui, indagando circa sui principi portanti e la sua struttura formale, si fa chiaro con la riflessione sull'educazione trascorre da una descrizione storico-empirica o un'indagine storico-teoretica fune senza avente una genesi ideale e una logica di svolgimento. Se la pedagogia è anche ricerca dei presupposti e del criterio informatore del pensiero e dell'azione, volti a promuovere la persona nel suo effettivo valore, essa richiede di riflettere su quanto è fondamentale e non solo di enumerare e catalogare i dati oggettivi del problema. È letteralmente impossibile trattare argomenti fondamentali di pedagogia senza impegnare una determinata concezione della vita punto l'educatore deve rinunciare a misurare con la precisione del geometra il risultato dei suoi sforzi. La sua azione personale ha un'efficacia propria della disponibilità radicale al rischio della libertà. L'educazione si attua in un contesto fatto di interferenze continue, che sollecitano l'educatore un intervento non puramente osservativo, ma fondamentalmente etico, in cui si deve prendere posizione sulla natura e sul valore dell'uomo, e quindi pronunciarsi sul senso della sua esistenza è sul suo destino. Spiegare il bisogno tipico della nostra umanità di comprendere la realtà nella sua coerenza e nella sua assurdità, nella sua unità e nella sua complessità, servendosi solo del dato scientifico, rende manifesto come questo tipo di razionalità confina nell'irrazionale; pretendere di chiarire, organizzare e manipolare ogni cosa sotto il profilo del calcolo riduce anche l'uomo a un numero anonimo, e quindi a una cosa progettabile, a un oggetto adoperabile da altro da sé. Invece, essere persona significa essere più di cosa. La persona è precisamente l’assoluto di cui non ci si deve appropriare; si può solo aiutarla a rispondere di volta in volta al suo compito storico, e quindi a progettarsi come soggettività libera. L'indisponibilità al calcolo del nostro elemento più intimo ci sottrae all'arbitrio dell'auto disporci attraverso gli strumenti della scienza, non permette di definirsi come un mero prodotto di presupposti biologici sociali, ci difende dal essere assorbiti in un insieme anonimo che finisce per dissolvere tanto la libertà quanto la responsabilità. Perché ciò non accada, poco giova attribuire i primati di maggiore scientificità alle riflessioni psicologiche e pedagogiche che metodologicamente trascurano il senso di quanto è individuale, le variazioni soggettive, il ritmo personale. Insieme ho dovuto apprezzamento per il sicuri risultati offertici dalle scienze, occorre una ragionevole sorveglianza critica per non confondere lo scientifico con il pedagogico. Perché l'uomo è oggetto di tutte le scienze, il pedagogista, pur nel 32 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 rispetto di quanto compete alle scienze, dovrà contattare come tutte le antropologie empiricoscientifiche non sono in grado di cogliere pienamente il senso di quel essere unico e irripetibile qual è appunto l'uomo. la sua rilevanza assoluta sfugge la pluralità delle scienze, tanto diverse e sempre più complesse. Impostazione secondo cui ogni innovazione pedagogica deve essere una serie di prove di laboratorio, quasi si trattasse di nuovo tipo di medicinale, non è condivisibile incondizionatamente. Tale tendenza non considera adeguatamente il centro vivo e attivo della personalità, che è libertà. L'innovazione educativa è un aspetto della libertà e della responsabilità di chi ha il compito di educare. La persona umana, sostiene Gabriel Marcel, non si lascia afferrare con gli strumenti della scienza, perché essa non si pone come problema, ma come mistero. Se ci si accosta a essa mediante l’analisi scientifica, la si riduce a un lui, a oggetto o cosa. Per rispettare quello che veramente è, per trattarla da persona, occorre accostarsi a essa come a un tu; e questo avviene nell’interrogazione, nel dialogo, nell’amore. La ragione pedagogica ha carattere dialettico, perché dialettico è lo sviluppo della persona, dialettica è la storia, in quanto il suo svolgimento attraversa il contrasto, la lotta tra fattualità e possibilità, tra conservazione e cambiamento. Si capisce allora perché ogni scoperta pedagogica avvenga come un momento integrante di un processo in cui le parti sono insieme coinvolte in maniera inestricabile. Pensare in termini di dialettica aperta e non chiusa avvicina al modo con cui Romano Guardini parla di Gegensatz o opposizione polare, per esprimere l’irriducibilità della tensione di due poli che non accettano di risolversi in una sintesi superiore. La sua dialettica non si spiega come superamento della tensione inerente all'opposizione, ma come impossibilità di superarla per mezzo di una logica o calcolo necessitante. Essa sempre rinvia ed integrazioni sistematiche sempre più vaste, amplia un vero e proprio sviluppo del sapere, ma non è mai conchiusa. La semplicità della sintesi pedagogica è asintotica;infondo ripropone la dinamica che caratterizza la complessità di ogni organismo vivente. Gabriel Marcel parla con critica consapevolezza della realtà del nostro io,il quale lo considera come una presenza globale. è fondamentale che la pedagogia affermi in l'uomo come persona libera e non come appartenente ad altri, come soggetto e non oggetto. In questo modo, si esige che la libertà sia custodita come un valore essenziale del nostro più intimo essere. Una pedagogia che si basasse semplicemente sulle esperienze immediate personale presto mostrerebbe le sue gravi insufficienze. La pedagogia non deve disprezzare il sussidio delle scienze umane, scienze dell'uomo, scienze sociali e scienze del comportamento. Se non vuole perdersi in vaghi astrattismi, ha bisogno del 33 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 concorso di tutte le ricerche che hanno per oggetto l'uomo nella sua natura e azione storica. Tuttavia, decidere di fermare la riflessione pedagogica e i risultati delle dimostrazioni scientifiche è una scelta parziale, dovuta a una visuale angusta, che disegna un'immagine antropologica distorta è depauperata. Qualsiasi tipo di riduzionismo finisce per equivocare l'educazione, perché rende incapaci di riferimento all'uomo nel suo vivere concreto, e quindi nel suo farsi individuale e comunitario, culturale e civico: all'uomo nel suo educarsi. Alla prova dei fatti, qualunque sia il punto di vista adottato, non si riuscirà a produrre una definizione rigorosamente comprensiva dell'uomo. Molto induce a pensare che non giungeremo mai a conoscere tutte le leggi della nostra coscienza. Su questo punto, i risultati delle scienze, spesso positivamente generosi, anche quando suggeriscono magnifiche possibilità, non possono superare il carattere delle ipotesi e non sono in grado di imporsi come necessità. In questo senso si spiega perché tutti i tentativi di costruire una pedagogia, basandosi soltanto sui risultati delle varie scienze, non tardano a rivelarsi insufficienti. Si conviene che neanche la verità scientifica può considerarsi indipendente dalla situazione storica e culturale in cui la ricerca si esercita. In realtà, il progresso scientifico non procede accumulando verità assolute, ma attraverso percorsi segnati da fratture e ripensamenti. Anche per la scienza vale l'osservazione che tra sapere e realtà non sussiste un rapporto di semplice e oggettivo rispecchiamento, esiste piuttosto un nesso di reciproca implicazione: ogni realtà offro un suo peculiare sapere e ogni sapere manifesta una propria visione della realtà a partire da un determinato è sempre mutevole contesto di esperienze, conoscenze, necessità e finalità. In questo quadro, si presenta promettente la scelta di collocarsi sul piano ermeneutico, propria di chi non si limita a una pura teoria del soggetto in esame per affermarlo o per negarlo, ma intende curarsi anche del modo in cui un processo formativo può essere riconosciuto, per trarne, in seguito, semmai risultasse utile, dei principi prudenziali di educazione. Il nostro esistere a un'approfondita più grande dei nostri studi, della nostra professione, e sempre eccede tutto quello che pretende in qualche modo di definirci. Tra gli elementi filosofici di cui la pedagogia fa uso, il concetto di persona copre un ruolo centrale punto l'indole peculiare di questa fondamentale nozione non è sufficientemente descritta se ci si serve soltanto di categorie tra per dall'osservazione delle cose inanimate. Nella persona, infatti, si realizza una singolare immanenza, consistente nel fatto che solo essa è coscienza di sé, è un altrettanto singolare trascendenza, che permette alla libertà di aprirsi al valore o all'altra persona. Il compito marginale della pedagogia è rimarcare che l'educatore è tale se sollecita la responsabilità dell'educando a cercare e percorrere la sua via, se difende quest'ultimo da ogni pretesa invasiva di chiunque altro voglia sostituirlo scegliendo di percorrere i sentieri giusti della vita al suo posto. 34 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 L'inesauribile profondità della persona appare come un abisso inattingibile alla ricerca scientifica, un mistero conoscibile solo se esso stesso concede di rivelarsi. Il segreto più intimo dell'uomo promette una maggiore intelligibilità mediante l'interrogazione metafisica. Non tanto della forma dell'occultismo e dello spiritualismo, quanto come questione appartenente alla filosofia prima, intesa non come dialettica astratta, ma come affermazione di una ragione fondata sulle evidenze originarie. La metafisica non si lascia contraddire da chi niente sta per conoscerla. chi la nega deve mostrare di conoscere veramente il suo non senso e di aver tentato seriamente di superarne i limiti. L'uomo buone spiegazioni razionali, se non le trova all'orizzonte dell'esperienza sensibile, allora, anche senza volerlo, fa della metafisica, cioè inizia la sua esplorazione su quanto è al di là della scienza positiva. Contro la prevenuta ed esiziale antimetafisicità diffusa nel nostro tempo, non si deve pensare che il metafisico stia in un mondo inesistente, egli vuole, penetrare la realtà con più acutezza di chi si limita a una semplice descrizione. Il metafisico non fugge il mondo, ma al contrario vuole comprenderlo fino alla scoperta della sua vera norma. In questo senso” l'al di là” della metafisica non designa una realtà contraddittoria rispetto a quanto l'osservazione scientifica può controllare definire, il suo apporto non è quello di supplire all'ignoranza scientifica, ma di spiegare secondo una forma diversa di studio la complessità e la finalità degli stessi processi scientifici. Vedere l’intero. Trattandosi dell'uomo, occorre imparare a vedere più in profondità rispetto al campo visivo delle sole esperienze misurabili, e quindi vincere ogni segreta o esplicita avversione contro quanto eccede il mondo fenomenico. Non basta rispecchiare un aspetto importante dell'uomo per pretendere di coniare un nuovo paradigma antropologico. Il fatto che si parli di nucleo non deve costituire un pretesto per immaginare l'uomo diviso in parti da accostare. In realtà il nucleo al quale si riferisce è piuttosto il fattore che fa l'uomo uomo. Quindi, nucleo non significa un elemento diviso dagli altri, ma il motivo unitario della nostra vita personale. Bisogna evitare sia il materialismo grossolano, primitivo, che riduce l'attenzione educativa al semplice soddisfacimento dei nostri bisogni corporali, sia lo spiritualismo ingenuo, che fissa l'educazione in una pura trasmissione di idee e norme ideali. È necessario contestare tutte le visioni antropologiche che scendono la persona in settori incompatibili, da una parte la vita serena e pura della ragione, dall'altra il ribollimento spregevole dell'affettività. L'uomo non è affatto un 35 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 osservatore passivo, in grado di isolarsi dalla realtà, di giudicare a una distanza indifferente il proprio oggetto per dedicarsi a una scienza inconfutabile. Qualsiasi dualismo che separa rigidamente l'uomo dal suo ruolo minaccia gravemente il suo peculiare equilibrio. Karl Rahner scrive: “corpo e anima dell’uomo non sono affatto due realtà autonome, accoppiate tra loro solo in un secondo tempo; sono invece due momenti dello stesso unico uomo, due componenti che non possono venir ricondotte una all’altra. Sono due costitutivi metafisici del medesimo essere umano”. L'educatore e tale se trova il modo di coinvolgere la persona in un esperienza di unità come un protagonista che assume se stesso nella totalità. Allo scopo, egli dovrà concentrarsi con cura sull'elemento che costituisce l'intero e l'uno dell'esistenza, e quindi sorvegliare, per non distrarsi nei mille particolari della composita realtà umana. Da qui l'opportunità di riconsiderare la tradizione metafisica; infatti, è nella profondità del suo rapporto con l'essere che l'uomo sperimenta la sua apertura all'infinito e la sua unità personale. Nel contempo, io "mi rendo competente sull'essere, osservando quel che è l'essere in me stesso". L'intero, visto dal pedagogista, non è solo un'unità di funzionamento, un'addizione di profili molteplici, con un risultato che solo soggettivamente costituisce una totalità, ma è una totalità preliminare da rispettare e aiutare a esplicitarsi. solo che attinge a questo livello di intelligenza conosce la forma intuitiva e il senso dell'azione educativa, senza restare paralizzato nell'incertezza scettica. Conta, però, rimarcare che vedere l'intero non è un esito raggiunto da chi sorvola sulle particolarità, bensì è il riconoscimento di una unità genetica e aperta a tutto quanto veramente umano. Poiché educare significa volere il perfezionamento dell'uomo in tutte le dimensioni della sua esistenza, non è tra gli ultimi doveri di chi educa promuovere una tendenziale unità tra compito professionale e persona. Se si perde di vista il carattere integrale esigito dalla formazione dell'uomo, si fa forte la tentazione di ridurre la complessa avventure educativa al fornire istruzioni e tecniche strumentali alle varie urgenze professionali. Allora, l'orizzonte proprio dell'educazione cambia, per far luogo a preoccupazioni di carattere settoriale: il cardine dell'interesse non è tanto la formazione della persona, ma il potenziamento di procedure addestrative di segno tecnico-professionale. L'educazione finisce per occupare il ruolo di guidare la persona a individuare alcuni obiettivi vantaggiosi insieme e problemi da affrontare, e quindi selezionare i mezzi idonei per risolvere, nella maniera più efficace possibile, la questione che momentaneamente è avvertita più interessante. Il rapporto educativo trova la sua giustificazione in un contenuto di senso capace di accogliere unitariamente la vita dell'educatore e dell'educando. la pensione di chi educa non consente 36 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 all'astrattismo; quando guarda in un punto, tiene conto di tutto il resto, nella consapevolezza che solo così il punto guardato si proporziona veramente. Se la formazione della persona nella complessità dei suoi aspetti è lo scopo peculiare dell'educazione, allora si deve considerare l'uomo secondo tutta la verità della sua soggettività spirituale e corporale, e quindi anche nella totalità delle sue potenzialità ancora da realizzare, cioè nel suo farsi persona. La rinuncia un orizzonte di totalità spedisce la profondità della nostra ragione e contraddice la natura propria dei nostri più originali desideri che mirano alla realizzazione della persona. Nel desiderio dell'uomo non c'è solo una tensione verso obiettivi limitarti, ma agisce anche un'apertura al tutto come espressione di una sua esigenza fondamentale. L'intero non è l'antipodo, ma al polo sostituibile della vita personale. L'esplicita apertura alla totalità segnala l’atteggiamento adeguato a garantire l'educazione dal non ridursi semplicemente a un percorso abilitante allo svolgimento di un ruolo particolare. Nel frazionamento introdotto dalla specializzazione dei saperi, occorre salvare uno sguardo non diviso. Al riguardo, l'educatore dovrà meno preoccuparsi di insegnare nuove nozioni e sempre più integrare quanto altrimenti resterebbe abbandonato alla discontinuità e al contrasto. Se il pericolo del passato era che gli uomini diventassero schiavi, il pericolo del futuro è che gli uomini possano diventare robots. Se l'educazione attende una soluzione comprensiva di tutti i fattori e di tutte le correlazioni che incrementano lo sviluppo formativo della persona, allora il problema educativo abbraccia l'assunzione di un orizzonte olistico. Tale orizzonte non permette di generalizzare certi aspetti dell'uomo, magari giusti ma incompleti; chiede piuttosto di non moltiplicare le alternative tra diversi momenti talvolta contrastanti, che, però, a uno sguardo più attento sulla vita e sul suo sviluppo storico, si rivelano complementari. l'uomo che si forma è sempre tutto l'uomo nella sua indissociabile totalità, una simultaneità di molteplici elementi. Perciò l'educazione si rivolge all'uomo totale, non come oggetto, ma come persona, non all'uno o all'altro aspetto, ma l'uomo secondo l'intera estensione dei suoi postulati più intimi, espressivi della sua profondità personale. Luigi Giussani scrive sull'educazione: "educazione significa lo sviluppo di tutte le strutture di un individuo fino alla loro realizzazione integrale, e nello stesso tempo l'affermazione di tutte le possibilità di connessione attive di quelle strutture con tutta la realtà". La meta del processo educativo: la realtà, intesa come fine ultimo entro il quale comprendere tutte le tappe intermedie, le stesse che, prese isolatamente, non sarebbero in grado di rendere ragione del fenomeno. Poiché la realtà condiziona l'educazione "dalle origini e la domina come fine", coerentemente Giussani afferma: "Qualunque pedagogia, che conservi un minimo di lealtà con l'evidenza, deve riconoscere e in qualche modo attendere a questa realtà". Nello svolgere il significato della definizione, egli poi attira l'attenzione sull'aggettivo "totale" e rivela la duplice 37 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 necessità dell'educazione come "apertura a tutta la realtà" e come sviluppo di tutta la persona. La ragione è apertura alla totalità, e la totalità ne è il correlato; non nel senso quantitativo, di somma di tutte le cose, ma perché è essenzialmente aperta a tutto, proporzionata a tutto comprendere. Perché una proposta educativa sia tale, deve rivolgersi alle essenziali caratteristiche dell'umano, quali la ragione e la libertà. Se una proposta non è in grado di spalancare la ragione e mobilitare la libertà, a rigore può non considerarsi una proposta educativa. L'allenamento esclusivo di alcune nostre funzioni, indipendentemente dalla totalità della nostra soggettività, non rende in ragione di cosa sia l'educazione. Essa coltiva con decisione e sapienza uno sguardo aperto sulla totalità del reale, per cogliere non soltanto i nodi problematici, ma anche la straordinaria è positiva ricchezza di quanto accade. Non si tratta di eliminare la specializzazione, ma di evitare di credere che essa sia in grado di sostituire l'attenzione all'integralità della persona propria dell'educare. Contro i vari riduttivismi degli approcci unilaterali, la comprensività nel riflettere la vita secondo la sua totalità, unitarietà e integralità delle dimensioni personali, caratterizza il pensiero pedagogico nelle sue espressioni più geniali. Non è nuova l'intuizione che anche il bambino deve essere consapevolmente educato, secondo una modalità integrale è operata in modo da costituire il primo momento ciclico dell'educazione dell'uomo. Non bisogna vedere il bambino come un settore cronologico dell'uomo, come tale destinato a essere superato, ma con la integrale base infantile dell'umanità di ciascun uomo punto giusto non confondere il bambino con un uomo in piccolo, ricco fin dalla nascita di connotazioni umane. Pertanto è conveniente che anche nel bambino si parli di educazione dell'uomo. Infatti, l'educazione è sempre dell'uomo in ciascuna sua età; è sviante che si parli di educazione di una età o di un momento o di un aspetto dell'uomo stesso. Altrettanto decisivo è non perdere il carattere unitario del essere umano. L'uomo non è un fattore biologico più un fattore culturale, più un fattore morale, io un fattore religioso; è, invece, una sintesi irriducibile e non scomponibile: sintesi vissuta, pensante e operante. Poiché l'uomo è interamente presente in ciascuna delle sue parti, chi educa non può non rivolgersi alla persona nella sua interezza. Ciò non significa che non si debba tener conto dei caratteri di ciascuna età o meno ancora fare confusione fra i periodi evolutivi, introducendo anticipazioni o posticipazioni nella proposta educativa. Insomma, chi educa deve considerare la realizzazione dell'uomo carattere integrale, cioè non solamente nel suo aspetto intellettuale, fisico o economico, ma nello sviluppo dell'intera personalità, valorizzandone il ripetibile unicità e aprendola a tutta la comunità umana. Il valore educativo di un gesto sta nella misura in cui esso si connette con il tutto. Perciò l'uomo non deve considerarsi unicamente nella sua interiorità personale, ma nella totalità del suo essere umano. 38 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 L'educazione deve comunicare un'ipotesi sintetica, capace di introdurre l'uomo nella vita, coerentemente con suo bisogno di verità e libertà. Perciò, la proposta educativa deve farsi attenta soprattutto i fattori costitutivi e originali dell'uomo in quanto uomo e quindi all'unità della sua persona. La sua significatività si coglie se si ha uno sguardo interpretativo unitario, ossia una visione di insieme, capace però di dare ragione del concreto particolare cui si riferisce. L'interesse che mantiene unito il processo educativo, pur nel suo non del tutto prevedibile ritmo di sviluppo, s'ispira sempre a una volontà di totalità. Unità e totalità dinamica della persona. L’educazione, come azione mirata alla formazione della persona, è tale perché promuove una risposta alle nostre esigenze più proprie; per esempio, l'espressiva, la logica, economica, la morale, la religiosa. Esse sono distinte ma nel soggetto non si sviluppano separatamente, bensì nella simultaneità, condizionandosi a vicenda nell'interferenza reciproca. l'educazione non si limita a sviluppare soltanto la ragione, né unicamente la volontà, ma, rivolgendosi all'uomo nella sua interezza, promuove lo sviluppo delle facoltà dell'ammirazione, dell'intuizione, certo della teoria e del pensare rigoroso in vista del formarsi di un giudizio personale. Stabilire che l'educazione non è un assemblaggio di parti già perfezionate in ambiti settoriali, ma è un processo organico, unitario, uno sviluppo perfettivo dell'uomo considerato nell'unità composita di tutti i suoi fattori, è un esigenza inerente alla considerazione dell'educando nell'unità e identità del suo io. Ciò richiede lo sforzo continuo di risalire oltre il momento derivato dell'analisi, per raggiungere l'intelligenza unitaria dell'intero punto si sa che ogni funzione è un rapporto con l'organismo, solo la totalità di un corpo segna il valore di un particolare membro, ed è così che il particolare assurge a dignità di 39 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 funzione. Nel mio essere posso distinguere il sentire, il volere, il pensare, sono pur sempre io che sento, io che voglio, io che penso. E' la persona che, con intelligenza e volontà, vive e deve essere educata. La sua condotta, infine, risulta da tutta la sua personalità, e la sua affettività vi è interessata quanto la sua intelligenza. Ciò non significa che ciascuna facoltà non possa essere caratterizzata con propri elementi. L'educazione non è opera di immaginazione, ma luce che si offre alla ragione, cioè alla capacità di riconoscere il vero. Dell'arte stessa di educare, il pedagogista può imparare non tanto a creare un senso, quanto a portarlo da un una latenza inespressa, da una chiusura oscura, all'autenticità e all'apertura. Ciò esige una posizione morale capace di sostenere il desiderio di mettersi obiettivamente a guardare le cose e ricomporre insieme il reale senza prevaricare con alcun pregiudizio. Siccome non si tratta di un lavoro fatto una volta per tutte, è normale che si diano pedagogia marcatamente distinte e formulate in modo diverso, a seconda della tradizione culturale di chi le elabora, con diversi presupposti terminologici e filosofici e situazioni concrete a cui la pedagogia tenta di dare il suo contributo. Lo sviluppo perfettivo proprio della formazione della persona, cui mira l'educazione, non può prescindere dalla crescita naturale, e dal fatto che essa gode di una sua innegabile spontaneità: sicuramente, una notevole parte della nostra evoluzione fisico psichica può avvenire senza interventi coscienti da parte di altri uomini. Ma anche tale sviluppo pone allo studioso di pedagogia il problema della comprensione teorica. Il centro dell'educazione e della pedagogia, infatti, è la persona concepita nella completezza delle sue strutture fisiche, intellettuali, morali e spirituali. La riflessione pedagogica sullo sviluppo perfettivo dell'uomo non può contentarsi di sovrapporre o di coordinare i risultati delle diverse scienze. Essa deve tener conto delle loro acquisizioni e farne materia di riflessione, ma alla fine sa di doversi misurare non tanto a livello dei meccanismi parziali, ma di un essere considerato nella sua totalità. Il pedagogista sta bene che senza un osservazione scientifica accurata il suo discorso mancherebbe della concretezza e della positività richieste dal rigore dello studio, ma egli deve pure collegare in un quadro sintetico ogni riferimento al senso della vita derivato dalle scienze sperimentali. Alle scienze umane si concederà volentieri una validità funzionale, ma è compito della riflessione pedagogica dare un'indicazione direttiva all'educazione. L'insistenza sulla necessità di una visione unitaria e organica dell'atto educativo porta a riconsiderare il tema della persona. Il concetto di persona, alla base degli ideali moderni di libertà, democrazia, solidarietà, dignità umana, partecipazione politica e responsabilità economica, assume anche in pedagogia un ruolo 40 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 chiave. Il problema della persona, scrive Alberto Granese, si caratterizza come il problema pedagogico per eccellenza e anche il problema filosofico per eccellenza. Luigi Stefanini dichiara che l'educazione tocca l'ideale della concretezza quando raggiunge la concretezza personale. L'educatore deve sempre tener conto tale primato, oltre qualsiasi determinismo e considerazione sentimentale; solo così egli ha cura che l'educando realizzi la propria umanità nella sua concreta situazione, senza asservimenti di sorta. Il pedagogista guarda all'unità totalità dinamica della persona; non a una sua parte, fosse anche la più eccelsa, ma al tutto nella sua completezza. Unità "dinamica", perché considerata come totalità ancora incompiuta, come unità di prospettiva, posta com'è nel contesto di uno sviluppo mai concluso, non esauriente il processo educativo. In effetti, l'unità della persona, la cui ricchezza si rifrange in una varietà di disposizioni specifiche, eh sempre anche costante ricerca della sua integralità, nel concreto, ha bisogno di essere continuamente ricomposta. L'unità naturale e culturale, che costituisce l'orizzonte della formazione, può prospettarsi come il risultato di una storia aperta alla novità. Nessun atto educativo è fine a se stesso, esso può dirsi tale solo come un aspetto e in funzione dell'unità di corpo e anima, di cuore e di coscienza, di intelletto è volontà, e quindi della situazione globale in cui la persona vive. Il cardine della riflessione pedagogica non può che essere l'unica di cui facciamo esperienza, come realtà dinamica e differenziata nel suo interno da molteplici livelli. La continuità del nostro sviluppo è spesso interrotta da brusche mutazioni. Non di obiezioni, ma della condizione storica in cui avviene la nostra crescita. Quanto si intende rimarcare è che l'educazione possiede per sua natura una dimensione di globalità, perciò, l'educatore non può limitarsi a dare il suo pezzetto d'istruzione. Un educatore che non forma, deforma. Una scelta educativa non è mai indifferente e irrilevante; da essa può dipendere l'ascesa o il tramonto di una persona o di una società. Non esiste neutralità di sorta in educazione, anche il non far nulla, in realtà, equivale a un bloccare, a un produrre una stasi, cui inevitabilmente segue un'involuzione. I rilievi fatti vorrebbero servire sia per segnalare l'insufficienza di una prassi educativa riduttivamente concentrata nella coltivazione di qualche aspetto o abilità dell'educando, sia per rimarcare che la teoria pedagogica, per orientare e accompagnare il formarsi della persona, studia i singoli aspetti fisici, psichici, rituali, sociali, religiosi, dell'uomo nella loro integralità e dinamicità. Chi pone al centro della sua riflessione la formazione dell'essere personale non studia affatto una parte del tutto, ma un vissuto nel tutto. Realismo pedagogico. 41 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Secondo Aldo Agazzi, le note autentiche dell’educazione, “richieste dalla deontologia educativa”, “possono essere così enumerate: integralità, integrazione, armonia, gerarchia, simultaneità”. L’educazione deve essere integrale, nel senso che deve volgersi a tutti gli aspetti costitutivi e dinamici del soggetto; - Integrata, cioè sempre coinvolgente l’intera personalità, anche quando si specifica in uno dei suoi aspetti, ad esempio quello intellettuale, fisico, sociale ecc. - Armonica, e quindi secondo giusti equilibri di sviluppo e di esercizio, vigile nei confronti di prevalenze e vantaggio di certi aspetti o d’insufficienze a scapito di certi altri; - Gerarchica, nel senso che deve valorizzare quanto è umanamente più elevato rispetto a quanto lo è meno: ad esempio l’etico ha più valore sull’intellettuale, lo spirituale del fisico ecc. - Simultanea, vale a dire diretta contemporaneamente a tutti i vari aspetti della vita dell’educando, in ogni sua età. Anche se non tutto si riesce a conoscere, occorre in ogni caso tendere alla completezza, perché l’uomo è un’unità ottenuta con un’integrazione di elementi tutti diversi, ma ciascuno necessario alla somma. Adottare questa prospettiva significa giudicare equivoco il proposito di dedicare l'educazione in una determinata età ai sensi, in quella successiva all'immaginazione, in seguito all'intelligenza, poi alla moralità e via dicendo. Se l'educazione abbraccia l'intero orizzonte della personalità, essa non si attua per periodi successivi e da funzione a funzione. Tuttavia, ciò non esclude che essa sia progressiva, soprattutto nel senso che l'educatore deve sapersi adattare ai caratteri presentati dalla personalità dell'educando, considerato nel suo contesto di sviluppo in ciascuna fase dell'età evolutiva. E' una necessità propria dell'educazione sciogliere i problemi da una sospensione astratta, per valutarli nell'unità della loro effettiva concretezza. Quanto più importa è imparare un atteggiamento che chiamerei realismo pedagogico, per evocare l'atteggiamento mentale di chiaroveggenza verso la realtà, che si deve saper riconoscere per ciò che è, quale essa è. Questa disposizione guida la volontà ad abbracciare la vita umana nel suo insieme, compresi la precarietà e il bisogno. Si tratta di rispettare l'uomo nella sua estrema complessità. Per questa ragione, le comunità umane esigono relazioni non solo politiche e sociali, ma anche personali. La divisa della prudenza, che suppone una giusta valutazione quanto è giusto decidere delle proprie circostanze concrete della vita, può costituire un principio orientativo coerente con la consapevolezza propria del realismo costruttivo dell'educatore, risoluto a non disperdere il suo compito in una frammentarietà di problemi indipendenti dal rinvenire una sintetica visione esplicativa. Non bisogna dimenticare che la cautela è la modalità dell'agire. 42 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 La condizione efficace per poter realizzare la nostra umanità secondo il suo autentico destino è l'impegno con la vita intera, nella quale tutto va compreso: amore, studio, politica, denaro ecc. L'educazione deve disporsi in modo da comprendere tutto, non solo con un'intenzione implicita, ma sul piano stesso della manifestazione e dell'azione. Deve accingersi a integrare nell'unità della coscienza anche quelle componenti dolorose della nostra condizione quale per esempio la malattia e l'insuccesso. Le innumerevoli azioni che costituiscono la trama dell'educazione sono sempre nel segno della speranza di conseguire una meta. Non attendere alle esigenze dello scopo che occorre perseguire, non lasciare che esso guadagni tutto lo spazio di cui ha bisogno, sarebbe una grave insipienza educativa, essa farebbe perdere all'educazione l'organicità che le appartiene. Come l'educazione non deve essere un bene da fruire riservato a un'elite, a un'aristocrazia intellettuale o economica della società, ma un elemento essenziale che appartiene alla dimensione ontologica dell'uomo, così essa deve anche estendersi a tutte le manifestazioni proprie dell'umano, a tutto ciò che è intima connessione con l'esistenza dell'uomo. La vita stessa e il campo dell'educazione. L'ascesi che l'educazione richiede interessa tutta la persona e non deve confondersi con una delle forme di allenamento parziale in vista di un exploit, di un record, sebbene siano noto quanto al riguardo sia intenso il rigore ascetico dell'esercizio. Al riconoscimento della vasta capienza della pedagogia corrisponde l'elasticità e molteplicità del metodo di lavoro nella ricerca e nella comprensione dell'unità interiore che legga insieme la varietà nei suoi singoli aspetti. Tuttavia, il punto di vista della pedagogia verrebbe equivocato, se dall'esigenza di totalità ed al conseguente dovere di tendervi si deducesse che il pedagogista pretende di conoscere l'intera realtà. Osservare e riflettere sul fenomeno educativo dispone più facilmente a comprendere che i casi della vita non possono comprendere tutta la vita, né permettono su di essa giudizi assoluti. Sarebbe un falso giudizio definire vita il segmento di destino misurato indipendentemente dalla totalità del nessi che l'uniscono al suo reale compiersi, cioè al fine che le dà il suo valore. Anche gli enunciati pedagogici non riescono ad assumere la pienezza del reale. Nessun concetto riesce a dominare pienamente il problema pedagogico. Un altro equivoco potrebbe darsi nel momento in cui si chiede al pedagogista di distribuire la sua attenzione sugli innumerevoli elementi dell'intero pedagogico: impossibile abbracciare in una sola volta troppe cose, perché, se così avvenisse, la conoscenza che se ne avrebbe sarebbe superficiale e generica. Se la ragione specifica la natura umana, allora il senso della vita dell'uomo riguarda non solo la sua attività istintiva, ma anche quella razionale, cioè quanto muove il suo interesse, è la verità dell'essere. Forse è questo il motivo principale per cui chi cerca veramente la verità può non 43 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 dubitare di essa, ma soltanto delle proprie e dimostrazioni del vero. La ricerca dell'uomo, infatti, è tensione mai del tutto compiuta, positiva, ma incompleta nel risultati, perché provvisoria rispetto al definitivo e assoluto cui aspira. Solo l'assoluto può considerarsi l'ultima struttura di riferimento e quindi di funzionalità dell'uomo. L'assoluto è tale perché ha in se la sua ragione di essere, a differenza del relativo, che non può evitare di chiedere all'assoluto la sua ragione d'essere formale, efficiente e finale. Non si possiede la verità come cosa raggiunta, piuttosto come una strada da percorrere per arrivarci punto la nostra conoscenza, anche quando attinge con certezza a una verità obiettiva, non ne esprime a fondo che qualche aspetto. L'azione dell'uomo è sempre nel mondo, la stessa conoscenza della propria interiorità spirituale si raggiunge congiuntamente alla conoscenza del mondo. Impegnare la propria umanità per una società migliore, partecipare alla trasformazione del mondo, conduce anche a una progressiva umanizzazione di sé, a una crescente e più intensa autocoscienza, e quindi ha una più radicale responsabilità davanti alla storia di tutti. Se questo è il metodo adeguato per studiare l'uomo in prospettiva pedagogica, ne consegue che, senza un impianto ideale ricco di uno sguardo positivo, di un'ipotesi capace di abbracciare interamente l'esistenza, l'uomo non scopre se stesso come la sintesi di molteplici significazioni in un senso unitario. La pedagogia molto può contribuire a ricordare che la persona deve essere considerata nella sua unità integrale, non atomizzata, e quindi saputa guardare come una totalità dell'intero corso della sua esistenza, contro divisioni e opposizioni preconcette. L'esigenza si avverte più vivamente all'inizio della vita, perché l'inizio richiama il tutto con più insistenza; in realtà è vera sempre. Se si guarda alla singola persona, occorre preoccuparsi della formazione della sua intelligenza, senza trascurare la crescita della sua libertà e della sua capacità di amare. Forse più delle altre scienze umane, la pedagogia può valorizzare il metodo denominato da Blondel "dell'implicazione e dell'esplicitazione", e così da lui chiarito: "Implicare non significa inventare, dedurre, significa piuttosto scoprire ciò che è già presente, ma non osservato, non ancora conosciuto". Bisogna distinguere, ma non separare, so che nel concreto della realtà storica si intreccia e concresce unitariamente. 44 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Paideia come paradigma. A fondamento dell’azione educativa e della ricerca pedagogica sussiste la consapevolezza del rapporto del particolare col tutto di cui è espressione. Tale riconoscimento porta con sé la volontà di conseguire l'integrazione di tutti gli elementi necessari perché l'uomo realizzi la sua umanità. Il discorso pedagogico non si rassegna alla pura evidenza logica, perché fa parte della sua natura mirare alla persuasione esistenziale. Nella volontà di accogliere è valorizzare l'uomo in tutta la sua ricchezza e complessità, può rivivere perfezionarsi l'idea classica di Paideia, come formazione armonica dell'intera personalità umana allo scopo di renderla libera e felice. Questa esigenza non è solo dei Greci, si tratta di aiutare l'uomo a diventare padrone di sé, e quindi salvarlo dallo squilibrato furore delle sue passioni, dallo scontrarsi degli interessi egoistici, facendo leva sulla sua vocazione alla razionalità. La Paideia, abbraccia sia l'esercizio e l'impegno di tutte le facoltà di ciascun individuo sia la realtà e i valori cui egli si apre, perché ritenuti idonei all'educazione o formazione di un uomo libero. La virtù che si deve perseguire richiede l'acquisizione di una certa nobiltà, perché l'uomo sia armonico ed equilibrato. Allo scopo è necessario un austera autodisciplina che comandi e sorvegli la "giusta misura, risultato di una esperienza in cui contemporaneamente si deve dare prova di prudenza e di coraggio, di semplicità, di sincerità, e armonia". Marrou sottolinea che "la pedagogia classica s'interessa all'uomo in sé, non al tecnico attrezzato per un compito particolare". Il suo scopo dichiarato è quello di aiutare l'uomo a progettare la sua esistenza secondo un ideale capace di conferirle un senso completo, in modo tale da dargli anche il coraggio di vivere questo progetto. In una prospettiva unitaria che non scinda corpo, psiche, ragione, ogni attività, anche la più umile, se è volta al miglioramento dell'uomo, può essere educazione o Paideia. La paideia è educazione alla liberazione personale del male, e quindi a fare il bene e a fare bene quel che si fa. Perché l'uomo si disponga al bene in modo critico e consapevole, il suo giudizio abbraccerà il problema del come fare, del perché fare e del se è bene fare così. Si rimarca in questo modo il significato di Paideia come sorvegliata attenzione perché il moltiplicare la vita nel fare tante cose non finisca per sostituire la verità dell'essere con il fare. Il fare senza l'essere è sempre un disfare. Socrate può dirsi l'esempio più celebre di dialogo tramandatoci dalla cultura greca. Alla sua scuola di filosofia si assiste alla nascita di rapporti umani che vanno oltre la semplice connessione logica delle idee, sicuramente Socrate è una guida più che un professore. In lui ci si imbatte anche con un sapere peculiare e consapevolmente finalizzato a educare. Egli apre una strada maestra per l'intelligenza del problema educativo. 45 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Nel Lachete, dialogo platonico che mette a tema il problema educativo dei giovani, egli parla dell'educazione come della pratica che "ha per fine la cura dell'anima", per rendere i giovani più nobili possibile. L'uomo per Socrate è essenzialmente anima, di essa bisogna prendersi cura più di ogni altra cosa punto egli deve curare la propria anima e non deve lasciarsi prendere né dal proprio corpo né dei beni che possiede. Il filosofo ateniese assegna all'educazione il compito di richiamare all'uomo il dovere di conoscere sé stesso, per sapere chi egli sia e in che modo debba impiegare la vita per realizzarsi pienamente. Fatto proprio da Socrate l'imperativo del dio greco ha assunto nella storia occidentale un accento un nuovo. "Conosci te stesso" vuole significare “impara a conoscere e ad accettare i tuoi limiti, non serve superarli, perché non può darsi efficacia alcuna fuori da ciò che ti è assegnato”, oppure, detto più concisamente "ricordati che sei uomo e non Dio". Conoscere se stessi e non prevaricare è l'atteggiamento autentico che l'uomo deve assumere, l'unico coerente con la fondamentale legge morale della sua natura. In Socrate c'è questo e altro, il comando divino è anche un appello a cercare in noi stessi la fonte della verità per modellare il nostro io in obbedienza a un ideale etico. Senza coscienza di sé non è possibile alcuna azione libera. Scrivere Francesco Adorno: "non si tratta, per lui, di rendere gli uomini più dotti, ma consapevoli di suscitare negli altri una consapevolezza critica. Il suo insegnamento fu un seminare, non un travasare, un fare sì che ciascuno partorisse sé medesimo". Il dialogo con Socrate non si affretta a produrre facili risposte ma coltiva domande. Davanti all'interlocutore, egli si pone come colui che non sa e chiede, così stabilisce un orizzonte educativo in cui tutto può essere domandato. Le risposte non sono accolte con scontatezza, ma riprese attraverso sempre nuovi tentativi di penetrare nelle esigenze ed evidenze più recondite della coscienza. La domanda è uno strumento potente per chiarire come si giunge alla verità. L'arte di rivolgere domande non è facile, se dura a lungo diventa snervante. Socrate può fare domande senza timore, perché per primo non esita a mettere la propria persona al servizio della verità, senza preoccuparsi di altro. Socrate è un autentico educatore, capace di ascoltare l'interlocutore in modo che ogni sua parola, anche se è molto insufficiente, risulti una vera e propria presa di posizione, della quale la discussione deve tener conto. Grazie alla dote di Socrate di sentire e di reagire con l’interiorità dell’interlocutore, il dialogo con lui costituiva sempre una benefica pro-vocazione, una sorta di scossa elettrica capace di creare un turbamento intellettuale ed esistenziale, in cui la persona in causa finiva per sentirsi obbligata a uscire allo scoperto e aprirsi al richiamo del cambiamento. 46 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Socrate paragonava la sua opera il suo metodo dell'ironia al lavoro della levatrice. Levatrice non è la madre, la quale è tale perché concepisce, genera e matura in sè la vita del figlio, ma è colei che aiuta la madre a mettere al mondo, a partorire il proprio figlio. Allo stesso modo, l'educatore non da la verità all'educando, ma lo aiuta soltanto a scoprirla e custodirla, a esprimerla e a esprimersi in essa. Il significato pedagogico proprio dell'idea di educazione come maieutica (arte della levatrice) della persona ritorna in vari modi nella storia del nostro pensiero. Il maieuta aiuta a partorire il vero. In questo modo Socrate può spiegare il prima e il dopo dell'apprendimento contro l'argomentazione dei sofisti, secondo cui non si può insegnare, perché, se il discepolo sa già qualcosa, non ha certo bisogno di venirne a conoscenza, se invece non sa, non può apprendere. A tale obiezione Socrate risponde con la teoria della reminiscenza, secondo cui conoscere significa ricordare, cioè esplicitare quanto già presente in forma latente nella coscienza. Socrate è il maestro perché insegna ad interrogare. Alla sua scuola si apprende che nessuno acquisisce un sapere capace di placare definitivamente la vita. Anche Socrate però, sa essere persuasivo. La sua arte educativa è difficile ma efficace. Non si limita a comunicare semplici nozioni, piuttosto, in un discorrere intimo da persona a persona, rivela come dentro un interesse vitale operi una vera e propria presenza. La parola è certamente un mezzo di formazione ma sciolta dalla verità si presta facilmente anche alla deformazione e alla corruzione. Dopo Socrate si comprende che la scuola relativa a un'educazione puramente civica, destinata quasi esclusivamente all'esercizio di funzioni quali l'arte del discorrere per persuadere, non basta più. Si fa strada la necessità di istituzioni più complete e di grado superiore, capaci di guidare la mente oltre la grammatica e la retorica verso la scienza e la filosofia. Perciò l'Accademia platonica e il liceo aristotelico diedero forma a un nuovo tipo di istituzione educativa che fu l'archetipo dell'Università occidentale. Questa tradizione venne mantenuta ad Atene e più tardi ad Alessandria durante i periodi ellenistico e romano fino alla chiusura delle scuole ad opera di Giustiniano nel 529 d.C. Socrate, presentandosi come inviato dalla divinità per annunciare il primato della cura dell'anima, offre la testimonianza di una proposta educativa, di un metodo di risveglio della coscienza morale, di un esercizio formativo dell'habitus del pensare il vero e il bene. Da questa tradizione si continua a imparare che l'educazione o è integrale o non lo è. Essa, per essere autentica, deve saper cogliere l'uomo nel suo articolato e complesso rapporto con la realtà della sua crescita. L'io permane nella sua unità pur nel fluire del corpo che si trasforma. Nelle diverse età che vive, l'uomo è un tutto, così nella sua fanciullezza, giovinezza, maturità, vecchiaia, l'unità del suo io permane nella molteplicità e successione di tutti i momenti esistenziali attraversati dal suo mutare, evolvere e crescere. 47 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Sosta nella metafisica classica. Un'opinione diffusa sostieni l'idea che la ricerca del fondamento e del senso ultimo che giustifica la vita riguarda soltanto l'ambito di un'opzione privata. Il sapere intersoggettivo, proprio della verità oggettiva, non sarebbe in grado di dire nulla sul valore che finalizza la scelta e l'azione individuale. Il pensiero antico e medievale ha una ferma consapevolezza di quanto sia determinante per la vita dell'uomo non perdere di vista il fine ultimo cui tende il suo pellegrinaggio intellettuale e morale. Secondo questo modo di vedere, ogni tendenza è sempre tendenza verso qualcosa; tale è la caratteristica del fine, che, dal punto di vista dinamico, cioè dell'azione, equivale esattamente alla forma dal punto di vista statico, cioè dell'essere. In questa prospettiva, forma e fine non possono incontrarsi e compenetrarsi, perché nella stessa forma dell'ente è iscritta la spinta verso la sua piena realizzazione. Il nominalismo moderno, invece, non può essere fatto proprio da chi intende ogni fase ed espressione del processo formativo in essenziale coesione con la dimensione ultima e privilegiata di un esistente radicato nell'essere. L'uomo è in divenire, non nasce in uno stato di compiutezza: prima di essere adulto, egli è bambino, cioè deve farsi adulto. Lo sviluppo non potrebbe determinarsi se non scaturendo da un’intima energia, tale da permettere al bambino di affermare la sua personalità e la coscienza di sé come uomo. In questo senso può dirsi formazione dell’uomo l’emergere di qualcosa qualitativamente già implicata nella sua peculiare natura sin dall’inizio, almeno come esigenza dinamica della struttura del suo essere. Determinato nella propria essenza dal momento stesso in cui comincia a esistere, l'uomo, perché sostanza finita, si dirige verso il proprio condimento attraverso le modificazioni operate dal suo agire. Così, egli cerca e trova la sua forma. Il nostro essere è dunque un'essere-verso una pienezza conforme alla nostra natura, che, tuttavia, deve essere realizzata dall'azione. Secondo la metafisica classica l'essere vivente agisce secondo il dinamismo della sua natura e del suo istinto, ha una propria iniziativa, una capacità di muoversi in vista del suo arricchimento e perfezionamento. Per comprendere in radice il significato di "formazione" è utile interpretare i fondamenti della realtà. La formazione, infatti, è caratterizzata da una connotazione dinamica, figura come seme e sviluppo che si esplica secondo una gradualità, e quindi una finalità. Se si guarda la materia come capacità di assumere una determinata forma, allora si parla di "potenza" di quella determinata forma. Correlativamente, il termine "atto", nel suo compiersi, designa il realizzarsi di una determinata potenza. La potenzialità di un ente è la sua stessa capacità di essere. La parola "atto" per Aristotele designa compiutezza. A rigore, non "forma", ma realizzazione della forma. Solo quando è in atto, resistente esprime esplicitamente ciò che è: l'atto 48 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 ha perciò una priorità sulla potenza, perché solo l'atto è conosciuto. Aristotele chiama "atto" la prima perfezione dell'essere, e "potenza" il soggetto proporzionato che la riceve. In tutto ciò non c'è dualismo: la potenza e l'atto non sono due cose, ma due stati o modi di essere di cui è suscettibile ogni categoria. Nessuna contrapposizione è più assurda di quella tra atto ed essere, dal momento che la determinazione dell'essere reale è precisamente l'atto. Poiché la forma e principio di essere e di attività e ogni attività si esplica attraverso la forma, l'assenza sta all'esistenza come la potenza all'atto, precisamente nel senso che la perfezione dell'essenza è l'atto di esistere cioè quanto fa sì che l'essenza non resti nel mondo dei possibili, ma diventi parte della realtà attuale 1. Dovendo stabilire il rapporto ontologico tra la potenza e l'atto, non si esiterà a fissare il netto primato dell'atto nell'ordine logico, perché la potenza si definisce mediante l'atto; sul piano gnoseologico, perché senza un essere in atto non c'è possibilità di conoscere ecc. Bisogna precisare che il passaggio dalla potenza all'atto non si dà mai come tensione di sviluppo verso un attuazione qualunque, ma avviene sempre in quello sviluppo predisposto da una finalità predeterminata. Si tende secondo quello che si è. Questa è la ragione per cui il concetto generale di divenire è insufficiente a definire la potenza: il passaggio dalla potenza all'atto esige, infatti, la spiegazione di un divenire specifico. Lo sviluppo è questo passaggio dalla potenza all'atto, il quale avviene secondo il parametro della possibilità e non della necessità. Giacché l’atto, come principio di unità determinante, è il pieno tradursi in realtà della forma che presiede al divenire, si apprezza la genialità di Aristotele nel designare questa peculiare caratteristica con il termine Euteyexia? (termine greco). Con questo termine egli intende indicare lo stato di perfezione, di compiutezza, proprio di un ente che ha raggiunto il suo fine, cioè ha attuato interamente il suo essere in potenza. Secondo Aristotele, l'ente possiede una causa formale in quanto ha in se stesso una finalità, verso la propria realizzazione. Perciò, è il culmine dello svolgimento organico di esso, il pieno realizzarsi della sua forma. Questa forma, insiste Aristotele, è anche la causa motrice dell'ente, il cui moto non è altro che "l'atto del possibile in quanto possibile". Perciò, il fine e il termine del movimento, del divenire, non sono altro che la proiezione dinamica dell'eioos? (termine greco). Dunque ogni ente ha in se stesso una determinazione immanente al divenire. Ogni uomo ha la sua forma interiore che lo dispone alla visibilità del mondo. I passaggi della sua crescita, con i suoi colpi, i suoi ritmi, il tragitto delle sue energie, i suoi slanci e le sue misure, possono tradursi in una morfologia esistenziale, perché obbediente a un dinamismo finalizzato. 1 Tommaso d’Aquino, Summa Theologica. 49 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Il problema dell'educazione è quello "dello sviluppo dell'individuo fino a raggiungere il livello dei tempi attuali, il livello di sviluppo qui è giunta alla cultura e la civiltà occidentale". Significa chiedere alla memoria un sostegno per realizzare quegli obiettivi di criticità, creatività e scientificità peculiari della nuova Paideia. Sostare nella metafisica classica non è un superfluo archeologismo, ma un aiuto a fissare con maggior chiarezza i termini essenziali della nostra natura oggettiva, e quindi approfondire teoricamente i fattori fondamentali senza i quali il processo formativo non potrebbe sussistere. Il contributo della metafisica penso possa meglio attrezzarsi quando si constata come da un problema teorico possa dipendere una più intelligente visione della nostra concretezza, della nostra singolarità, la ove si presenta nell'ontologia della persona e nella storicità della decisione. 50 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Identità e differenza. Una pedagogia che intenda farsi capace di dialogare con le molteplici visioni dell'uomo non può relativizzarsi nello scetticismo, soprattutto se si dispone a riflettere su fondamenti e finalità che reggono il processo educativo. Lo sforzo razionale richiesto richiede, infatti, il ritrovamento di uno sguardo metafisico. Nell'orizzonte della metafisica classica, il fine prevale sui mezzi, dal momento che nel fine si esplicita la verità ontologica dell'ente. Poiché il fine cui sono destinato è anche il compimento del mio sviluppo, l'euteyexeia? della mia persona, se ne manca la coscienza, si lavora a vuoto. Tuttavia, non ogni agire può essere qualificato come educazione. Non basta operare limitandosi a perseguire dei fini particolari, ma è necessario aprirsi alla luce di un senso capace di orientare l'uomo in quanto persona, e quindi di regolare il dover essere del processo formativo. Parlare di traguardi invece che di fine, perché meno vincolante e più aperto al principio di variabilità del processo formativo in base agli avvenimenti esterni, offre un contributo ma non è un'alternativa. Promuovere la libertà della persona di essere ciò che essa è esige la coscienza cui mira il nostro divenire perfettivo, cioè dal punto di attrattiva in cui l'esistente può comporsi in unità. Nel corso del suo sviluppo l'uomo si presenta sempre perfettibile, mai del tutto realizzato. Si fa presto a riconoscere quanto sia difficile essere quel che dobbiamo o vogliamo essere. La nostra personalità coincide con la nostra storia, e la storia è uno svolgersi irreversibile, non una sorta di ingranaggio d'orologio predefinito che gira in tondo. Devo guadagnare l’unità della mia persona, vivere in modo da essere veramente quello che vive la sua vita. Dallo stato indifferenziato del neonato alla personalità differenziata dell’adulto, l’uomo è un dato già al primo avvio, ma mai può dirsi giunto alla sua pienezza; sempre gli manca qualcosa che deve avere e cui la sua natura tende. Resta sempre una divergenza fra ciò che il nostro essere desidera e ciò che effettivamente realizza. La tensione più profonda sembra sia quella volta a conseguire la certezza di non essere vissuti invano, di non apparire e sparire come un’ombra. Nella formazione dell'uomo si attua una sintesi in cui sulla ricchezza del dato originario si costruisce l'acquisito, l'esperienza: verso il personale riconoscimento dell'essere, dell'unità, del vero, del buono e del bello, convergono sviluppo, apprendimento, cultura. Quando si tratta del farsi dell'uomo, è ingiustificato parlare di uno slancio istintivo, ateleologico, cioè senza fini predeterminati. Una delle qualità del vivente è quella di trovarsi in un costante processo di mutamento. Quando la vita stagna, assomiglia terribilmente alla morte. Il vivente possiede la caratteristica di articolare invarianza e capacità di cambiamento. Il soggetto del cambiamento è sempre lo stesso io in un continuo crescere, divenire, evolversi, esposto alla possibilità di migliorare o degenerare. Per diventare ciò che si deve essere è necessaria una lotta per identificare se stessi, 51 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 per costruire la propria identità. Il senso o il non senso della sua umanità non appartengono all'uomo in forza di automatismi in nati, la nascita non esaurisce tutta l'esprimibilità delle sue esperienze storiche e sociali. Il “devi” diventare ha per presupposto il puoi diventare, occorre riconoscere che i ritmi nell'esistenza umana sono segnati da cedimenti e riprese di una libertà responsabile situata nello spazio e nel tempo. L'affermazione che l'uomo è unico con le sue qualità non chiude il suo io nell'identico, ma richiama la categoria della differenza. Noi siamo continuamente sospinti fuori di noi stessi, verso l'alterità, verso tutto ciò che è altro da noi. Esistendo, uscendo da noi stessi, trascendendoci, aprendoci noi viviamo nella forma e creiamo differenza, ci differenziamo. Il processo della nostra formazione è un processo continuato di differenziazione e identificazione. La differenziazione dei peculiari tratti personali avviene nella coscienza, da parte del soggetto, della propria identità. I due aspetti coinvolgono in un itinerario per a un traguardo mai del tutto staticamente definito. Una dialettica ineludibile e aperta vieta al formarsi della persona di fissarsi nell'identico. Proprio la differenza è il fattore che tiene aperto il futuro. La maturità non giunge a noi come un destino cieco di un corso naturale, ma si realizza coinvolgendo la decisione della nostra libertà. Frutto di una differenziazione progressiva e non dell'accadere sempre-lo-stesso, la nostra identità rimane custodita nell'esperienza della differenza, e quindi nella coscienza del cambiamento. Restare bambini significa prolungare una persistenza dentro un'incompleta differenziazione. La persona, dunque, non potrà essere compresa nella sua interezza senza tener conto di questa sua disponibilità strutturale all'alterità, alla differenza che la qualifica nella sua identità. Ogni persona ha valore in sè, ma è anche capace di assumere l'alterità come proprio fine. L'uomo non sente solo la voce del proprio Io, delle sue passioni, dei suoi dolori, ma si costituisce come un trascendere il proprio egoismo, e quindi come un arricchirsi con la conquista del ulteriore. Affinché vi sia storia, non basta si diano avvenimenti importanti, ma è necessaria tra essi una continuità. Se la vita è processo, essa non può muoversi verso qualcosa, non potendo attendere a nessun'altra a metà migliore, tenderà al compimento di sta stessa, e quindi ha un traguardo che durante il processo non può dirsi del tutto realizzato punto al riguardo, un interessante suggestione ci viene offerta dall'etimologia della parola dif-ferre, cioè portare altrove, oppure portare da un'altra parte. Il movimento suppone un essere che cambia, il quale pur cambiando resta se stesso attraverso le fasi del cambiamento. Si può anche dire che uno sviluppo è sensato solo se l'essenza di quanto muta rimane se stessa. 52 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 L'uomo non consiste in sé stesso, ma aperto e proteso, sul filo del rischio, verso ciò che è altro da se, soprattutto verso l'altro essere umano. In ciò egli è autenticamente se stesso, e lo diventa sempre più, quanto più osa affermarsi non come individualità chiusa ma aperto e proteso verso qualcosa che giustifica tale rischio. L'uomo e in ogni momento in procinto di farsi uno di fronte al diverso. L'universalità cui tende non è mai terminata, ma dovrà essere sempre completata. Si deve anche dire che essa è continuamente compromessa, perciò l’uomo deve difenderla e, in tanti casi, perfino “rifarla”. Ognuno di noi è lo stesso io di quando è stato concepito, pur nel metabolismo e nel ricambio, nel mutare dei pensieri e dei sentimenti, delle opinioni e delle convinzioni, che nel tempo si susseguono. Sulla base di quanto detto, si tratta di comprendere di più cosa concilia equilibrio e modificazione, in prospettiva di un'evoluzione nel segno della continuità nel cambiamento. Un altro principio regolativo si potrebbe così formulare: l'aspetto mutabile dell'uomo è relativo al suo quid assoluto, che permane immutabile. Si rende necessario riconoscere l'altro nella sua irriducibile originalità, senza definirlo unicamente dalle differenze che presenta. Se formazione non è solo ripetersi dell'identico, ma dice anche autentica è attiva trascendenza, bisogna rimarcare come nel nostro formarci, così come nell'atto e pone una differenza, sia necessario il permanere dell'identità, qualunque sia il fine del nostro trascenderci. Chi si forma non diventa un altro essere, ma resta quello che è. Si diventa sempre più se stessi intorno all'originale nucleo della propria personalità, secondo le individuali disposizioni e capacità. Formare e formarsi non significa semplicemente cambiare, anche perché una tale enfatizzazione del cambiamento espone al rischio di considerarlo un valore in sé che esime dal compito di interrogarsi sulla sua direzione e qualità. L'arricchimento formativo è manifestazione dell'essere, rende visibile e porta a espressione matura quanto l'individuo ha di più intimo ed essenziale. 53 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 CAPITOLO TERZO L’UOMO COME INSOPPRIMIBILE DOMANDA DI SENSO La ricerca di senso. L’uomo non può evitare di preoccuparsi di ciò da cui la sua vita dipende, come il cibo, il vestito, l’abitazione. Il suo interesse, però non termina qui; si apre, infatti, a originali esigenze conoscitive, estetiche, sociali, politiche, religiose. Egli non può eliminare la domanda di senso della sua condizione presa nel suo insieme, senza rinunciare a esistere umanamente. La necessità decifrarti è sempre stata presente nella coscienza dell'uomo. Gli altri problemi esistono solo perché l'uomo è un problema a sé stesso. Il segno distintivo che segna l'uomo consiste nel suo essere destinato a cercare il senso ultimo della sua vita. "Ultimo" in quanto è il più radicale e influisce su tutti i precedenti interrogativi. L'esigenza propria dell'uomo di una verità chiarificatrice il senso della sua esistenza, e quindi del suo agire, può essere ben espressa nei termini con cui Maurice Blondel ha iniziato il suo capolavoro "La vita umana ha o non ha un senso?". Il termine "senso" può essere inteso come un'accezione inclusiva di senso come significato (così come si parla di senso di una frase) e di senso inteso come direzione (così come si parla di senso unico di una strada, di un fiume). Si giunge allo stesso rilievo se si parla di senso come valore intelligibile, che orienta lo sforzo di conoscere, e di senso come scopo o destinazione finale. Forse non si deve trascurare di osservare che il problema del senso, benché legato a quello della verità, non coincide del tutto con esso. Da un punto di vista logico-linguistico, il primo precede di fatto il secondo; infatti, soltanto una proposizione sensata può essere vera o falsa, mentre un giudizio privo di senso o significato non può né essere vero né falso. Quando si parla di senso come destino, si solleva con urgenza pratica di soluzione più facilmente e chiaramente presente alla coscienza di tutti. Rinunciare alla determinazione del destino della vita, significa oscurare il mondo dell'azione morale. Se oltre ai fini e al di sopra di essi non vi fosse una finalità ultima, capace di giustificare l'intero processo del vivere, la vita mancherebbe di un valore adeguato a sostenere la volontà di progredire. Scoprire per la vita ha un senso, e quindi un destino, vuol dire il ricercare, non in una parola, ma in una pienezza, la manifestazione integrale di quanto giustifica l'esistere, proprio perché significa scegliere quella direzione verso cui la vita si muove per raggiungere il suo compiersi. Poiché la domanda di senso capace di giustificare la vita è inerente alla senza peculiare dell'uomo, essa non è confondibile con altri interrogativi. Gli altri interrogativi si ricollegano alle domande con le quali l'uomo cerca di sondare la sua essenza. Chiedersi il perché della vita, cosa voglia dire essere al mondo, il perché della gioia e del dolore, per quali strade il tempo ci porta ecc. 54 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Il nostro rapporto con la verità della vita non è tanto in un soddisfatto possesso quanto in un'attesa: non possiamo impadronirci della verità, ma possiamo esprimersi autenticamente secondo una modalità che ci protende nella ricerca, anche quando la nostra fiducia è gravemente ferita. Non si può prendere posizione sul senso della propria vita. Chi pretende di non scegliere ha già fatto una scelta. Se il problema di quale sia il senso della totalità dell'esistenza è destinato a rimanere insoluto, ogni cosa nella vita dell'uomo si relativizza e fluttua secondo il variare di un soggettivo sentire: le ore di tutti i giorni passano disordinatamente, senza un filo capace di legarle in un ricamo sensato. “Il mondo delle spiegazioni e delle ragioni non è quello dell’esistenza”, afferma Jean- Paul Sartre , per il quale l’uomo vaga nell’esistenza come un vasto mare i cui flutti lo sospingono da uno scoglio all’altro. Vano pensare di attaccarci per afferrarci, qualsiasi appiglio si vola ai nostri agganci e fugge. Porre come definitiva l'assurdità dell'esistenza rende vana la ricerca di uno scopo, di regole, di motivazioni. Ma pretendere diversamente significherebbe adagiarsi, in mala fede, in una soluzione fideistica. Se l'unica conclusione della nostra ragione coincide con l'accorgerci che la nostra breve vita si sazia solo di affanni, sboccia come un fiore ma presto appassisce, scompare come un sogno di un'ombra in capace di durare, non possiamo nascondere a noi stessi la sua intima assurdità priva di scopo, il suo essere un circolo senza traguardo. Al contrario della dialettica idealista (visione grandiosa e e totale di tutta la storia dell'uomo), si contrappone si contrappone che l'esistenza concreta sfugge alle conciliazioni della logica, si presenta come antinomia e contrasto. L'uomo abbandonato a se stesso, si sente come un enigma spaventoso e impotente a sanare il divorzio tra il desiderio del cuore è il mondo che delude. Dentro il progressivo aggravarsi di pena e delusione, si cela l'inesorabilità della morte. In un simile orizzonte, l'esistenzialista, anche quando ammette che il sentimento dell'angoscia non è comune né quotidiano, lo ribadisce come l'unica possibilità per andare oltre la fatua immediatezza, fino all'autentica trama della vita. L'angoscia rivela l'essere nel suo complesso. Solo all'angoscia può essere attribuito il ruolo doloroso ma lucido di svelare l'uomo a se stesso nella storicità radicale della sua esistenza finita. Poiché l'angoscia permette di avvertire cosa significhi essere gettati nel mondo e limitati in ogni senso, sentirsi sospesi tra l'essere e il nulla, essa ha il compito di farci comprendere l'esistenza come finitudine e indefinita problematicità. Sempre più lucida la convinzione che l'individuo è padrone non della propria vita, ma soltanto della propria morte. A questa paradossale conclusione, che promette la forza di vivere solo a chi non ha una ragione per vivere, accede chi guarda nel buio dell'angoscia come alla sola luce per cui l'uomo può divenire consapevole della sua soggezione alla morte, precisamente nel senso che essere-nel55 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 mondo significa essere-per-la-morte; "morte" come "possibilità dell'impossibilità di ogni possibilità" dell'esser-ci. Così, nell'atto di scegliere la sua radicale contingenza, anche a rischio di scoprire il carattere insopportabile dell'esistenza, l'uomo supera l'immediatezza della mera individualità e mentre coglie in sé l'essenza dell'essere, può fare derivare ogni felicità possibile dalla situazione dell'assurdo. Nella volontà di accettare la nostra finitezza, s'impone come una consecuzione fatale il passaggio dal timore di fronte a ciò che ancora non si conosce all'angoscia di fronte al nulla. Non basta più parlare della semplice paura di qualcosa ma occorre parlare di angoscia, perché l'oggetto della paura non è conoscibile e le nostre reazioni di difesa contro l'oscurità che prende la vita alla gola sembrano impossibili. La decisione di considerare l'angoscia quale criterio assoluto dell'autentica esistenza proviene da un tema religioso caro a Kierkegaard. La filosofia moderna spiega il filosofo danese, ho scelto di iniziare a filosofare partendo dal dubbio. il bisogno di una fede, di una verità non riducibile a una semplice formula, di una presenza per cui si possa vivere e morire. Se questa è la sua funzione, l'angoscia può non essere considerata soltanto un esperienza negativa. Per chi è caduto nel peccato, l'angoscia, purché facilita il ritrovamento della fede come decisione nell'infinità del possibile, contribuisce ad aprire una via di salvezza alla redenzione e alla nascita. Il peggiore delle angosce ovvero l'angoscia essenziale ed esistenziale: il terribile spavento di perdere definitivamente l'amore. La drammatica percezione del nostro essere per la morte, dell'esistenza umana gettata nel mondo a morirvi in uno stato di derelizione e di angoscia, l'esperienza della notte spaventosa della nostra disperazione, chiama in causa la questione fondamentale del senso della vita e porta alla crisi a un livello di profondità. Il nostro desiderio di essere è esposto continuamente al fallimento. Una verità sulla vita anche le ferite della vita. Non si può rispondere alla vita, immaginandola senza ferite quando ne è piena. Vale la pena chiedersi perché si concede una così esclusiva invadenza all'angoscia, mentre si respingono altre esperienze esistenziali come non autentiche. Non è un'esperienza rara trovarsi a contattare di non sapere cosa desideriamo, cosa vorremmo profondamente, scoprirsi a sapere soltanto di non poter vivere dentro un buio impenetrabile. Secondo l’antropologo Gehlen l’esigenza fondamentale dell’uomo di sapere della sua origine, e quindi del senso della sua vita, è quanto poi decide del suo comportamento nel mondo. Ascoltare la propria umanità significa accettare tutte le domande della vita e non rinunciare a cercare in prima persona una risposta adeguata, servendosi di tutte le conoscenze e informazioni di cui si dispone. Confrontare ogni accenno di risposta con le proprie esigenze ed evidenze personali è un lavoro che ha la durata dell'intera esistenza. 56 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Per sapere cosa sono io, ho necessità di conoscere il motivo per cui sono al mondo e lo scopo cui mi conduce la mia storia. Si può osservare che, senza una risposta al perché ultimo, l'uomo non sa rimanere sospeso alla sua contingenza, ma perde la sua forma e precipita nel nulla del non senso. Poiché la vita dell'uomo cresca, occorre che essa possa attingere a quanto è in grado di giustificarla. Dal fondo di questo bisogno, che nessuno riesce a colmare da solo, scaturiscono domande radicali, peculiari alla nostra umanità. “Perché alla gioia è legato il dolore?” ecc. in queste domande si esprime l'elemento dinamico di quanto da forma e unità alla vita dell'uomo, cioè ragione, esigenza essenziale, che guida la sua espressione personale e sociale attraverso originali istanze e sollecitazioni. Il dissenso nell'uomo, è insopprimibile, ed è tale da investire la sua conoscenza il suo affetto, le sue relazioni pubbliche e private. Quando l'interrogativo affiora rivela che la persona è protagonista di un consenso e un'iniziativa originali. Le fondamentali domande interessano il dinamismo più spontaneo della ragione di ogni uomo. Il solo accendersi di una domanda di senso costituisce una testimonianza di come la realizzazione autentica dell'umano non si dà senza il coinvolgimento profondo del nostro io. La domanda di senso immette dentro un campo di tensione in cui sia l'intelligenza sia la libertà vibrano e oscillano. Affermare l'esistenza di un senso significa anche lavorare per respingere il caos fuori dalla dimora degli uomini, nel deserto impenetrabile, cioè ai margini del nostro potere di rendere il mondo abitabile. Il riconoscimento di come la nostra struttura intima coincide con una domanda inesauribile avvicina alla scoperta che gli interrogativi fondamentali, espressione della nostra disponibilità essenziale ho un continuo trascendimento di noi stessi, sono la manifestazione più alta della nostra umanità: rispondervi misura la serietà del nostro impegno con la vita. Ridicolizzare il problema, relegando le domande fondamentali sul destino nel campo delle inutili astrazioni, significa voler sopprimere la domanda che ci costituisce, decidere di rinnegare la nostra stessa natura. Sarebbe un errore pensare che l'affermazione di un senso blocchi la libertà della ricerca, chiuda lo sviluppo della coscienza in uno schema predeterminato. In realtà, pone la condizione per ricercare veramente, per rendersi capaci di vera apertura di sincero dialogo e di autentica educazione. All'uomo non basta vivere. E gli chiede anche di sapere cosa sia la vita e perché valga la pena viverla. Egli vuole anche avere qualcosa per cui vivere. La vita umana, possiede una più profonda attrattiva che nella prospettiva accennata risulta nascosta o rinnegata. Una pienezza di limite e gloria non chiude il nostro io nella prigione del puro calcolabile, ma lo apre alla conoscenza di una dimensione infinita, che ci costituisce ontologicamente aperti alla luce della verità assoluta come un momento essenziale di noi stessi. 57 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Corollario pedagogico. L'approfondimento della tematica circa la ricerca del senso ultimo della vita e sicuramente indispensabile per comprendere la natura e il valore dell'educazione, la cui azione si svolge costantemente in un campo di verità e libertà, di testimonianza e cura. Poiché essa si situa in relazione essenziale e necessaria a ciò che l'uomo è nel mondo e al suo destino, l'euristica del senso della vita e condizione fondamentale della relazione educativa. La possibilità stessa dell'educazione costituisce il primo problema pedagogico. Nessuna pedagogia può avanzare nel suo discorso, se già in partenza si è costretti a constatare che mancano le condizioni della sua possibilità. In educazione l'esigenza di un giudizio positivo sulla realtà, senza censurare la sua contingenza e le sue tensioni, presto fa sentire la sua forza. Rassegnarsi a ripetere che altro "non siamo se non il sogno di un'ombra" (Pindaro), su cui pesa un destino cieco, destinati a subire i contraccolpi di una storia sulla quale non abbiamo nessun potere, e quindi paventare un mondo paralizzato, ove la volontà di ognuno è inceppata, contribuisce non poco a togliere in anticipo qualsiasi energia per ricercare uno sbocco positivo. Ricorrere al caso significa mascherare la nostra ignoranza. Stare sul filo teso della negatività è molto difficile, è una situazione fragile. Il peso di un destino assurdo risulta insopportabile, certo è l'ostacolo principale perché l'uomo impegni la sua libertà. Quel che avviene nel mondo civile a partire dalla fine dell'Illuminismo è il totale disinteresse per il senso della vita. Non contrasta con il darsi da fare, anzi. Si riempie il vuoto con l'inutile. L'uomo non ha più interesse per l'umanità. Sembrerebbe che a lungo andare anche il problema di un senso ultimo della vita possa essere obliterato. La noia presto riempie il Carpe Diem di chi si trova desolatamente ingombro della persuasione che quanto riesce ad afferrare non vale neppure per l'attimo. Avvalorare questa prospettiva non può non finire per produrre una cultura di vita incentrata sul consumo del presente e marginalizzare tutto quanto giudicato inservibile al proprio successo e al guadagno a tutti i costi. Rassegnarsi ad andare avanti, fino a incontrare il nulla, la morte, non è un programma che un uomo ragionevole può fare proprio. L'educazione si fonda su una concezione dell'esistenza, e quindi tenta di risolvere il problema del senso della vita. Un'educazione neutra è impraticabile. La relazione educativa intesa come rapporto tra chi apprende e chi insegna, fiorisce in una trama articolata di rapporti in cui il problema del senso sta alla base di ogni possibilità di apprendimento. L'emergenza educativa mi pare sia quella di restituire ai giovani le condizioni di poter trovare il valore e il compito della loro umanità. Senza un ideale ci si piega su proprio un vuoto, prevale il disprezzo di sé, si diventa negativi, violenti, l'intelligenza perde la sua intuizione, l'amore la sua tenerezza la stessa vita istintiva finisce per trascinarsi dentro una profonda apatia. 58 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Nessuna scienza, arte, politica, educazione, potranno aiutare l'uomo se viene meno la certezza del minimo, se la vita non può in alcun modo essere percepita come rivelatrice di senso, se le sue domande devono essere ascritte al campo dell'illusione irrealizzabile. L'educazione rende inevitabile la necessità di sapere cosa sia corrispondente o difforme all'umano, insieme a quale sia la via per conseguire la meta. La perdita dell’interesse al problema del senso della vita è insieme effetto e causa dell’indifferenza al problema educativo, e quindi alla questione della formazione della persona. Secondo Rita Fadda “in uno scenario culturale in cui ne va del senso stesso dell’uomo, della sua consistenza e inconsistenza, data l’incertezza dell’esito del processo educativo o in genere delle attività della cura pedagogica, l’interrogazione sul senso diventa domanda sul senso dell’educare”. Poiché la nostra realizzazione ha a che fare con una decisione circa il senso ultimo della vita e dell'intero universo, spingersi fino alla profondità radicale del problema significa aprire la via d'accesso al discorso pedagogico. La questione del senso, almeno in qualche momento, emerge nella vita di tutti. In pedagogia deve sorgere in modo profondo per impedirci di soffocarne la serietà o abbandonarci a un'indifferenza scettica oppure rassegnarci a gratificazioni di piccolo cabotaggio. Nel contesto di queste riflessioni giova anche rimarcare che la simpatia comprensiva richiesta a un educatore è sempre frutto della sua sensibilità umana, e quindi della sua cordiale apertura all'autentica realizzazione dell'uomo come tale. L'azione educativa è tale se sospinge e guida l'educando a divenire a se stesso, cioè a diventare quanto deve essere in ordine alla pienezza e al compimento del suo essere uomo. Soprattutto per questa ragione si può dire che l'azione di educare ha un senso formante e non formale, precisamente in considerazione del riconoscimento del valore della forma. Poiché il problema della formazione presenta molteplici incognite si deve riconoscere che il fondo essenziale della questione coincide con l'aiuto per prendere posizione consapevole e libera davanti al mistero dell'essere, così come esso affiora nella trama delle circostanze di cui è fatta l'esistenza. Infatti, in questa libera decisione l'uomo può dare la sua personale figurazione al proprio ambito esistenziale. Solo se non si sottrae a questa responsabilità, egli può sperare di aiutare un altro uomo nella sua personale conquista di una convinzione, nel coraggio di azioni lucide e conseguenti alla propria scelta ideale. L'educazione non può non avere come sua preoccupazione fondamentale chiarire quale sia il senso della vita, e quindi dell'uomo, quale sia l'origine del suo agire e la forma della sua personalità. Per rispettare l'autentica natura e il valore dell'educazione, non basta soltanto dire cosa fanno e pensano gli uomini che educano, ma occorre pronunciarsi su quale scopo essi debbano proporsi. 59 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Alla base dell'educare agisce la persuasione che l'esperienza umana è dotata di senso. Noi non siamo in un mondo assurdo, dall'ipotesi esistenziale di un senso possibile, alternativa ha un relativismo oscuro e senza costrutto, consegue l'opzione secondo cui l'esperienza della nostra realizzazione, si fa sempre non al lato, ma attraverso la nostra ricerca della verità. La pedagogia non può elaborarsi con cognizione di causa se manca un riferimento costante a un esplicitazione coerente del problema del senso, e quindi se non si è in grado di mettere in opera la mediazione della riflessione filosofica. Sulla prospettiva aperta da questo principio euristico, si disegna la figura di una circolarità dinamica: noi non dominiamo il senso della nostra vita come se fosse una cosa, bensì il senso, quando domina la nostra coscienza ci rende a noi stessi formando la nostra personalità. La nostra conoscenza del senso ultimo della vita, cioè del destino, per noi non potrà mai essere un sapere esaustivo e totale. 60 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Forma e senso nell’uomo coincidono. Prendere sul serio come una questione fondamentale il fenomeno del nostro divenire uomini apre il problema sulla soggettività protagonista del successo educativo, e quindi l’interrogativo sulla sua destinazione. Non ci si allontana mai tanto dal bene come quando si misconosce quello che si è. L'uomo nasce intelligente e libero; ma all'inizio la sua connotazione di persona non appare come un'espressione manifesta, ma come una promessa affidata all'educazione. Se l'uomo disprezza il suo dovere di pensare e amare, degrada al livello dell'individualità animale e corre il pericolo di finire con essa. La formazione è un processo di perfezionamento per cui un essere sviluppa le sue parti fino al conseguimento dello scopo della sua esistenza. Al principio ideale e allo scopo del processo formativo risponde sempre l'esperienza del personale maturare la propria identità, attraverso un vero e proprio lavoro di identificazione destinato a durare l'intero arco della sua esistenza. L'essere-se-stessi implica sempre una parola che ci previene e ci forma, ma non si presenta ai nostri occhi come un fatto compiuto, si chiarisce nell'ineliminabile coscienza del dover essere, e quindi nella modalità di una destinazione da raggiungere mediante comportamenti conseguenti. L'uomo non viene al mondo già formato piuttosto nasce come un avvio aperto, progrediente verso la scoperta di se, e quindi come un compito che si realizza attraverso il tempo nell'orizzonte del possibile. Conoscere la forma di un essere significa conoscere la sua natura. Infatti, la materia di quest'ultima è specificata dalla sua forma a essere un corpo piuttosto che un altro. Il luogo della nostra formazione non è appena quello della natura, ma chiama in primo piano quello della storia. Poiché la storia di ogni uomo è fatta di eventi e soprattutto di tanti incontri con altri uomini, la sua forma non si dà indipendentemente dalle decisioni prese nei vari incontri nella vita. Il concetto di forma hominis, poiché è essenzialmente connotato dalla relativa storicità dell'uomo stesso, indica qualcosa di permanente ma anche l'aspetto variabile, il continuo nell'evento, la stabilità nel fenomeno mutevole. La sua identità è una permanenza in un cambiamento continuo. Perciò l'uomo forma la sua umanità, ma non può dire di aver raggiunto la sua forma definitiva: di fatto, il suo formarsi è anche un continuo trasformarsi attraverso un dialogo storico e pratico con gli avvenimenti. Nella cultura moderna il formarsi di una personalità coerente si basa sulla Costituzione della sua identità soggettiva. La formazione è il raggiungimento dell'identità personale. Il nostro formarci non avviene sempre alla luce e consapevole di quanto sappiamo e vogliamo. La nostra vita procede anche attraverso eventi che ci accadono; anche il nostro comportamento di fronte a un evento imprevisto è in fondo una risposta e una decisione. L'uomo, in virtù della sua 61 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 storicità, diventa sé stesso attraverso le sue decisioni. La storia è il campo della decisione in cui l'uomo vive in un continuo formarsi e manifestarsi. Il fallimento delle sue decisioni aliena la sua vera vita. Ogni uomo vive l'esperienza di una tensione tra ciò che è e il suo possibile miglioramento. La coscienza della distanza nutre l'impegno morale di corrispondere alla destinazione del proprio essere uomo, allo sviluppo e alla pienezza. Ciò permette di prendere decisioni davanti al destino e non subirlo passivamente. Il principale dovere dell'uomo che vuole realizzare se stesso è prendere coscienza della forma umana e di quella sua propria. La libertà e il destino divengono fattori portanti dell'entelechìa personale; cioè, nel senso aristotelico del termine, dello stato finale o perfetto dell'ente che, attuando tutte le sue potenze, raggiunge il suo tèlos. Anche per l'uomo lo sviluppo verso il compimento delle sue potenzialità obbedisce all'ontologia normativa della propria natura razionale. Essa costituisce la condizione necessaria affinché l'uomo possa rimanere fedele a se stesso. Frequentemente si presenta il caso di chi pretende o pensa di dover esigere da sé stesso più di quanto può dare, ma constata di non riuscire nemmeno a realizzare quanto rientrerebbe nelle sue possibilità. Il piccolo dell'uomo che cresce e attinge orizzonti sempre più vasti in cui ampliare la sua conoscenza, non perde la sua umanità, ma diviene più se stesso. Non è facile definire con esattezza in cosa consiste la nostra maturità nei concordare un criterio uniforme per stabilirla. Si può dire che la maturità è lo stato di completo sviluppo di un organismo. La nostra vita inizia in un fragile organismo che progressivamente si adegua alla levatura del fanciullo, dell'adolescente, dell'adulto. La maturità consiste anche nel prendere piena consapevolezza del proprio essere imperfetti, cioè con sapere di non sapere né potere tutto, e quindi accettare la propria responsabilità di lottare contro ostacoli, di soffrire, di morire. Quando termina la nostra formazione essenziale, rimane la necessità di perfezionamenti particolari o accidentali, formarsi dura tutta la vita. Ogni ha il suo tipo di maturità, mai può dirsi una metà facile né fissa, ma un problema la cui soluzione richiede un equilibrio che impegna lungo tutta l'esistenza. Se l'uomo si rassegna a essere come è, diventa peggiore, bisogna attendere a quanto si deve essere, per convertirsi in ciò che si può arrivare ad essere. Perciò il motto "diventa quello che sei" si traduce in educazione in "diventa quello che devi essere". La classica accezione di forma indica che essa è quanto sussiste, mentre ognuno dei suoi elementi materiali integrati continuamente si rinnova. Finché c'è vita, la forma è più duratura della materia, che, se presa a sé stante manca di ogni fisionomia. L'equazione forma=senso permette anche di specificare che la formazione umana sia tua coniugando affermazione e ricerca come funzioni complementari. Trascurare una delle due equivale per noi a trascurare l'altra, e quindi impoverirsi 62 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 anziché arricchirsi. La persona non afferma se stessa se non tende verso il suo fine ultimo. La forma umana di un individuo nella sua esistenza non si lascia fissare in una definizione esauriente, ma si fa intravedere nella ricerca del suo senso; non si dà come una cosa compiuta, ma informarsi in cui molte cose possono assumere sviluppi diversi, rinnovarsi in vari acquisizioni. Si potrà avere il senso pieno solo quando la persona giungerà al termine del suo rinnovarsi, in via, il senso si da solo come un disegno ancora in gestazione. Conviene dire della nostra formazione non è infinita, ma infinitesima, per designare la non come ciò che non può essere raggiunto, ma come ciò che si può infinitamente approssimare. Nessuno può dire di essere arrivato definitivamente al traguardo. Nessuno e padrone del suo futuro. Per contro, rinunciare alla ricerca del senso dell'esistenza significa abbandonare l'umano alla deformazione. Affermazione e ricerca possono considerarsi come le condizioni necessarie, le disposizioni indispensabili, oppure le circostanze ineludibili, grazie alle quali si attua il formarsi della persona. L'educazione dell'uomo implica la verità di una destinazione capace di spiegare il divenire e dargli consistenza. Di tale verità nessuno può dirsi un possessore autorizzato e imporla agli altri. Il riconoscimento personale della verità non blocca la ricerca, ma la riapre continuamente, dà valore al dialogo, fonda il rispetto dell'altro, difende la libertà di tutti. Se il riconoscimento della verità è affermazione e ricerca, non basta seguire passivamente i luoghi comuni del proprio gruppo sociale; così non si acquista una convinzione personale, solo si disimpegna il proprio io nel "si dice" della pressione collettiva. L'educazione si fa incomprensibile e svanisce se ci si ferma alla sola analisi di idee e di affermazioni puramente teoriche. Infatti, siamo alle prese con la faticosa tensione dialettica di una esperienza protesa verso l'unità sintetica della persona. Il senso del destino da unità all'educazione dell'uomo, e quindi alla pedagogia, perché di entrambe e l'esegesi, come anche l'esegeta; è veramente il Logos. Si possono mettere in risalto due significati del termine uomo. Il primo per designare la persona in potenza, il secondo per la persona in atto, cioè il punto di partenza per quello di arrivo del processo educativo. Chi accetta di assumersi il compito di educare entra nella logica della speranza propria di chi semina largamente senza esigere un calcolato raccolto. L'uomo deve diventare ciò che è già, ed è già quel che deve diventare. La formazione è la dimensione dentro cui perennemente stiamo, perché è la dimensione del divenire uomo dell'uomo. Non si da l'uomo e poi la sua formazione, come suo derivato, ma solo l'uomo in formazione. Si parla di formazione come un processo di sviluppo perfettivo attraverso cui la forma della persona può manifestare tutte le sue virtualità. La formazione ha tante sfaccettature quanti 63 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 sono i momenti essenziali dell'esistenza, ma ha il suo nucleo nella piena realizzazione dell'uomo, qui si trova il momento riassuntivo che raccoglie tutti i vari aspetti in un unico centro, principio attivo, verso il quale tutto il resto converge come mezzo al fine. 64 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 L’azione e la visibilità dell’io. Il centro del nostro essere non si lascia attingere immediatamente come un oggetto a portata di mano ma solo per riflessione. La difficoltà è notevole, una constatazione di vuoto può investire chiunque si appresti a prendere coscienza di sé, soprattutto se egli non si rende capace di trovare un punto di partenza adeguatamente ancorato alle esigenze del suo io. Per chiarire il problema bisogna partire dall'osservazione del mio io vivo, cioè del mio io che si attua sempre determinate circostanze, cammina, studia, lavora. L'individuo non deve essere considerato astrattamente, ma accolto come è: immerso nei bisogni della sua condizione storica, e quindi vincolato alla natura, alla società, alla tradizione, al mistero. Nessuno riesce ad afferrare un "io" indipendente dall'azione che lo rivela. L'io raggiunto dallo sguardo della nostra conoscenza è sempre quello che si manifesta in azione, un io tatticamente inerte non sarebbe da noi concepibile. Rifugiarsi in una coscienza di noi stessi che prescinda da come agiamo è una scelta destinata al fallimento. L'ordine logico per giungere alla conoscenza di se è il seguente: dapprima l'io pone un atto diretto di conoscenza di qualcosa, per riflessione l'intelligenza conosce il suo atto, poi l'io giunge a conoscere sé stesso come principio dell'atto. Non si tratta tanto di un ragionamento quanto di una percezione riflessa, o un'intuizione dell'intelligenza nel suo atto e per sé stesso. Sarebbe un errore segnare un vallo troppo profondo tra pensiero e azione. La conoscenza umana include sempre queste due componenti in un'unità correlativa: l'azione senza la riflessione scade a semplice reattività; la riflessione senza l'azione perde di senso. In concreto non si dà teoria senza conseguenze pratiche. Se il punto di partenza e l'esperienza dell'uomo nella concretezza del suo vivere, allora il metodo di indagine più efficace non può soltanto appartenere all'introspezione. Presta decisiva l'osservazione di se stessi in azione. Blondel invita a studiare l'azione, per capire ciò che essa implica, non mediante la descrizione psicologica, ma attraverso l'analisi riflessiva, situandosi alla radice comune dell'intelligenza e della volontà, dove esse attingono la loro forza. Bisogna cercare il senso della nostra umanità osservandoci in seno alla realtà nella quale siamo immersi e alla quale non possiamo sfuggire. Questa realtà è l'azione. L'azione costituisce una espressione più sicura e completa della personalità umana. I nostri atti non solo ci seguono, ma ci trasformano. Il mio realizzarmi non conosce una risposta statica previamente e di colpo capace di eliminare tutti i conflitti dell'esistenza. Quando l'atto conforme alla mia natura razionale, cioè corrisponde alle esigenze del mio io, mi perfeziono, edifico la mia personalità. Se, invece, l'atto è discorde con ciò che sono, porta con se una sorta di sanzione immanente: mi diminuisce, diminuisce l'unità interiore e la trasparenza della mia coscienza. 65 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 L’azione è la struttura tangibile dello spirito. Agire non significa mettere in moto i nervi, tendere i muscoli. Agire significa governare e creare. L’azione del lavorare. L’azione designa ogni attività specificatamente umana, sia essa metafisica, morale, estetica, scientifica ecc. L’azione propria del lavoro è una dimensione essenziale e universale dell’uomo, la forma espressiva nella personalità umana, e quindi del rapporto dell’io con l’universo. L’uomo, chiamato a fare di sé ciò che è veramente, raggiunge il suo scopo soltanto grazie al lavoro. Su questa scia, Giovanni Gentile parla di “umanesimo del lavoro”. L’incontro dell’uomo con la natura avviene attraverso il lavoro di chi ha coscienza di quel che fa, ha coscienza di sé e del mondo in cui vive. Il lavoro è presente in ogni momento dello sviluppo dell’uomo; in sua assenza, egli non attua nella sua integralità la formazione della persona, senza la quale l’uomo non giunge alla sua humanitas. L’esistenza oziosa nutre una profonda avversione per tutto ciò che richiede spirito di sacrificio. Ma il lavoro non è fine a sé stesso, il lavoro deve procurare anche i mezzi per la gioia, l’espansione e il diletto dello spirito. L’uomo non si limita a raccogliere i frutti che la natura gli offre, non si ferma a coltivare piante, ad addomesticare animali, ma trasforma il suo ambiente naturale, crea nuovi materiali in funzione dei propri progetti. Poiché la ripercussione del lavoro sulla persona produce esiti formativi evidenti, nella scelta professionale è estremamente importante una consapevolezza critica delle ragioni per cui si lavora, tale da poter essere espressa e difesa intersoggettivamente. Nell’attività l’uomo manifesta il suo essere e possiede la sua essenza. Il lavoro dà alla persona la sua posizione sociale, la lega alla società e le conferisce un prestigio. L’uomo privato della dimensione del lavoro presto viene nuovamente ridotto a “natura”; nel senso che la sua condizione immobile diviene quella di un passivo adoratore di ciò che è. Attraverso il lavoro noi ci realizziamo come uomini, cioè diventiamo più di noi stessi, perché nel lavoro possiamo attingere alla caratteristica specifica della nostra condizione. Con il lavoro l’uomo dà all’indeterminato una determinazione; così egli conferisce al mondo un senso, cioè una finalità umana. Lavorare significa rendere il mondo più abitabile. Il disoccupato soffre un attentato grave alla coscienza di sé. Educare significa provocare la persona a coinvolgersi con la realtà, perché giunga a un’adeguata coscienza di sé. Per conoscerci veramente, occorre sorprenderci dentro l’esperienza di un impegno reale. Per essere reale l’uomo deve uscire da sé. 66 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 L’esistenza non è mai riducibile a oggetto, ma bensì progetto e soggetto dato che si prende coscienza del mondo nell’agire, in una decisione, che nel tempo muove e trasforma l’uomo. Non l’uomo è per il lavoro, ma il lavoro per l’uomo. Il lavoro dovrà essere fatto per promuovere effettivamente la formazione della persona conformemente alla sua destinazione originaria. La madre e il padre hanno cura del bambino se gli consentono di essere “lui”, se sono tesi a valorizzare le inclinazioni costitutive del suo essere. Nessun uomo deve essere rinchiuso nel lavoro; l’uomo non è solamente lavoro, ma è anche parola e dialogo. Il compito peculiare dell’educazione non è quello di preparare il lavoratore, ma di formare la persona, che attraverso il lavoro, umanizza le cose, ma non si identifica con esse. La competenza professionale del lavoratore sarà tanto più esperta quanto più fondata su una solida formazione umana. Le abilità e le qualità proprie del lavorare sono subordinate a valori effettivi di verità, giustizia, bellezza, liberazione. Abilità rivolte a scopi pratici che hanno un valore pedagogico se si lasciano permeare da un’ideale morale. 67 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 La verità della mia destinazione. Ogni esistenza ha il suo senso essenziale da scoprire e realizzare. Conferire un senso alla vita non è diverso da scoprire la verità del proprio destino. Questo problema si risolve attraverso la scoperta di uno scopo, di un ideale. Misurarsi con l’interrogativo posto dal destino ha un valore esistenziale e un altro esistentivo. Esistenziale perché pertinente ai principi che permettono l’intelligenza di se stessi, e quindi della propria origine e del proprio fine; Esistentivo perché si tratta di me, del fallimento o realizzazione della mia esistenza. Il momento esistentivo include quello esistenziale: non può non manifestarsi in principi, in affermazioni, in verità esistenziali capaci di interpretare il dramma dell’uomo; ma aggiunge in più un personale coinvolgimento con i principi conosciuti. Per prendere veramente coscienza di me stesso devo dispormi in maniera tale da considerare profondamente il telòs che mi muove. Se tutto dipende dalla coscienza del proprio fine, allora tutto è sospeso al contenuto che l’uomo stesso si dà per orientare la propria vita, e muovendosi verso il quale conduce la sua esistenza. Non è un caso che il desiderio si riveli come l’insostituibile fattore dell’azione della nostra libertà. L’uomo non può evitare di affermare un senso alla propria vita. La domanda di senso non tarda così a rivelarsi come la radice da cui scaturiscono i valori. Un valore manifesta quale sia la prospettiva del rapporto tra il contingente e il necessario, l’effimero e l’eterno, la parte e il tutto. La verità non è una nozione astratta, ma un messaggio che interpella. Ciò significa che l’uomo, per comprendere se stesso e compiere il suo desiderio di essere, deve lasciarsi interpellare e a sua volta deve interpretare tale sollecitazione scoprendone il rapporto con la sua esistenza. Quando l’uomo è alle prese non con una qualunque verità, ma con la verità della sua vita non è pensabile che egli sia destinato a restare in uno stato d’indifferenza. L’intelligenza dell’educazione esige la comprensione del significato di una storia, la percezione di uno sviluppo storico, piuttosto che una conoscenza di connessioni logiche fra proposizioni. Si comprende perché a questo livello si può parlare di “difficili certezze”. Per certezza s’intende saldezza, quiete nel possesso della verità. La ricerca di un senso promette all’uomo la sua forma unitaria. 68 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Ineliminabilità del senso religioso. Secondo T. D’Aquino, l’uomo “è una specie di orizzonte e di frontiera tra l’universo corporeo e l’universo incorporeo”. Egli appartiene a due universi e li rivela entrambi dal lato in cui sono in rapporto. Il corpo umano è il più perfezionato degli organismi ma il suo spirito è tra gli spiriti il più umile. Il senso forte del discorso tomista è che l’uomo non è puro spirito, ma uno spirito incarnato. La nostra vita sì, comunque la si interpreti, si rivela alla coscienza come un'aspirazione all'infinito. L'uomo, però, non sbaglia a riconoscersi superiore alle cose corporali e a considerarsi più che soltanto una particella della natura o un elemento anonimo della città umana. Solo l'uomo sa di andare incontro alla morte. Ciò fa si che la morte umana non sia un puro evento biologico, il termine di un anonimo processo di logoramento, ma abbia risonanze profonde in tutto il nostro essere, scuota il nostro pensiero fino alle ultime radici. L'uomo infatti è il solo essere vivente ad essere persona. L'uomo sa di morire, la coscienza che morrà segna la differenza con il perire. Gli uomini hanno il desiderio di superare i propri limiti, una vera e propria esigenza di infinito. La trascendenza verso cui la natura dell'uomo aspira non è il veleno della libertà da cui difendersi, piuttosto è l'elemento che le conferisce stabilità, significato, futuro e movimento ultimo, in modo tale però che l'essenza della creatura spirituale, ciò che gli appartiene, non risulta per questo sminuita, ma proprio così acquista la sua ultima validità e consistenza e progredisce. Non si comprende l'uomo se non si riesce a vedere con la dimensione orizzontale, intesa come progetto di mondo, implichi un apertura verticale all'assoluto, che costituisce il fondamento stesso nel mondo, conferendogli il suo senso definitivo. Il senso della vita si offre la verità ultima di quanto realizza la nostra libertà. Ogni nostro atto di effettiva libertà si apre sulla profondità dell'assoluto. Tale profondità, si manifesta nell'atto stesso e non al di fuori di esso. L'uomo può e deve decidere in favore di quanto sceglie come il suo senso definitivo; e inizia ad aprirsi all'orizzonte in cui libertà e verità coincidono. Egli stesso sa di esistere, ma non di avere in sé il fondamento del proprio essere. Nella ricerca del suo essere l’uomo rischia di perdersi entro indecifrabili enigmi. Ogni giudizio di verità che l’uomo pone lo apre al problema dell’assoluto, a quanto il linguaggio della religione indica con la parola “Dio”. La parola Dio può essere usata sensatamente solo se indica Colui che sta di fronte all’illimitato bisogno umano di avere un punto fermo. Altrimenti diviene un vocabolo vuoto. Si può rifiutare di ammettere l’esistenza di Dio, ritenendo tale idea solo un’invenzione dell’uomo. Ma non si può eludere il problema di Dio. Con il linguaggio biblico si dirà che l’uomo è relazione vivente con Dio. A lui è legato da una somiglianza: il suo essere sfugge alla presa del calcolo, perché nei suoi occhi porta il riflesso del volto di Dio. 69 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Affermare positivamente il rapporto dell’uomo con Dio conferisce all’esistenza un senso non solo davanti alla storia, ma anche davanti all’eternità. Questa presa di coscienza deve riversarsi dentro un’operosità senza limiti. Nessun uomo può esistere senza religione. Si può non credere a Dio, o almeno credere di non credere, ma il problema di Dio continua ad avere un posto nella vita dell’uomo. Se il posto di Dio resta vuoto non può essere riempito da niente altro. In realtà la questione di Dio scaturisce dall’esperienza di contingenza radicale che l’uomo fa del mondo e di se stesso. L’umanesimo ateo ha diffuso il punto di vista per cui chi si interessa al problema religioso porta a opprimere l’io dell’uomo e ad eclissare la sua libertà. Non è questo l’insegnamento della religione cristiana che nel rapporto con Dio fonda il più rigoroso imperativo di amare il prossimo. 70 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 Conclusione. Vi è nell’uomo una profondità originaria, invariabile, che le varie scienze, anche quelle umane, analizzano. La sua identità non si lascia comprendere né con una descrizione naturalistica né come un mero prodotto dell’evoluzione storica, ma obbedisce a una predelineazione di senso aperta su una realtà eccedente ogni calcolo. Le scienze non sono capaci di esercitare efficacemente la funzione regolatrice e motrice dell’ideale pedagogico. Si può meglio comprendere il nucleo della formazione umana se non ci si limita alla descrizione scientifica, ma si accetta il rischio di un’interpretazione metafisica, la sola capace di scoprire negli atti umani quanto essi hanno d’intellettuale e di morale, e quindi di ricongiungere quanto è fatto o si fa a un’intenzionalità originaria profonda come il mistero, che invita all’umiltà, rispetto, perdono ecc. Il consapevole sentimento di finitezza dell’uomo lo muove alla domanda di partecipare a un “sempre” che solo un Altro può dargli. Nel momento in cui l’uomo si sente finito, imperfetto, mortale non può evitare la nostalgia dell’infinito. Inizia così la ricerca di un Essere assoluto, perfetto, a cui non manca nulla. Chi si occupa di educazione deve aiutare chi è in formazione a capire cosa sia la vita, in modo che egli possa decidere liberamente come vivere, agire, comportarsi di conseguenza. Perché l’educando attinga alla verità della sua persona non bisogna sostituirlo nelle scelte che devono essere sue, né gli si deve imporre una regola morale o psicologica bell’e fatta, quasi una sorta di corazza da indossare una volta per tutte. Ciò accade se l’educazione è un’efficace liberazione dell’uomo dalla pressioni di tutte le forme di trascendenza incapaci di essere immanenti. La sfida dell’educazione implica che ognuno giudichi la scoperta della risposta alla vita non soltanto come un bene in sé, ma come un bene per lui. 71 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected]) lOMoARcPSD|4790068 72 Scaricato da Francesca Cardanelli ([email protected])