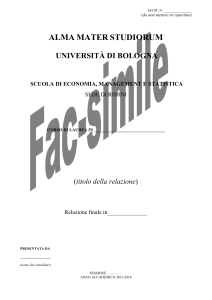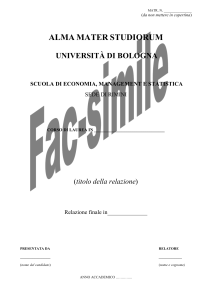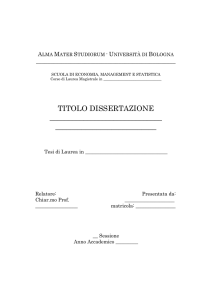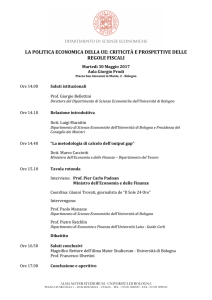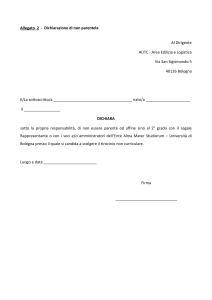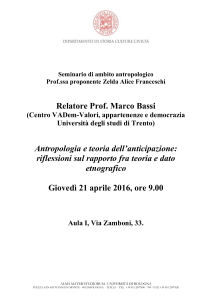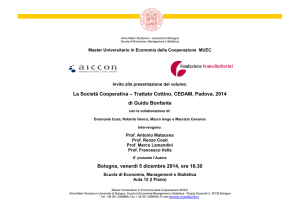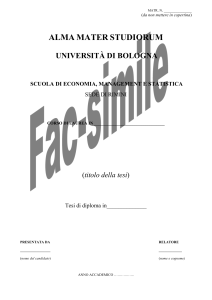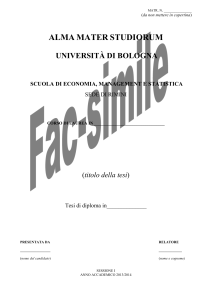caricato da
common.user3465
Cetacei nel Tirreno: Analisi e Distribuzione

Ad Eligio che ha sempre creduto volessi "sanai is topisi". (Ad Eligio che ha sempre creduto volessi curare i topi). Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA Corso di Laurea in Scienze Biologiche Classe L-13 Scienze Biologiche “Analisi della presenza e della distribuzione di cetacei e altre specie di rilevanza IUCN nel Tirreno meridionale mediante l‟utilizzo di transetti fissi” CANDIDATO RELATORE Marzia Mattia Porcu Chiar.mo Prof. Maria Vallisneri CORRELATORE Direttore Fabrizio Atzori Sessione II ________________________________________________________________________________________________________________________ Anno Accademico 2014/ 2015 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna INDICE 1 INTRODUZIONE ....................................................................................................................... 1 1.1 Il progetto e l‟area di studio................................................................................................... 2 1.1.2 AMP Capo Carbonara e AMP Isole Egadi .................................................................. 4 1.2 I cetacei del Mediterraneo...................................................................................................... 5 1.3 Altre specie presenti di rilevanza IUCN................................................................................. 6 1.4 Brevi cenni sulle specie regolari............................................................................................ 7 2 MATERIALI E METODI........................................................................................................... 15 2.1 Raccolta dati ......................................................................................................................... 15 2.2 Protocollo e schede utilizzate................................................................................................. 16 3 ANALISI DATI .......................................................................................................................... 21 4 RISULTATI................................................................................................................................. 22 4.1 Analisi preliminari dei dati sui cetacei................................................................................... 23 4.2 Analisi preliminari dei dati sulle altre specie......................................................................... 26 4.3 Confronto con la tratta Cagliari-Trapani (2013) e Cagliari-Palermo(2014).......................... 28 5 CONCLUSIONI........................................................................................................................... 29 6 BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................................... 30 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 1 INTRODUZIONE Il Mar Mediterraneo viene considerato un bacino chiuso che comunica con le aree adiacenti mediante pochi stretti passaggi: esso è unito ad ovest all‟Oceano Atlantico, attraverso lo stretto di Gibilterra; ad est, tramite il Mar di Marmara, i Dardanelli e il Bosforo, è collegato al Mar Nero; mentre a sud il Canale di Suez mette in comunicazione il Mediterraneo con il Mar Rosso. A livello topografico viene suddiviso in due parti: il Mediterraneo occidentale, delimitato dal canale di Sicilia e caratterizzato da ampie piane abissali, e il Mediterraneo orientale dominato dal sistema della dorsale Mediterranea. Il Mediterraneo occidentale è distinto in due bacini principali, quello algero-provenzale che comprende il mare di Alborán, il mare delle Baleari, il canale di Sardegna, il mare di Sardegna, il mare di Corsica e il mar Ligure, e quello Tirrenico. La piattaforma continentale varia dai 60 kilometri di larghezza (raggiungendo i 72 km presso il Golfo del Leone) a larghezze decisamente inferiori nella zona tra Genova e Tolone, dove si ha un fondale caratterizzato da profondi canyon. Il bacino Tirrenico è la parte più profonda del Mediterraneo Occidentale che raggiunge i 3600 metri di profondità (Fossa del Tirreno): a nord un canale profondo circa 300/400 metri lo mette in comunicazione con il Mar Ligure; lo stretto di Bonifacio, con profondità massima di 50 metri, lo collega con il bacino algerino; il canale di Sardegna, caratterizzato dalla presenza della fossa algerotirrenica, mette in comunicazione i due bacini a sud della Sardegna; ed infine il canale di Sicilia dal basso fondale lo mette in comunicazione con il Mediterraneo Orientale. Il Mediterraneo orientale, invece, contiene il bacino del mare Adriatico, il mar Ionio, il mar Egeo, il mar Libico e il bacino del mar di Levante. Figura 1.1 Batimetria del Mediterraneo utilizzata per il modello WAM alla risoluzione di 1/32°(http://utmea.enea.it) 1 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 1.1 Il progetto e l’area di studio Lo studio effettuato prende in esame la zona a sud del Mediterraneo occidentale, in particolare il canale di Sardegna. Nonostante il Mediterraneo sia un‟area molto circoscritta, la presenza di mammiferi marini è di grande rilevanza: questo ha reso necessario l‟avvio di una serie di programmi finalizzati ad incrementare le conoscenze sulle popolazioni in modo da determinare gli areali di distribuzione, conoscere lo stato di conservazione e valutare gli impatti di origine antropica. Infatti molte specie, abituali e non, di cetacei che popolano i nostri mari sono protette da leggi nazionali o accordi internazionali (Tab.1.1 Direttiva Habitat, Convenzione di Bonn, Convenzione di Barcellona, CITES, CBD, IUCN, Accordo ACCOBAMS). Queste normative richiedono informazioni e programmi di monitoraggio anche al fine di attivare azioni specifiche di tutela e conservazione. specie CITES Berna Bonn ASPIM ACCOBAMS Dir. Habitat Marine Stategy B. physalus ● ● ● ● ● ● ● D.delphis ● ● ● ● ● ● G. melas ● ● ● ● ● ● G. griseus ● ● ● ● ● ● P. macrocephalus ● ● ● ● ● ● S. coeruleoalba ● ● ● ● ● ● T. truncatus ● ● ● ● ● ● Z. cavirostris ● ● ● ● ● ● ● Tabella 1.1 Accordi e leggi tutelanti le singole specie di cetacei. E‟ in questo panorama che si inquadra il progetto, coordinato dall‟ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che da Maggio 2007 ha attivato un network in collaborazione con un‟ampia rete di enti pubblici e privati, università e istituti di ricerca e compagnie di navigazione. È stato così realizzato un progetto di monitoraggio al fine di individuare, su larga scala (lungo le principali rotte commerciali) e a lungo termine, quali sono le aree ad alta densità di cetacei confrontando lo stato degli habitat, l‟effetto della pressione antropica e delle variazioni ambientali. 2 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna La mappatura di queste aree permetterà, inoltre, di prevenire collisioni fra le navi e le grandi balene e di avviare delle strategie atte a ridurre al minimo le interferenze umane con le abitudini delle varie specie che popolano i nostri mari. Figura 1.2 Network di monitoraggio mediterraneo su transetti fissi al 2015. Nel cerchio rosso il transetto considerato per il presente studio. Verde = Transetti monitorati da Giugno a Settembre; Rosso = transetti monitorati tutto l‟anno; Linee tratteggiate =Transetti non attivi. La continuità e la ripetitività del progetto permettono di avere dati annuali e stagionali da poter sovrapporre, per cosi riuscire a monitorare le variazioni nella presenza delle specie di interesse su vasta scala temporale, oltre che spaziale. I risultati permettono inoltre di confermare l‟importanza dell‟area di studio e di migliorare le conoscenze tutt‟oggi limitate sulle specie marine che vivono o migrano in queste acque nonostante la presenza di due AMP ai bordi del canale. Anche dal punto di vista amministrativo la continuazione del progetto permetterà di gestire opportunamente e di limitare al minimo le svariate interferenze antropiche con le specie d‟interesse. 3 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 1.1.2 AMP Capo Carbonara e AMP Isole Egadi Le Aree Marine Protette sono definite “aree costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono”(Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare). La tratta Cagliari-Palermo risulta essere molto importante dal punto di vista geografico. Nelle acque limitrofe alla rotta seguita vi sono due aree marine protette: l‟ Area Marina Protetta Capo Carbonara, vicino al golfo di Cagliari, e l‟ Area Marina Protetta Isole Egadi, nella Sicilia occidentale. È fondamentale sottolineare la presenza di tali zone perché elemento di importanza di un monitoraggio volto alla conservazione e alla difesa di questo tratto di mare: i dati ottenuti dal monitoraggio lungo il transetto nel canale di Sicilia hanno infatti il duplice scopo di fornire informazioni di vasta area utili a completare il quadro conoscitivo necessario per pianificare azioni di gestione adattativa nelle singole Aree Marine Protette e, dall‟altra parte, permettono di sperimentare un‟azione sinergica fra le due Aree Marine Protette al fine di estendere gli effetti di una conservazione pianificata e condivisa anche al tratto di mare compreso fra le due aree. È quindi di grande rilevanza promuovere la connettività tra AMP in quanto la collaborazione potrebbe portare ad una conoscenza migliore delle aree tutelate e delle acque circostanti. 4 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 1.2 I Cetacei del Mediterraneo I Cetacei (Cetacea, Brisson 1762) sono un ordine di mammiferi euplacentati completamente adattati alla vita acquatica (Würsig, 1989; Notarbartolo di Sciara, 1993). Nel Mediterraneo, la cetofauna può essere considerata come un sottoinsieme di quella nordatlantica (sono ritenute, in base a studi di comparazione del DNA, geneticamente separate dalle stesse specie dell‟Oceano Atlantico nord-orientale). Delle 78 specie conosciute di Cetacei, 19 sono state osservate nel Mediterraneo (Guida dei Mammiferi marini del Mediterraneo, Notarbartolo di Sciara, 1997) e, di queste, solo otto possono considerarsi regolari. Queste otto, dal punto di vista delle loro preferenze di habitat, possono essere suddivise in tre gruppi principali: • pelagiche (a profondità medie superiori ai 2000 m) • di scarpata profonda (tra i 1000 e i 1500 m) • neritiche o costiere (profondità inferiori ai 500 m) Specie regolari: • Balenottera comune -Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) • Capodoglio -Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) • Zifio -Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) • Globicefalo -Globicephala melas (Traill, 1808) • Grampo -Grampus griseus (Cuvier, 1812) • Tursiope -Tursiops truncatus (Montagu, 1821) • Stenella striata -Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) • Delfino comune - Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) Specie occasionali: • Balenottera minore -Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) • Orca -Orcinus orca (Linnaeus, 1758) • Pseudorca -Pseudorca crassidens (Owen, 1846) 5 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna • Steno -Steno bredanensis (Lesson, 1828) Specie accidentali: • Balena franca boreale -Eubalaena glacialis (Müller, 1776) • Balenottera boreale -Balaenoptera borealis (Lesson, 1828) • Cogia di Owen -Kogia sima (Owen, 1866) • Focena comune -Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) • Megattera -Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) • Mesoplodonte -Mesoplodon europaeus, M. densirostris, M. bidens • Susa indo-pacifica -Sousa chinensis (Osbeck, 1765) Oltre ai Cetacei, rilevante la presenza occasionale di Pinnipedi (altro ordine di Mammiferi marini): • Foca Monaca -Monachus monachus (Hermann, 1779) (ultimo avvistamento nel Maggio 2015 presso Porto Corallo, Villaputzu) 1.3 Altre specie presenti di rilevanza IUCN (IUCN Red List of Threatened Species, IUCN Red List o Red Data List) Tartaruga verde -Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) Tartaruga liuto -Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) Squalo volpe -Alopias vulpinus (Bonaterre 1788) Figura 1.3 caratteristiche identificative carapace tartarughe. 6 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 1.4 Brevi cenni sulle specie regolari BALENOTTERA COMUNE Specie: Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) Eng: Fin whale, sottordine Misticeti, Famiglia Balaenopteridei. La Balenottera comune è l‟unico misticete regolarmente presente nel Mediterraneo, è il secondo animale al mondo per grandezza (fino a 22 m) e peso (massimo 70 tonnellate), dopo la balenottera azzurra (Balaenoptera musculus) e può vivere fino a 80 anni. Ha un corpo molto affusolato, testa triangolare e sfiatatoio a doppio orifizio ben visibile. La parte superiore risulta grigio scura mentre l‟inferiore risulta biancastra. Non solleva la coda se non occasionalmente. Le collisioni con le navi sono una minaccia per questa specie, che sembra abbia una scarsa capacità di evitare gli impatti con le grandi imbarcazioni. Lunghezza, peso maschio: 20 metri, 70 tonnellate. Nuoto sinusoidale regolare con velocità dai 3 ai 13 nodi. Immersione fino a 230 metri con permanenze in superficie da 20‟‟ ai 1‟. Balenottera comune è classificata come Vulnerabile (VU, vulnerabile) nella Lista Rossa IUCN 2015 per la subpopolazione mediterranea e inserita nell‟Appendice I della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. 7 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna CAPODOGLIO Specie: Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 Eng: Sperm whale sottordine Odontoceti Famiglia Physeteridae. È il più grande odontocete esistente nel Mediterraneo, caratterizzato da un capo enorme di forma squadrata, con la testa che rappresenta 1/3 della lunghezza del corpo, con una pinna dorsale poco evidente e piccole pinne pettorali. La colorazione è tendente al nero o grigio ardesia uniforme. La superficie del corpo, soprattutto sul dorso, si presenta corrugata. In superficie nuota lentamente se indisturbato, mentre è un campione delle immersioni, raggiungendo per alimentarsi profondità medie intorno ai 1000 metri per circa 45 minuti di apnea. Il soffio, basso e diretto obliquamente in avanti di 45°, è un carattere distintivo inconfondibile, così come la coda che, nell‟immersione, viene sollevata verticalmente e rimane in alto per due secondi. I maschi e le femmine adulti formano gruppi separati che si uniscono nel periodo riproduttivo. Può arrivare agli 80 anni di età. Lunghezza, peso maschio: 18 metri, 50 tonnellate. Nuoto sinusoidale con velocità dai 2 ai 7 nodi. Immersione fino a 2000 metri con permanenze in superficie da 20‟‟ ai 1‟. Il capodoglio è classificato come Endangered (EN, in pericolo di estinzione) nella Lista Rossa IUCN 2015 per la subpopolazione mediterranea e inserito nell‟Appendice I della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. 8 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ZIFIO Specie: Ziphius cavirostris Cuvier, 1823 Eng: Cuvier‟s beaked whale sottordine Odontoceti Famiglia Ziphiidae Proporzioni medie e corpo tozzo con un muso caratteristico che ricorda un becco d‟oca. La colorazione è chiara e spesso ha evidenti cicatrici. Nei maschi sono presenti due denti che nella femmina sono del tutto assenti. Il suo comportamento elusivo, la piccola dimensione dei gruppi, l‟estrema localizzazione della specie e l‟habitat di acque profonde, di solito lontano dalla costa, rendono lo zifio difficile da avvistare in mare. Gli zifi sono inoltre campioni nelle immersioni: un nuovo studio ha rivelato che sono i mammiferi che si immergono più in profondità nel nostro pianeta. Nel 2010 è stata registrata un‟immersione di zifio a 2992 metri(Cascadia Research Collective), della durata di quasi due ore e mezza. Anche lui alza la coda prima di un‟immersione profonda anticipata da 2/3 atti respiratori. Lunghezza, peso maschio: 5 metri, 2 tonnellate. Nuoto regolare con muso emerso in velocità. Velocità dai 2 ai 4 nodi. Immersione fino a 3000 metri con permanenze in superficie da 20 ai 40‟. Lo zifio è classificato come “Data Deficient” (DD carente di dati) nella Lista Rossa IUCN 2015 per la subpopolazione mediterranea e inserito nell‟Appendice I della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. 9 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna GLOBICEFALO Specie: Globicephala melas (Traill, 1809) Eng: Long-finned pilot whale sottordine Odontoceti Famiglia Delphinidae Presenta un melone peculiare tendente alla forma semisferica. La pinna dorsale è grossa e inclinata verso la pinna caudale. La colorazione è marrone scura tendente al grigio. Lunghezza, peso maschio: 5 metri, 2 tonnellate. Nuoto normalmente lento con non rare evoluzioni aeree. Immersione fino a 600 metri. In emersione tende a tenere la testa in avanti fuori dall‟acqua. Il globicefalo è classificato come “Data Deficient” (DD carente di dati) nella Lista Rossa IUCN 2015 per la subpopolazione mediterranea e inserito nell‟Appendice I della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. 10 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna GRAMPO Specie: Grampus griseus (G. Cuvier, 1812) Eng: Risso‟s dolphin sottordine Odontoceti Famiglia Delphinidae Il grampo è un delfino di medie dimensioni. A breve distanza è abbastanza facile da riconoscere in mare per la sua pinna dorsale piuttosto grande e alta, anche rispetto a quella del tursiope, con cui però può essere confuso a distanza. Il grampo ha un capo arrotondato e privo di rostro, pinne pettorali piuttosto lunghe e un corpo robusto. Il carattere esterno tipico del grampo è la colorazione, che è variabile con l‟età. Infatti, crescendo la pigmentazione può passare dal grigio chiaro dei cuccioli, al grigio-scuro ardesia per arrivare al bianco degli adulti, per la depigmentazione della loro pelle. Un‟altra particolarità è che da adulto il grampo può essere quasi completamente ricoperto di estese cicatrici permanenti che si accumulano sul corpo con l‟età. Il grampo in Mediterraneo forma gruppi da 3-5 individui fino a 15-20. Un comportamento frequente di questo delfinide è l‟head-standing, in cui un animale porta lentamente fuori dall‟acqua la coda e la parte posteriore del corpo, salendo in verticale verso l‟alto e rimanendo in questa posizione per diversi secondi. Lunghezza, peso maschio: 3metri, 700 kg. Nuoto normalmente molto rapido (fino a 20 nodi), agile ed elegante e può compiere salti e acrobazie. Immersione fino a 500 metri. Comuni evoluzioni verticali e orizzontali. Il grampo è classificato come “Data Deficient” (DD carente di dati) nella Lista Rossa IUCN 2015 per la subpopolazione mediterranea e inserito nell‟Appendice II della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale 11 delle specie minacciate di estinzione. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna STENELLA STRIATA Specie: Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) Eng: Striped dolphin sottordine Odontoceti Famiglia Delphinidae La stenella striata è considerata il cetaceo più comune del Mediterraneo. Si distingue dal delfino comune per una visibilissima “fiamma” di colore bianco o grigio chiaro, che parte dalla zona del capo verso la pinna dorsale. E‟ chiamata “striata” per via di tre bande, più o meno scure e marcate, che partono dall‟occhio e ne percorrono i fianchi verso l‟area genitale. Può formare gruppi numerosi: in genere da 10–40 individui fino a più di 100. Lunghezza, peso maschio: 1,7 metri, 80 kg. Nuoto attivo e veloce, si esibiscono in una grande varietà di comportamenti “acrobatici” come salti, surf sulle onde e avvitamenti in aria. Talvolta hanno un comportamento confidente nei confronti delle imbarcazioni, cavalcandone l‟onda di prua (“bow riding”). Immersione discontinua. La stenella striata è classificata come Vulnerable (VU, vulnerabile) nella Lista Rossa IUCN 2015 e inserita nell‟Appendice II della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. 12 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna TURSIOPE Specie: Tursiops truncatus (Montagu, 1821) Eng: Common bottlenose dolphin sottordine Odontoceti Famiglia Delphinidae Ha una corporatura possente e muscolosa e un rostro corto e tozzo (da cui deriva l‟epiteto truncatus) munito di denti robusti e conici. In natura può vivere fino a 40-50 anni. Ha una colorazione grigio scura con i fianchi più chiari e la parte ventrale più pallida. L‟organizzazione sociale del tursiope è quella più studiata e meglio conosciuta tra i cetacei. Si incontra spesso solitario o in piccoli branchi di 5–10 individui, ma talvolta vengono osservati gruppi numerosi, anche di 20-30 individui. Lunghezza, peso maschio: 2metri, 275 kg. Nuoto molto variabile in base alla situazione. Immersione fino a 200 metri. Il tursiope è classificato “Vulnerabile” (VU) nella Lista Rossa IUCN 2015 per la subpopolazione mediterranea e inserito nell‟Appendice II della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione e negli Allegati II e IV della Direttiva Europea Habitat. Figura Profilo comune a Tursiops truncatus. Stenella coeruleoalba, Delphinus delphis. 13 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna DELFINO COMUNE Specie: Delphinus delphis Linnaeus, 1758 Linnaeus, 1758 Eng: Short beaked common dolphin sottordine Odontoceti Famiglia Delphinidae Il delfino comune ha una forma snella, un rostro lungo e sottile e raggiunge dimensioni leggermente maggiori della stenella striata . Si distingue sui lati per la colorazione peculiare del disegno a clessidra rovesciata, con una zona toracica color senape e una posteriore grigio chiara. Il dorso è scuro e il ventre color panna. E‟ una specie gregaria e può arrivare a formare gruppi anche di 300 individui, ma negli oceani può superare anche il migliaio. La sua vita media si aggira intorno ai 2030 anni. E‟ un delfino che predilige sia habitat pelagici che costieri, talvolta in associazione con stenella striata e tursiope. Ha un comportamento simile a quello della stenella striata: anch‟esso è in grado di compiere salti e acrobazie e di nuotare ad elevate velocità. Lunghezza, peso maschio: 1,5 metri, 75 kg. Nuoto vario ma solitamente rapido. Immersione fino a 300 metri Il delfino comune del Mar Mediterraneo è stato classificato nel 2003 come Endangered (EN, in pericolo) nella Lista Rossa IUCN 2015. È inserito nell‟Appendice II della CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. 14 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 2 MATERIALI E METODI Dal 2013 fino ad oggi, l‟Area Marina Protetta Capo Carbonara in collaborazione con ISPRA, si occupa di monitorare, durante i periodi estivi, le 171 NM (miglia nautiche) che intercorrono tra Cagliari e Palermo (il primo anno il transetto era Cagliari - Trapani). Questo è tutt‟ora possibile grazie alla collaborazione con la società di navigazione Tirrenia CIN che ha concesso a 4 osservatori di presiedere sul ponte di comando del traghetto Dimonios. In questo studio sono stati presi in considerazione i dati raccolti nel periodo compreso tra Giugno e Settembre 2014. 2.1 Raccolta dati Fra le varie tecniche di monitoraggio cetacei disponibili in Italia, quello dei transetti fissi è utilizzato ormai ampiamente in quanto permette in modo efficace, e soprattutto con un costo contenuto, di monitorare, a intervalli regolari e per un lungo periodo, un ampio areale ottenendo un quantitativo di informazioni più che adeguato all‟analisi e al confronto. I vantaggi del metodo sono: Ripetibilità Correlazione con parametri ambientali e pressioni antropiche Possibilità di rilevare specie eventi rari Possibilità di monitorare ampie zone d‟alto mare Costo contenuto Per la raccolta dei dati è stato applicato il protocollo redatto dall‟ISPRA “Fixed line transect using ferries as platform of observation” (ISPRA 2012) attraverso osservazioni visive su transetto lineare coincidente con la tratta Cagliari-Palermo. Durante la navigazione sono stati registrati sistematicamente: dati meteo-marini, dati di origine antropica, come il traffico marittimo, presenza di cetacei, tartarughe e altre specie marine di interesse (Alopias vulpinus, M. mobular, Thunnus spp.). 15 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 2.2 Protocollo e schede utilizzate. Per gli avvistamenti viene utilizzato personale competente in quanto è facile cadere in errori dovuti all‟inesperienza. Gli osservatori si dispongono generalmente in coppia sui due lati del ponte di comando, raccogliendo dati solo quando le condizioni meteorologiche risultano essere idonee, con stato Beaufort <4 (on effort). Gli osservatori più esterni monitorano prevalentemente il versante laterale dell‟imbarcazione mentre quelli centrali operano prevalentemente sulla direzione di rotta tenendo conto così dell‟intero spazio compreso dall‟orizzonte al ponte di comando. Principali variazione di “Visibilità” possono essere dovuti a: -errore di disponibilità dell‟esemplare: si presenta quando l‟animale non può essere osservato come nel caso di una immersione dell‟individuo; -errore di percezione quando l‟operatore per fattori come condizioni meteorologiche o di affaticamento non è in grado di avvistare. Per evitare di introdurre errori di percezione, il protocollo di campionamento prevede il settaggio di condizioni standard per l‟osservazione che tengono conto ad esempio di: Gradiente di densità I transetti sono stati scelti in modo da essere perpendicolari a possibili gradienti di densità delle popolazioni animali (es. rotte di migrazione delle balenottere) Condizioni Il monitoraggio viene eseguito con scala Beaufort ≤3 (≤2 per Ziphius metereologiche cavirostris) Velocità, tipo di Vengono usati solo traghetti con velocità comprese fra 17-27kn e di imbarcazione simile tipologia (es. Ponte commando fra 12-20m) Esperienza In uno studio preliminare sono state osservate variazioni anche del 50 % dell‟osservatore fra osservatori esperti o no, vengono quindi utilizzati per il monitoraggio solo osservatori esperti e dedicati al programma 16 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Distanza La probabilità di osservazione cambia con la distanza quindi la effective strip width viene stimata per ogni transetto/tipo di traghetto utilizzato. Il dato rimane costante all‟interno della stessa tipologia di traghetto Stima della distanza Da uno studio preliminare è stata verificata l‟efficacia dell‟utilizzo del measuring stick per la stima della distanza Riconteggio degli Viene concentrato lo sforzo di osservazione nell‟angolo di 130° da prua animali dell‟imbarcazione ad entrambi i lati, per evitare il possibile riconteggio degli animali a poppa. Vengono inoltre effettuate analisi preliminari di correlazione fra andata e ritorno sullo stesso transetto, se effettuate all‟interno di una settimana Identificazione di specie Può variare con l‟esperienza dell‟osservatore: solo osservatori esperti e grandezza del gruppo vengono utilizzati nel programma e vengono effettuate foto per aiutare nell‟identificazione delle specie e della grandezza del gruppo Risposta attiva E‟ limitata dal range di velocità utilizzate dall‟imbarcazione utilizzata dell‟animale nel monitoraggio e dall‟angolo utilizzato come campo di osservazione all‟imbarcazione Errori di trascrizione del Il dato viene sempre validato da un esperto indipendente prima di essere dato utilizzato per le analisi. In alcuni casi viene utilizzata un‟applicazione dedicata 17 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna SCHEDE UTILIZZATE: Data Collection Sheet: Meteo Utilizzate per annotare ogni tipo di variazione metereorologico-ambientale: utile per valutare le condizioni “on effort” e “off effort”. Scheda 2.1 Data collection sheet: Meteo 18 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Data Collection sheet: sightings cetacean and other species Per ciascun avvistamento viene registrata la specie, il numero di individui, la presenza di cuccioli, il comportamento e la eventuale presenza di altre imbarcazioni e/o attrezzature umane. Scheda 2.2 Data collection sheet: Sighthings Scheda 2.3 Data collection sheet: Sighthings other species 19 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Data Collection sheet: Naval traffic Periodicamente si registra la presenza di imbarcazioni in modo da valutarne l‟influenza e la correlazione con la presenza di animali. Scheda 2.4 Data collection sheet: Naval Traffic 20 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 3 ANALISI DATI: I dati sperimentali trascritti sulle schede sono stati poi riportati in un foglio di calcolo Excel e comparati con i dati sperimentali dell‟anno precedente sulla tratta similare CA-TRA, CagliariTrapani. Per ogni transetto, di cui viene indicata tratta, anno e numerazione si registrano i dati relativi a: condizioni meteo eventuale presenza di imbarcazioni durante gli avvistamenti ampiezza del gruppo e all‟eventuale presenza di cuccioli comportamento nei confronti della nostra piattaforma e/o all‟interno del gruppo direzione del nuoto I valori così ottenuti ci hanno dato modo di calcolare la frequenza relativa (numero di avvistamenti della singola specie su avvistamenti totali) e gli Encounter Rate (ER), ovvero i tassi di incontro calcolato come avvistamenti per 100 km percorsi in osservazione con meteo favorevole, relativi ad ogni singola traversata. In questo modo si è ottenuto l‟ER medio stagionale per ciascuna specie, considerando ciascun transetto come unità statistica di base. È stato quindi calcolato: • Frequenza relativa delle specie: numero di avvistamenti di una specie su totale degli avvistamenti (in percentuale) • Tasso di incontro (ER): numero di avvistamenti di ogni specie diviso per i km percorsi in osservazione con meteo favorevole in ogni singola traversata moltiplicato 100; l‟ER per il totale della stagione si ottiene dalla media degli E.R. di ciascun transetto effettuato nell‟annualità considerata (estate 2014). Il tasso di incontro calcolato per l‟estate 2014 è stato poi confrontato con quello rilevato nell‟annualità precedente (estate 2013). Le coordinate dei punti degli avvistamenti della stagione 2014 sono state elaborate con un software GIS (MapSource, BaseCamp; ArcMAP 10.1) che ci ha permesso di elaborare le mappe di distribuzione delle diverse specie e relazionarli con i dati raccolti durante l‟annualità precedente, sulla base del loro comune riferimento geografico, in modo da creare nuove informazioni a partire dai dati esistenti. 21 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 4 RISULTATI. Dal 27 luglio all‟8 settembre 2014, sono state monitorate dai ricercatori 1.462,414 miglia nautiche fra Cagliari (Sardegna ) e Palermo (Sicilia) dal ponte comando del traghetto Dimonios della società di navigazione Tirrenia (Tab.4.1; Fig.4.1). Tabella 4.1 Risultati generali Traversate 11 Periodo Dal 27/07/2014 Al 08/09/2014 Ore 69 Min 25 Km per traversata 420 226,68 NM Km TOT on effort 2708,39 1.462,414 NM TOT ore on effort Figura 4.1 Area di studio e i transetti on effort della stagione 2014 in grigio. 22 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 4.1 Analsi preliminari dei dati sui cetacei Durante le 11 traversate sono stati effettuati complessivamente 46 avvistamenti per un totale di 226 animali cosi ripartiti: 23 avvistamenti di S coeruleoalba per un totale di 166 individui 2 avvistamenti di T.truncatus per un totale di 8 individui 1 avvistamento di P.macrocephalus di cui 3 individui 20 avvistamenti di esemplari non identificati di cui 49 individui Nella seguente tabella e figura è riportato il numero di avvistamenti,la loro frequenza relativa e i tassi di incontro: Tabella 4.2 Numero avvistamenti di cetacei, Frequenza relativa e Tassi di incontro cetacei. Cetacei N. avvistamenti Frequenza relativa Tassi di incontro S.coeruleoalba (stenella) 23 50% 0,677 T.truncatus (tursiope) 2 4% 0,196 P.macrocephalus (capodoglio) 1 2% 0,023 Ni 6 13% 0,15 Nis 11 24% 0,26 Nib 3 7% 0,08 Figura 4.2 Frequenza relativa (numero di avvistamenti di una specie su totale degli avvistamenti) delle diverse specie di cetacei. 23 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Delle 8 specie ritenute presenti regolarmente in Mediterraneo ne sono state identificate solo 3. Fra queste è da subito confermata la preminenza di stenella striata con una frequenza relativa pari a 50% rispetto al totale degli avvistamenti (20 volte superiore a quella di tursiope e capodoglio). Analizzando il tasso di incontro (numero di avvistamenti su 100 km di effort) i risultati mostrano un tasso di incontro totale medio di 1.3 avvistamenti su 100 km di osservazione in condizioni standard, con una presenza prevalente di stenella (0.7 avvistamenti/100Km) seguita da tusiope (0.19 avvistamenti/100Km) e capodoglio (0.02 avvistamenti/100Km) (fig. 4.3). Tasso di incontro (sight/100Km on effort) cetacei Cagliari -Palermo Estate 2014 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Encount er rate (sight/Km on effort 0,1 0 S.coeruleoalba T.truncatus P.macrocephalus Ni Nib Nis Figura 4.3 Tasso d‟incontro cetacei Estate 2014. Tasso di incontro (Encounter rate) = avvistamenti per 100 Km di osservazione. Tabella 4.3 Dimensioni medie dei gruppi delle specie di cetacei avvistati. Cetacei Dimensioni medie dei gruppi S.coeruleoalba (stenella) 7 T.truncatus (tursiope) 2 P.macrocephalus (capodoglio) 1 24 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Si è inoltre rilevata una corrispondenza specifica di alcuni areali con determinate specie verificando la peculiare presenza di queste in alcune aree definite. Nella figura sottostante (Fig. 4.4) sono stati evidenziati i punti di avvistamento di cetacei dell‟intera tratta 2014. Figura 4.4 Punti di avvistamento delle diverse specie di cetacei (CAPAL 2014) 25 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 4.2 Analisi preliminari dei dati sulle altre specie Oltre agli avvistamenti di cetacei nelle traversate è stata rilevata la presenza di altre specie e, fra queste, una considerevole abbondanza di Caretta caretta, classificata dalla IUCN Red List come specie in pericolo di estinzione (Endangered). Tabella 4.4 Numero avvistamenti, Frequenza relativa e tassi di incontro altre specie. Altre specie N. avvistamenti Frequenza relativa Tassi di incontro Caretta caretta (tartaruga comune) 118 95% 3,448 Mobula mobular (manta) 2 2% 0.074 Mola Mola (pesce luna) 2 2% 0,074 Shark (squalo) 1 1% 0,037 Thunnus ssp (tonno) 1 1% 0,037 Su 122 avvistamenti OS 118 sono di C.caretta per un totale di 131 esemplari la cui presenza è stata significativa lungo tutta la tratta ma con alcune aree di maggiore densità. Nel seguente grafico si mette in evidenza la netta sovra presenza di caretta nella tratta osservata. Grafico 4.1 Frequenza relativa altre specie (CAPAL 2014) 26 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Nella mappa sottostante è possibile visualizzare i punti di incontro delle carette nella stagione 2014. Figura 4.5 Punti di avvistamento delle altre specie (CAPAL 2014) Ulteriormente ragguardevole, ma non paragonabile, presenza di: Mola mola (Linnaeus, 1758) Mobula mobular (Bonnaterre, 1788) Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Thunnus thynnus (Linnaeus 1758) 27 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 4.3 Confronto con la tratta Cagliari-Trapani (2013) e Cagliari-Palermo(2014) I dati delle due annualità risultano similari tra loro, con un leggero aumento del tasso di incontro generale nel 2014 guidato dall‟aumento di tasso di incontro di Stenella coeruleoalba e Tursiops truncatus. Gli avvistamenti di P.marcrocephalus, D.delphis e G.griseus prevalenti nella estate 2013, essendo degli eventi rari e di difficile individuazione potrebbero dipendere in parte dal caso (Fig. 4.6) Figura 4.6 Confronto tasso di incontro 2013-2014 cetacei. 28 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 5 CONCLUSIONI Il metodo utilizzato seguendo il protocollo ISPRA (Arcangeli, 2012) si è confermato idoneo e efficiente allo scopo, ed è stato validato anche per il monitoraggio delle tartarughe marine. In 11 traversate sono state monitorate sistematicamente 1.462,414 miglia nautiche in buone condizioni meteo fra Cagliari (Sardegna) e Palermo (Sicilia) con 46 avvistamenti totali di cetacei. I risultati di questa campagna di monitoraggio cetacei, condotta nella stagione estiva 2014 nelle acque sardo-siciliane mostrano un tasso di incontro di cetacei, pari a 1.5 avvistamenti per 100 km percorsi in condizione standard lungo il transetto, valore in linea con quello rilevato nella precedente annualità (estate 2013, 1.4 avvistamenti/100Km) e con quelli medi rilevati lungo i transetti del Santuario Pelagos (Arcangeli et al., 2014). E‟ evidente la presenza costante di Stenella coeruleoalba su varie batimetrie (50% degli avvistamenti totali), in gruppi di dimensione media pari a 7,2. La presenza di Tursiops truncatus (frequenza relativa pari al 4% del totale degli avvistamenti) si conferma limitata alle aree semi-costiere sarde e siciliane in piccoli gruppi (media= 3). Confermata per il secondo anno l‟occasionale presenza di Physeter macrocephalus (2% degli avvistamenti) avvistato a sud-est dell‟AMP Capo Carbonara, nella stessa area in cui era stato avvistato nella precedente annualità (estate 2013). Nelle due annualità i dati risultano similari tra loro: differenze sono state rilevate nell‟avvistamento di P.macrocephalus e G.griseus ma il risultato potrebbe essere ricondotto a variabili dovute alla rarità di incontro di queste specie, che rendono il dato più soggetto a variazioni dovute al caso. Il dato sorprendente (in entrambe le stagioni) è la inusuale abbondanza di C.caretta (Frequenza relativa di 0,95) rispetto a quanto osservato negli altri transetti della rete di monitoraggio coordinata da ISPRA. Questi ultimi dati, che si confermano nelle due annualità, suggeriscono una distribuzione non omogenea della specie nel Mediterraneo ed evidenziano l‟importanza dell‟area del canale di Sardegna, almeno durante la stagione estiva. Rilevanti anche gli avvistamenti occasionali di T.thynnus e M.mobular. A fronte dei dati ottenuti, si conferma l‟importanza dell‟area di studio ed il valore di questo lavoro per migliorare le conoscenze sulla biodiversità marina dell‟area e ne consegue una doverosa continuazione di monitoraggio nelle stagioni successive. 29 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 6 BIBLIOGRAFIA ARCANGELI A., AISSI M., ARAGNO P., ATZORI F., AZZOLIN M., BACCETTI N., CAMPANA I., CASTELLI A., CERRI F., CINTI F., CROSTI R., DAVID L., DI MEGLIO N., FRAU F., LIPPI S., LUPERINI S., MAFFUCCI F., MARINI L., MOULINS A., PARABOSCHI M., PELLEGRINO G., RUVOLO A., TEPSICH P., TRINGALI M. (2014). Cetacean, marine birds, sea turtle, marine traffic and floated marine litter: potential of a synoptic multi-disciplinary data collection in the Western Mediterranean Marine Region. Biol.Mar.Med. 21 (1): 366-368. ARCANGELI A., CASTELLI A., MARINI L., MOULIN A., PALIAGA B., TEPSICH P., TRINGALI M. (2013). A cooperative program for studying and monitoring cetacean in Mediterranean Sea. Biol.Mar.Med. 20 (1): 254-255. ARCANGELI A., COMINELLI S., DAVID L., DI-MEGLIO N., MOULINS A., MAYOL P., MARINI L., ROSSO M., TEPSICH P., 2014. Seasonal monitoring of cetaceans and validation of the system REPCET in terms of monitoring. Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, 28: 37-48. ATZORI F., FRAU F., CINTI M. F., CORRIAS S., LIPPI S., PALIAGA B., ARCANGELI A. The role of Marine Protected Areas for monitoring marine species: the example of Capo Carbonara MPA in the Sardinia channel. 27° European Cetacean Society Conference. April 2014. Liége, Belgium. BORNIOTTO LUCIO; LIMARDO ROBERTA; (01/1999) Incontrare i cetacei. Ugo Mursia Editore. CARWARDINE MARK; (2004) Balene e delfini. Guida illustrata ai cetacei di tutto il mondo. Dorling Kindersley Handbook Editore. Cinti M.F., Atzori F., Frau F., Corrias S., Lippi S., Ghiani R., Donati S., Arcangeli A. Monitoring marine species (cetacean, sea turtle) in the Sardinian channel Connecting Marine Protected Areas. Biol. Mar. Mediterr. (2014), 21 (1): 371-372. 30 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ISPRA (2012) - Fixed line transect using ferries as platform of observation monitoring protocol. Allegato tecnico della convenzione quadro per lo svolgimento di attività di “Fixed line transect using ferries as platform of observation for monitoring cetacean populations”. ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA „schede cetacei‟. MAURIZIO WURTZ; NADIA REPETTO; (1998) Balene. Delfini. Guida alla biologia e al comportamento dei cetacei. White Star Edizioni. NOTARBARTOLO DI SCIARA; DEMMA MASSIMO; (2004) Guida dei mammiferi marini del Mediterraneo. Franco Muzio Editore. Web references: http://www.ilgiornaledeimarinai.it/i-mammiferi-campioni-dapnea/ http://www.iucnredlist.org/ http://www.iucnredlist.org/initiatives/mediterranean/mammals http://www.seame.it/ 31 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna RINGRAZIAMENTI Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nella realizzazione di questa Tesi e nel conseguimento di questa laurea. Va doverosamente ringraziata, in quanto indispensabile, la dottoressa Antonella Arcangeli (ISPRA), senza la cui guida avrei impiegato per lo meno altri sei anni. Non meno importante la dottoressa Lara Carosso e la sua grande capacità di sopportazione a cui, soprattutto, mi sento di esser grata. Ringrazio inoltre il direttore Fabrizio Atzori e l‟intera Area Marina Protetta Capo Carbonara per l‟opportunità concessami. La mia vera riconoscenza però, non solo per questo lavoro ma perché ha influenzato e influenza tutt‟ora la mia intera esistenza, va alla Sardegna e a tutto quello che comporta essere nata su quest‟isola, a mia madre e alla famiglia Pili, che mi supporta ancora in tutto quello che faccio e che inspiegabilmente, continua ad amarmi, agli Errata Corrige e agli altri amici veri, senza cui nessuna sbronza avrebbe senso. A Grisù, il mio unico rimpianto. GRAZIE.