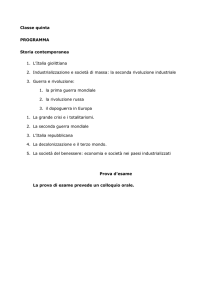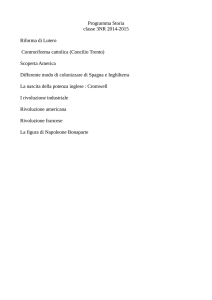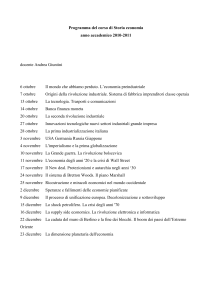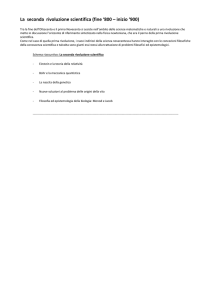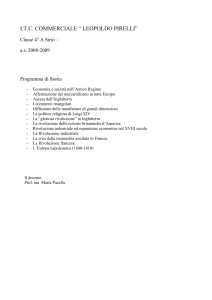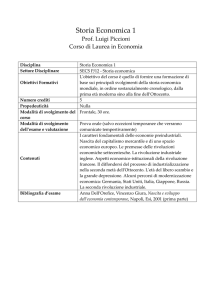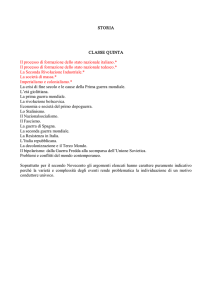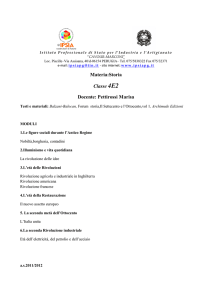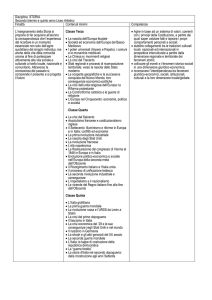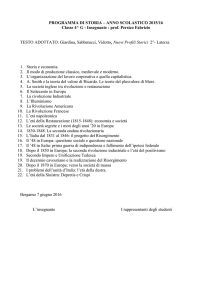caricato da
common.user1949
Storia d'Impresa: Complessità e Comparazioni - Parte I

STORIA D’IMPRESA – Complessità e comparazioni
PARTE I – TEMI DI FONDO
INTRODUZIONE
Il tema di questo libro è lo sviluppo economico moderno, osservato attraverso l’analisi di uno dei suoi attori
principali: l’impesa. Sulla scia della grande recessione del 2008-2010, molti hanno cominciato a riflettere approfonditamente sulle imprese, sul loro impatto sulla società e sulle opportunità economiche del presente.
Le fasi della transazione da un paradigma tecnologico all’altro, sono determinate da variabili quali:
le competenze tecniche;
la conoscenza scientifica;
le fonti di energia;
l’intensità di capitale.
Molti attori contribuiscono a determinare il valore di queste variabili, e fra questi è l’impresa, sicché un paradigma tecnologico di lungo periodo appare contemporaneamente esogeno ed endogeno alla storia delle
imprese. Il progresso tecnologico è cumulativo, ma registra anche sostanziali discontinuità.
Definiamo imprenditori coloro che innovano, assumono rischi, colgono le opportunità e, soprattutto, assumono le decisioni ai massimi livelli aziendali. I più importanti sono coloro che riescono a sincronizzare l’attività della loro impresa con le caratteristiche del paradigma tecnologico che offre il contesto in cui si trovano
a operare. Da questo punto di vista, evidenziamo diversi livelli di imprenditorialità, e una tipologia variegata
di imprenditori.
I manager sono coloro che, portatori di competenze teoriche ed esperienza pratica, hanno sviluppato un
preciso sapere funzionale, spesso radicato nella specificità della singola impresa. La loro caratteristica distintiva è che godono di autonomia decisionale in un segmento significativo dell’attività aziendale, di solito nel
quadro della strategia delineata dall’imprenditore.
Lo Stato riveste diversi ruoli nella nostra narrazione. In molti contesti rappresenta:
il garante della cornice giuridica al cui interno si svolge l’attività economica;
il fornitore di infrastrutture, reali o intangibili;
può essere il regolatore;
imprenditore e partecipante alla competizione economica;
pianificatore, a livello centrale o per settori specifici.
Ciò che funziona in una fase storica non necessariamente funziona anche in quella successiva. Chi mai nel
1800 avrebbe potuto immaginare il declino del Regno Unito alla metà del XIX secolo, l’ascesa degli Stati Uniti
e della Germania intorno al 1900, il declino degli stessi Stati Uniti dopo gli anni sessanta, l’ascesa e il declino
del Giappone negli ultimi quattro decenni o l’enorme crescita della Cina alla fine dell’era maoista?
Con la decisa insistenza sul ruolo della grande impresa industriale quale motore dello sviluppo economico,
Chandler ha messo molti studiosi in una posizione difficile. L’originale metodologia chandleriana (con la sua
attenzione concentrata sull’azione imprenditoriale capace di generare la grande impresa, e sulla comparazione fra i cambiamenti strutturali registrati in centinaia di imprese) ha reso possibile sviluppare generalizzazioni, punto di riferimento fondamentale non solo per gli storici, ma anche per studiosi di altre discipline.
CAPITOLO 2 - STORIA E TEORIE D’IMPRESA
Una nuova unità di analisi
Dall’inizio del XIX secolo l’impresa è stata identificata sempre più con la fabbrica, cioè con la modalità inglese
di organizzazione della produzione che, con la tecnologia relativa, si è diffusa progressivamente nel continente europeo. Grazie a questa innovazione, l’Europa ha sperimentato un consolidamento del suo potere
politico ed economico che ha avuto ripercussioni in tutto il mondo. Quando la prima rivoluzione industriale
ha preso avvio, alla fine del XVIII secolo, la concentrazione del capitale e forza lavoro in un unico luogo fisico
non era una novità.
Nel settore tessile mercanti-imprenditori facevano affidamento su numerosi lavoratori a domicilio, mentre
le fasi del processo produttivo ad alta intensità di capitale erano svolte in impianti centralizzati gestiti direttamente dagli imprenditori, spesso con l’impiego di lavoratori specializzati.
Le nuove fabbriche (normalmente localizzate lontano dai centri urbani) utilizzavano l’acqua e, in seguito il
vapore. Così si creò un’organizzazione d’impresa altamente produttiva e sempre più efficiente, che diventò
l’unità fondamentale delle prime economie industriali.
La natura mutevole dell’impresa
È importante riconoscere che l’impresa e le sue interpretazioni sono state al centro dell’interesse di numerose discipline oltre all’economia e agli studi di management. La transizione della produzione artigianale –
condotta da lavoratori specializzati e generici nell’ambiente domestico - alla fabbrica ha comportato una
radicale trasformazione dello status giuridico della stessa unità produttiva.
Nel secolo passato la crescita delle imprese ha comportato ulteriori, sostanziali trasformazioni, con l’affermazione di nuove forme giuridiche e organizzative necessarie a sostenere la crescente complessità delle attività aziendali.
Partendo dalle teorie delle organizzazioni burocratiche di Max Weber, passando al funzionalismo di Talcott
Parsons, e arrivando alle più recenti analisi del conflitto e dell’evoluzione sociali, questi studi hanno migliorato la nostra comprensione delle attività interne all’impresa e delle sue relazioni con l’esterno, nel mercato
e nei confronti di altre autorità.
La prospettiva neoclassica
Nel pensiero economico la prospettiva originaria sull’impresa è quella proposta dalla teoria neoclassica, un
approccio analitico piuttosto statico che considera il comportamento dell’impresa in un segmento temporale
definito.
L’impresa rappresentativa dispone di un’informazione perfetta e opera in maniera efficiente al punto più
basso della curva di costo marginale. La teoria neoclassica non indaga sull’evoluzione dal momento 1 al momento 2, o all’eventuale fase 3. L’impresa rappresentativa è di dimensioni medio-piccole e svolge un numero
limitato di funzioni.
L’impresa neoclassica opera all’interno di un price-oriented, altamente competitivo, caratterizzato dalla presenza di:
numerose unità produttive nello stesso settore;
minima integrazione funzionale;
assenza di tecnologia esclusive.
Le conoscenze tecniche e le altre informazioni erano ipotizzate come liberamente disponibili, o ottenibili a
costi minimi.
La prospettiva neoclassica ha una particolare rilevanza per la storia dell'impresa nella prima rivoluzione industriale. Descriveremo infatti nei prossimi capitoli come questa prima trasformazione industriale non abbia
prodotto immediatamente quel tipo di grande impresa integrata, ad alta intensità di capitale, che oggi è per
noi familiare. Alcune si diffusero velocemente attraverso un processo che è stato definito di «invenzione
collettiva», simile all'odierno sistema open source, nel quale le innovazioni incrementali circolano liberamente fra gli utenti, ciascuno dei quali contribuisce a incrementare lo stock condiviso di conoscenze.
Dinamica economica in prospettiva storica
In contrasto con questo tipo di impostazione teorica, la storia d'impresa ha una specifica dimensione comparativa e dinamica: le imprese sono viste come unità complesse che evolvono nel tempo, caratterizzate da
notevoli differenze nelle loro strutture e dinamiche interne. Nonostante la loro estrema varietà, gli storici
cercano di proporre generalizzazioni: sebbene le imprese operino in molti Paesi diversi con distinte strutture
proprietarie e organizzative, quelle appartenenti allo stesso settore di solito condividono alcune caratteristiche di rilievo, quali l'intensità di capitale e di lavoro.
Data una certa tecnologia, ci si aspetta che le imprese si espandano fino al punto in cui - nel linguaggio dell'economia neoclassica - i rendimenti marginali cominciano a decrescere. Nel mondo reale, tuttavia, la crescita
non è un processo meccanico, soggetto solo ai calcoli economici. Le imprese possono continuare a espandersi, alla ricerca di maggiori quote di mercato, anche in presenza di una riduzione nel tasso di crescita dei
profitti. Per esempio, le nuove tecnologie dell'informazione degli anni più recenti incentivano la crescita interna e l'ulteriore integrazione, consentendo di diminuire l'impatto dei costi di informazione sulle attività del
management.
Infine, va considerata la complessità relazionale. Il processo di sviluppo economico dei due secoli passati ha
creato organizzazioni estremamente complesse, con significative relazioni interne ed esterne.
Data una certa tecnologia, lo sviluppo dell'impresa è spesso determinato dalle dimensioni e dal dinamismo
del mercato di consumo. Altri due elementi significativi capaci di determinare l'espansione dell'impresa possono essere:
l'efficienza dei mercati finanziari nel convogliare le risorse necessarie alla stessa;
la presenza di una cornice giuridica che protegga i suoi asset e faciliti l'attività economica.
Tutti questi fattori di sviluppo interagiscono. Tecnologie e mercati sono molto sensibili ai cambiamenti che si
verificano nel sistema giuridico e nei mercati finanziari, e questi elementi dinamici possono spingere l'impresa
a compiere adattamenti e adeguamenti.
Nel caso del consumo di birra, per esempio, esistono ancora oggi radicali differenze di opinione negli Stati
Uniti e nell'Europa continentale, e questo condiziona non soltanto gli standard tecnologici, ma anche le scelte
strategiche degli attori economici che operano nel settore. In altri casi, la struttura dei mercati finanziari può
avere conseguenze dirette sulla disponibilità di risorse, in termini sia di quantità che di qualità.
Teoria e realtà delle grandi imprese
Molti anni fa l'economista austriaco Joseph Schumpeter ha lanciato una sfida all'approccio neoclassico. La
riflessione di Schumpeter era costruita su due assunti fondamentali:
il primo riguardava la «propensione competitiva» dell'impresa intesa quale motore principale della
crescita economica, soprattutto grazie all'azione dell'imprenditore;
in secondo luogo Schumpeter credeva che il disequilibrio fosse più importante dell'omogeneità fra
le imprese ipotizzata dall'apparato teorico classico. Nelle ultime opere, inoltre, egli sottolineò il ruolo
della grande impresa come il più potente agente del cambiamento e della crescita.
La situazione cambiò dopo la seconda guerra mondiale, quando venne sviluppata la maggior parte delle
"nuove" teorie dell'impresa. A partire dagli anni Cinquanta e fino ai primi anni Sessanta alcuni studiosi spesso con background molto differenti - cominciarono a interessarsi al successo della grande impresa, verticalmente integrata, multidivisionale, multinazionale, a guida manageriale. Questo tipo di organizzazione
era in parte responsabile della leadership economica americana, clamorosa dopo il secondo conflitto mondiale. La comprensione dei meccanismi di governo della grande impresa era quindi considerata estremamente importante proprio per capire il "mistero" dello sviluppo economico.
Partendo dalla sua conoscenza della General Motors, Drucker ha descritto nei dettagli questo nuovo attore
economico, sostenendo che la grande impresa potesse essere compresa al meglio qualora si fossero analizzate le sue fondamenta tecnologiche, lo "sforzo" necessario al coordinamento efficiente della moltitudine di
individui in essa operante, e l'impatto sociale che questa istituzione ha avuto sul capitalismo moderno.
Un'attenzione crescente venne dedicata alla tecnologia, considerata quale motore principale del processo di
crescita. Innovazioni di prodotto e di processo resero più conveniente, e talvolta obbligata, l'espansione della
dimensione produttiva.
Chandler considerava implicitamente il cambiamento tecnologico come una forza esogena che aveva un impatto decisivo sulle scelte imprenditoriali. Nella sua prospettiva, i «regimi» o «paradigmi» tecnologici - un
insieme di principi scientifici e tecnologici che producono «traiettorie dominanti» (per esempio la consistenza
dimensionale o la tendenza alla meccanizzazione) - determinano l'attività e la competitività delle imprese, e
le loro strutture organizzative «ottimali».
Fra i primi a orientare l'interesse degli studiosi verso la spiegazione del processo di crescita dell'impresa moderna è stata l'economista americana Edith Tilton Penrose (1959). Nel suo libro “The Theory of the Growth
of the Firm” Penrose ha evidenziato un nuovo tema, fornendo un contributo originale alla fondazione della
cosiddetta teoria evolutiva. Secondo l'autrice, le imprese sono «stratificazioni» di risorse e competenze; l'impresa moderna è un'organizzazione che apprende, e alla fine sa «come fare le cose».
Fondato sia sull'idea elaborata da Schumpeter a proposito dell'attività innovativa interna alla grande società
per azioni, sia sull'idea della Penrose relativa alle conoscenze e competenze «stratificate» all'interno dell'impresa, è il concetto di routines introdotto da due economisti americani, Richard Nelson e Sidney Winter
(1982). Il concetto di routine rappresenta uno dei fondamenti della teoria evolutiva dell’impresa, che considera un processo economico non determinato unicamente da scelte razionali e ben definiti obiettivi individuali e istituzionali. Gli agenti economici (e le imprese, fra questi) sono caratterizzati da razionalità limitata e
da apprendimento cumulativo basato sull'esperienza e su procedure «per tentativi ed errori».
Quando le organizzazioni economiche diventano istituzioni grandi e complesse, una funzione cruciale nel loro
sviluppo è svolta dal flusso di conoscenze e informazioni che percorre dall'interno l'organizzazione stessa. Al
di là dell'idea neoclassica dell'impresa come soggetto passivo teso a minimizzare i costi, e diversa anche dalla
"creatura" dell'iniziativa imprenditoriale, l'azienda veniva ora considerata quale attore capace di influenzare
in profondità le caratteristiche dell'ambiente circostante, simile agli organismi viventi per le complesse dinamiche interne e l'abilità di evolvere e adattarsi al contesto.
Dopo la seconda guerra mondiale le corporation statunitensi assunsero una posizione di dominio internazionale per quanto riguarda gli investimenti diretti all'estero. Nel 1960, a un anno di distanza dalla pubblicazione
del volume della Penrose, Stephen Hymer (1960) propose una spiegazione convincente dell'espansione
dell'impresa multinazionale: questa era fondata sulla premessa che il vantaggio competitivo acquisito da
un'impresa sul mercato interno potesse essere sfruttato, in seguito, anche all'estero.
L'analisi di Hymer venne ulteriormente sviluppata da altri studiosi: nella seconda metà degli anni Settanta
John Dunning propose una spiegazione dell'attività internazionale delle imprese basata su una combinazione
di vantaggi competitivi sviluppati sul mercato interno (vantaggi di «proprietà») e vantaggi presenti nel Paese
ospite (vantaggi di «localizzazione», per esempio la presenza di una forza lavoro specializzata). Ulteriori incentivi all'investimento diretto (di «internalizzazione») derivavano dalla necessità di mantenere conoscenze
e «attività creatrici di valore» all'interno dei confini dell'impresa.
La teoria del capitalismo manageriale formulata da Marris è importante almeno per due ragioni. In primo
luogo, la sua analisi ha valore in relazione all'intenso processo di diversificazione che ha modificato il panorama delle imprese statunitensi tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta, segnato da un'ondata di fusioni
e da una massiccia creazione di conglomerate.
In secondo luogo, Marris ha gettato le basi per un successivo dibattito di grande interesse nell'ambito delle
teorie dell'impresa, quello sulla relazione fra «principale» e «agente» formalizzato nella teoria dell'agenzia
(agency theory).
Gli anni Settanta e Ottanta: teoria dell’agenzia ed economia dei costi di transazione
Il potere del top management generato dalla separazione fra proprietà e controllo nell'ambito delle corporation americane è stato messo in discussione a partire dall'inizio degli anni Settanta. La crisi economica
mondiale e la crescente pressione competitiva delle imprese europee e giapponesi hanno rivelato l'inadeguatezza dei dirigenti a gestire politiche capaci di generare risorse e profitti sufficienti a finanziare sia i processi di crescita dell'impresa, sia la distribuzione delle quote di utili ragionevolmente attese dagli azionisti. Il
conflitto fra manager e azionisti ha talvolta raggiunto picchi di elevata tensione.
La teoria dell'agenzia sviluppata da Jensen e Meckling considera l'impresa come una sorta di «finzione legale», utile per definire un sistema di relazioni contrattuali. Tale finzione legale è impegnata nella produzione
di un saldo positivo nelle attività e nei flussi di cassa; la redistribuzione degli utili, in presenza di interessi
potenzialmente conflittuali fra principale e agente, spiega la necessità di un «allineamento» degli interessi
personali coinvolti sia attraverso il mercato azionario, sia con il tramite di strumenti legali. Due implicazioni
spiegano l'importanza dell'impostazione teorica di Jensen e Meckling: il suo sviluppo ha segnato una fase di
acuta critica alla gestione manageriale della grande impresa diversificata, considerata sempre meno efficiente dagli studiosi e, soprattutto, dagli operatori.
L'idea dell'impresa come «artificio legale», destinato a risolvere i problemi emergenti dall'interazione fra vari
attori economici, è stata alla base di un'altra feconda corrente di studi, che si è proposta di spiegare la ragione
dell'esistenza stessa dell'impresa: la teoria dei costi di transazione.
L'origine di questa teoria risale al provocatorio articolo pubblicato da Ronald Coase nel 1937, intitolato The
Nature of the Firm. Le questioni fondamentali proposte allora da Coase erano le seguenti: perché esistono le
imprese? Perché è necessario internalizzare alcune transazioni, svolgerle cioè dentro i confini giuridici dell'impresa, invece di lasciarle semplicemente al mercato? La risposta è: a causa dell'inefficienza dei mercati. Nelle
parole di Coase, le imprese sono «isole di potere consapevole in questo oceano di cooperazione inconsapevole, come grumi di burro che coagulano in un secchio di crema di latte», e devono la loro origine alla necessità di contenere i costi che le transazioni di mercato comportano.
La teoria dei costi di transazione ha avuto un potente impatto sugli studi di business history. Il quadro concettuale che essa ci offre ci ha aiutato a comprendere meglio una serie di eventi storici, dall'affermazione del
sistema di fabbrica durante la prima rivoluzione industriale, alle strategie di crescita perseguite - attraverso
l'integrazione verticale – dalla grande impresa industriale nel periodo successivo. Infine, la teoria dei costi di
transazione ha fornito un'interpretazione convincente della persistente efficienza di sistemi alternativi alla
produzione di massa.
"Da una a tante": teorie sull'impresa del XXI secolo
L'obiettivo comune alle teorie fin qui presentate è stato quello di comprendere e interpretare l'origine e le
dinamiche di crescita della grande impresa, vale a dire della forma di organizzazione industriale dominante
per quasi tutto il XX secolo. All'inizio del nuovo millennio, però, sono emersi diversi modelli organizzativi e
differenti approcci teorici.
Le tecnologie della terza rivoluzione industriale (elettronica e telecomunicazioni) hanno avuto infatti un impatto profondo sulla struttura e sulle dinamiche delle aziende; nuove forme di coordinamento del processo
produttivo hanno acquistato importanza; reti di produttori specializzati indipendenti - in particolare quelli
raccolti attorno a particolari progetti e obiettivi - hanno mostrato di possedere la flessibilità necessaria per
far fronte alle esigenze imposte dalle nuove tecnologie e dai nuovi prodotti.
Le nuove tecnologie informatiche hanno facilitato un processo di coordinamento fra aziende, che a sua volta
ha favorito una sostanziale riduzione dell'incertezza e dei costi di transazione.
CAPITOLO 3 – IMPRENDITORIALITÀ
Un fenomeno elusivo
Nel ventennio appena trascorso il tema dell'imprenditorialità ha richiamato l'attenzione generale. Il suo fascino è dovuto a una serie di ragioni, in primo luogo la crisi della grande corporation, che appare governata
da manager-burocrati, e la contemporanea scoperta della piccola impresa. Decisivo nel dar forma alla visione
dell'imprenditorialità nell'immaginario comune è il fatto che grandi imprenditori hanno segnato con un'impronta tipica l'imponente processo di ristrutturazione degli anni Novanta (si pensi a Jack Welch alla General
Electric). Ancora più rilevante è però il fatto che veri talenti imprenditoriali siano stati capaci di cavalcare la
grande ondata dell'innovazione in quei settori - come l'elettronica e le ICT - che hanno portato il mondo
nell'era della globalizzazione.
L'imprenditorialità appare a tal punto centrale per la ricchezza e la competitività di una nazione che in tutti i
Paesi a economia avanzata c'è la tendenza a cercarne una codificazione - sia per individuare un percorso
formativo, sia per definire le politiche industriali.
L'imprenditorialità emerge nelle diverse scale dimensionali: si ritrova nelle grandi corporation come nei piccoli esercizi di distribuzione al dettaglio. Si presenta in varie forme. Possiamo scoprirla come spinta e motivazione di uno/a scienziato/a che attribuisce un valore economico alla sua attività di laboratorio.
William Baumol può scrivere: «L'imprenditore è contemporaneamente il più intrigante e uno dei più elusivi
fra i personaggi che costituiscono il soggetto dell'analisi economica». E un altro economista e storico, Mark
Casson, può affermare che il termine "imprenditorialità" «assume significati diversi per i diversi storici».
Eroe, entità invisibile, uomo qualunque
Utilizzando il termine "eroe" in una disamina sull'imprenditorialità, viene subito alla mente il lavoro scientifico di Joseph Schumpeter. Egli era però esponente di un ambiente culturale di lingua tedesca tipico del periodo a cavallo fra XIX e XX secolo, un clima intellettuale che sottolineava il ruolo della cultura nella spiegazione dell'attività imprenditoriale.
Si pensi solo a figure di enorme importanza come:
Max Weber, il quale descrive l'imprenditore come portatore di una «razionalità strumentale» che lo
rende capace di mettere sistematicamente in relazione alcuni obiettivi (il perseguimento del profitto)
con i mezzi più adatti a raggiungerli, con una diffusa attitudine al calcolo;
Werner Sombart, il quale in Der moderne Kapitalismus (1909) sottolinea le caratteristiche elitarie
dell'imprenditore, che con la sua energia vitale e la sua creatività dà vita a fattori economici che
altrimenti possono essere considerati inerti - fattori quali il lavoro e il capitale, quest'ultimo al di là
della definizione dei diritti di proprietà o della posizione formale in una società;
Friedrich Nietzsche, la cui influenza culturale raggiunse il massimo grado proprio nel primo decennio
del XX secolo, negli anni in cui Schumpeter completava la sua formazione a Vienna. Nietzsche sottolineava la differenza fra coloro che sono molto più avanti rispetto alle convenzioni morali del loro
tempo e coloro che non fanno nient'altro che adattarsi a esse, evidenziando così il ruolo di individui
i quali scelgono un percorso che non appare razionale, spinti da una non comune forza di volontà.
L'innovazione, che giustifica il profitto imprenditoriale, non si adatta alla domanda corrente, ma impone il
suo prodotto sul mercato. Innovazione significa cambiamento, squilibrio, "distruzione creatrice"; essa non
coincide con l'invenzione ma è la realizzazione di questa a livello economico.
In tale visione, l'imprenditore è una sorta di "traduttore", che compie ogni sforzo per trarre vantaggio dalle
onde lunghe della tecnologia delineate da Kondratieff: dal 1786 al 1842 l'onda caratterizzata dai grappoli di
innovazioni nei settori tessile e metallurgico; dal 1843 al 1897 le innovazioni concentrate nel settore delle
ferrovie e nelle attività correlate; dal 1897 allo scoppio della seconda guerra mondiale, quando i settori elettrico, chimico e automobilistico nacquero e iniziarono un periodo di crescente espansione.
Un'altra concezione del processo economico può essere rinvenuta sul versante opposto dello spettro argomentativo; qui, l'imprenditorialità è assunta de facto come irrilevante. Tale assunto non è di poca importanza,
perché si fa ora riferimento al cosiddetto mainstream del pensiero economico.
«La teoria economica e l'imprenditore non sono mai stati buoni compagni di viaggio.» È l'affermazione iniziale di un saggio dedicato a questo tema da J.S. Metcalfe, un'affermazione che appare valida anche quando
la teoria economica dominante vuole spiegare il fenomeno della crescita. In questo caso l'imprenditorialità è
considerata "residuale", qualcosa che non può essere misurato con gli strumenti abituali con cui l'economista
indaga gli incrementi della produttività. In questo modo, Edward Denison - cercando di individuare l'origine
della crescita degli Stati Uniti nel periodo 1900-1960 per rendere conto dell'incremento di produttività - menziona fattori quali il progresso tecnico, il capitale umano, la riallocazione delle risorse, il cambiamento istituzionale, mentre non cita l'imprenditorialità perché la considera automaticamente inclusa nei vari input.
L'innovazione tecnologica, considerata come una variabile indipendente per gli imprenditori, risulta cruciale
per l'eroe schumpeteriano il quale era soprattutto un uomo impegnato nella produzione, non necessariamente colui che assumeva il rischio d'impresa (e non necessariamente un proprietario). Per questo tipo di
imprenditore il fattore discriminante era ancora una volta l'innovazione. Ciò che conta è la funzione esercitata dal singolo capitalista, dal manager stipendiato dal team o, ancora, dall'ente politico. In un'età di sfide
violente al sistema borghese capitalistico, l'imprenditorialità schumpeteriana (considerata come forza endogena a questo ordine economico e sociale) acquista il valore di un'efficace apologia di questo stesso sistema.
Nell'analisi di Adam Smith, la funzione più importante dell'uomo d'affari è quella di fornire il capitale, mentre
David Ricardo sottolinea ancora più chiaramente l'automatismo dei movimenti economici. Naturalmente i
padri fondatori della scienza economica consideravano l'abilità negli affari come un importante fattore per il
successo o il fallimento delle singole iniziative, ma quelle stesse abilità difficilmente avrebbero potuto influenzare il processo economico considerato nella sua totalità. Ancora, Karl Marx, nonostante l'elogio della
borghesia industriale contenuto nel suo Manifesto (1948), sempre fedele alla logica dei classici, negava ogni
rilevanza ai fattori soggettivi come l'imprenditorialità.
L'imprenditorialità è stata così sempre più trascurata a causa del successo del paradigma neoclassico fondato
sul concetto dell'equilibrio del mercato.
Cantillon riconosce nell'imprenditore il vero motore dell'economia, anche se la sua definizione abbraccia un
significato così ampio che è possibile includervi addirittura i ladri e i mendicanti. In realtà, l'idea che Cantillon
ha dell'imprenditore è quella di un individuo abile nel fronteggiare l'incertezza, e questo argomento è stato
ripreso due secoli dopo dall'economista americano Frank Knight.
L'abilità di far fronte a situazioni difficili e incerte è uno degli attributi normalmente riconosciuti alla funzione
imprenditoriale così come nell'opinione comune è considerata una manifestazione di capacità di leadership
l'abilità di organizzare e coordinare i fattori della produzione e della distribuzione.
Anche Alfred Marshall, uno dei padri della scuola neoclassica con i suoi Principles of Economia (1890), colloca
l'imprenditorialità all'interno della routine gestionale, sia pure distinguendo un ruolo imprenditoriale dedicato alle decisioni fondamentali da un ruolo manageriale caratterizzato da un potere delegato. Nella concezione di Marshall l'imprenditore non è una personalità eccezionale; al contrario, egli è ritratto nella sua attività quotidiana, profondamente inserito nell'impresa e impegnato a far funzionare l'organizzazione proprio
quando i fondatori carismatici hanno cessato la loro attività. Molto più recentemente, alcuni economisti
hanno sottolineato la dimensione psicologica dell'azione imprenditoriale. Israel Kirzner, il quale appartiene
alla cosiddetta "scuola austriaca", seguendo le suggestioni di Ludwig von Mises e Frederic von Hayek in merito alla relazione fra economia e conoscenza, considera l'attenzione (alertness) come l'essenza dell'agire
imprenditoriale.
L'imprenditore (al quale Casson guarda come individuo, non come team), in quanto colui che assomma i ruoli
del capitalista, del proprietario e del manager, è diverso dalle altre persone per la sua abilità di riconoscere
le situazioni in cui è possibile trarre un profitto.
Concludendo, per tutti gli autori fin qui considerati, l'imprenditore - anche se "diverso" per le sue doti di
coraggio, leadership, prontezza nel cogliere le opportunità, capacità di giudizio - è essenzialmente "uno di
noi", un uomo comune.
Imprenditorialità e organizzazione
Questo processo si presenta come il paradosso dell'imprenditorialità: le organizzazioni, con le loro regole
burocratiche e le loro routines, finiscono per soffocare lo slancio dell'imprenditore. È la famosa argomentazione di Joseph Schumpeter nel volume Capitalism, Socialismi, Democracy (1941), un'argomentazione secondo la quale, come abbiamo già visto, l'economista austriaco anticipava l'inevitabile declino del sistema
capitalistico borghese che nella forza vitale dell'imprenditore trovava la sua giustificazione.
William Lazonick ha ripreso il tema della competizione fra diversi modelli di capitalismo e ha evidenziato, nel
successo dell'impresa giapponese degli anni Ottanta, l'abilità della classe dirigente a coinvolgere nel processo
innovativo tutte le componenti della vita dell'impresa partendo dai lavoratori in fabbrica. Ma è il management di medio livello che va considerato con particolare attenzione. Le parole chiave sono intrapreneurship
e corporate venturing.
Ci sono situazioni sfortunate in cui l'apprendimento paziente non è adeguato; per esempio, in momenti di
profonda crisi, un'eccessiva enfasi sull'apprendimento rischia di risolversi in un danno per ciò che funziona
già e può comportare conseguenze indesiderate. Concludendo, l'apprendimento è di importanza vitale per
un'organizzazione, ma deve procedere nella cornice di un sistema dominato dalla capacità di direzione e
decisione. Dopo questo excursus ci ritroviamo dunque di fronte al problema della leadership imprenditoriale.
Nel suo primo importante lavoro, Strategy and Structure (1962), Chandler distingue attentamente le funzioni
di un imprenditore da quelle di un manager. Mentre il primo ha la responsabilità di allocare le risorse ai
massimi livelli dell'impresa, il secondo agisce all'interno di un sistema di risorse creato dall'imprenditore.
Compito imprescindibile dell'imprenditore, reale atto critico della sua azione, è la creazione di un'ampia gerarchia manageriale. Questo network è essenziale per il buon funzionamento della grande impresa, a sua
volta strumento indispensabile per la crescita e la competitività economica nell'età della seconda rivoluzione
industriale.
Il ritorno agli animal spirits
Nel libro The Concept of the Corporation (1946) di Peter Drucker, uno studio che evidenzia la capacità dell'organizzazione della General Motors, grande ma flessibile, di rispondere alla domanda del periodo bellico. E
tuttavia c'è un'altra ragione che spiega questa tendenza allo studio delle organizzazioni: essa ha maggiormente a che fare con l'evoluzione del clima intellettuale nel quale operavano gli storici d'impresa.
È significativo sotto questo profilo che nella voce Entrepreneurship compilata nel 1980 per la Enciclopedia of
American Economie History, Jonathan R.T. Huges scelga di sottolineare le fondamenta profonde del fenomeno: libera proprietà della terra, massima flessibilità nelle transazioni economiche; stabilità della cornice
giuridica, limitato controllo sociale, e gli occupanti abusivi dei terreni di frontiera quali progenitori dell'imprenditore schumpeteriano.
La distanza dal modello chandleriano dell'imprenditore -manager nel quale si realizzano le teorie weberiane
non potrebbe essere più evidente. L'imprenditore sembra essere di nuovo il protagonista, mentre il problema
più arduo per gli storici è scoprire come egli sia capace di rompere vincoli piuttosto che identificare i fattori
sociali che ne influenzano le azioni. Nell'ambito delle scienze sociali alle quali gli storici devono guardare, la
sociologia deve essere certamente integrata dalla psicologia.
L’imprenditorialità nella storia
Non è sufficiente correlare l'incremento della produzione a quello della quantità degli input e, tuttavia, nemmeno l'idea di chiamare questo surplus «reazione creativa della storia», come fa Schumpeter, appare convincente. Secondo Cipolla, l’economista austriaco commette l'errore di ridurre l'intera questione a una parte
che, in questo caso specifico, è l'attività imprenditoriale. «Questo è un elemento importante e necessario,
ma io non penso - scrive Cipolla - che sia sufficiente.» Come è stato argomentato a proposito del fattore
lavoro, è la «forza vitale» di un'intera società che a un certo punto - ammesso che questo punto esista - può
entrare in gioco con un effetto decisivo, producendo la scintilla della «reazione creativa della storia».
Per quanto il fenomeno dell'imprenditorialità possa essere elusivo, sono stati condotti vari tentativi di misurazione. Un esempio è offerto dal lavoro del sociologo Paul H. Wilken, volto a comprendere il valore dell'impatto dell'imprenditorialità sullo sviluppo economico nazionale. Wilken individua quattro variabili:
O (opportunità),
Y (crescita economica),
X (variabili non economiche),
E (imprenditorialità).
Fondando il proprio studio su fonti secondarie, Wilken considera i casi di sviluppo inglese, francese, tedesco,
giapponese, statunitense e russo nel corso del XIX secolo: arriva così a un risultato apparentemente strano,
che evidenzia il bassissimo impatto dell'imprenditorialità nel caso americano e in quello inglese. Il problema
di tentativi così concepiti è che è veramente arduo tracciare delle linee di separazione nette fra le variabili.
Potrebbe essere quindi interessante riportare l'attenzione sugli imprenditori seguendo una metodologia
chandleriana, per esempio promuovendo una ricerca comparata internazionale basata sulle biografie collettive (si veda, come riferimento, il lavoro di Jeremy). Sarebbe necessario riconsiderare i dizionari biografici
esistenti, aggiornarli, promuovere la compilazione di nuovi repertori, analizzando le fonti sulla base di un
questionario comune pensato allo scopo di illuminare l'origine degli imprenditori, l'istruzione, le motivazioni
e i valori, l'idea iniziale, le strategie e le strutture organizzative elaborate per realizzarla, le relazioni con l'ambiente e in particolare con il contesto politico e sociale.
PARTE II – DALL’ETÀ PREINDUSTRIALE ALLA
PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
CAPITOLO 4 – PRIMA DELL’INDUSTRIA
Nel XVIII e XIX secolo il sistema di fabbrica impone un drastico riallineamento delle economie europee, ma
imprenditorialità e impresa capitalistica non hanno avuto inizio con la prima rivoluzione industriale. Molto
prima dell'età dominata dalle fabbriche inglesi, gli uomini d'affari avevano sviluppato nuove combinazioni di
capitale, lavoro e risorse naturali (la "terra", nelle definizioni classiche), per rispondere alla domanda di beni
e servizi. Il ritmo del cambiamento è stato relativamente lento, ma la trasformazione si è diffusa in tutti i
settori dell'economia europea, incluso quello della manifattura.
L'Europa preindustriale: caratteristiche generali
L'Europa preindustriale non si presentava come un'area economica omogenea e tuttavia i Paesi europei condividevano alcuni tratti comuni, a partire dalla preponderanza del settore primario, a cui le stime attribuiscono una quota fra l'80 e il 90% del prodotto interno lordo complessivo e la maggioranza della popolazione
attiva (fino al 70%). La forza lavoro era infatti composta soprattutto da contadini e dalle loro famiglie, che
lavoravano appezzamenti di terra trasmessi di generazione in generazione.
La forza della tradizione rendeva il panorama poco dinamico, ma queste economie non erano certo immobili.
Gli indici di crescita, variabili nelle diverse regioni, non erano comparabili con quelli che si registreranno nel
periodo della rivoluzione industriale, ma erano in movimento. La popolazione europea totale era cresciuta
da 51 milioni di persone all'inizio del Cinquecento a 132 milioni calcolati alla fine del Settecento. Secondo le
stime di Angus Maddison, il tasso annuale di crescita della popolazione dell'Europa occidentale fra l'anno
1000 e il 1500 si era mantenuto vicino allo 0,16%, mentre fra il 1500 e la fine dell'Ottocento si era attestato
allo 0,26%.
L'economia preindustriale europea, fondata quasi esclusivamente sull'agricoltura, dipendeva quindi dalle
profonde fluttuazioni che caratterizzavano gli andamenti del settore dominante. Condizioni climatiche negative e lunghe guerre causavano imprevedibili flessioni nella produzione; la malnutrizione rendeva le popolazioni vulnerabili alle malattie e le periodiche carestie avevano effetti devastanti sulla dinamica demografica.
Fattori culturali e sociali, insieme a un assetto economico e politico fondato sulla diseguaglianza e sulla scarsa
mobilità, condizionavano negativamente l'andamento della domanda aggregata e solo nei tre secoli che precedono la rivoluzione industriale questo contesto presenta segni di cambiamento: l'economia nel suo complesso diventa progressivamente più dinamica, grazie alla diffusione di una serie di importanti innovazioni
nel settore primario - la cosiddetta "rivoluzione agraria" -, ed è tutta l'area europea che si incammina su un
sentiero di plurisecolare crescita economica cumulativa.
È facile intuire che non stiamo parlando di processi diffusi in maniera omogenea a livello continentale: le
forze dinamiche della "nuova agricoltura", della rivoluzione commerciale e della modernizzazione istituzionale appaiono all'opera nell'area britannica, nell'Europa nord-occidentale e nell'Italia settentrionale, mentre
le periferie scontano l'arretratezza e la stagnazione economica, rimanendo esposte alle conseguenze di crisi
economiche potenzialmente devastanti.
Tipologie della produzione manifatturiera: il putting-out system
In uno scenario rurale caratterizzato dalla prevalenza di strutture economiche autarchiche, l'attività manifatturiera assumeva forme organizzative diverse a seconda della localizzazione del settore considerato e del
grado di specializzazione della forza lavoro impiegata.
La presenza di una manodopera poco costosa, senza pretese e docile incoraggiò quindi gli imprenditori a
trasferire in campagna alcune fasi produttive della manifattura, sviluppando il putting-out system, basato su
un'architettura organizzativa gerarchica ma flessibile. Al vertice dell'organizzazione era il mercante-imprenditore, proprietario delle materie prime, che coordinava l'attività di una rete di lavoratori a domicilio impegnati in alcune fasi del processo produttivo (nel settore tessile, per esempio, la filatura e la tessitura).
L'efficienza di questa formula di organizzazione derivava, oltre che dall'ampia disponibilità di manodopera
rurale a basso costo, dall'elevata flessibilità del sistema: la rete di lavoranti - centinaia, talvolta - coordinata
dal mercante-imprenditore poteva essere velocemente estesa o ridimensionata a seconda delle fluttuazioni
della domanda, senza aggravio di costi per lo stesso imprenditore: l'unità produttiva coincideva infatti con la
famiglia contadina, proprietaria di un capitale fisso poco costoso e di semplice manutenzione (nella manifattura tessile, per esempio, i telai a mano).
La produzione artigianale rurale e urbana
Se il putting-out system e le reti decentrate della manifattura domestica rappresentavano le modalità organizzative più diffuse nella produzione dei beni di consumo, l'artigianato aveva nondimeno un ruolo importante. Caratteristiche di questa attività erano un maggiore livello di complessità organizzativa, tecniche più
sofisticate e la presenza di lavoratori specializzati, come fabbri, ciabattini, armaioli, conciatori; questi erano
impiegati in settori a più elevata intensità di capitale e dediti a lavorazioni in cui maggiore era il valore aggiunto del prodotto finale.
Le lavorazioni a valore aggiunto più elevato tendevano a concentrarsi all'interno delle città e dei villaggi;
l'artigianato contribuiva a generare una porzione consistente del reddito e della produzione della società
urbana, accanto al settore terziario composto da servizi domestici, burocrazia e amministrazione. L'organizzazione interna di un'unità produttiva artigiana era semplice e fondata su una rigida gerarchia. Il maestro,
proprietario della bottega (spesso adiacente al domicilio), gestiva l'intero processo produttivo supervisionando il lavoro degli apprendisti.
Il maestro e la sua bottega erano parte integrante di un sistema organizzato più ampio - la corporazione - che
riuniva le attività specializzate dello stesso tipo: per esempio, una corporazione molto diffusa e potente nelle
città dell'Europa preindustriale era quella degli orafi.
Gli obiettivi del sistema corporativo variavano in relazione all'area di insediamento e alla particolare situazione politica, ma la regolazione dell'attività artigianale presentava molti vantaggi, tra cui l'organizzazione
degli input produttivi, la gestione della formazione del capitale umano e il severo controllo degli standard
qualitativi del settore. Le corporazioni regolavano l'accesso al mercato del lavoro operando una selezione
attraverso l'obbligo di lunghi periodi di apprendistato e specializzazione: questo sistema di controlli si risolveva, da un lato, in un abbassamento dei costi di informazione per la clientela, ma non garantiva, dall'altro,
che all'interno della singola bottega si realizzasse un'efficiente divisione del lavoro; gli artigiani inseriti nel
sistema corporativo godevano infine di una protezione e di una stabilità lavorativa rari nell'economia preindustriale, esposta a violente fluttuazioni nel livello dei redditi.
E del resto importante sottolineare ancora una volta che tale sistema rappresentava una frazione circoscritta
dell'attività manifatturiera preindustriale; il suo impatto sull'economia europea è stato di conseguenza limitato e inoltre la sua fisionomia "istituzionale" non arrivava a influenzare in profondità le modalità di produzione al livello dell'organizzazione del lavoro nelle botteghe e nelle officine.
Il maestro esercitava sui lavoratori un controllo ben più elevato rispetto alle pratiche diffuse nel putting-out
system, era in grado di fissare le quantità e selezionare il tipo di articoli che la manodopera era impegnata a
produrre; i lavoranti inquadrati nella corporazione avevano nella manifattura la loro occupazione primaria e
a questa dedicavano la maggior parte del loro tempo lavorativo, ma la divisione del lavoro vera e propria,
sistematica, non era il tratto operativo e organizzativo della bottega artigiana inserita nel sistema corporativo.
Rispetto al putting-out system, le corporazioni mostravano una maggiore rigidità dal lato dell'offerta. Teoricamente, volumi di produzione più consistenti potevano essere raggiunti nelle singole botteghe semplicemente aumentando il numero dei lavoranti.
La "grande impresa" prima della rivoluzione industriale
Imprese di grandi dimensioni, con un elevato numero di lavoratori e un'alta intensità di capitale erano presenti anche prima della rivoluzione industriale. "Manifattura" era il termine comunemente usato per descrivere la concentrazione di lavoratori attivi nello stesso luogo, "sotto lo stesso tetto". È corretto comparare
questo precursore con la grande impresa che si affermerà secoli dopo? Secondo alcuni studiosi l'emergere
dell'organizzazione di fabbrica rappresenta la conseguenza della concentrazione di numerosi lavoratori nelle
"manifatture". Non si può far derivare, sostengono, il sistema di fabbrica solo dalle trasformazioni tecnologiche della prima rivoluzione industriale, mentre evidenziano come molti dei grandi impianti preindustriali fossero in grado di sviluppare metodi sofisticati di amministrazione e contabilità per gestire processi produttivi
complessi.
Come sottolinea Sidney Pollard nel suo studio sulla genesi del management moderno, i grandi opifici preindustriali, spesso protetti da patenti regie e operanti in regime di monopolio, erano l'eccezione e non la regola;
inoltre, in molti di essi, solo una piccola porzione dei dipendenti lavorava esclusivamente "dentro" l'impianto,
perché la maggioranza era in realtà impegnata "fuori", nelle lavorazioni a domicilio.
Anche in altri settori le "manifatture" presentavano livelli di concentrazione della forza lavoro elevati: nella
lavorazione dei metalli, nelle costruzioni navali e nell'edilizia, per esempio, era impossibile operare economicamente alla scala limitata dell'officina o della bottega artigiana.' Nell'attività mineraria era la natura stessa
del processo produttivo a imporre la concentrazione di numerosi lavoratori in un unico luogo, ma anche nel
settore tessile alcune fasi della lavorazione (in particolare quelle finali, come la tintura e la stampa delle tele
di cotone) erano svolte in impianti centralizzati, gestiti da mercanti-imprenditori che ne detenevano la proprietà totale o in compartecipazione.
Un simile compromesso fra il sistema della lavorazione a domicilio e il vantaggio economico della produzione
centralizzata in stabilimenti dedicati è evidente anche in altri settori produttivi in cui operavano imprese di
grandi dimensioni: nelle costruzioni navali e nell'edilizia, diverse migliaia di lavoratori erano impiegati "sotto
lo stesso tetto", ma l'organizzazione e la natura stessa delle lavorazioni conservavano tuttavia i caratteri di
un sistema decentrato.
La tecnologia disponibile non consentiva quindi a queste imprese di realizzare economie di scala significative,
sia pure in presenza di elevati incrementi della produzione. Da questo punto di vista si può riscontrare una
somiglianza con gli odierni sistemi di produzione in lotti; nella cantieristica, infatti, l'unico modo per produrre
un maggior numero di vascelli era attivare unità di lavoro aggiuntive, quindi impiegare un numero maggiore
di artigiani.
Le motivazioni di questi interventi erano varie, e andavano dalla necessità di assicurarsi la fornitura di alcuni
prodotti "strategici" (navi e armi) al perseguimento di politiche mercantiliste dirette a contenere l'acquisto
all'estero di beni ad alto valore aggiunto. È questa l'origine della Saint-Gobain, oggi uno dei maggiori produttori internazionali nel comparto del vetro: fondata nel 1665 dal ministro delle Finanze francese Jean-Baptiste
Colbert con il nome di Manufacture Royale de glaces de miroirs, la società era gestita da imprenditori privati,
era finanziata in parte dallo Stato e godeva di privilegi reali.
CAPITOLO 5 – IMPRESE E IMPRENDITORI NELLA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
La prima rivoluzione industriale ha trasformato l'economia mondiale, ha imposto l'egemonia britannica e ha
dato inizio al primo profondo cambiamento della dinamica demografica. Secondo le statistiche storiche di
Angus Maddison, il tasso medio composto di crescita della popolazione della Gran Bretagna tra il 1820 e il
1870 si attestava a 0,79%, contro la media di 0,69% dell'Europa occidentale. Nello stesso periodo si registra
un incremento percentuale annuo del prodotto interno lordo britannico pari a 1,26, a fronte di una crescita
continentale ferma a 0,96. La comparazione fra crescita del PIL negli stessi decenni vede solo due piccoli
Paesi, Svizzera e Belgio, con indici superiori a quello inglese, mentre Germania e Francia registrano un incremento inferiore. Nei decenni seguenti, naturalmente, si osserva una tendenza al livellamento; le stime di
crescita sull'arco del "lungo" XIX secolo - dal 1789 al 1914 - evidenziano infatti tassi comparabili per tutti i
Paesi citati, con incrementi medi annui del PIL intorno a 1,2-1,3 %.
L’eccezione britannica
A rendere eccezionale la performance economica della Gran Bretagna nei decenni successivi alle guerre napoleoniche non era solo il tasso di crescita, quanto soprattutto il modo in cui lo sviluppo si andava realizzando,
in un percorso differente rispetto alle coeve vicende europee e mondiali. Per la prima volta nella storia l'origine della "ricchezza della nazione" non era più riconducibile in modo esclusivo al settore primario e al commercio dei prodotti agricoli: il cuore dell'economia era ora l'industria. La vera differenza tra la Gran Bretagna
e gli altri Paesi si realizzava quindi nel diverso contributo fornito dal macro-settore industriale in rapida espansione alla formazione del prodotto nazionale lordo e del valore aggiunto e, di conseguenza, nella redistribuzione della forza lavoro.
Alla metà del XIX secolo, ottant'anni dopo, l'agricoltura britannica dava lavoro a Va degli occupati maschi,
contro una media continentale del 55%; lo stesso settore contribuiva al reddito totale con una quota del 25%,
a fronte di un 40% a livello europeo. Infine, nello stesso arco cronologico, in Belgio, Francia e Germania - i
Paesi economicamente più avanzati nel continente - la forza lavoro stabilmente occupata in agricoltura era
rimasta uguale o superiore al 50%. Lo stesso studioso sostiene che «una profonda redistribuzione delle risorse ha avuto luogo prima del decennio 1840, quando la Gran Bretagna presentava una struttura dell'occupazione ormai decisamente diversa rispetto al resto d'Europa».
Man mano che le diverse nazioni procedevano sulla strada della transizione economica, aumentava anche il
grado di specializzazione nelle esportazioni dei Paesi coinvolti, come conseguenza dell'impiego più efficiente
della dotazione di risorse e, contemporaneamente, delle tecnologie disponibili. Grazie a un livello di apertura
senza precedenti nella storia dell'economia mondiale, alcuni dei Paesi che per primi avevano seguito l'esempio inglese acquisirono, nella seconda metà del XIX secolo, la posizione di leader nella graduatoria delle
esportazioni di prodotti industriali.
All'inizio del XX secolo, infatti, la percentuale di esportazioni (misurata in valore) sull'intera produzione industriale superava il 70% per la Gran Bretagna, la Svizzera e la Germania, mentre toccava il 60% per la Francia;
le posizioni raggiunte dalle nazioni periferiche testimoniavano della loro arretratezza, poiché solo quote oscillanti fra il 20 e il 25 % della loro produzione manifatturiera prendeva la via dell'esportazione.
Cambiamento strutturale e vantaggio competitivo britannico
Alla tradizionale fonte primaria di energia - la forza idraulica - si aggiunse la macchina a vapore, un efficace
esempio di tecnologia universale capace di un ampio spettro di applicazioni. L'introduzione e la diffusione
della macchina a vapore, insieme ai miglioramenti nello sfruttamento dell'energia idraulica, mise a disposizione dell'industria quantità crescenti di energia inanimata a basso costo che, per la prima volta, poteva essere trasferita con relativa facilità da un luogo all'altro, con un impatto significativo sull'efficienza e sui costi
di localizzazione degli impianti. Secondo Joel Mokyr (1990), nella seconda metà del XVIII secolo vennero costruiti in Gran Bretagna circa 2500 motori a vapore, e di questi un migliaio destinati al settore minerario.
Nel tessile, e in particolare nella lavorazione del cotone, le innovazioni tecnologiche nella filatura e nella
tessitura avevano prodotto un notevole incremento dell'efficienza e della produttività del settore, più che
triplicata nell'ultimo quarto del XVIII secolo. Secondo le stime di Crafts, fra il 1700 e il 1760 la produzione di
cotone era cresciuta in media di 1,37% all'anno; nel decennio successivo, dal 1760 al 1770, l'andamento aveva
registrato un balzo del 5 % di incremento annuo, per toccare infine un'eccezionale crescita media del 12,79%,
segnata negli anni dal 1780 al 1790.
Il cluster di innovazioni caratteristico della fase iniziale della prima rivoluzione industriale inglese deve essere
ricondotto a una serie di presupposti economici, culturali, istituzionali e legali che si affiancarono allo sviluppo
commerciale, ormai consolidato e già in grado di garantire un'elevata efficienza nella distribuzione delle
merci e nella mobilitazione del credito.
L'"illuminismo industriale", un clima culturale favorevole alla scienza all'innovazione, alla sperimentazione e
alle nuove applicazioni tecniche aveva creato un contesto positivo per l'attività di inventori, tecnici e imprenditori desiderosi di realizzare profitti mettendo in pratica le "utili conoscenze" sviluppate in proprio o apprese
in altri settori.' La protezione legale della proprietà intellettuale (i brevetti) costituiva un ulteriore incentivo
all'innovazione e all'invenzione.
Nella prima metà dell'Ottocento, infine, i beni industriali arrivarono a coprire un consistente 80-90% delle
esportazioni inglesi, con le voci più importanti derivate dai comparti tessile (lana e cotone) e siderurgico. Nel
caso dei tessuti di cotone, inoltre, più della metà della produzione nazionale era venduta all'estero e alla
metà del secolo l'esportazione di beni prodotti nel comparto copriva quasi la metà del valore di tutte le
esportazioni britanniche.
Dal “macro” al “micro”: imprenditori e imprese
La composizione di quella che già dai contemporanei veniva etichettata come "classe imprenditoriale" variava naturalmente da Paese a Paese, in base alla combinazione di fattori istituzionali, storici e culturali tipici
di ogni ambiente economico. In molti casi, cultura e istituzioni sono apparse come discriminanti, in particolare quando hanno fornito un contesto favorevole in termini di disponibilità di risorse finanziarie e di protezione giuridica della proprietà intellettuale, come nel caso inglese.
Sono percorsi interessanti come quello di Josiah Wedgwood, un imprenditore inglese fra i più famosi: nato
nel 1730 in una famiglia di maestri artigiani attivi nel settore della lavorazione delle ceramiche, trasformò la
piccola impresa tradizionale in un'organizzazione complessa di grandi dimensioni, caratterizzata dalla divisione del lavoro, da grandi volumi produttivi e dallo sviluppo di moderne tecniche di marketing; questo consentì a Wedgwood e ai suoi soci di acquisire una posizione di leadership nell'industria della ceramica a livello
europeo.
Vicende di questo tipo erano comuni nel settore tessile, in cui numerosi mercanti e negozianti di prodotti per
l'abbigliamento estendevano l'attività di smercio al controllo diretto della produzione. Un esponente di questo gruppo di mercanti-industriali, James Walker di Wortley, gestiva più di venti telai, la metà dei quali nella
propria abitazione e l'altra metà da lavoranti a domicilio.
Su un gradino molto più basso della scala sociale era un tecnico come James Watt: in questo caso l'imprenditorialità nasceva dalla possibilità di brevettare il frutto del proprio ingegno e trarne un profitto attraverso
il suo sfruttamento commerciale; Watt poté valersi di un efficiente sistema di protezione della proprietà intellettuale, che gli consentì di sviluppare il motore a vapore proprio quando le necessità dell'industria avevano superato le potenzialità di sfruttamento dell'energia idraulica.
L’impresa nella prima rivoluzione industriale: proprietà, controllo, gestione
Le nuove tecnologie e l’allargamento dei mercati rivoluzionano insomma anche le unità di produzione, la cui
organizzazione poneva nuove sfide agli imprenditori.
Sarebbe tuttavia un errore sovrastimare l'estensione di questo aumento della scala dimensionale e della
complessità organizzativa e gestionale delle imprese, o considerare i grandi impianti e il sistema di fabbrica
come esperienze diffuse nella prima rivoluzione industriale, soprattutto in una visione di prospettiva, se compariamo questa fase con quella ad alta intensità di capitale della seconda rivoluzione industriale.
Dimensioni iniziali ridotte comportavano così necessità finanziarie contenute che, nella maggioranza dei casi,
venivano fornite da investitori di modeste ricchezze ma in buone relazioni con l'imprenditore: questa modalità di reperimento dei capitali faceva sì che proprietà e controllo delle aziende restassero stabilmente nelle
mani del fondatore e della sua cerchia familiare.
Queste forme organizzative, con una gestione adeguata, si adattavano facilmente ai nuovi sistemi industriali:
data la dimensione media delle unità produttive e la complessità relativa delle nuove tecnologie impiegate
nella prima rivoluzione industriale, le strutture organizzative delle società erano ancora relativamente elementari.
L'impresa nella prima rivoluzione industriale: il processo di produzione
Le nuove tecnologie impiegate nei settori trainanti della rivoluzione industriale avevano generato solo scarse
economie di scala e di flusso. Nel caso del tessile, per esempio, grappoli di innovazioni avevano interessato
singole fasi o stadi (nella filatura o nella tessitura), senza coinvolgere l'intero ciclo di trasformazione dalla
materia prima al tessuto finito.
L'innovazione introdotta in una fase - per esempio il miglioramento tecnico creava una strozzatura del flusso
della produzione e spingeva le aziende a introdurre innovazioni anche nella tessitura, e questa dinamica di
"innovazione per contagio" incoraggiava un rinnovamento generale a lungo termine, non necessariamente
era in grado di indurre un'immediata integrazione dei vari stadi della produzione: sempre nel comparto tessile, per esempio, il processo produttivo - sia pure meccanizzato - rimase a lungo frammentato in distinte
unità funzionali allo svolgimento di una sola fase.
Unità produttive relativamente piccole, quindi, caratterizzate da strutture di costo semplici e raramente in
grado di influenzare i livelli dei prezzi, che operavano in ambienti in cui era continuo il flusso di informazioni
e conoscenze, erano la versione "reale" dell'"impresa rappresentativa" descritta dall'economista inglese Alfred Marshall. Questa configurazione del rapporto imprese-settore era tipica di alcuni insediamenti molto
conosciuti, come l'agglomerato produttivo tessile nell'area di Manchester, il distretto metallurgico delle Midlands e quello della lavorazione delle lame a Sheffield.
È ancora Marshall a evidenziare l'importanza della «forza collettiva» derivante dalla concentrazione di attività
omogenee nei «distretti industriali», dove le conoscenze e le innovazioni avevano una circolazione libera e
veloce e le informazioni su tecnologia e mercati erano «nell'aria».
Distretti industriali con questi tratti erano diffusi in quasi tutte le aree europee toccate dal processo di industrializzazione e spesso le nuove tecnologie e le nuove forme organizzative si innestavano su un tessuto locale
di attività manifatturiere risalente al periodo preindustriale.
Commercio e mercati
La trasformazione sul versante della produzione impose una complessa ridefinizione anche delle funzioni
distributive e commerciali all'interno del sistema economico, e le forme emergenti in questa fase non erano
quelle tradizionali legate all'attività del mercante-imprenditore.
La specializzazione della funzione commerciale all'ingrosso e al dettaglio, così come la creazione di un'adeguata rete di vendita, poneva all'impresa industriale nuovi problemi, riconducibili a un aumento dei costi di
transazione e all'incertezza nella gestione di relazioni con operatori indipendenti.
Il finanziamento delle imprese
Artigiani, mercanti, nobili e tecnici: tutti si trovarono a fronteggiare sfide nuove nel momento dell'avvio di
nuove imprese industriali o dell'espansione di attività già esistenti. La creazione di organizzazioni produttive
complesse poneva problemi sconosciuti a chi era abituato ad agire nelle strutture economiche preindustriali.
In questa fase si presenta come decisiva la capacità di sfruttare in maniera efficiente una molteplicità di canali
di finanziamento a breve e lungo termine, a partire dai patrimoni personali, dalle risorse familiari o della
cerchia prossima di conoscenti, fino al credito delle istituzioni locali.
Le ricchezze familiari, spesso rappresentate dalle proprietà fondiarie o originate in un'attività mercantile,
confluivano nel finanziamento dell'attività imprenditoriale insieme ad altre voci di reddito, come il prestito
su pegno. Il patrimonio personale rappresentava il serbatoio di risorse indispensabile non solo nella fase di
avvio, ma anche per le necessità correnti dell'azienda e per finanziarne l'eventuale espansione: la ricchezza
fondiaria e immobiliare conferiva infatti all'imprenditore la solida reputazione capace di garantirgli il credito
presso le banche o altri soci finanziatori.
Non di rado, anzi, l'attività industriale rappresentava solo una delle componenti di un diversificato ventaglio
di investimenti, articolati nei tre settori - agricolo, industriale e commerciale - secondo una semplice strategia
di diversificazione dei rischi, in una fase e in un contesto economico segnati da un'elevata incertezza.
Sotto ogni profilo, i capitali necessari agli imprenditori attivi in questa fase - di entità e origine diversa - non
raggiunsero mai i livelli elevati che caratterizzeranno le esigenze finanziarie delle imprese ad alta intensità di
capitale e tecnologia tipiche nel periodo successivo della seconda rivoluzione industriale. Dal punto di vista
del finanziamento alle società, le somiglianze fra l'era preindustriale e la fase della prima industrializzazione
erano maggiori delle differenze.
CAPITOLO 6 – TECNOLOGIA, SOCIETÀ E SISTEMA DI FABBRICA
Nelle fabbriche della "nuova economia" industriale gli imprenditori combinavano capitale fisso (edifici e macchinari) e capitale circolante (materie prime e semilavorati, salari) per produrre grandi quantità di beni standardizzati destinati al mercato interno e a quelli esteri. Nonostante le differenze organizzative caratteristiche
delle diverse aree geografiche, il sistema presentava significative omogeneità strutturali e l'impatto combinato di tutte queste novità sull'economia europea e mondiale non lascia dubbi circa lo sviluppo rivoluzionario
in atto, le cui implicazioni hanno una diffusione che va ben oltre i sistemi economici direttamente coinvolti,
con ripercussioni sugli assetti politici e sociali mondiali ottocenteschi. Karl Marx e Joseph Schumpeter compresero chiaramente la portata sconvolgente della trasformazione industriale per ogni nazione toccata dal
cambiamento.
La fabbrica moderna si impone come un modello completamente diverso dai precedenti luoghi e metodi di
organizzazione del lavoro. Innanzitutto, nella fabbrica si radunava un consistente numero di lavoratori, molti
più di quanto normalmente accadesse in ogni insediamento produttivo del passato: né i cantieri né gli arsenali occupavano e coordinavano tanta manodopera in sistemi di produzione meccanizzata, mentre le torme
diffuse dell'artigianato e della manifattura a domicilio raramente superavano le dimensioni numeriche di una
famiglia allargata.
La meccanizzazione di alcune fasi del processo di produzione era un ulteriore carattere distintivo della fabbrica moderna, quello che più suscitava lo stupore degli osservatori contemporanei, sgomenti di fronte all'infernale rumore» degli impianti. Le macchine erano strumenti molto più sofisticati degli attrezzi utilizzati dagli
artigiani e dai maestri nell'organizzazione corporativa, ma erano anche più complicate dei rudimentali telai
dei contadini-tessitori che lavoravano a domicilio per conto dei mercanti-imprenditori. I macchinari richiedevano, proprio per la loro maggiore complessità tecnica, la presenza di lavoratori specializzati nella manutenzione, e infine erano costosi: l'investimento in capitale fisso rappresentava in questa fase un vincolo rilevante.
A differenza del passato, il lavoratore non era più proprietario dei mezzi di produzione e questo comportava
diversi problemi organizzativi inerenti all'uso corretto delle macchine e alla disciplina degli operai, da risolvere attraverso un sistema regolato di addestramento e supervisione.
Il sistema di fabbrica si diffuse velocemente in Gran Bretagna e con un ritmo più lento sul continente: la
nuova modalità di produzione comportava disagi non indifferenti, perché sottraeva lavoratori all'agricoltura
mentre relegava il lavoro artigiano in nicchie di mercato sempre più ristrette, man mano che i beni standardizzati a basso prezzo conquistavano fasce sempre più ampie di consumatori.
L’impatto sociale del sistema fabbrica
Man mano che i Paesi europei erano interessati dal processo di industrializzazione e si adattavano alle nuove
tecnologie e ai nuovi sistemi di produzione, una serie di cambiamenti profondi investiva le strutture economiche e le società nel loro complesso.
Dal punto di vista dei lavoratori, l'inserimento nel sistema di fabbrica comportava spesso un profondo cambiamento delle abitudini e degli stili di vita. Sia per coloro che provenivano dalle schiere dell'artigianato, sia
per quelli di origine contadina si imponeva un brusco adattamento ai ritmi di lavoro richiesti dalle nuove
tecnologie e, contemporaneamente, l'adeguamento a traumatici processi di inurbamento; il risultato era per
tutti lo scardinamento delle abitudini della vita contadina o del villaggio, la rinuncia a una relativa libertà nella
scelta dei tempi di lavoro e riposo, e l'inserimento nel processo continuo dei turni diurni e notturni scanditi
da orari fissi e dal ritmo delle macchine.
Ancora, diversamente dai sistemi organizzativi preindustriali, il funzionamento della fabbrica introdusse progressivamente gerarchie e ruoli rigidamente definiti: le macchine dettavano ora legge per quanto riguardava
l'applicazione al lavoro e l'attenzione allo svolgimento delle mansioni.
Tale stravolgimento dello stile di vita tradizionale - completato solo durante la seconda rivoluzione industriale
non poteva realizzarsi senza creare tensioni nelle diverse società europee; nuovi problemi di adattamento
fisico e psicologico si aggiungevano infatti alle difficoltà concrete che i lavoratori e le lavoratrici di fabbrica
erano obbligati ad affrontare, come i lunghi spostamenti giornalieri per raggiungere il luogo di lavoro o la
permanenza in affollati dormitori e, per tutti, lo sradicamento dalle comunità locali e dalle reti familiari che
avevano garantito in precedenza un certo grado di sicurezza e protezione.
La gestione del cambiamento
Di fronte allo sgretolamento delle strutture sociali tradizionali, gli imprenditori - in momenti e in luoghi diversi
sperimentarono una serie di soluzioni per controllare i tumultuosi cambiamenti della prima industrializzazione e dare una risposta al disagio sociale di cui erano essi stessi responsabili. Se qualcuno semplicemente
ignorava le tensioni generate dalla presenza della fabbrica, altri si mostrarono invece più sensibili e preoccupati e cercarono di elaborare risposte concrete alle questioni sociali emergenti: alla fabbrica venivano così
affiancati alloggi e dormitori per i lavoratori provenienti da villaggi lontani e, in seguito, spacci per l’acquisto
di generi di prima necessità, come cibo e vestiti, mentre "villaggi operai" cominciarono a sorgere presso gli
impianti produttivi di maggiori dimensioni, spesso con l'intervento finanziario dell'imprenditore stesso.
A Crespi d'Adda, il villaggio operaio edificato in Lombardia attorno al cotonificio alla fine del decennio 1870,
queste scelte portarono alla creazione di una nuova comunità molto coesa, all'interno della quale erano soddisfatte le necessità della vita quotidiana, comprese le occasioni ricreative e le attività educative. Il villaggio,
che prese il nome dalla famiglia Crespi, proprietaria del cotonificio, includeva le case degli operai, le ville dei
dirigenti, la chiesa, il cimitero, lo spaccio, l'ospedale, i bagni pubblici. L'imprenditore abitava invece in una
grande villa - quasi un castello medievale - collocata in posizione dominante rispetto al villaggio e circondata
da un ampio parco.
Come in questo caso esemplare, la liberale generosità che la società preindustriale si attendeva dall'élite
aristocratica era riproposta da alcuni imprenditori durante la fase di transizione, ma con una variante: la
tradizionale relazione personale fra il nobile e i lavoratori poveri era ricreata nella società industriale senza
la mediazione di strutture associative come le corporazioni o i gruppi professionali.
Mentre l'avanzata della rivoluzione industriale scuoteva alle radici le strutture sociali consolidate, si affermava in Europa una classe sociale nuova, la borghesia industriale, destinata ad assumere la leadership politica ed economica e a produrre una legislazione mirata ad attenuare gli aspetti più aspri della vita in fabbrica.
La borghesia industriale tentava per questa via di introdurre una moderata redistribuzione dei vantaggi che
traeva dal processo di industrializzazione, con interventi a sostegno di un miglioramento delle condizioni di
vita della società in generale, ma anche promuovendo una cultura favorevole alle trasformazioni in atto; in
questo modo la classe dirigente affermava la propria "egemonia" (secondo la definizione di Antonio Gramsci),
riducendo gli spazi di conflitto per stabilizzare un assetto economico industriale senza compromettere il proprio potere e la nuova distribuzione del reddito e della ricchezza.
Perché la fabbrica?
Nemmeno l'imprenditore più attento ai risvolti sociali del sistema di fabbrica era in grado di prevenire o
sanare tutti i problemi sorti con l'industrializzazione. Molti lavoratori consideravano offensivo il paternalismo
e alto livello di controllo del nuovo sistema, che appariva con evidenza a favore dei capitalisti e delle loro
imprese.
Joseph Schumpeter studiò con attenzione quei conflitti per le implicazioni che avevano sullo sviluppo del
capitalismo industriale moderno: nella sua visione gli imprenditori-innovatori erano quelli che traevano immediato vantaggio dalle nuove tecnologie e dalle nuove forme organizzative, ma la maggiore efficienza del
sistema economico aveva in definitiva portato grandi benefici alla società in generale. La "torta" economica
da spartire era diventata più grande - come in effetti avvenne durante la prima rivoluzione industriale - e,
secondo le parole di Schumpeter, questo aveva portato all'esclusione dal mercato delle vecchie organizzazioni economiche a favore delle nuove imprese, attraverso un processo di «distruzione creatrice».
Durante la prima rivoluzione industriale la coesistenza di diverse forme di impresa era la regola, e accanto
alle fabbriche centralizzate, in cui i processi avanzati di meccanizzazione consentivano di produrre con notevoli economie di scala, sopravvissero a lungo piccole unità specializzate e addirittura botteghe artigiane. La
transizione fu una fase complessa e lunga, che si svolse fra il XVIII e il XIX secolo. Nel settore cotoniero mercanti-imprenditori cominciarono presto a investire nelle nuove tecnologie della filatura, centralizzando le fasi
a monte del processo produttivo, mentre mantenevano un'ampia rete di lavoratori a domicilio e fornitori
dispersi nella tessitura e nel finissaggio.
Il sistema di fabbrica, quindi, forniva soluzioni a molti problemi, ma contemporaneamente ne creava di nuovi:
il mantenimento di costosi macchinari, la delega dell'autorità, la gestione e la trasmissione delle informazioni,
la definizione di nuove procedure e nuovi ruoli nella società. Superato il sistema della remunerazione a cottimo dei lavoratori, gli imprenditori impegnati nella produzione di massa ebbero non poche difficoltà a comprendere come mantenere disciplinata una forza lavoro che non riconosceva valore alle relazioni paternalistiche come principio di rispetto per il proprietario e i dirigenti dell'impresa.
L'ulteriore specializzazione delle funzioni portava alla svalutazione dei livelli di professionalità del lavoratore
e quindi alla genericità delle mansioni svolte nella fabbrica meccanizzata: questo offriva all'imprenditore
nuove opportunità di sfruttamento del lavoro. I frutti del progresso economico erano alla fine sottratti alla
classe operaia, che non era in grado di acquistare i beni industriali, e questo esito, secondo la teoria Marxiana,
avrebbe condotto alla crisi finale del capitalismo.
La gestione del processo produttivo attraverso la divisione del lavoro ha richiesto la formazione di una competenza specifica - una sorta di software - necessaria a produrre beni standardizzati in grande quantità-a sua
volta, questo ha imposto la ricerca di nuovi metodi di distribuzione, nuove forme di marketing e vendita al
dettaglio, ma anche nuove forme di finanziamento delle imprese.
L'affermazione del sistema di fabbrica sembra aver quindi creato sia quella nuova ricchezza auspicata da
Schumpeter, sia quei conflitti che Marx considerava come centrali in ogni forma di capitalismo. Le vecchie
forme di organizzazione della produzione lasciavano inevitabilmente il passo al sistema di fabbrica, man
mano che quest'ultimo conquistava il dominio sui mercati nazionali e internazionali: la centralizzazione della
produzione era, da un lato, imposta dalle nuove tecnologie e, dall'altro, consentiva agli imprenditori una
migliore gestione della forza lavoro, insieme al controllo degli investimenti, della produzione e della qualità
dei beni immessi sul mercato.
PARTE III – NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLA GRANDE IMPRESA
CAPITOLO 7 – LE INFRASTRUTTURE
L'emergere della grande impresa: alle origini della discontinuità
L'ultimo quarto del XIX secolo ha visto sorgere nei Paesi industriali più avanzati le grandi imprese (large corporation), destinate a diventare in poco tempo multi-unitarie, multifunzionali, multiprodotto, multinazionali.
Per la loro dimensione e complessità, queste organizzazioni richiedono, per la prima volta nella storia, una
struttura di governo formata da manager salariati - non proprietari - portatori di specifiche competenze tecniche.
Prima della rivoluzione industriale i pochi esempi di imprese di grandi dimensioni erano rappresentati da
banche, compagnie commerciali d'oltremare (come la inglese East India Company, creata durante il regno di
Elisabetta I), o manifatture statali. Questi "giganti" del capitalismo preindustriale, per quanto potenti, erano
gestiti da pochi manager e impiegati, perché il numero delle unità operative e la quantità delle transazioni
erano nettamente inferiori rispetto agli standard moderni.
Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la grande trasformazione economica iniziò con l'industrializzazione: l'uso di nuove fonti di energia (come i combustibili fossili), l'applicazione del vapore ai processi produttivi, l'introduzione di nuovi macchinari e l'ingrandimento delle fabbriche rappresentano tappe significative nella storia dell'umanità. Come scrissero due acuti osservatori contemporanei, la borghesia nella prima
rivoluzione industriale «ha creato ben altre meraviglie che le piramidi d'Egitto, gli acquedotti romani e le
cattedrali gotiche; essa ha fatto ben altre spedizioni che le precedenti migrazioni dei popoli e le crociate».
La grande impresa, però, non è sorta in concomitanza con i cambia menti sperimentati nell'Inghilterra della
fine del XVIII secolo. Le fabbriche nei settori tipici della prima rivoluzione industriale avevano dimensioni
limitate nonostante i tentativi di estendere i mercati di sbocco, a causa dei costi e delle incertezze dei trasporti a largo raggio. I dati a confronto suggeriscono che le dimensioni di allora e quelle odierne non sono
comparabili. Per esempio, un cotonificio rappresentativo di Manchester nel decennio 1830 poteva impiegare
fino a 200 lavoratori, a fronte dei 20 000 e più dipendenti registrati in 401 imprese nei Paesi a economia di
mercato nel 1971.
Gli incrementi sostanziali nella produzione e negli scambi rilevati nei primi decenni dell'Ottocento non avevano quindi sostenuto fenomeni significativi di concentrazione dell'attività economica, le aziende continuavano a svolgere una singola funzione ed erano concentrate su un unico prodotto, le strutture proprietarie e
l'organizzazione interna erano assimilabili a quelle del periodo preindustriale. Come ha spiegato Sidney Pollard, nella prima industrializzazione le funzioni amministrative e gestionali erano minime, e quindi non ha
senso «una teoria manageriale della Rivoluzione Industriale».
La diffusione delle reti di trasporto e comunicazione
La seconda metà del XIX secolo è stata testimone di un progresso senza precedenti nei sistemi di comunicazione e trasporto; innovazioni come il telegrafo e il telefono hanno infatti consentito uno scambio di informazioni sempre più veloce, efficiente, esteso.
Il telegrafo, inventato nel 1844, era già utilizzato commercialmente tre anni dopo: invenzioni e miglioramenti,
combinati con gli sforzi per la creazione di standard condivisi a livello internazionale, hanno consentito di
creare una rete per lo scambio di telegrammi - e quindi di informazioni -sulle grandi distanze, mentre l'economicità del mezzo e la facilità di installazione ne hanno sostenuto la velocità di diffusione.
L'arrivo della ferrovia rappresenta la svolta decisiva, che rende di colpo obsoleta - lenta e inaffidabile - ogni
altra forma di trasporto: cominciarono a sparire le carrozze, si eliminarono i pedaggi, il traffico di merci su
strada rimase confinato a brevi tratti, per i quali frequenza e regolarità dei servizi erano comparabili a quelli
offerti dalla ferrovia. Fino alla metà dell'Ottocento l'Europa poteva contare solo su 15 000 miglia di ferrovie
in due decenni, dal 1850 al 1870, l'espansione dei tracciati aveva raggiunto le 70 000 miglia.
Il sistema ferroviario inglese, inaugurato nel 1820, era completato al 70% nel 1875. Con la progressiva estensione e ramificazione della rete europea, le società ferroviarie assunsero le dimensioni di grandi imprese nelle
nazioni industrializzate o in via d'industrializzazione. In Inghilterra alla metà del XIX secolo solo un gruppo
esiguo d'imprese industriali poteva contare su un capitale superiore alle 500 000 sterline, ma erano ben 19
le compagnie ferroviarie con un capitale sociale più alto di 3 milioni di sterline.
Nel 1860, quando la Gran Bretagna aveva poco più di 9000 miglia di strade ferrate, gli Stati Uniti avevano
completato un tracciato che superava le 30 000 miglia; nel 1880 si contavano quasi 16 000 miglia per la Gran
Bretagna e più di 93 000 per gli Stati Uniti. Nel 1910, al completamento della rete nazionale, le ferrovie statunitensi avevano un'estensione più di dieci volte superiore a quella britannica (240 000 miglia contro 20
000). Anche l'installazione delle linee telegrafiche in Europa e negli Stati Uniti era stata rapida, in parallelo
alla posa dei binari: man mano che procedeva la costruzione della ferrovia, si installava anche il collegamento
telegrafico, componente fondamentale per il movimento rapido, sicuro ed efficiente dei treni in un sistema
sempre più esteso.
Fino alla metà del XIX secolo erano pochi i battelli di questo tipo, ma nel secondo Ottocento l’uso del vapore
rivoluzionò anche la navigazione oceanica: le navi di acciaio alimentate da turbine a vapore erano affidabili,
veloci e sopportavano carichi molto superiori a quelli delle navi a vela. Prima dei battelli a vapore la traversata
oceanica dall'Europa agli Stati Uniti poteva durare da 3 settimane a 3 mesi, mentre lo stesso tragitto su una
nave a vapore durava 10-15 giorni. Ulteriori progressi tecnologici diedero risultati positivi e molti paesi europei e del nuovo mondo adottarono diffusamente la navigatone a vapore anche per i trasporti lungo costa e
sulle vie navigabili interne.
Le reti di comunicazione e trasporto e la nascita della grande impresa
La costruzione e il completamento delle reti di trasporto e comunicazione di estensione nazionale e collegate
oltre i confini con quelle dei Paesi vicini hanno richiesto tempo, così come lo sviluppo delle competenze per
amministrarle e la creazione di istituzioni dedicate a garantirne il consolidamento. Una volta operative, però,
queste infrastrutture divennero l'elemento decisivo nella fase di formazione delle grandi imprese moderne,
prima negli Stati Uniti e, in seguito, nelle nazioni europee più avanzate. La ferrovia, in particolare, ha avuto
un ruolo critico nel processo di apertura di mercati sempre più ampi, nella ricerca di nuove forme di finanziamento, nel favorire lo sviluppo di capacità organizzative e gerarchie manageriali, ma anche di un moderno
sistema di relazioni industriali e di politiche di regolazione della concorrenza.
Treni e mercati
Il mezzo di trasporto ferroviario è diventato in breve tempo una componente fondamentale della produzione
e distribuzione su larga scala, un requisito indispensabile per la nascita delle grandi imprese industriali e
commerciali moderne. Velocità, regolarità e affidabilità erano le caratteristiche del nuovo mezzo, capace di
trasportare merci e persone sulle grandi distanze grazie alle estese interconnessioni delle reti; i vantaggi
erano infatti particolarmente evidenti in un Paese come gli Stati Uniti, dove la sostituzione dei trasporti via
acqua o con carri rivoluzionò i tempi di viaggio: il tragitto fra New York e Chicago era coperto in treno nel
1857 in tre giorni, contro le tre settimane del periodo precedente.
La locomotiva a vapore contribuì invece a ridurre sensibilmente i costi unitari di trasporto: nel tempo prima
impiegato da un battello a percorrere un unico tragitto, si vedevano ora vagoni ferroviari carichi coprire la
stessa distanza, molte volte, avanti e indietro, fra le due destinazioni. L'esito della rivoluzione dei trasporti e
delle comunicazioni della seconda metà del XIX secolo fu in definitiva un abbassamento dei costi e una velocizzazione nella distribuzione dei beni: ora le imprese avevano un importante incentivo ad accrescere la scala
delle attività e a riorganizzare in maniera più efficiente l'intero processo produttivo.
Ferrovie e finanza
La costruzione delle infrastrutture richiedeva capitali, e le stesse istituzioni finanziarie nazionali che sostennero la diffusione della rete ferroviaria saranno fondamentali nello sviluppo delle grandi imprese industriali
moderne.
In età preindustriale un imprenditore, una famiglia o un gruppo di soci erano in grado di raccogliere il capitale
necessario per avviare una piantagione, un'attività tessile o addirittura acquistare una flotta di navi. L'ammontare del capitale necessario per costruire una ferrovia era di gran lunga più alto e impose quindi il ricorso
ad altre fonti di finanziamento; i canali per convogliare capitali verso questa nuova attività furono perfezionati nella seconda metà dell'Ottocento, sia in Europa sia negli Stati Uniti.
In Germania, la costruzione delle infrastrutture ferroviarie aveva portato alla creazione delle banche universali, che avranno un ruolo decisivo anche nello sviluppo della grande impresa in altri settori, mentre negli
Stato Uniti, durante il decennio 1850, la cospicua quantità di capitali necessaria alla realizzazione delle ferrovie aveva contribuito alla creazione delle banche di investimento specializzate.
Le pressanti esigenze di finanziamento delle grandi compagnie ferroviarie statunitensi avevano favorito infine la concentrazione dei mercati finanziari: la maggioranza delle istituzioni e degli strumenti finanziari di
Wall Street servivano nella seconda metà del secolo XIX a finanziare le compagnie ferroviarie e le società
correlate, come la Western Union, la Pullmann Palace Car Company e alcune imprese carbonifere.
Le ferrovie e il management
Lo sviluppo delle ferrovie ha imposto nuove forme nell'assetto della proprietà delle grandi imprese emergenti
e, soprattutto, nelle strutture di governo aziendale. Diversamente dalle imprese di piccole dimensioni del
passato, le compagnie ferroviarie si trovavano a dover gestire enormi investimenti e numerosissimi dipendenti: il coordinamento delle attività era quindi vitale per poter fornire un servizio di trasporto sicuro ed
efficiente.
A partire dalla metà dell'Ottocento, il confronto con i problemi specifici relativi alla gestione e al finanziamento delle società ferroviarie ha reso i quadri dirigenti del settore dei pionieri nella creazione, sperimentazione e diffusione di nuove forme di management.
L'estensione complessiva della rete di trasporti statunitense - quasi tutta a binario unico - faceva sì che fosse
un imperativo per ogni singola compagnia ferroviaria dotarsi di una gerarchia manageriale dedicata alla programmazione e al controllo preciso della circolazione dei propri treni: un coordinamento efficiente era essenziale per la velocità, la regolarità e la sicurezza di un sistema di traffico che movimentava una grande
varietà di merci fra centinaia di località diverse.
La distinzione di line e staff - probabilmente mutuata dall'organizzazione militare - venne presto adottata
nelle compagnie ferroviarie Per definire la struttura dei ruoli, funzionale e flessibile, che rese possibile la
gestione di queste complesse organizzazioni. I manager di line coordinavano il movimento dei passeggeri e
dei treni e operavano secondo una gerarchia che andava dal presidente al direttore generale, al sovrintendente generale, al sovrintendente di divisione.
Nell'arco di pochi decenni, le organizzazioni manageriali delle società ferroviarie americane si rivelarono capaci di risolvere, con soluzioni inedite, tutti i nuovi problemi sorti nella gestione di imprese complesse di
grandi dimensioni. I manager delle ferrovie erano riusciti a stabilire gli standard per i binari e per le attrezzature, come gli scambi, i freni ad aria compressa e la segnaletica: poterono così muovere i convogli carichi di
merci fra centinaia di siti di carico e scarico senza soste, passando dal tracciato ferroviario di una compagnia
a quello di un'altra.
Nel 1850, prima dello sviluppo delle ferrovie, un trasporto di merci da Philadelphia a Chicago richiedeva l'uso
di carri coperti e chiatte, con nove postazioni intermedie di scarico e ricarico, per una durata di almeno tre
settimane; alla fine del secolo, grazie all'efficienza della ferrovia e ad un sistema di trasporto coordinato, lo
stesso tragitto richiedeva due giorni, un'unica operazione di carico in partenza e una di scarico alla destinazione finale.
Treni, relazioni industriali e regolamentazione della concorrenza
Le grandi compagnie ferroviarie si trovarono infatti ad affrontare su larga scala alcune questioni classiche nel
campo delle relazioni industriali- la ricerca e l'assunzione della manodopera, la formazione e la gestione della
stessa erano solo alcuni dei problemi che la dirigenza doveva affrontare, aggravati dal fatto che l'organizzazione del lavoro si svolgeva in un'area geografica molto vasta.
E ancora nell'ambito delle ferrovie statunitensi che si osservano i primi tentativi di controllo della concorrenza
attraverso accordi di cartello, quale risposta delle compagnie all'assetto fortemente oligopolistico e intensamente competitivo del settore. Nel decennio 1870 veniva infatti istituita una federazione, in risposta al sistema delle alleanze informali fra compagnie in competizione tra loro e fra le imprese che gestivano le medesime tratte ferroviarie: vennero allora fissate nel dettaglio la ripartizione dei profitti, le procedure di controllo e le sanzioni. La stabilità del sistema restava tuttavia precaria, ed erano ancora molto vantaggiosi gli
incentivi a disattendere gli accordi.
Le competenze strategiche e organizzative accumulate nel settore delle ferrovie vennero infine rapidamente
trasferite agli altri comparti dell'attività economica grazie all'apporto d'imprenditori e manager che avevano
iniziato la loro carriera nelle società ferroviarie prima di intraprendere iniziative industriali autonome.
Proprio come nel settore ferroviario era conveniente caricare al massimo treni grandi e rapidi, così Carnegie
intuì che nell'industria siderurgica la produzione di grandi quantità di acciaio avrebbe causato una drastica
caduta dei costi unitari. La strategia adottata da Carnegie, come vedremo nel prossimo capitolo, avrebbe
conosciuto una vasta popolarità nella grande impresa americana.
Sulle fondamenta materiali, finanziarie, organizzative e istituzionali costituite dalle nuove infrastrutture di
trasporto e comunicazione fu dunque possibile realizzare la rivoluzione dei processi di distribuzione e produzione nei decenni a cavallo fra il XIX e il XX secolo.
CAPITOLO 8 – TECNOLOGIA E ORGANIZZAZIONE
Le tecnologie della seconda rivoluzione industriale
Verso la fine dell'Ottocento i nuovi sistemi di trasporto e comunicazione hanno rapidamente messo in moto
la trasformazione di interi settori dell'economia, a partire dalla distribuzione delle merci.
Mentre nuovi venditori prendevano il posto dei commercianti tradizionali, empori e grandi magazzini guadagnavano velocemente popolarità nel corso della seconda metà del secolo, proponendo innovazioni quali l'entrata libera, i prezzi fissi, il vasto assortimento di beni, le vendite in saldo, rese possibili dal rapido avvicendamento dell'inventario e dell'assortimento. Le nuove forme di vendita al dettaglio, dopo il successo riscosso
negli Stati Uniti (Wanamaker, Macy, Bloomingdales, Marshall Fields) e in Francia (Bon Marche, Le Louvre, Le
Printemps, La Samaritaine), negli ultimi decenni del secolo fecero la loro comparsa anche negli altri Paesi
europei.
Anche le catene di vendita, che spesso avevano cominciato offrendo prodotti alimentari, erano cresciute
velocemente all'inizio del XX secolo: questi centri di smercio al dettaglio per il consumo popolare avevano
sottratto importanti quote di mercato ai piccoli rivenditori tradizionali, grazie alla possibilità di operare economie di scala e di diversificazione. In pochi anni arrivarono a contare su squadre di manager specializzati
nelle tecniche di vendita e nel coordinamento della distribuzione per una molteplicità di negozi collegati.
Le nuove reti di trasporto e comunicazione trasformarono infatti in profondità il mondo dell'industria - con
esiti più sconvolgenti rispetto a quelli registrati nella distribuzione - in parte perché proprio nel decennio
1870 erano state introdotte (inventate o perfezionate) numerose e varie innovazioni nei processi produttivi
di settori come quelli meccanico, chimico ed elettrico, così da essere ora completamente disponibili per l'applicazione industriale e offrire occasioni di sviluppo, impensabili fino a pochi anni prima, per una grande varietà di settori e imprese.
Questo complesso di innovazioni, correntemente definito "seconda rivoluzione industriale", si distingueva
dalla precedente fase di cambiamento industriale perché coinvolgeva volumi produttivi significativamente
accresciuti, ma anche per il ritmo del cambiamento molto più rapido.
Il dualismo settoriale e le condizioni per il successo
Le tecnologie della seconda rivoluzione industriale ebbero un impatto non uniforme sui vari rami dell'industria, al punto da creare fra i settori un profondo dualismo destinato a durare per tutto il Novecento, e a
marcare il confine fra quelli dominati dalla grande impresa e gli altri.
Già all'inizio del XX secolo le maggiori imprese industriali presenti negli Stati Uniti, in Germania e in Gran
Bretagna erano concentrate nei settori in cui resteranno dominanti fino agli anni Settanta: alimentare, chimico, petrolifero, metallurgico, meccanico e dei mezzi di trasporto.
In tutti questi settori ad alta intensità di lavoro l'innovazione tecnologica era rappresentata dal perfezionamento e dalla messa a punto dei macchinari già in uso, ma non portava alla realizzazione di grandi impianti
capaci di potenti economie di scala. Per aumentare la produzione in questi settori l'unica via era applicare
altri lavoratori e altre macchine allo stesso processo produttivo: aggiungere unità operative non significava
però ricalibrare la scala efficiente minima degli impianti.
Nell'industria petrolifera questa transizione fu particolarmente evidente: negli Stati Uniti il processo di ristrutturazione del settore e la costruzione di raffinerie capaci di ottenere grandi economie di scala furono
decisivi. L'impiego intensivo di energia necessario nella distillazione con vapore surriscaldato e nel cracking
ad alte temperature portò alla realizzazione di grandi stabilimenti progettati per aumentare sia la velocità sia
la quantità della produzione petrolifera: nel decennio fra il 1860 e il 1870 i costi fissi per l'impianto di una
raffineria crebbero da 30-40 000 dollari a quasi 60 000 dollari.
Gli investimenti necessari: la produzione
Il primo obiettivo da raggiungere per le grandi aziende impegnate nello sfruttamento delle economie di scala
e di diversificazione era quello di ottenere un elevato livello di produzione.
Due componenti risultavano quindi decisive nella determinazione dei costi e dei profitti: la capacità produttiva installata e il throughput, vale a dire la quantità di materie prime effettivamente immesse nel processo
produttivo in una data unità di tempo. L'unica via per ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità di
riduzione dei costi derivava quindi dal mantenimento di un flusso elevato e costante dei materiali nello stabilimento.
All'inizio del decennio 1880 erano quaranta le società operative nel settore petrolifero, legate da un'alleanza
che consentiva loro di esercitare il controllo della produzione. Erano entità indipendenti dal punto di vista
legale e amministrativo, ma ognuna era legata alla Standard Oil Company di John D. Rockefeller attraverso
scambi di azioni e altri stratagemmi finanziari; sebbene questo "cartello" consentisse loro di esercitare il monopolio sulla produzione di petrolio, nel 1882 le società decisero di collegarsi formalmente dando vita allo
Standard Oil Trust.
Se la Standard Oil aveva investito nella costruzione di grandi raffinerie per trarre vantaggio dalle economie
di scala, i produttori tedeschi di coloranti realizzarono investimenti anche maggiori, per sfruttare pienamente, oltre a quelle di scala, anche le economie di diversificazione. Bayer, Hoechst e BASF furono le prime
imprese chimiche a effettuare gli investimenti necessari per ottenere questi vantaggi di costo. Costruendo
impianti di grandi dimensioni, furono in grado di produrre - con lo stesso processo, le medesime materie
prime e identici composti chimici intermedi - centinaia di coloranti diversi e anche molti prodotti farmaceutici.
In molti comparti industriali i volumi prodotti da un singolo impianto operante a ciclo veloce e continuo - con
elevato throughput - erano sufficienti a permettere a un numero limitato di nuovi stabilimenti di soddisfare
la domanda nazionale (o addirittura quella globale) dell'epoca. Settori con questi tratti distintivi diventavano
facilmente oligopoli, con poche grandi imprese in competizione fra loro sui mercati mondiali.
Se le nuove tecnologie fossero state disponibili nei decenni precedenti, però, le stesse imprese non avrebbero
potuto utilizzarle sfruttando le economie di scala e di diversificazione nei settori ad alta intensità di capitale.
Conseguenze importanti dei nuovi impegnativi investimenti si registrarono nell'organizzazione del lavoro di
fabbrica, il cui controllo non poté più essere delegato ai capi officina. Alla fine del XIX secolo si diffondeva
infatti il "verbo" dell'"organizzazione scientifica" del lavoro di Fredrick W. Taylor: sulla base di un attento
studio delle reali condizioni dell'attività svolta nelle fabbriche, Taylor sostenne la necessità di una suddivisione delle fasi di lavoro in una serie di compiti elementari; tutto il know-how organizzativo, ricondotto alla
programmazione manageriale, avrebbe quindi imposto un ordine nuovo e più efficiente ai lavoratori, eliminando ogni autonomia operativa in fabbrica.
Investimenti necessari: la distribuzione
Gli investimenti in macchinari e impianti adeguati alla produzione su larga scala non erano tuttavia sufficienti
a garantire, da soli, i risultati economici attesi dalle grandi imprese. La storia delle prime large corporation
moderne dimostra che, per rendere effettive le economie di scala e di diversificazione, le imprese hanno
dovuto subito raggiungere un alto livello di integrazione verticale (a monte e a valle) per mantenere un costante throughput nel processo produttivo, evitando quindi ogni ostacolo o ritardo nell'approvvigionamento
o nella distribuzione che potesse intaccarne la regolarità.
Prima dell'affermazione delle nuove tecnologie, l'intermediario tipico si occupava della commercializzazione
di merci provenienti da diversi produttori: poteva così contare su un volume di affari elevato che gli consentiva di realizzare - a sua volta - economie di scala, abbassando i costi unitari di distribuzione; nella stessa
logica, la grande varietà delle merci distribuite consentiva agli intermediari tradizionali di mantenere più bassi
i costi di marketing e distribuzione rispetto a quelli che avrebbero dovuto sostenere i produttori per una
singola linea di merci. Infine, i distributori ottenevano economie di diversificazione operando sia all'ingrosso
sia al dettaglio.
Inizialmente gli intermediari commerciali si videro costretti a coprire i costi necessari a creare questi sistemi
specializzati di distribuzione, assumendo personale con le competenze tecniche adeguate; queste nuove
strutture e capacità erano comunque utili per una sola linea di prodotti e questo aumentava la dipendenza
diretta del distributore dal produttore. In breve, il vantaggio una volta detenuto dal distributore si era spostato dal commercio al dettaglio all'imprenditore industriale, che ora poteva contare anche su queste migliorate strutture di commercializzazione (migliorate nel know-how tecnico, nelle attrezzature e nei servizi) per
il marketing e la distribuzione dei suoi prodotti. I continui investimenti richiesti per mantenere in efficienza
tale sistema scoraggiarono alla fine gli intermediari e, contemporaneamente, incentivarono gli industriali ad
assumere in proprio i costi del marketing e delle spedizioni.
Negli Stati Uniti i fabbricanti di macchine per cucire furono fra i primi a procedere nell'integrazione verso il
sistema distributivo. Cominciarono infatti a collegare all'impresa agenti indipendenti con mandati commerciali in aree definite, impegnati a tempo pieno, retribuiti con un piccolo incentivo supplementare per ogni
commessa realizzata.
Nel decennio 1850 la Singer aveva già inaugurato i propri negozi: in ogni showroom una dimostratrice spiegava il funzionamento della macchina, un meccanico si faceva carico del servizio di manutenzione e riparazione, un venditore si occupava del servizio di vendita vero e proprio, un direttore commerciale negoziava le
condizioni di pagamento con i clienti e dirigeva l'operato del personale dipendente. I produttori di macchine
per scrivere, macchine fotografiche e registri di cassa seguirono presto l'esempio della Singer e degli altri
industriali del settore, concentrando i propri negozi nelle aree urbane densamente popolate.
Gli effetti dell'integrazione delle attività distributive si videro presto nella strategia aziendale anche sul versante dell'organizzazione delle forniture, e quindi dell'integrazione a monte. La creazione di una rete distributiva nazionale - o, addirittura, mondiale - stimolava infatti lo sviluppo di un sistema di approvvigionamento
altrettanto vasto. Il mantenimento di alti volumi di produzione imponeva infatti un sistema di fornitura efficiente e stabile di materie prime e un'accurata programmazione dei flussi di materiali fra i vari impianti.
La specializzazione delle attività relative alle forniture per ogni linea produttiva era complessa e importante
come le funzioni dedicate alla distribuzione. Una serie complicata di passaggi era necessaria per gestire la
progressiva trasformazione delle materie prime in prodotti finiti nel settore delle lavorazioni alimentari, nella
produzione di sigarette, distillati, carne e verdure in scatola, latticini, cioccolato confezionato.
Investimenti necessari: la gerarchia manageriale
L'investimento in mezzi di produzione di consistenza adeguata a generare vantaggi di costo e il quasi simultaneo investimento in reti di marketing, distribuzione e approvvigionamento per ogni linea di prodotto provoca un significativo aumento della complessità delle grandi imprese in un arco di tempo relativamente
breve.
Diversamente dalle economie di scala, che erano in relazione diretta con la tecnologia, l'imperativo di mantenere costante il flusso produttivo in una grande impresa dipendeva dalla creazione di capacità manageriali
specifiche. Competenze tecniche e capacità di lavoro in gruppo erano alcune delle componenti indispensabili
per formare un team di dipendenti interno all'organizzazione capace di sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dalle innovazioni tecnologiche della seconda rivoluzione industriale.
Se per l'imprenditore della prima rivoluzione industriale il successo derivava dalla abilità di controllare la
manodopera in fabbrica e coordinare l'attività produttiva con il supporto di un paio di tecnici e qualche
esperto venditore, l'atto critico imprenditoriale della seconda rivoluzione industriale è invece l'abilità di
creare e controllare un'estesa gerarchia manageriale.
Le gerarchie manageriali vennero inizialmente organizzate sulla base di dipartimenti, ognuno dedicato a una
specifica funzione. Al vertice di ogni dipartimento erano i dirigenti di livello intermedio, responsabili del coordinamento e del controllo delle attività dei manager di livello più basso, e del sistema di incentivi che spingeva
questi ultimi a ottenere i risultati migliori.
Uno dei dipartimenti più importanti si occupava del controllo finanziario: coordinava la distribuzione delle
risorse fra le varie unità operative, ma aveva anche il compito di garantire la trasmissione costante e veloce
di informazioni all'interno dell'impresa; il flusso di informazioni forniva al management gli strumenti necessari a monitorare le prestazioni e decidere la ripartizione delle risorse a seconda delle necessità delle varie
unità operative.
Un esempio classico di questa formula organizzativa era l'impresa chimica americana DuPont, la quale aveva
un ufficio centrale con il quale collaboravano diversi staff a definire la strategia aziendale. Le singole funzioni
(finanza, vendite, produzione, acquisti, ricerca e sviluppo, traffico) erano dirette dai dipartimenti; a ogni dipartimento facevano infine riferimento i gruppi di unità operative.
Il top management sovrintendeva all'attività nel complesso, i manager di medio livello erano a capo dei diversi dipartimenti e i manager di basso livello erano responsabili delle unità operative. Molte erano, in realtà,
le variazioni rispetto a questo tipo di struttura.
In alcune imprese industriali integrate il nucleo decisionale era formato dai dirigenti dei principali dipartimenti, dal presidente e, a volte, dal presidente a tempo pieno del Consiglio di amministrazione. Negli Stati
Uniti questa combinazione era chiamata Comitato esecutivo del Consiglio di amministrazione (Executive
Committee of the Board), mentre in Germania era nota come Consiglio di gestione (Vorstand).
Le nuove dinamiche della concorrenza
La moderna corporation industriale ha avuto origine negli anni a cavallo fra XIX e XX secolo, quando gli imprenditori hanno deciso di investire in impianti produttivi sufficientemente grandi da realizzare economie di
scala e di diversificazione, in sistemi di distribuzione e lavoratori specializzati per singole linee di prodotto, e
in un'organizzazione manageriale capace di coordinare tutte queste attività. I pionieri, i primi a realizzare
questi cospicui e rischiosi investimenti, hanno spesso acquisito notevoli vantaggi competitivi, i cosiddetti vantaggi del first mover.
Per poter competere con i first mover, i potenziali concorrenti sono stati costretti, nei decenni successivi, a
costruire impianti di dimensioni analoghe, a realizzare i necessari investimenti nella distribuzione e nella ricerca, ad assumere e formare una propria gerarchia manageriale.
Le dinamiche della competizione, sempre più aspra fra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento,
e la progressiva saturazione dei mercati nazionali hanno quindi stimolato le grandi imprese a ricercare e sperimentare nuove e varie strategie di crescita. Questa tensione ha segnato il resto del secolo e l'attività di
aziende che hanno continuato a svilupparsi aggiungendo nuove unità produttive - con modalità simili a quelle
adottate nel passato - o elaborando inediti modelli di organizzazione industriale.
CAPITOLO 9 – I MODELLI NAZIONALI
Varianti nazionali
Gli Stati Uniti e l'Europa occidentale erano le prime aree a sperimentare il cambiamento che nei decenni
seguenti si sarebbe diffuso in tutto il mondo. Differenze qualitative e temporali segnavano comunque l'affermazione delle grandi imprese nelle diverse nazioni. Gli Stati Uniti, favoriti dalla dotazione di materie prime e
da una popolazione in continua crescita, furono i primi ad approfittare di queste opportunità e acquisirono
la posizione di leader nello sfruttamento delle nuove tecnologie. Prima dello scoppio della guerra mondiale
la large corporation era ormai un fenomeno ampiamente diffuso nell'economia nordamericana, così come lo
era la rapida crescita economica del Paese.
La grande impresa nei Paesi avanzati
Le opportunità offerte dalla seconda rivoluzione industriale sono state sfruttate in maniera diversa dalle tre
maggiori nazioni industriali: Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna. Per comprendere a fondo le differenze è
necessario considerare alcune determinanti dell'azione imprenditoriale, vale a dire le caratteristiche dei mercati, la regolamentazione della competizione economica da parte dei governi, gli atteggiamenti sociali nei
confronti della grande impresa e le risorse culturali disponibili per quest'ultima.
Gli Stati Uniti
Alla vigilia della prima guerra mondiale la grande impresa si era affermata negli Stati Uniti in tutti i settori in
cui lo sviluppo tecnologico lo aveva reso possibile, sia nella produzione dei beni di consumo sia in quella dei
beni intermedi o industriali. Nella maggioranza dei casi le caratteristiche di queste imprese erano sostanzialmente differenti da quelle che le avevano precedute: in primo luogo perché si trattava di società per azioni
e non di partnership, come era comune nel passato; inoltre, queste società tendevano a integrare un crescente numero di funzioni all'interno, perseguendo sia l'espansione orizzontale sia l'integrazione verticale, e
in molti casi diventavano multinazionali.
Nei consigli di amministrazione erano allora presenti membri provenienti dall'interno dell'impresa (inside
director) e altri di provenienza esterna (outside director): i secondi rappresentavano la proprietà ed erano in
maggioranza, ma non avevano né il tempo, né le competenze, né le informazioni necessarie ad amministrare
l'impresa; erano quindi costretti a dipendere dagli inside director, manager stipendiati presenti in azienda a
tempo pieno, i quali prendevano le decisioni strategiche, ma anche quelle relative alla loro successione ai
vertici della società.
Il mercato nordamericano aveva le dimensioni di quello europeo continentale ed era estremamente dinamico grazie alla crescita esponenziale della popolazione e al progressivo incremento del potere d'acquisto
dei consumatori. L'altro fattore determinante per il consolidamento della grande impresa è da ricercare sul
versante dei cambiamenti nella pubblica opinione e nelle scelte adottate dal legislatore statunitense.
Nel corso del decennio 1880 nuovi gruppi di interesse manifestarono la loro opposizione alzando la voce
contro le concentrazioni industriali. L'applicazione delle nuove tecnologie ai processi industriali aveva causato uno squilibrio fra domanda e offerta e, conseguentemente, una generale caduta dei prezzi che aveva a
sua volta spinto le grandi imprese ad accordarsi per il controllo del mercato.
È tuttavia impossibile ignorare l'esistenza di un vero e proprio "paradosso americano" a proposito della regolamentazione della competizione fra imprese. Anche se l'intenzione delle forze politiche e della magistratura era di limitare la crescita delle large corporation, nella realtà la legislazione antitrust provocò fin dall'inizio l'effetto opposto: la proibizione legale per le imprese di stringere accordi (per esempio, di cartello o relativi alla fissazione dei prezzi) portò a un'ondata di fusioni e quindi di vincoli dati dalle gerarchie d'impresa.
Questo processo di concentrazione industriale era iniziato nel decennio 1880, ma si era esteso fino a raggiungere un boom nei decenni seguenti: fra il 1895 e il 1903, ogni anno aveva registrato una media di 300 imprese
assorbite da altre società.
Le grandi imprese sono cresciute e hanno messo salde radici negli Stati Uniti anche grazie al fondamentale
contributo del sistema educativo e formativo. Qui l'istruzione superiore seppe adattarsi velocemente alle
esigenze dell'industria: prima del 1880 i college erano genericamente dedicati alla formazione dei giovani
americani delle classi medio-alte, e solo poche università erano orientate alla preparazione dei tecnici necessari alle costruzioni ferroviarie; a cominciare dagli ultimi anni del secolo, però, centri come il Massachusetts
Institute of Technology (MIT), Purdue e Cornell diedero vita a corsi per ingegneri meccanici, elettrici e chimici.
Fondamentale fu soprattutto il ruolo del MIT, grazie agli stretti legami con imprese come la DuPont, la Standard Oil, la General Electric e la General Motors.
Lo sviluppo delle grandi corporation aveva naturalmente alterato anche l'impatto delle piccole imprese sulla
produzione della ricchezza nazionale, ma il dato importante è che la piccola dimensione non divenne obsoleta
negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Anzi, molte piccole aziende furono in grado di trovare una collocazione persino all'interno dei mercati che avevano subito le recenti spinte alla concentrazione, affermandosi
con successo in un sistema che le vedeva coesistere accanto alla grandissima dimensione delle maggiori società.
Germania
Prima del 1914, la grande azienda in Germania mostrava caratteri simili a quelli della large corporation americana, ma anche evidenti tratti originali. In particolare, la proprietà continuava a esercitare un peso nella
direzione dell'impresa e a decidere gli investimenti necessari all'espansione. I proprietari tedeschi mostravano inoltre una particolare sensibilità alla costruzione di un'estesa e selezionata gerarchia manageriale.
Diversamente da quanto stava avvenendo negli Stati Uniti, infatti, la grande corporation non assunse in Germania il ruolo di leader in tutti i settori della seconda rivoluzione industriale: a partire dalle ferrovie, come in
America, il fenomeno della crescita dimensionale si era esteso ai settori elettromeccanico, siderurgico, chimico e della meccanica pesante, mentre era quasi assente nella produzione dei beni di consumo, a causa
soprattutto del reddito pro capite nazionale relativamente basso - a confronto con quello statunitense e
britannico - ma anche perché le grandi imprese inglesi e americane avevano velocemente occupato questi
mercati.
Al contrario, già all'inizio del decennio 1880 le industrie elettromeccaniche tedesche Siemens e Allgemeine
Elektricitàts-Gesellschaft (AEG) avevano eguagliato le americane General Electric e Westinghouse per un dominio del settore a livello mondiale che durerà più di sessant'anni. All'inizio del XX secolo le due imprese
tedesche controllavano il 70% del proprio mercato nazionale e la situazione era simile nel settore chimico,
dove nel 1913 tre società (BASF, Bayer e Hoechst) non solo dominavano il mercato interno, ma coprivano fra
il 70 e l'80% della domanda mondiale di coloranti sintetici.
In Germania la relazione fra le imprese e le banche universali aveva assunto dall'inizio tratti che la differenziavano dalla situazione statunitense e da quella inglese. Nella crescita della ricchezza nazionale era stata
infatti centrale la funzione delle banche: sulla base delle loro valutazioni si erano creati flussi di investimenti
verso settori e imprese specifici e, in quanta di azionista, la banca - che poteva contare su uno staff specialisti
nei settori in cui aveva deciso di investire - arrivava a esercitare un ruolo critico nella stessa direzione delle
imprese. In effetti, i rappresentanti delle Grossbanken tedesche partecipavano in misura molto maggiore ai
processi decisionali di alto livello delle nuove società industriali rispetto a quanto avveniva negli Stati Uniti e
in Gran Bretagna.
La dimensione e le caratteristiche del mercato - interno ed estero -, la posizione delle autorità politiche nei
confronti del big business, la disponibilità di risorse: la combinazione di questi fattori ha definito i tratti del
sistema delle grandi imprese in Germania. Diversamente dagli Stati Uniti, dove il mercato interno, tanto
esteso e dinamico, rappresentava il principale target delle imprese, per l'industria tedesca erano i mercati
esteri a giocare un ruolo critico nel loro successo.
Nel 1913 la Germania era il maggiore esportatore mondiale nei settori chimico (28,5% del totale), elettromeccanico (35%), della meccanica industriale (29%). La combinazione di un mercato interno in crescita e di
mercati esteri sempre più estesi offriva sufficienti stimoli agli imprenditori tedeschi per attuare grandi investimenti, innovare, e puntare alla crescita dimensionale delle imprese.
Se la presenza dei cartelli ha segnato lo sviluppo dei settori più dinamici dell'economia tedesca, essa non ha
tuttavia eliminato la competizione fra imprese: al contrario, ha semplicemente cambiato le regole del gioco.
La partecipazione delle grandi aziende ai cartelli non ha infatti comportato un sacrificio dell'efficienza, perché
le società coinvolte negli accordi sui prezzi avevano un forte incentivo a perseguire le economie di scala e di
diversificazione, a individuare processi produttivi più efficienti e ad integrarsi verticalmente per ridurre i costi
unitari: ciò avrebbe infine permesso loro di aumentare il differenziale fra i prezzi stabiliti dal cartello e i propri
costi di produzione.
Nel caso tedesco è importante anche sottolineare lo sviluppo di eccellenti istituzioni educative di livello superiore, che hanno rappresentato una componente decisiva per il successo economico di molti settori. A
partire dalla fine del XIX secolo le università tedesche hanno ospitato alcuni dei migliori dipartimenti di ricerca
e centri di studio scientifico e tecnologico al mondo, capaci di sopravanzare per qualità gli omologhi statunitensi e britannici.
La presenza, in alcuni settori, di forti associazioni imprenditoriali ha inoltre consentito la realizzazione di piani
di crescita e ristrutturazione a lungo termine, coordinati con politiche pubbliche di sostegno e negoziati con
altri settori industriali. Queste strutture associative erano importanti anche nel coordinamento di politiche
economiche destinate a regioni diverse all'interno del Paese.
Come nel caso degli Stati Uniti, l'affermazione della corporation come protagonista dell'economia tedesca
ha cambiato, ma non eliminato, la piccola impresa. A proprietà familiare e diversificate nelle attività produttive, le piccole e medie aziende hanno continuato ad avere un posto importante nel tessuto economico nazionale, mantenendo un estremo dinamismo che, grazie alle capacità artigiane e al supporto delle associazioni locali, ha permesso loro di individuare presto promettenti nicchie industriali.
Gran Bretagna
Durante gli anni a cavallo fra XIX e XX secolo il big business inglese spiccava per la limitata integrazione verticale e, nella maggioranza dei casi, per la persistenza di un buon numero di famiglie proprietarie, che lasciavano ben poco spazio alla creazione di estese gerarchie manageriali.
Un secolo di industrializzazione aveva però fatto del Regno Unito un Paese molto differente dagli altri: i vincoli e le opportunità che gli imprenditori inglesi si erano trovati ad affrontare erano infatti diversi da quelli
dei loro pari tedeschi e americani, e anche la grande impresa aveva assunto in Gran Bretagna tratti differenti
da quelli finora descritti: era concentrata nei settori dei beni di largo consumo e, in alcuni casi, si era deciso
di non investire né nella produzione e nella distribuzione di massa né nel management.
Se, da un lato, la persistenza al comando delle famiglie è stata spesso considerata come un sintomo di arretratezza industriale nel momento in cui l'adozione delle nuove tecnologie era un imperativo, bisogna anche
ricordare che il contesto che caratterizzava la Gran Bretagna alla fine del secolo rendeva più razionale per gli
imprenditori l'adozione del paradigma statunitense del triplice investimento. Il percorso seguito con maggiore frequenza dalla grande impresa britannica è stato quindi, in buona misura, il meno efficiente, perché
non ha permesso di cogliere a pieno il vantaggio del potenziale economico insito nell'adozione delle nuove
tecnologie.
In generale le imprese inglesi sembravano godere dei vantaggi di un ampio mercato, sia interno sia internazionale. Nel 1870 la Gran Bretagna aveva infatti il reddito pro capite più alto al mondo, e il più elevato tasso
di urbanizzazione: i 10 milioni di abitanti del "quadrilatero d'oro" compreso fra Londra, Cardiff, Glasgow ed
Edimburgo rappresentavano la prima "società dei consumi", mentre nello stesso periodo, fra il 1870 e il primo
conflitto mondiale, le esportazioni britanniche ammontavano a quasi il 30% del reddito nazionale.
Nei primi anni del nuovo secolo i prodotti tessili coprivano ancora il 38% delle esportazioni inglesi, il 14% era
costituito da ferro e acciaio, i macchinari rappresentavano solo il 7 % e il carbone corrispondeva al 10%.
Anche dal punto di vista della struttura socioeconomica, una comparazione con Germania e Stati Uniti evidenzia un punto debole per l'affermazione della large corporation secondo il modello americano. Già nel
1870 l'Inghilterra aveva completato la sua trasformazione in una società urbano-industriale.
Le ragioni che hanno reso la grande impresa inglese diversa dalle dirette concorrenti straniere non sono ancora esaurite: un'altra differenza importante riguarda infatti la regolamentazione. In Gran Bretagna gli accordi per il controllo della competizione fra imprese si erano dimostrati molto efficaci: la legge non poteva
né impedirli né sanzionarli. Prevaleva un atteggiamento di "vivi e lascia vivere", perché la grande impresa
non era elemento di eccessivo disturbo per il commercio tradizionale e, tantomeno, per la piccola impresa:
proprio grazie agli accordi era in realtà assicurata anche al produttore meno efficiente la possibilità di sopravvivere e, a volte, addirittura di prosperare. Senza un gruppo di interesse che percepisse come minacciati i
propri diritti, non si vedeva l'esigenza di adottare una politica antitrust.
Mentre negli Stati Uniti il risultato fu la creazione di gerarchie manageriali centralizzate e lo sviluppo di nuove
capacità organizzative, nel Regno Unito le società nate dalle fusioni erano rimaste federazioni di imprese, di
dimensioni più piccole delle corrispondenti imprese americane. Mentre si rivelavano capaci di stabilire nuove
forme di cooperazione (per esempio, negli acquisti o nella ricerca), mantenevano come obiettivo dichiarato
quello di assicurare a ogni azienda partecipante il mantenimento della propria quota di mercato, nonché
l'assoluta autonomia gestionale. Le società nate dai merger inglesi non avevano bisogno dei grattacieli che in
America ospitavano le estese organizzazioni manageriali delle corporation che emergevano dalle fusioni: era
sufficiente un piccolo quartier generale, un ufficio dove i capi delle società federate potessero incontrarsi un
paio di volte l'anno per stabilire i prezzi, ripartire le quote di Produzione e verificare che gli accordi fossero
rispettati da tutti i partner.
Alcuni passi importanti erano in realtà stati fatti per creare università capaci di venire incontro alle richieste
di tecnici da parte delle imprese britanniche, ma poco o niente rispetto alla formazione manageriale. Alcuni
studiosi hanno attribuito questo sviluppo e altri aspetti della peculiare situazione inglese a una profonda
rivolta contro la società industriale da parte dell’élite intellettuali e di vasti strati dell'opinione pubblica. Le
evidenze empiriche non sono comunque tali da supportare una simile teoria.
Se comparata con i successi ottenuti dalla grande impresa negli Stati Uniti e in Germania, la vicenda dell'industria britannica dopo il 1880 può essere descritta in larga parte come una storia di occasioni mancate e di
ritardi che forse, con maggiore sforzo, sarebbe stato possibile colmare. Emblematico è il caso della produzione di coloranti sintetici. Nel 1870 l'Inghilterra sembrava possedere tutti i requisiti per sviluppare su larga
scala questa industria e prevalere nella competizione internazionale.
Era stato l'inglese William Perkin a inventare nel 1856 il primo colorante artificiale; il Paese era ricco di carbone (la materia prima di base), e aveva un enorme settore tessile che offriva il miglior mercato potenziale;
non erano presenti strozzature sul versante dell'offerta di capitali o delle capacità tecniche. Eppure sono
state le imprese tedesche a rivestire il ruolo diversi mover del settore nell'ultimo decennio dell'Ottocento,
rinnovando completamente gli impianti e investendo in una capillare rete di marketing.
Anche se la Gran Bretagna aveva perso il primato industriale secolare, oramai ceduto agli Stati Uniti seguiti
dalla Germania, diversi settori dell'economia inglese mantenevano posizioni forti, come quello della finanza
internazionale, destinato ad acquisire un'importanza ancora maggiore nella seconda parte del XX secolo.
Infine, in Gran Bretagna il sistema del big business - fra successi e fallimenti - si è evoluto a fianco di una
vivace articolazione di piccole e medie imprese che in alcuni campi, come il tessile, ha dato origine a estesi e
ricchi distretti industriali.
Francia
La Francia viene tradizionalmente classificata come Paese industriale ritardatario. Molti studiosi hanno sostenuto che questa collocazione deriva dalla rivoluzione francese e dalla sua eredità politica ed economica,
che ha reso il percorso nazionale all'industrializzazione più lungo e difficile. Prima del conflitto mondiale quasi
mancavano in Francia large corporation paragonabili per dimensioni a quelle statunitensi.
È possibile che i problemi più seri per la crescita delle imprese siano venuti dal lato del finanziamento, ma il
tema del rapporto fra banche e industria in Francia è ancora oggetto di dibattito fra gli studiosi; mentre è
certo che quasi tutte le maggiori società del Paese erano ancora possedute e controllate da famiglie, e questo
può aver rallentato gli investimenti nella produzione e nella distribuzione di massa.
Le imprese francesi crescevano investendo nelle nuove tecnologie, professionalizzando le strutture amministrative e sviluppando competenze organizzative tali da permettere loro di raggiungere e mantenere nel
lungo periodo una posizione di leadership nei rispettivi settori. In questa prospettiva, l'economia francese si
stava muovendo nella stessa direzione delle nazioni first mover.
L'industria siderurgica, sia pure con imprese più piccole delle tedesche a causa della minore disponibilità di
materie prime sul territorio nazionale e di un mercato interno meno ricettivo, si segnalava come la più dinamica e testimoniava l'emergere dei primi esempi di capitalismo manageriale e di produzione di massa nel
Paese.
Alla vigilia della guerra mondiale le large corporation in Francia erano concentrate sia nei settori maturi, ma
trasformati dalla seconda rivoluzione industriale, sia in alcuni comparti nuovi, come il petrolifero, l'industria
della gomma e degli pneumatici, l'automobilistico, l'elettrico e la produzione dell'alluminio. Sia pure lentamente, l'economia francese stava quindi procedendo nella stessa direzione delle economie più avanzate.
Russia
La storia della grande impresa in Russia inizia prima della rivoluzione d'ottobre del 1917: essa appare qui in
una versione che ha caratteristiche simili a quelle rilevate nelle altre nazioni.
L'intervento del governo in Russia è stato decisivo per la promozione e il sussidio alle iniziative locali, attraverso l'imposizione di dazi a protezione del mercato nazionale, e l'attrazione degli investimenti esteri, una
volta accertata la scarsa disponibilità di capitali nazionali a favore dell'industria. Ancora allo Stato si deve
attribuire l'iniziativa diretta della costruzione di quelle infrastrutture fondamentali al processo di industrializzazione e modernizzazione in un Paese di dimensioni tanto vaste, a cominciare dalle ferrovie che, come
nelle altre nazioni, rappresentarono la prima forma di big business e fornirono un massiccio stimolo alla crescita di altri settori, come il metallurgico e il meccanico. Lo Stato finanziò infatti direttamente la costruzione
di intere linee e, tra il 1892 e il 1903 prese in carico altri tratti ferroviari acquistandoli dalle compagnie private:
all'inizio del XX secolo il 70% della rete ferroviaria nel territorio russo era amministrato dallo Stato.
Nel 1892 il sindacato dei produttori di petrolio veniva infatti approvato dal governo e, tre anni dopo, era lo
stesso intervento del governo a modificare un accordo informale fra le imprese operanti nella raffinazione
dello zucchero in un cartello ufficiale. In alcuni rami industriali il successo delle imprese russe fu rimarchevole:
per esempio nella produzione di acciaio, un'attività sviluppata grazie all'importazione delle tecnologie più
avanzate.
Giappone
Il Giappone è stato il primo Paese non occidentale a raggiungere una posizione di primo piano nel panorama
economico internazionale. A partire dalla restaurazione del 1868, il governo ha attivamente promosso il processo di industrializzazione, assumendosi il compito di fondare e gestire imprese in diversi settori, da quello
minerario al cotoniero, dalla produzione di cemento, a quella del vetro, alla cantieristica, e favorendo l'arrivo
di tecnici stranieri quali consulenti; sempre all'iniziativa del governo facevano capo diversi sussidi all'attività
industriale.
Il progresso economico giapponese nei decenni a cavallo fra Ottocento e Novecento è stato senza dubbio
importante e ha aperto la strada alla fenomenale crescita industriale del Paese nella seconda metà del XX
secolo, ma la ristrettezza del mercato nazionale e il faticoso sviluppo di competenze tecnologiche adeguate
alla competizione internazionale hanno impedito alle imprese giapponesi di raggiungere - nella fase della
prima industrializzazione - livelli di efficienza pari a quelli raggiunti dal big business delle nazioni più avanzate.
Italia
Nei decenni che precedono lo scoppio del primo conflitto anche l'economia italiana ha visto l'avvio di un
vigoroso processo di industrializzazione, che possiamo qualificare come combinazione di prima e seconda
rivoluzione industriale: la diffusa presenza di piccole imprese nei comparti tradizionali coesisteva infatti con
una precoce affermazione di strutture oligopolistiche nei settori dell'industria siderurgica, meccanica ed elettrica.
La modesta dotazione di risorse del Paese, combinata con la difficoltà a raggiungere la frontiera tecnologica
internazionale, ha reso quasi inevitabile la creazione di fitti intrecci fra la grande impresa e lo Stato.
La crescita delle grandi imprese private - per esempio la Fiat per l'industria automobilistica, la Pirelli nell'industria della gomma e la Falck nel settore siderurgico - era vincolata dai limiti del mercato interno, che ne
condizionava a tal punto lo sviluppo da renderle inadeguate a un confronto con le large corporation delle
nazioni più avanzate; nondimeno, la loro presenza faceva dell'economia italiana l'unica dell'area europea
meridionale in cui si registrava un grado di industrializzazione relativamente diffusa e consolidata.
La crescita dimensionale delle imprese è stata però quasi universale, così come il trend verso l'affermazione
delle competenze tecniche nella direzione aziendale, e questo anche nelle società in cui il controllo familiare
restava saldo.
PARTE IV – STATO E MERCATO FRA LE DUE GUERRE MONDIALI
CAPITOLO 10 – L’IMPRESA MULTIDIVISIONALE E IL CAPITALISMO MANAGERIALE
Il cambiamento organizzativo nella grande impresa americana: dalla U-form alla M-form
Alla fine della prima guerra mondiale gli Stati Uniti erano il Paese industriale più sviluppato a livello mondiale:
le grandi imprese americane erano in parte il risultato di percorsi di crescita interni, in parte l'esito di fusioni.
Nel secondo caso, le imprese nate dalla fusione erano complessi di valore ben superiore alla semplice somma
delle parti iniziali, perché il processo di fusione aveva comportato la chiusura degli impianti inefficienti e la
costruzione di nuovi stabilimenti, realizzati tenendo conto della tecnologia più avanzata per sfruttare adeguatamente le economie di scala e diversificazione.
La formula organizzativa e di gestione caratteristica della grande azienda americana era, in generale, la Uform (impresa unitaria), nella quale erano individuate funzioni come la produzione, il marketing, la logistica,
le risorse umane, la finanza e i servizi legali. Spesso queste funzioni contavano sulla supervisione quotidiana
dei membri del consiglio di amministrazione: il management e il consiglio coincidevano e l'autorità era fortemente centralizzata.
Negli Stati Uniti i problemi che ne derivavano erano stati risolti nel corso del quarantennio precedente la
prima guerra mondiale. I "pionieri" avevano acquisito le necessarie competenze tecniche e manageriali mettendo a punto il nuovo disegno organizzativo, e avevano delineato chiari percorsi gerarchici (line) relativi
all'autorità e alle comunicazioni interne all'impresa. Significativi cambiamenti organizzativi erano poi intervenuti negli anni Venti, quando il ruolo del management professionale aveva acquisito un'importanza crescente: da questa fase di trasformazione era infine emersa la moderna impresa multidivisionale.
In alcuni settori, come l'elettromeccanico e il chimico, la crescita dei dipartimenti di ricerca e sviluppo (R&S)
schiudeva la possibilità di elaborare nuovi prodotti basati su tecnologie originali. In casi di questo tipo, la
crescita dell'impresa non si fondava su condizioni esterne (l'andamento dei prezzi, in preferenza, o altri fattori
legati alla domanda), quanto piuttosto sugli sviluppi interni alla stessa azienda. Per i manager, quindi, risorse
sottoutilizzate all'interno della società costituivano un continuo stimolo all'espansione, e spesso era il management stesso a rappresentare la risorsa più preziosa dell'impresa.
Un ruolo pionieristico nella soluzione di questi problemi svolsero allora la DuPont e la General Motors. I vertici di queste corporation compresero le diverse sfaccettature del problema, che imponeva di considerare A
focus sulla strategia e, insieme, l'importanza di concedere ai manager un certo grado di libertà operativa nella
gestione dei rispettivi mercati. Furono quindi definite divisioni indipendenti basate sulle diverse linee di prodotto o su aree geografiche; le nuove divisioni erano dotate delle funzioni di Une e staff necessarie a operare
efficacemente, e la struttura mostrava ora un'importante differenza: il vertice dirigente non risultava più
impegnato nelle funzioni operative ordinarie; al contrario, poteva concentrarsi sulla supervisione, sul coordinamento, sulla valutazione e sull'allocazione delle risorse per l'intero complesso.
Le divisioni recentemente costituite erano di norma definite sulla base di aree tecnologiche o geografiche. La
DuPont era partita dalla nitrocellulosa per arrivare ai pellami artificiali, alle vernici, alle fibre sintetiche e alle
materie plastiche, mentre le divisioni alla General Motors producevano locomotive diesel, trattori e aeroplani. A partire da una base comune, l'impresa multidivisionale raggiungeva così un elevato grado di coesione, pur conservando una grande flessibilità.
Nel caso dell'impresa multidivisionale, il limite alla crescita era rappresentato dalla prossimità delle nuove
produzioni al nucleo scientifico e tecnologico dell'azienda. In questa prospettiva, il processo di crescita era
proseguito, ma poteva essere efficacemente controllato.
Il modello multidivisionale richiedeva in realtà la diffusione del potere decisionale all'interno dell'impresa: se
i top manager erano comandanti in capo, i leader delle divisioni operavano come i loro generali sul campo di
battaglia.
All'inizio del decennio 1940, il pessimismo di uno dei più reputati economisti, Joseph Schumpeter, non sembrava giustificato. Schumpeter aveva descritto il capitalismo industriale basato sulla grande impresa e aveva
espresso la preoccupazione che quest'ultima avrebbe finito per soffocare le scintille di imprenditorialità che
egli associava all'egemonia borghese.
Anche le riflessioni di Oliver Williamson appaiono leggermente fuori centro se cerchiamo di afferrare il significato del modello di crescita della multidivisionale sul lungo periodo. Williamson ha proposto una brillante
analisi sulla natura della grande impresa verticalmente integrata, indicando come lo sforzo di contenere i
costi di transazione fosse un elemento chiave nel suo percorso di sviluppo.
La prospettiva di Alfred Chandler, però, con la sua visione dell'impresa come un pool di risorse tecniche e
manageriali, sembra quella capace di abbracciare tutti i temi della crescita. Il suo approccio alla storia della
grande azienda - molto vicino, a dir la verità, all'impostazione analitica dell'economista Edith Penrose - gli
permette di considerare sia l'integrazione verticale sia quella orizzontale e di gettare quindi solide fondamenta alla nostra comprensione dell'impresa moderna. Il suo lavoro su questi temi giunge a compimento
con la pubblicazione di Strategy and Structure, il volume che è alla base delle argomentazioni esposte nel
capitolo.
General Motors: successo e conflitto interno in una grande impresa multidivisionale
A questo punto è ragionevole sottolineare che la soluzione multidivisionale non ha certo rappresentato per
ogni impresa un esito, semplice e universale, di successo. Henry Ford, probabilmente il maggior imprenditore
del suo tempo, aveva un'avversione per gli organigrammi e la burocrazia aziendale, e fu incapace di compiere
questo passaggio.
Gli investimenti operati da Ford negli impianti, soprattutto nello stabilimento di Highland Park vicino a Detroit, sono diventati il simbolo della moderna produzione in serie e delle economie di scala. Nel 1921 Ford
era di gran lunga il numero uno al mondo nella produzione automobilistica: copriva il 55,7% del mercato
eterno statunitense, mentre la General Motors occupava, ben distanziala, la seconda posizione con una
quota del 12,3 %.
GM era alla fine articolata in divisioni indipendenti destinate alla produzione di automobili, autocarri e altri
veicoli commerciali, accanto a quelle dedicate alla fabbricazione di componenti per auto e accessori. Ogni
divisione era quindi dotata di una propria organizzazione per la produzione e la distribuzione.
Così ristrutturata, la GM superò presto la Ford. Se il motto di Ford era «di ogni colore, purché sia nero», la
filosofia di Sloan era invece riassunta nella frase «un'automobile per ogni borsa e per ogni scopo». La produzione automobilistica alla GM era ripartita in cinque divisioni, ognuna mirata su un diverso livello di reddito
dei consumatori. La produzione era programmata meticolosamente sulla base di indicatori riportati nelle
registrazioni mensili, che fornivano dati non soltanto sulle quote di mercato conquistate dalla stessa GM, ma,
cosa ancor più importante, su quelle della concorrenza.
Quando Ford cominciò a perdere terreno su quelli che erano stati i suoi punti di vantaggio in quanto first
mover, reagì licenziando alcuni manager in posizioni chiave per l'impresa. Sloan arrivò subito ad assumerli
per la propria organizzazione, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il suo team di dirigenti di alto livello.
A partire dal 1921 Ford stesso aveva ripreso a occuparsi della direzione operativa del suo impero, ma i risultati
non lo confortavano: la sua società era in grado di produrre solo lo stesso modello di automobile, e con gli
stessi metodi, ormai non più all'avanguardia.
Negli anni fra il 1927 e il 1937 la Ford segnava una perdita 15,9 milioni di dollari. Nello stesso periodo i profitti
netti della GM si attestavano leggermente sotto i 2 miliardi di dollari. L'anno 1940 fu quello della caduta
fatale: la quota di mercato della Ford crollava al 18,9%, inferiore rispetto al 23,7% della Chrysler, mentre la
GM deteneva quasi la metà del mercato (47,5%).
Solo dopo la morte di Henry Ford (1947) la società che portava il suo nome si dimostrava capace di riconquistare alcune delle posizioni perse, copiando la forma organizzativa della GM e assumendo manager di alto
profilo. La soluzione multidivisionale ebbe successo perché rispondeva al problema dell'allocazione del potere decisionale in una grande e complessa impresa moderna. Se il potere era conferito solo ai massimi livelli,
tutta l'organizzazione ne soffriva, a causa della mancanza di una veloce circolazione delle informazioni e della
scarsa motivazione a innovare; l'anarchia, al contrario, era il risultato di una distribuzione del potere solo fra
i ranghi inferiori.
La ristrutturazione aziendale era naturalmente più complicata di quanto la teoria della M-form suggerisca e
andava misurata sulle esigenze di ogni impresa. Aree di potere personale e compromessi abbondavano e
influenzavano le strutture di comando alla GM, così come era accaduto alla Ford. I proprietari (primi fra tutti:
la famiglia DuPont) premevano per un'applicazione ortodossa del modello teorico dell'impresa multidivisionale e, soprattutto, puntavano a escludere i capi delle divisioni dal quartier generale, per concentrare il potere in un comitato esecutivo formato dai manager di alto livello e da pochi rappresentanti degli azionisti.
Il problema relativo a chi dovesse essere incluso nel processo di pianificazione strategica non era l'unica questione pressante di divergenza fra proprietari e management. I dirigenti si opponevano vigorosamente al
diritto di veto della proprietà sui nuovi investimenti, sostenendo che le decisioni chiave in merito agli indirizzi
strategici futuri dell'impresa non potevano essere assunte da un gruppo che considerava esclusivamente
l'ultima riga del bilancio annuale (cioè i profitti e le perdite).
La battaglia fra proprietari e manager su chi dovesse guidare la trasformazione organizzativa della società era
inoltre influenzata da vincoli istituzionali e tecnici. In particolare, erano due i fattori che nel tempo avevano
impedito ai proprietari di realizzare la versione delle M-form aderente alla teoria a cui puntavano. Il primo
era la politica antitrust del governo: alla fine degli anni Quaranta il Dipartimento di giustizia iniziava una battaglia legale (alla fine coronata da successo) contro l'azionista DuPont.
I proprietari della GM furono in grado di riprendere il controllo dell'impresa solo quando la performance della
società cominciò a registrare un arretramento, negli anni fra il 1956 e il 1958, quando venne infine adottata
la versione "pura" della M-form. La nuova struttura creata nel 1958 ristabiliva infine il potere di veto degli
azionisti basato sulla finanza e imponeva una rigida separazione fra le divisioni e il quartier generale.
L'ascesa del capitalismo manageriale nel dibattito dei contemporanei: la separazione fra controllo
e proprietà e il ruolo dei manager
Indipendentemente dall'esito del caso GM, la comparsa della forma multidivisionale ha rappresentato un
fattore importante nell'affermazione dell'impresa manageriale, con la separazione fra controllo e proprietà.
All'inizio degli anni Trenta, il giurista Adolf Berle e l'economista Gardiner Means riconoscevano chiaramente
questa trasformazione e il suo impatto sul concetto di proprietà, sottolineando il divorzio fra coloro che governano un sistema e quelli che ne detengono la proprietà. Il volume del 1932 di Berle e Means, The Modem
Corporation and Private Property, offriva una serie di riflessioni originali sull'impresa americana, basate su
una vasta ricerca condotta attraverso un'indagine sistematica sulle grandi imprese negli Stati Uniti. I due
autori evidenziavano il fatto che le grandi compagnie ad azionariato diffuso erano diventate la forma economica dominante nel mondo moderno.
L'opinione di Berle e Means sull'azione dei manager era pessimista: erano infatti convinti che gli alti gradi
dell'azienda potessero dimostrarsi completamente indipendenti dalla proprietà, e capaci di perpetuare il loro
potere al punto di non dover giustificare con nessuno le loro scelte.
Per Berle e Means i vertici manageriali erano in condizione di annullare le prerogative della proprietà e vincolare la sopravvivenza stessa dell'impresa all'azione di chi aveva il compito di sorvegliarne il funzionamento
operativo. Il trasferimento del potere di controllo al management non era semplicemente l'effetto del progressivo frazionamento della proprietà, ma, piuttosto, la conseguenza della rivoluzione organizzativa imposta
dalla crescita della large corporation, in quanto il fenomeno si registrava anche nelle imprese in cui la proprietà non era suddivisa. Invece di essere parti complementari o integrate del medesimo sistema, per Berle
e Means la proprietà e il controllo erano collocati su posizioni opposte, al punto che l'una operava contro
l'altro.
Fortunatamente, scrivevano Berle e Means, «esisteva una terza alternativa»: il riconoscimento del principio
secondo il quale le moderne società quotate in Borsa non erano solo al servizio dei proprietari (o degli individui che si occupavano della loro gestione), ma, piuttosto, dell'intera comunità.
Solo la terza opzione, sostenevano gli autori, poteva schiudere il percorso dello sviluppo dell'impresa moderna secondo linee socialmente più accettabili. Di fronte alla complessità della struttura e degli interessi
organizzati presenti in essa, la moderna società per azioni aveva ragione di esistere per servire non solo i
proprietari o il gruppo dirigente, ma l'intera società. La risposta al problema del controllo societario (azionisti
contro manager) doveva quindi spostarsi su un piano diverso, mettendo al centro il valore sociale dell'impresa e gli interessi degli stakeholder: dipendenti, fornitori, distributori e, infine, i clienti, fino a estendere il
campo alla comunità intesa nel modo più ampio.
Anni prima, e in un contesto completamente diverso (quello della Germania del primo dopoguerra), Walter
Rathenau, stimata figura di manager e politico, era arrivato a conclusioni simili, dichiarando che l'impresa e
lo Stato avrebbero dovuto integrarsi nella società, allo stesso modo in cui i vari gruppi che componevano
l'impresa avrebbero dovuto integrarsi per porsi al servizio della comunità.
Era convinto che gli obiettivi del primo gruppo potessero coincidere con quelli del management, ma pensava
che il secondo gruppo rappresentasse un rischio continuo di conflitto di interessi, perché quel tipo di azionisti
era interessato solo ai guadagni sul breve periodo, mentre le imprese volevano accumulare e reinvestire gli
utili.
Rathenau, come Berle e Means, arrivava alla conclusione che gli interessi di un'impresa possono essenzialmente essere integrati nell'organizzazione e anche allineati a quelli della comunità. Gli autori americani partivano da questa premessa per delineare il potere dei manager nel quadro di un sistema tradizionale di equilibri e controlli tipico del pluralismo anglosassone.
L'esito, l'indebolimento della proprietà e la sua spersonalizzazione, erano per Rathenau non solo un'evoluzione naturale provocata dalla presenza della grande azienda, ma anche un preciso obiettivo della politica, e
uno degli elementi fondanti della "nuova economia", nella quale l'impresa avrebbe posto sé stessa al servizio
degli interessi collettivi, assumendo il ruolo di pilastro nella conservazione e nella difesa dello Stato nazionale.
Tabella 10.1 - L'adozione della M-form nelle 100 maggiori imprese dei cinque Paesi più industrializzati (%)
1932
1950
1960
1970
1980-83
1990
Stati Uniti
8
17
43
71
81
n.d.
Giappone
0
8
29
55
58
n.d.
Germania
n.d.
5
15
50
60
70
Francia
3
6
21
54
66
76
Regno Unito
5
13
30
72
89
89
CAPITOLO 11 – L’EUROPA FRA DUE GUERRE:
CONVERGENZE E DIVERGENZE CON GLI STATI UNITI
Questo processo di aggregazione attraverso fusioni e federazioni aveva alla base diversi fattori di natura sia
economica sia politica. Nell'industria chimica, un settore al centro della seconda rivoluzione industriale, i
gruppi di imprese servivano da un lato a stabilizzare i profitti e dall'altro a ridurre i costi unitari attraverso le
economie di scala e di diversificazione. Un tratto costante era infatti l'unificazione delle attività di Ricerca e
Sviluppo (R&S), delle competenze scientifiche e dei brevetti.
Una convergenza imperfetta
La vicenda dell'ICI non rappresenta un caso isolato nel periodo fra le due guerre, ma è particolarmente significativa sotto diversi aspetti. Innanzitutto, dietro questa storia si intravvede la logica ineludibile della seconda
rivoluzione industriale. La prima guerra mondiale aveva rappresentato una cesura netta nel percorso di sviluppo economico dell'Occidente, e in particolare dell'Europa.
Al di là dei gravi danni materiali sofferti dal continente, la perdita di vite umane e i grandi cambiamenti politici
e istituzionali verificatisi in quasi tutti i Paesi, la guerra aveva evidenziato la decisa modernizzazione in corso
nei settori di punta delle economie europee più avanzate.
Molti Paesi coinvolti nel conflitto avevano verificato i vantaggi connessi ai grandi volumi produttivi e all'elevata intensità di scala, proprio perché la guerra aveva messo alla prova l'efficacia dei sistemi industriali nazionali a tutti i livelli, nell'industria meccanica come in quella chimica, nella produzione di acciaio e in quella
elettrica.
Alla vigilia del secondo conflitto, fra i 50 maggiori gruppi industriali per capitalizzazione a livello internazionale, 32 erano negli Stati Uniti, 11 in Gran Bretagna e 4 in Germania (Schmitz, 1993, tab. 2). Tutte le rilevazioni
comparative disponibili sottolineano inoltre come nel periodo fra le due guerre le più grandi compagnie europee fossero, sempre in media, di dimensioni ben inferiori rispetto alle concorrenti americane. Nel settore
elettromeccanico, ad alta intensità di capitali e tecnologie, nel 1930 gli asset delle quattro maggiori imprese
statunitensi si avvicinavano a 1,3 miliardi di dollari, contro i 358 milioni delle concorrenti tedesche e i 135
milioni delle francesi.
Alle origini del "modello europeo": la ristrettezza dei mercati
In un discorso generale, la dinamica di diffusione della seconda rivoluzione industriale in Europa presenta per
lo storico alcuni punti controversi. Come era accaduto negli Stati Uniti, e nonostante alcune differenze fra i
vari Paesi, gli imperativi della nuova ondata tecnologica obbligavano gli imprenditori e i governi europei a
considerare le nuove pratiche organizzative, finanziarie e competitive.
Gli imprenditori europei che operavano nei settori più avanzati si trovarono a mettere in atto politiche di
sviluppo e integrazione, a ricercare appropriate fonti di finanziamento e di materie prime, a organizzare e
disciplinare la forza lavoro, ad aprire nuovi canali di distribuzione per i beni che stavano cominciando a produrre in scala ben maggiore rispetto al passato. Molti effettivamente ebbero successo, arrivando a creare
aziende competitive a livello internazionale, caratterizzate da un nucleo forte e durevole di competenze.
Nel complesso, la risposta europea alle sfide della seconda rivoluzione industriale fu diversa da quella americana: la diffusione del modello dell'impresa manageriale in Europa avvenne più lentamente a causa dei
fattori culturali, della struttura dei mercati e delle politiche industriali adottate dai governi in ogni nazione.
Non è difficile trovare spiegazioni alla lentezza della transizione europea al capitalismo manageriale. Nella
prima metà del XX secolo l'Europa sprofondò nella crisi e nel caos: due guerre mondiali, una crisi economica
di vaste proporzioni, le dittature, il nazionalismo economico degli anni Trenta non potevano non avere conseguenze.
Come abbiamo ricordato nel capitolo 9, la Gran Bretagna manteneva la sua posizione di leadership nei settori
caratteristici della prima rivoluzione industriale: per esempio, concentrava ancora una porzione significativa
delle attività internazionali nel comparto tessile.
Le aree periferiche del continente (l'Italia meridionale e, in qualche misura, anche le province rurali francesi)
erano ancora gravate da una diffusa arretratezza sociale ed economica, e da un esteso dominio dell'agricoltura. Queste regioni, quindi, non solo esprimevano livelli di domanda molto contenuti, ma la struttura dei
consumi era antitetica a quella delle società in cui si andavano manifestando i moderni consumi di massa.
Ciò era evidente nei settori alimentari (per cibi e bevande), ma anche in quelli dell'abbigliamento, delle calzature e dei mobili, nei quali prevalevano la piccola e media scala di produzione.
Incrementi nelle esportazioni avrebbero potuto stimolare sistemi nazionali relativamente stagnanti, così
come quelli negli investimenti esteri diretti. Questo si era verificato prima della guerra e avrebbe potuto ora
contribuire al pieno sfruttamento dei vantaggi competitivi da parte dei Paesi europei. Tuttavia, nel periodo
fra le due guerre - periodo segnato dall'esaurimento della "prima globalizzazione" e dall'azione dei regimi
economici autarchici emersi dalla Grande depressione -, non era facile costituire grandi imprese internazionali competitive.
Complessivamente, però, gli investimenti esteri furono colpiti in profondità dalla congiuntura bellica e dalla
fine della "prima globalizzazione", in particolare quelli delle imprese delle nazioni coinvolte nel conflitto. Oltre alle requisizioni e alle nazionalizzazioni operate durante la guerra, nel periodo postbellico si verificava un
esteso esproprio degli investimenti esteri dei Paesi sconfitti. Così, il denso network delle consociate costruito
in Europa dalle compagnie tedesche nel periodo precedente le operazioni belliche veniva smantellato dagli
alleati vittoriosi.
Contemporaneamente, alte barriere erano opposte nel continente alla mobilità dei capitali, e queste scelte
culminavano nelle politiche autarchiche dei primi anni Trenta: l'Europa si frammentava in mercati nazionali
circoscritti, ognuno con tassi di espansione significativamente minori di quelli registrati al di là dell'Atlantico.
Mentre il PIL pro capite statunitense, nel periodo 1914-1950, segnava tassi medi annui di crescita del 2,8%,
in Europa solo i Paesi Bassi e la Svezia erano in grado di superare il 2% annuo, mentre gli altri Paesi ristagnavano, ben distanti, con medie fra 1 % e 1,2 %.
Le origini del modello europeo: il ruolo delle istituzioni
Una conseguenza dell'"arretratezza" strutturale dell'Europa continentale fu l'adozione di politiche statali tali
da rendere più rapido l'accesso alla frontiera tecnologica internazionale. Le istituzioni pubbliche ebbero in
Europa un ruolo importante nella definizione delle regole relative alla competizione e alle strategie imprenditoriali, con effetti anche molto diversi da Paese a Paese.
I cartelli
Innanzitutto, le istituzioni giuridiche assunsero una funzione importante nella regolamentazione dei mercati
e della concorrenza. Gli europei erano molto più tolleranti nei confronti dei comportamenti "collusivi" rispetto agli americani, che avevano introdotto la legislazione federale antitrust nel 189 Al contrario, come
abbiamo visto, i cartelli erano la norma nella Germania impegnata nel processo di diffusione della seconda
rivoluzione industriale, e lo Stato sosteneva gli accordi fra imprese come un importante strumento di politica
industriale. Nel periodo fra le due guerre, la "cartellizzazione" si diffondeva in tutta Europa, diventando una
componente essenziale delle politiche economiche approntate sia dai regimi dittatoriali sia dai governi democratici.
Da un punto di vista sociale, nella cultura europea i cartelli rappresentavano una buona alternativa alle grandi
concentrazioni industriali tipiche dello "stile" americano, e questo era particolarmente vero in Paesi come la
Germania, nei quali la grande impresa e il Finanzkapital godevano di scarsa popolarità nel dibattito politicoideologico e sociale. La stabilità delle quote di mercato consentiva quindi alle aziende un'accurata pianificazione degli investimenti, mantenendo relativamente in equilibrio il livello dell'occupazione, il che era allora
altamente auspicabile, in particolare dopo lo scoppio della crisi finanziaria all'inizio degli anni Trenta.
Nel corso dei turbolenti anni fra le due guerre, i cartelli si erano diffusi velocemente anche a livello internazionale, un risultato "logico" della stagnazione e dell'instabilità dei mercati globali. Le imprese erano infatti
spinte a ricercare un elevato coordinamento con l'obiettivo di ridurre i margini di incertezza. Esempi di cartelli
internazionali e "associazioni" si trovavano così in svariati settori e produzioni, dalla chimica alla farmaceutica, dalle fibre artificiali alle lampade a incandescenza, dall'elettromeccanica al settore minerario. Alla fine
degli anni Trenta quasi tutte le imprese leader europee erano associate a un cartello internazionale. In Francia se ne contavano 69, in Germania 57, più di 40 nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna 40, in Svizzera 25 e in Italia
16.
Stati imprenditori e interventisti
Nell'esperienza dell'Europa continentale i governi hanno avuto - pur con molte sfumature diverse - un ruolo
rilevante nella creazione, nel sostegno, nella proprietà di diverse imprese nei settori ad alta intensità di capitale. In diversi casi il governo era il maggior cliente per le grandi concentrazioni industriali, in particolare per
i comparti direttamente correlati alla sicurezza nazionale; in altri casi, con ordinativi, protezione, tariffe e
anche aiuti finanziari, il supporto statale mirava alla creazione di una moderna ed efficiente base industriale
in Paesi che scontavano una debole domanda interna.
Nel 1937 il governo italiano controllava così più dell'80% del capitale azionario nella cantieristica, intorno al
25 % nell'industria meccanica e la metà nel settore siderurgico. In alcuni casi questa operazione spianava la
strada alla razionalizzazione e alla modernizzazione di interi comparti industriali, con l'adozione delle tecnologie più avanzate.
L'esperienza italiana può essere considerata un caso eccezionale, con rare imitazioni da parte delle altre nazioni europee. Il caso ICI, per esempio, esemplificava un'altra modalità di intervento, meno invasiva e diretta,
più simile a quel tipo di pressione informale che caratterizzerà, più tardi, la politica industriale del ministero
giapponese per il commercio estero e l'industria (MITI, Ministry of International Trade and Industry).
Mercati dei capitali, finanza aziendale, proprietà e controllo
Un secondo fattore determinante nella configurazione assunta dalla grande impresa europea fra le due
guerre era rappresentato dalla struttura dei mercati dei capitali e dal loro impatto sulle strategie finanziarie
aziendali. In Gran Bretagna, mentre le banche regionali e locali finanziavano la maggior parte delle piccole
imprese operanti nei settori tradizionali, un dinamico mercato azionario aveva occupato una posizione di
rilievo a supporto delle più significative iniziative imprenditoriali nell'industria e nel commercio.
Fra il 1920 e il 1940 circa 3200 società risultavano coinvolte in processi di fusione, in alcuni casi con il risultato
di creare grandi corporation caratterizzate da strutture organizzative decentrate e sistemi di contabilità moderni.
Anche se quotate in Borsa, molte imprese industriali britanniche rimanevano largamente "personali", con
esponenti della famiglia del fondatore a occupare numerosi posti nei consigli di amministrazione (talvolta
addirittura sproporzionati rispetto ai diritti conferiti dalle reali quote azionarie in loro possesso).
In Germania lo sviluppo delle grandi imprese fu sostenuto dal mercato azionario, insieme a un consistente
autofinanziamento e ad un efficiente sistema bancario, articolato in grandi istituti di credito. Come abbiamo
notato in precedenza, le banche "universali" avevano forgiato il mercato finanziario tedesco, supportando il
processo di concentrazione nel quale i proprietari maggiori erano sia famiglie sia individui o altre imprese. Le
banche più grandi investivano in titoli industriali ed erano anche influenti nei consigli di amministrazione
attraverso il voto dei loro fiduciari.
Nel resto dell'Europa continentale i mercati dei capitali assumevano intanto delle forme intermedie. In Francia e, ancor più, in Italia, le famiglie imprenditrici nei settori ad alta intensità di capitale furono in grado di
mantenere uno stretto controllo sulle loro imprese, conservando la posizione di vertice, ricorrendo in misura
relativamente limitata al mercato azionario e accentuando la dipendenza dal credito fornito dalle banche più
importanti.
Le relazioni industriali
Un altro ambito in cui si rese evidente la differenza fra Europa e Stati Uniti è quello che riguarda le relazioni
fra capitale e lavoro, sia dalla prospettiva della partecipazione dei lavoratori, sia da quella delle pratiche manageriali. Nella cultura economica europea (anche nei regimi autoritari e dittatoriali), i colletti bianchi (gli
impiegati) e le tute blu (gli operai) rappresentavano componenti fondamentali per l'impresa. La partecipazione dei lavoratori al governo dell'azienda era un tratto caratteristico dell'esperienza europea successiva al
primo grande conflitto.
Anche se il riconoscimento era puramente formale, la forza lavoro europea manteneva una posizione di rilievo nella cornice aziendale. I lavoratori si presentavano infatti con una decisa identità politica e una forza
organizzativa sindacale superiore a quella che si poteva riscontrare nel sistema delle relazioni industriali statunitensi prima del New Deal. In generale, i lavoratori americani - ben pagati - erano meno sindacalizzati e
meno interessati a un coinvolgimento diretto nella vita aziendale rispetto ai colleghi europei. La differenza
risale al fatto che in quasi tutte le grandi aziende europee la forza lavoro aveva mantenuto un certo controllo
sul processo produttivo in fabbrica, un processo guidato dagli operai specializzati, che godevano di un alto
grado di autonomia.
Alcuni tentativi di introdurre in Europa i metodi scientifici nell'organizzazione del lavoro ebbero luogo con un
certo successo, come nel caso del sistema Bedaux, che puntava a elevare la produttività attraverso un rigido
controllo dei ritmi e dei tempi di lavoro. Negli anni Venti molte aziende automobilistiche (in particolare quelle
francesi) scelsero di adottare le pratiche tayloristiche in uso oltreoceano, ma anche con queste tecniche,
apparentemente in pieno funzionamento, i livelli di efficienza delle linee di produzione europee restavano
mediamente al di sotto di quelli registrati nell'industria automobilistica statunitense. Questo dimostrava, insomma, la profonda resistenza del contesto sociale europeo all'introduzione di un sistema tipicamente americano.
Strategie e strutture delle imprese europee negli anni fra le due guerre
In questo panorama economico, nel periodo fra le due guerre le imprese europee erano rimaste in media più
piccole delle concorrenti americane, si mostravano meno interessate a promuovere la separazione fra proprietà e controllo, erano meno diversificate. Di conseguenza, strategie monosettoriali, insieme a strutture
organizzative elementari dimostrarono ovunque una notevole resistenza.
Il percorso seguito dall'Europa includeva inoltre la progressiva diffusione della H-form (struttura a holding),
che si dimostrava flessibile e adattabile a diverse situazioni. Nel caso britannico fu lo strumento che permise
di realizzare le fusioni in modo non traumatico, mantenendo in vita la tradizione inglese delle federazioni
d'imprese. Nel continente, in particolare nei Paesi in cui prevalevano mercati finanziari poco sviluppati e
aziende familiari, la stessa H-form rese possibile l'integrazione verticale e orizzontale, consentendo ai proprietari di raccogliere risorse finanziarie destinate ai processi di integrazione, senza perdere la posizione di
potere nell'impresa e nelle consociate.
CAPITOLO 12 – ALLE ORIGINI DEL MIRACOLO GIAPPONESE
Nel recente passato abbiamo visto il capitalismo assumere svariate forme, caratteristiche dell'evoluzione del
sistema nelle diverse nazioni e regioni in tutto il mondo. Differenze e somiglianze vanno ora richiamate a
proposito delle imprese e dell'economia giapponesi nell'età contemporanea.
Fra il 1820 e il 1870 il PIL giapponese crebbe con una media annua vicina allo 0,2%, contro l'1% registrato in
Europa. Nei quattro decenni seguenti, fino allo scoppio della guerra, il Giappone segnava un indice di sviluppo
annuo dell'1,5%, mentre il tasso di crescita europeo restava invariato.
Dal feudalesimo alla modernizzazione
L'anno 1868 segna l'inizio della cosiddetta "rivoluzione Meiji" (spesso definita anche "restaurazione Meiji"),
con la quale un gruppo di oligarchi, aristocratici e samurai prese il controllo del governo nazionale. Questa
seguiva a due secoli e mezzo durante i quali l'imperatore (cenno) era stato confinato a un ruolo simbolico,
mentre un leader politico e militare, lo shogun della dinastia Tokugawa, esercitava il potere effettivo. Quella
della rivoluzione Meiji è considerata convenzionalmente come la data d'inizio della storia del Giappone moderno.
Alcune eccezioni erano rappresentate dai rapporti con i mercanti olandesi e cinesi, ma, complessivamente, il
Giappone era rimasto isolato dall'Occidente e dagli sviluppi della sua economia capitalistica. All'isolamento
si accompagnava una forte rigidità sociale: la società giapponese premoderna era divisa in caste, che consentivano una mobilità minima. I contadini componevano la parte preponderante della forza lavoro, dedita in
maggioranza alla risicoltura.
L'intera economia nazionale, in realtà, compreso il sistema di imposizione di tasse e tributi, era basata sulla
produzione di riso. Artigiani e commercianti costituivano invece la seconda e la terza casta, numericamente
molto meno rilevanti. L'aristocrazia e l'élite militare - i samurai - appartenevano infine alla casta superiore.
Nonostante questi tratti di rigidità sociale, il Giappone premoderno mostrava una precoce tendenza all'urbanizzazione, sostenuta dall'insediamento e dall'affermazione economica di gruppi di commercianti e imprenditori.
Il Giappone vantava inoltre un efficiente sistema educativo basato su migliaia di scuole primarie diffuse su
tutto il territorio nazionale.
Dopo la svolta politica radicale della rivoluzione Meiji, il principale obiettivo del nuovo governo divenne la
modernizzazione economica, considerata necessaria per mantenere lo status di nazione indipendente. Un
diffuso e acceso sentimento nazionalistico incoraggiava inoltre aggressive politiche d'intervento, messe in
atto da una capace burocrazia.
L'obiettivo esplicito della nuova classe dirigente diventava quindi innestare su una base solida un processo di
catching up per "riprendere" l'Occidente: la nuova leadership dell'epoca Meiji metteva in atto a questo fine
una forte pressione sull'intera società per convincerla ad abbandonare la tradizione e raggiungere lo scopo.
L'impegno giapponese rivolto alla formazione di un capitale umano di alta qualità attraverso la riforma e il
potenziamento del sistema scolastico ottenne risultati straordinari: nel 1875 meno del 30% dei bambini giapponesi aveva accesso alla scuola primaria; vent'anni dopo la percentuale era cresciuta fino a superare il 60%,
arrivando poi quasi al 100% negli anni precedenti il primo conflitto mondiale.
Nonostante la rilevanza di questo flusso di tecnologie e conoscenze di importazione, il successo operativo di
queste imprese di proprietà dello Stato fu limitato: gli "impianti pilota" si rivelarono parzialmente inefficienti,
malamente gestiti e sottoutilizzati. La loro reale funzione era però quella di promuovere la graduale diffusione della tecnologia di frontiera, in una situazione economica che scontava la totale assenza di iniziative
private nei settori citati.
Presero piede velocemente le iniziative private: durante l'ultimo ventennio dell'Ottocento, quando il PIL giapponese cresceva del 4,3% annuo, la spesa pubblica totale segnava una crescita media annua del 4%. Questo
ebbe come esito un incremento del capitale azionario intorno al 5 % annuo, mentre la produzione del settore
minerario si attestava a un indice di crescita superiore al 10% su base annua e quella industriale superava il
6%. Nell'industria meccanica e tessile si registravano indici di crescita attorno al 10%, e una dimensione di
sviluppo simile seguiva la bilancia commerciale.
Grazie alle commesse militari e all'incoraggiamento alla formazione di cartelli, gli anni fra le due guerre vedevano un ulteriore incremento di potenza dei settori ad alta intensità di capitale. Il loro apporto alla produzione totale del settore secondario cresceva infatti dal 34% all'inizio degli anni Trenta al 55% del 1937. Fra il
1915 e il 1940 il tasso di crescita annuale dello stock di capitale fisso si attestava intorno al 7-8%, mentre il
tasso di sviluppo dei settori chimico, meccanico e siderurgico toccava incrementi percentuali annuali a due
cifre.
Da mercanti a imprenditori: la nascita degli zaibatsu
I successi dell'iniziativa privata convinsero quindi il governo giapponese a ridurre il proprio impegno diretto
in alcuni settori dell'economia nazionale: sul finire del decennio 1880, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nella modernizzazione industriale del Paese, lo Stato cominciò a vendere gli "impianti pilota" agli imprenditori privati a prezzi e condizioni favorevoli.
Negli anni fra le due guerre gli zaibatsu si diffondevano nei settori ad alta intensità di capitale, come in quelli
ad alta intensità di lavoro, nei servizi finanziari, nel settore bancario e in quello assicurativo. La loro potenza
in continua crescita era dimostrata dal fatto che, alla vigilia del secondo conflitto mondiale, ai cinque maggiori
zaibatsu - Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda e, più tardi, Nissan - era riconducibile un terzo dell'intera
produzione industriale giapponese, e più del 10% di tutto il capitale investito nel Paese.
La house bank di ogni gruppo agiva sia come creditore sia come azionista, ma ogni istituto aveva anche un
ruolo centrale di "stanza di compensazione", quando decideva come allocare le risorse in modo opportuno
fra le varie società appartenenti allo zaibatsu. L'evidenza del potere delle banche collegate ai maggiori gruppi,
potere che andava ben al di là dei puri valori economici in gioco, si ebbe alla vigilia della seconda guerra
mondiale: i tre quarti di tutti i crediti concessi in Giappone in quel periodo proveniva dalle quattro banche
dei maggiori zaibatsu del Paese.
Comunità di imprese
Gli zaibatsu svolsero indubbiamente una funzione cruciale nello sviluppo economico giapponese, ma non
deve essere sottostimato il contributo di altre iniziative imprenditoriali di piccole e medie dimensioni sparse
in tutto il Paese. La piccola azienda "imprenditoriale" era spesso attiva in settori con uno specifico contenuto
artigianale, come nella produzione delle macchine utensili e nei comparti della meccanica leggera. Un esempio interessante è quello del distretto Ota Ward, a sud di Tokio, che negli anni Trenta vedeva l'addensamento
di un sistema di imprese specializzate nella meccanica fine: nel corso del decennio l'area raggruppava più di
duemila aziende, ognuna con meno di cinquanta dipendenti.
“Famiglie che regnano, ma non governano”
I grandi gruppi diversificati giapponesi arrivarono presto a dotarsi delle gerarchie manageriali e delle strutture organizzative indispensabili per gestire le loro attività sempre più complesse e decentrate. Questi vertici
dirigenti avevano alcuni tratti in comune con gli omologhi europei e statunitensi, ma le caratteristiche di
funzionamento erano diverse.
Nel periodo precedente il secondo conflitto, la separazione fra proprietà e controllo all'interno dei grandi
gruppi era realizzata attraverso la nomina di un bantó, una sorta di general manager che tecnicamente non
apparteneva alla famiglia proprietaria, ma le era legato da anni di dipendenza e da un vincolo speciale di
fedeltà.
Parallelamente, la formazione di un proletariato industriale - un gruppo di lavoratori provenienti in larga
parte dalle campagne - poneva le compagnie di fronte al problema di motivare, disciplinare e gestire una
vasta forza lavoro. I modelli di paternalismo tradizionale che avevano regolato la società giapponese preindustriale enfatizzavano i principi di anzianità, disciplina e rispetto dell'autorità, ma anche in Giappone, come
altrove, il processo d'industrializzazione erodeva la cultura paternalistica, incoraggiando i lavoratori a cercare
risposte diverse.
I dirigenti degli zaibatsu arrivarono quindi a promuovere la stabilità della manodopera occupata attraverso
programmi di welfare, assicurarono istruzione estesi anche alle famiglie dei lavoratori. I programmi di formazione interna e una struttura salariale basata su un sistema di premi legati alle performance e ai profitti permisero infine ai manager di motivare la forza lavoro e garantirne l'obbedienza all'impresa.
Nazionalismo, militarismo e crescita industriale fra le due guerre: il ruolo dello Stato
Se gli zaibatsu hanno rappresentato una componente decisiva nel definire la "via giapponese" alla modernizzazione industriale, nel corso degli anni Trenta l'accentuazione delle politiche nazionalistiche ha avvicinato
l'esercito ai vertici dei grandi gruppi industriali, in quanto maggiori beneficiari delle commesse militari statali.
Parallelamente, i manager dei maggiori zaibatsu erano impegnati ad acquisire dall'estero le conoscenze tecnologiche più avanzate, ponendo particolare attenzione alle pratiche di reverse engineering, vale a dire lo
studio e l'imitazione delle tecnologie occidentali per migliorare la qualità e l'efficienza dell'industria nazionale.
Il governo operava intanto a sostegno della modernizzazione tecnologica nazionale incanalando verso il sistema industriale le scoperte e le conoscenze sviluppate nei laboratori di ricerca statali.
Nel settore elettrico due centri di ricerca - il primo pubblico e il secondo sotto il controllo dell'esercito e della
marina - contribuirono con importanti scoperte all'evoluzione tecnologica nei campi delle comunicazioni radio e radar.
Negli ottant'anni trascorsi fra la fine del plurisecolare isolamento del Paese e lo scoppio del secondo conflitto
mondiale il Giappone realizzò un processo di modernizzazione e operò con successo la transizione dalla prima
alla seconda rivoluzione industriale. Inizialmente nazione periferica, fu capace di raggiungere lo status di potenza economica mondiale nella seconda metà del XX secolo, grazie, almeno in parte, alle originali tecniche
organizzative e alla specifica forma d'impresa adottate in questo periodo.
La struttura organizzativa e proprietaria degli zaibatsu ha assunto tratti unici: i grandi gruppi diversificati,
responsabili di una quota considerevole dell'intera produzione industriale giapponese, erano governati da
una classe di manager professionali tecnicamente all'avanguardia, capaci di pianificare e realizzare strategie
a lungo termine destinate a spingere al massimo ritmo lo sviluppo economico dell'intero Paese.
Il successo industriale e commerciale dell'iniziativa - che immediatamente prima della seconda guerra mondiale era stata riconvertita alla produzione di automobili e cambiava il nome in Toyota - era fondato sull'accordo dell'impresa con lo zaibatsu Mitsui, che commercializzava su larga scala la sua produzione, mentre
società minori appartenenti allo stesso gruppo erano già da lungo tempo stabili azioniste della Toyota.
PARTE V – DAL DOPOGUERRA ALLA CADUTA DEL MURO
L’ETÀ DELLO “SPAZIO STRETTO”
CAPITOLO 13 - DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
ALLA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Lo scoppio della seconda guerra mondiale colse i Paesi più industrializzati in una situazione contraddittoria:
ancora indeboliti dalle conseguenze della grande depressione, cercavano contemporaneamente di incoraggiare i propri imprenditori a sfruttare tutti i vantaggi e le opportunità economiche generate dalle tecnologie,
ormai mature, della seconda rivoluzione industriale.
Alla fine del decennio 1930 i settori industriali capital intensive erano ormai presenti in tutto il mondo e
contribuivano a sostenere la crescita del PIL di molti Paesi, anche se importanti differenze nazionali ne caratterizzavano la distribuzione e l'impatto economico, come diverse erano le strategie e le strutture organizzative adottate da ogni azienda.
A partire dagli anni Venti, i dipartimenti di R&S avevano supportato le strategie di diversificazione delle grandi
imprese sviluppando nuove soluzioni tecnologiche e nuovi prodotti.
Dal punto di vista organizzativo, questo incremento dell'attività di R&S portava alla sistematizzazione del
processo di innovazione. La pratica prevalente nei primi tempi, affidata al caso e all'intuizione individuale,
veniva progressivamente sostituita dalla ricerca collettiva, in un'evoluzione paragonabile a quella in atto nelle
fabbriche, dove il funzionamento della catena di montaggio richiedeva un sistema di regole, responsabilità
definite e una gerarchia complessa e rigida.
La ricerca arrivava quindi ad assumere il carattere di risorsa strategica, soprattutto in quei settori che basavano il proprio sviluppo su una tecnologia sofisticata. Il possesso delle più avanzate conoscenze scientifiche
e di una tecnologia superiore era fondamentale per la competitività sui mercati interni e internazionali; per
proteggere le loro conquiste di punta, le imprese si servivano di un sistema di brevetti, e dalla validità di
questa protezione dipendeva la loro capacità di produrre profitti.
Gli alti costi di ricerca e sviluppo cominciarono quindi a incidere in maniera marcata sui budget di investimento delle imprese: questo poteva creare difficoltà, in particolare quando lo sviluppo di una nuova tecnologia implicava un'ampia ricerca di base, associata a un'elevata incertezza e a rendimenti differiti nel tempo.
Nelle nazioni guida della seconda rivoluzione industriale i centri di R&S delle maggiori imprese operavano
come snodi di una rete votata al progresso tecnologico, che comprendeva soggetti diversi: le università private e i politecnici (a cui negli Stati Uniti le grandi aziende destinavano consistenti finanziamenti per la ricerca
di base), i laboratori gestiti e finanziati direttamente dallo Stato, da istituzioni ad hoc, o dall'esercito. Il flusso
di invenzioni e innovazioni generato dal lavoro reticolare di tutti questi gruppi produceva una serie di effetti
di spill-over a beneficio del settore industriale, che si avvantaggiava in questo modo della ripartizione dei
crescenti costi della ricerca di base.
Le stesse grandi aziende finanziavano questa attività di ricerca di base, sia direttamente sia attraverso generose borse di studio. Accanto ai centri universitari e ai dipartimenti aziendali operavano poi laboratori di
ricerca privati e indipendenti, spesso fondati da ex docenti universitari, che svolgevano attività di ricerca su
commissione mantenendo legami stretti con la comunità accademica nazionale e internazionale.
Il National Research Council (NRC), un'istituzione pubblica in stretto rapporto con gli ambienti industriali,
cominciò a operare alla fine del 1916, poco prima dell'intervento statunitense nella guerra, con lo scopo di
promuovere e organizzare la cooperazione fra diversi centri di ricerca, pubblici e privati; fra il primo e il secondo conflitto l'NRC si dedicò allo sviluppo di tecnologie nuove in ambiti strategici come le telecomunicazioni e la raffinazione degli idrocarburi.
L'industria modellata dalla tecnologia: il ruolo della seconda guerra mondiale
Il funzionamento dei "sistemi nazionali dell'innovazione", progressivamente strutturati nella prima metà degli anni Venti, venne seriamente messo alla prova nel corso del secondo conflitto mondiale.
Durante la guerra gli Stati Uniti e la Germania furono così in condizione di procedere sulla via dell'avanzamento tecnologico in diversi settori della ricerca applicata all'ambito militare, tra cui il chimico, il farmaceutico, quello del trasporto aereo, l'elettronico, e quelli votati allo studio dei "nuovi materiali", come le fibre
sintetiche e le materie plastiche.
Innovazioni simili potevano emergere indipendentemente l'una dall'altra in diversi Paesi, generando così un
ampio ventaglio di alternative tecnologiche; le più efficienti fra queste avrebbero poi avuto effetti importanti
in guerra e anche nel dopoguerra, come nel caso della:
tecnologia del radar: basata sull'impiego delle onde elettromagnetiche, questa era sviluppata a livello
sperimentale negli anni fra le due guerre contemporaneamente nel Regno Unito, in Germania e negli
Stati Uniti;
i miglioramenti e le applicazioni successive la rendevano quindi indispensabile nelle operazioni belliche.
il motore jet era oggetto di sperimentazioni tedesche e inglesi nei primi anni Trenta, e trovava infine
applicazione in efficienti prototipi all'inizio degli anni Quaranta.
Nel periodo postbellico si intensificava la R&S in quegli ambiti caratterizzati dalla big science, nei quali l'attività innovativa era il frutto di progetti su larga scala, sia in termini di budget sia per il livello delle risorse
umane e delle strutture di ricerca impegnate.
Nei settori della big science si imponeva una convergenza tra i programmi di ricerca legati alla spesa militare
e quelli avviati dalle imprese private a fini puramente commerciali, incoraggiando queste ultime a destinare
risorse sempre più abbondanti alla R&S.
Nuovi settori per una nuova rivoluzione industriale
Larga parte dell'ondata di innovazioni di prodotto e di processo della seconda rivoluzione industriale aveva
un comune denominatore nella scienza chimica, cui si potevano ricondurre le scoperte e le applicazioni nei
settori chimico, farmaceutico, della raffinazione, della produzione di bevande e alimentari e della siderurgia.
Le nuove tecnologie sviluppate a livello industriale dal secondo dopoguerra - microelettronica, internet, motori jet e trasporto aereo di massa, energia nucleare - hanno invece la loro base scientifica e di innovazione
in processi fisici, e sono accomunate dallo sforzo di superare i precedenti limiti di spazio, tempo e materia.
La terza rivoluzione industriale ha visto la creazione di settori completamente nuovi e di nuove opportunità
di mercato che hanno indotto cambiamenti radicali in tre ampi cluster di attività economica.
Il primo è quello delle comunicazioni, con l'affermazione di internet e dei moderni sistemi di telecomunicazione. La diffusione dei personal computer su scala globale e i progressi tecnologici nella telefonia fissa e, più
tardi, in quella mobile, con i telefoni cellulari, hanno quindi permesso la realizzazione di reti di comunicazione
di massa in cui la circolazione delle informazioni avviene alla massima velocità.
La seconda area riguarda invece i trasporti, dove il progresso è stato una risposta tecnologica diretta alle
necessità imposte durante il secondo conflitto mondiale: aerei più grandi, più veloci, vennero allora costruiti
con materiali sofisticati e totalmente nuovi, come il plexiglas, con motori jet alimentati da combustibili speciali. Queste innovazioni trasformavano dopo la guerra anche l'aviazione civile, che, potendo contare sulla
considerevole riduzione dei costi di trasporto, inaugurava l'era del trasporto aereo di massa.
La terza area di addensamento delle innovazioni tecnologiche della terza rivoluzione industriale è quella della
fisica della materia. Le potenzialità ancora indefinite delle applicazioni in questo campo si erano già concretizzate nel Manhattan Project, con la produzione della bomba atomica. I programmi di ricerca per l'utilizzo
dell'energia atomica a fini pacifici iniziavano, subito dopo la guerra, in tutte le nazioni sviluppate: la sperimentazione nel settore nucleare e le possibilità di sfruttamento commerciale dell'energia derivata erano allora particolarmente importanti per quei Paesi industrializzati che cominciavano a fronteggiare le prospettive
di scarsità e i costi crescenti delle fonti energetiche tradizionali, il petrolio e il carbone.
Anticipando la crescita esponenziale della trasmissione dei dati e via voce, il Bell System individuava la necessità di potenziare la tecnologia allora esistente, quasi al limite per quanto riguardava il carico di traffico
negli Stati Uniti: il transistor rappresentava finalmente la soluzione al problema.
Shockley e il suo gruppo ottenevano il Nobel per la fisica nel 1956, per le applicazioni pratiche delle ricerche
condotte dai Bell Labs. La tecnologia dei semiconduttori - immediatamente resa disponibile sul mercato dalla
stessa AT&T - consentì quindi la sostituzione delle valvole e dei commutatori elettromeccanici, rimuovendo
la maggiore strozzatura all'espansione del sistema telefonico nazionale: questo avvenne alla fine degli anni
Cinquanta, proprio quando si era ormai reso necessario il miglioramento dell'efficienza e della performance
di una rete di telecomunicazione di dimensioni così vaste come quella americana.
I primi microchip, composti con germanio e cristalli di silicio - materiali semiconduttori di corrente elettrica venivano sviluppati all'inizio degli anni Cinquanta. A dieci anni di distanza questa innovazione era seguita dal
microprocessore, progettato e prodotto dalla Intel, una nuova impresa fondata da alcuni ex dipendenti della
Fairchild.
Nel 1955 circa il 40% della produzione di transistor era destinata a scopi militari, con una tendenza in crescita,
fino ad arrivare al 50% nel 1960. L'espansione dei consumi privati superava solo in seguito la quota delle
forniture pubbliche: alla fine del decennio 1960 la percentuale destinata alla Difesa era scesa a poco più di
un terzo, e si trattava di un livello comunque rilevante, considerato il fatto che il governo federale finanziava
la ricerca di base in questo campo, fra l'altro tramite i fondi erogati alla National Aeronautics Space Agency
(NASA).
La realizzazione di microchip, microprocessori e memorie in grado di archiviare ed elaborare enormi quantità
di informazioni, in tempi ridotti e a costi unitari rapidamente decrescenti, era ormai la premessa indispensabile per lo sviluppo e la diffusione capillare dei personal computer, iniziata nei primi anni Settanta.
Trend globali
Nell'ultimo quarto del XX secolo si è assistito a una nuova globalizzazione, testimoniata innanzitutto dall'incremento del volume e dell'intensità del commercio mondiale. Posto a 100 il valore dell'anno 2000, le importazioni e le esportazioni mondiali erano nel 1980 al livello di 30; poi, con rapida crescita, si attestavano a
54 nel 1990 e a 85 nel 1995, per passare a oltre 160 nel 2005.
La maggiore quota di questo interscambio si svolgeva - e si svolge - fra i Paesi più sviluppati. Nelle aree economicamente avanzate la globalizzazione si è presentata come un processo veloce e relativamente lineare,
che ha avuto come risultato un incremento impressionante del flusso di investimenti esteri effettuati dalle
maggiori imprese mondiali; queste, grazie alle nuove tecnologie, hanno ottenuto un sostanziale abbassamento dei costi di informazione e supervisione delle proprie controllate.
I mercati finanziari rappresentano un'altra area in cui la combinazione di innovazioni istituzionali e nuove
tecnologie ha avuto come effetto la crescita esponenziale del flusso di risorse finanziarie disponibili livello
globale per prestiti e investimenti. Un fattore concomitante è stato infine l'emergere di nuovi attori nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, che hanno reso via via disponibili risorse sempre maggiori nelle grandi
imprese multinazionali. Secondo le stime della Organisation for Economie Cooperation and Development
(OECD), tra il 1990 e il 2000 gli asset a disposizione degli investitori istituzionali (fondi comuni, fondi pensione,
compagnie assicurative, fra gli altri) attivi negli Stati membri sono quasi triplicati, fino a superare i 35 000
miliardi di dollari: un volume dieci volte superiore al livello raggiunto solo quindici anni prima.
L'intenso processo di globalizzazione esploso dopo il ciclo negativo degli anni Settanta ha quindi provocato
un radicale rimescolamento dello scenario competitivo: imprese e imprenditori hanno subito notevoli pressioni, che hanno indotto un'evoluzione delle strategie, delle strutture e delle performance organizzative.
Imprese e imprenditori nell'era dello "spazio stretto"
Le nuove tecnologie della terza rivoluzione industriale hanno dato origine a una gamma differenziata di risposte imprenditoriali. Le aziende consolidate hanno dovuto rinnovare le loro strategie per riaffermare la
posizione di first mover, mentre si aprivano spazi e opportunità per nuove attività imprenditoriali e nuovi
produttori di nicchia.
Nel settore dei mainframe prima, e dei personal computer in seguito il mercato era solo teoricamente globale, perché in pratica era controllato quasi totalmente dalle imprese statunitensi: fra le prime dieci comparivano le aziende leader nella produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche come la General
Electric, la AT&T e la Philco (elettronica di consumo); erano inoltre rappresentate tre società di punta nel
settore delle macchine per ufficio, la National Cash Register (NCR), la Burroughs e l'IBM: quest'ultima aveva
avviato un processo di diversificazione in seguito a un'azione legale antitrust, ma era evidente la contiguità
fra la sua attività industriale nel comparto dell'elaborazione dati e le nuove tecnologie informatiche.
L'IBM assumeva subito il ruolo di first mover anche nel settore dei computer, grazie agli investimenti strategici operati a partire dai primi anni Cinquanta in capitale umano e in ricerca e sviluppo, destinati sia alla
progettazione di nuovi computer sia alla realizzazione del linguaggio operativo necessario al loro funzionamento: il software.
A sostegno dell'impresa e del suo CEO, James Watson, si adoperava indirettamente anche il governo statunitense, il quale, oltre a essere il maggior cliente, ne finanziava i programmi di ricerca e la sperimentazione
dei nuovi prodotti, procurando in definitiva all'IBM un vantaggio costituito da solide barriere all'entrata in un
mercato nuovo e promettente.
Nonostante la posizione dominante, l'IBM si trovava a contrastare la concorrenza nella fascia di mercato dei
personal computer, in cui operavano alcune imprese specializzate, come la CDC e la Digital Equipement Corporation (DEC).
Nel 1963 l'IBM lanciava il System 360, dotato della nuova tecnologia dei microprocessori. Questa innovazione
aveva richiesto un investimento enorme: in quattro anni l'assunzione di 60 000 nuovi dipendenti (1000 impegnati a tempo pieno nello sviluppo del software) e la costruzione di cinque nuovi impianti, per un totale
stimato di circa 7 miliardi di dollari e perdite pesanti, fino a quando, alla fine degli anni Sessanta, il System
360 emergeva quale standard mondiale nel settore dei mainframe.
La Texas Instruments introduceva il circuito integrato alla fine degli anni Cinquanta, dopo una lunga sequenza
di investimenti in strutture produttive e commerciali. Iniziava quindi un processo di espansione internazionale che la portava al ruolo di maggior produttore mondiale di semiconduttori - con quote di mercato oscillanti fra l'I 1 e il 12% -, seguita dalla Motorola, che aveva adottato le stesse strategie espansive; la Fairchild
andava invece incontro al fallimento, non riuscendo a trasformare un'azienda dall'impronta "imprenditoriale" (a guida carismatica e basata sull'eccellenza dei singoli) in un'organizzazione integrata.
Nel mercato internazionale dei semiconduttori e dei circuiti integrati, i nuovi arrivati capaci di operare investimenti su larga scala erano quindi in grado di eccellere, ma le tecnologie che rendevano possibili questi
successi erano il frutto di prove ed errori di centinaia di piccole aziende, riunite in distretti tecnologici come
quello della Silicon Valley, in California.
Gli impianti di produzione dovevano infatti diventare sempre più grandi e costosi, e le economie di scala
sempre più elevate, con il risultato di un crollo dei costi medi unitari che induceva un processo di concentrazione in tutto il comparto e l'eliminazione dei produttori marginali e meno efficienti. Nei primi anni Sessanta
il prezzo medio di un circuito integrato era di circa 40 dollari, ma alla fine del decennio non superava i 2
dollari. Nonostante le politiche pubbliche di controllo delle forniture, i trenta produttori attivi negli anni Sessanta nel cluster della Silicon Valley erano ormai ridotti a sette nel 1980.
Nuove forme organizzative?
L'introduzione delle nuove tecnologie caratteristiche della terza rivoluzione industriale ha avuto un impatto
rilevante sulle strategie e sulle strutture delle imprese impegnate a sviluppare, promuovere e commercializzare i nuovi prodotti e servizi.
Gli investimenti in capitale intangibile, che in precedenza rientravano nelle attività di competenza della
grande impresa integrata, ora diventavano vitali per tutte le aziende che volessero operare nei nuovi mercati.
Le maggiori aziende partivano comunque in vantaggio, perché potevano contare su una consolidata pratica
di gestione delle competenze e delle capacità.
In un importante saggio dedicato al ruolo della grande impresa nel] sviluppo economico moderno, Alfred
Chandler e Takashi Hikino hanno sottolineato come una delle modalità con cui le imprese maggiori hanno
contribuito alla crescita delle economie contemporanee sia stata la loro abilità di funzionare come nodi centrali di una rete formata da piccole e medie imprese, una rete in continua espansione a seguito della globalizzazione economica.
L'età dell'informatica e dell'innovazione digitale ha abbassato i costi di informazione, contribuendo alla formazione di network di produttori coordinati da una grande impresa: un esempio significativo è rappresentato
dall'industria farmaceutica dopo la svolta verso le biotecnologie, quando si è avviata una ristrutturazione del
settore in direzione del decentramento delle unità produttive che fanno capo ai grandi gruppi, in un processo
che ha avuto il suo picco intorno all'anno 2000.
CAPITOLO 14 – L’EGEMONIA AMERICANA E IL SUO DECLINO
Quando ha termine il secondo conflitto mondiale, il grande Paese d'oltreoceano era da diversi decenni la
maggiore potenza economica del pianeta. Nessuno come gli Stati Uniti aveva afferrato le opportunità della
seconda rivoluzione industriale, quel fascio di innovazioni affermatesi sul finire dell'Ottocento, caratterizzate
da alta intensità di capitale, elevata applicazione d'energia, processo produttivo continuo e veloce, fabbricazione per grandi lotti, e che, consentendo lo sfruttamento massiccio di economie di scala e di diversificazione,
richiedevano l'approntamento di grandi impianti e vaste organizzazioni. Già all'inizio del XX secolo in America
i settori centrali per lo sviluppo - la metallurgia, la meccanica, la chimica - erano dominati dall'impresa di
ampie dimensioni: un esito tutt'altro che scontato, come dimostrano i contemporanei insuccessi inglesi su
questo terreno.
La "sfida" americana
I grandi sommovimenti politici ed economici della prima metà del XX secolo non misero in discussione la
supremazia americana, che anzi venne poderosamente rafforzata dalla seconda guerra mondiale. L'industria
non subì alcun danno dal conflitto, e addirittura beneficiò di finanziamenti statali senza precedenti a sostegno
della difesa nazionale, che stimolarono le produzioni già consolidate e si concretizzarono anche in risorse per
la ricerca - scienziati di prim'ordine giungevano negli Stati Uniti da tutto il mondo - e nella domanda di prodotti avanzati nel campo del trasporto aereo, dell'elettronica, dei materiali sintetici, dei farmaci; si trattava
di prodotti facilmente riconvertibili agli impieghi civili, come i milioni di uomini addestrati alla disciplina e ai
compiti militari, per i quali del resto il governo predispose programmi di formazione professionale e di reinserimento.
Mentre Europa e Giappone, devastati dalla guerra, erano ancora afflitti dalla penuria e dalla scarsità di beni
di prima necessità, gli Stati Uniti apparivano un paradiso del consumatore, raggiunto attraverso modernissimi
canali di distribuzione -il self-service, il fast-food - e incoraggiato da una martellante pubblicità radiofonica e
televisiva. In definitiva, all'inizio degli anni Sessanta erano pochi i settori nei quali gli Stati Uniti non risultassero in posizione di prima fila a livello mondiale.
Nei vent'anni successivi alla vittoria nel conflitto mondiale, era il clima di fiducia che pervadeva il Paese, un
atteggiamento che spingeva a nuove intraprese e al confronto con sfide rischiose. Sebbene il mercato interno
fosse tanto vasto e dinamico da limitare l'internazionalizzazione delle imprese, non mancavano certo gli investimenti all'estero.
Spinti dalla consapevolezza di una superiorità tecnica e organizzativa rispetto alle altre nazioni che tentavano
di ostacolarli con il protezionismo, e favoriti da una sicura egemonia culturale nel mondo occidentale - sempre più diffusi erano la comprensione e l'uso della lingua inglese -, gli investimenti esteri statunitensi raggiunsero una tale intensità dopo il 1960 da far parlare di "sfida americana".
Si verificarono quindi fusioni e acquisizioni prive di criteri razionali dal punto di vista industriale, mentre mutavano i sistemi gestionali e di controllo e i rapporti fra management e comunità finanziarie. C'erano anche
altre ragioni che spingevano alla diversificazione non correlata. Dopo l'approvazione della legge Celler-Kefauver nel 1950, l'azione antitrust si era fatta severa contro le operazioni di integrazione orizzontale e verticale, mentre la normativa fiscale appariva più benevola verso merger (fusioni) e acquisition (acquisizioni).
Nel periodo fra il 1973 e il 1977 le operazioni di fusione e acquisizione che portavano a una diversificazione
non correlata ammontavano addirittura alla metà del totale.
La parabola della conglomerata
Dall'ondata di fusioni e acquisizioni, la terza nella storia americana dopo quelle di inizio secolo e degli anni
Venti, emergeva un nuovo tipo di impresa, la conglomerata, che si distingueva dalla multidivisionale in
quanto il suo tratto distintivo era quello di operare in settori non correlati tra loro. Nel solo 1968 tra fusioni
e acquisizioni scomparvero negli Stati Uniti 4400 imprese, per un valore di 43 miliardi di dollari; gran parte di
queste operazioni riguardava imprese che potevano essere definite conglomerate, come per esempio la Litton Industries, che aveva finito per occuparsi contemporaneamente di macchine per ufficio, costruzioni navali ristoranti, cibi in scatola e consulenze ai governi per piani di sviluppo.
La Textron rappresentava un altro esempio significativo: iniziata la propria attività nel 1923 nel settore tessile,
nel dopoguerra entrava in diversi settori tramite fusioni realizzate per lo più durante gli anni Cinquanta e
Sessanta; nel 1963, dopo la dismissione delle attività tessili, il fatturato della società consisteva per il 35% in
prodotti aerospaziali, per il 20% in prodotti dell'industria meccanica pesante, per il 16% in prodotti di consumo, per il 17% in metalli e per il 12% in prodotti chimici per l'agricoltura.
Il grado di diversificazione raggiunto dalle aziende americane negli anni Cinquanta e Sessanta era tuttavia
anomalo, in quanto derivava dalla straordinaria situazione economica degli Stati Uniti, la cui produzione industriale nel 1950 ammontava al 45% di quella mondiale, mentre negli anni Venti era stata pari al 25%, un
livello vicino a quello a cui torneranno agli inizi del XXI secolo. La supremazia senza precedenti nella Produzione economica internazionale permetteva alle imprese americane di conseguire elevati profitti.
Molte aziende approfittarono della ricostruzione postbellica in Europa e in Giappone per espandersi sui mercati esteri tra la fine degli anni Quaranta e il decennio successivo. L'investimento in attività all'estero -reti
distributive, magazzini, impianti di assemblaggio e stabilimenti industriali - prometteva buoni profitti e crescita stabile. Non tutti i comparti produttivi, però, si prestavano a operazioni di internazionalizzazione, e anche le imprese che avevano trovato opportunità all'estero disponevano di altre opzioni per investire i propri
utili non distribuiti.
Anche le società impegnate dell'industria aeronautica e spaziale, nonché l'industria elettronica che forniva
loro i sistemi di guida e di controllo, si mossero nella stessa direzione. Esistevano tuttavia società che appartenevano a settori industriali maturi e per le quali non erano giustificabili investimenti sui mercati esteri o
iniziative di ricerca e sviluppo di ampio respiro. Si trattava di imprese siderurgiche, chimiche, automobilistiche
o attive nella produzione di beni di consumo standardizzati con tecnologie tradizionali. Nel periodo di boom
vissuto dagli Stati Uniti nel dopoguerra, anche queste aziende fornitrici di prodotti di base riuscirono a realizzare buoni profitti, ma erano le prospettive future a preoccupare i loro vertici manageriali.
L'esperienza della Armco Steel, fondata nel 1900 e arrivata a essere una delle maggiori aziende siderurgiche
a integrazione verticale degli Stati Uniti, è un esempio eloquente. La società aveva vissuto un periodo favorevole durante la guerra e nei primi anni del dopoguerra con la ricostruzione dei Paesi europei ma, alla fine
degli anni Cinquanta, il ciclo favorevole si era esaurito.
Con l'espansione dell'economia americana assicurazioni e finanza rappresentavano settori molto promettenti, e la Armco estese i propri investimenti in altre aree finanziarie: alla fine degli anni Sessanta la società
effettuava il leasing di beni strumentali pesanti quali macchinari, aeromobili, navi, materiali ferroviari, ed era
entrata nel settore immobiliare, mentre alla fine degli anni Settanta il 40% del suo fatturato era ormai estraneo all'attività siderurgica.
Naturalmente esistevano altri fattori strutturali che favorivano lo sviluppo delle conglomerate. Uno di essi
era, per esempio, l'aumento, avvenuto in maniera costante fra il dopoguerra e la fine degli anni Sessanta
della pressione fiscale sui profitti d'impresa: nel 1940 questa ammontava al 27 % sul totale, mentre nel 1969
era arrivata a sfiorare il 53 %.
Fra le trasformazioni strutturali che fornirono la base per l'espansione delle imprese conglomerate, una delle
più rilevanti fu una vera e propria rivoluzione avvenuta nel campo delle scienze manageriali, che trovava
origine nell'applicazione di modelli matematici alle attività logistiche e militari durante la seconda guerra
mondiale. I concetti e i metodi sviluppati durante il periodo bellico vennero infatti successivamente - ed entusiasticamente - applicati anche ai problemi gestionali dell'economia civile.
Negli anni Cinquanta e Sessanta le conglomerate furono al centro di un dibattito - non sempre in termini
positivi - sulla stampa specializzata.
Particolarmente criticata era la trasformazione dei top executive delle imprese conglomerate da responsabili
a tutto campo dell'efficienza della produzione e della distribuzione dei beni fabbricati, in uno o più settori
correlati, in dirigenti interessati esclusivamente ai ritorni finanziari che ci si poteva aspettare dal capitale
investito nelle diverse entità componenti il complesso aziendale.
In aiuto dei sostenitori della conglomerata era poi la constatazione che, per il periodo 1958-1966, il nuovo
modello di impresa sembrava vantare ottime prestazioni. Nell'arco di tale periodo, infatti, considerando un
campione di 58 imprese multibusiness, le performance della conglomerata erano state impressionanti: il fatturato era cresciuto del 17,8% annuo, più del doppio di quello medio delle imprese manifatturiere statunitensi, mentre i profitti erano cresciuti del 10% annuo, contro il 6,7% medio delle imprese appartenenti allo
Standard and Poor's. In realtà, i tempi d'oro non durarono a lungo.
I problemi maggiori furono individuati nella struttura amministrativa sviluppata dal management delle conglomerate, assai diversa rispetto a quella di una classica multidivisionale. I top executive infatti disponevano
di una conoscenza piuttosto esigua delle imprese acquisite; queste avevano produzioni diversissime fra loro,
tanto che il quartier generale non riusciva a controllarle adeguatamente. Mentre le aziende diversificate in
campi correlati avevano staff centrali per funzioni critiche come la Produzione, il Marketing e la Ricerca e
Sviluppo, la conglomerata ne era priva.
Ma neanche le nuove metodologie potevano incorporare aspetti non quantificabili della gestione aziendale
in un ambiente competitivo, e cominciarono a registrarsi crescenti livelli d'inefficienza nello svolgimento delle
funzioni tipiche dell'alta direzione - il controllo, il coordinamento, l'allocazione delle risorse per lo sviluppo
futuro -, che enfatizzarono ulteriormente la separazione fra il vertice della conglomerata e il middle management delle divisioni, quello che combatteva in prima linea per mercati e profitti.
Grazie al vasto patrimonio brevettuale di cui godeva, costantemente incrementato dalle grandi strutture di
ricerca interne, la RCA sfruttava in pieno la domanda generata dalla seconda guerra mondiale, non tanto di
prodotti già affermati, quanto di radar, sonar e altri congegni elettronici. Contemporaneamente l'azienda
cominciava a diversificarsi con la produzione di altri tipi di strumentazione elettronica, diventando altresì una
first moverne! nuovo mercato della televisione: prima sviluppava la tecnologia di riproduzione in bianco e
nero e, in seguito, realizzava la prima televisione a colori.
Fra il 1968 e il 1974 la RCA acquisiva la Hertz (noleggio di autoveicoli), la Banquet (cibi congelati), la Coronet
(tappeti), la casa editrice Random House, più altre aziende minori. Diventava così una conglomerata di grandi
proporzioni - l'originale business elettronico valeva ora meno di un quarto del fatturato totale - entrando
tuttavia quasi immediatamente in una spirale o crisi industriale e finanziaria.
Il peso ormai insostenibile dell'indebitamento - 2,6 miliardi di dollari nel 1981 contro 1,1 miliardi nel 1975 e il progressivo deterioramento della capacità della RCA di sviluppare e commercializzare con successo nuovi
prodotti elettronici - il lancio delle audiocassette Stereo 8 e del videodisco si risolveva in un totale fallimento
- portavano al collasso dell'azienda.
Finanzieri, banchieri e azionisti avevano inizialmente tratto profitto dalle strategie irrazionali di diversificazione non correlate che avevano portato alla creazione delle conglomerate; le conseguenze delle loro scelte
erano state in ultima analisi il peggioramento delle condizioni e delle prospettive a lungo termine delle imprese e delle industrie coinvolte. Le conglomerate non avevano fatto registrare gli andamenti positivi previsti
dai loro creatori, ed era ormai chiaro che erano diventate ingestibili per i loro stessi manager.
Nel 1982, per la prima volta in 44 anni, la Armco riportava una pesante perdita - 345 milioni di dollari, contro
un profitto di 294 milioni di dollari nel 1981 - e nel giro di un anno doveva ridurre del 23 % la forza lavoro,
tagliare le spese del 50%, abbassare il dividendo del 55% e svendere impianti per un valore superiore ai 500
milioni di dollari. Per sopravvivere, avviava un drastico piano di ristrutturazione e "dimagrimento", completato solo nel corso degli anni Novanta, che portava l'azienda a vendere gli asset acquisiti nel corso degli anni
Cinquanta e Sessanta e a concentrarsi sul core business siderurgico, in particolare sulla produzione di acciai
speciali.
La ristrutturazione degli anni Ottanta
La crisi della conglomerata portava all'inusitato fenomeno del disinvestimento. Se nel 1965 se ne aveva 1
ogni 11 merger, dieci anni dopo il rapporto era di 1 a 2. La compravendita di aziende o delle loro maggiori
divisioni divenne un business fiorente, che, sperimentato inizialmente dagli industriali, avvantaggiava alla
fine soprattutto il mondo della finanza. La febbre dei takeover degli anni Ottanta aveva fra le sue cause più
rilevanti la presenza di nuovi investitori istituzionali e dei loro manager.
Diversificazioni, disinvestimenti, compravendita e mercato per il controllo delle corporation portavano a un
notevole processo di ristrutturazione. Aziende e parti di aziende venivano comprate, vendute, separate e
ricombinate in modo impensabile in precedenza. Negli anni Settanta, come si è visto questo fenomeno si era
tradotto in un processo di "de-diversificazione" e di "de-conglomerazione" che riguardava soprattutto le società diversificate in settori non correlati, e veniva attuato dal loro management, in cerca di costi minori e
maggiori profitti.
Nel 1971 si registrava il primo deficit commerciale del secolo. Venivano ora allo scoperto alcuni lati deboli
concernenti il capitale umano. L'istruzione superiore, le università e le scuole più importanti non avevano
rivali al mondo, ma gravi problemi affliggevano la base del sistema formativo. Scarsa era la specializzazione
in discipline tecniche, carente la preparazione in matematica, nelle materie scientifiche, nella conoscenza
delle lingue straniere. Né esistevano buone scuole professionali, una lacuna che non era colmata dalla formazione aziendale, come in Giappone, o dalla lunga tradizione familiare, come in Italia.
Gli Stati Uniti conservavano formidabili posizioni di forza in settori cruciali collegati alla difesa, come l'aerospaziale, le telecomunicazioni, i computer, mentre la ricerca universitaria continuava a sfornare risultati eccezionali. Inoltre non tutti i rami dell'industria erano preda di irrazionali ristrutturazioni. Nella chimica, per
esempio, imprese stagionate come la DuPont, la Union Carbide, la Dow Chemical, la Monsanto hanno riconfigurato organizzazioni e linee di prodotto disincagliandosi dai comparti di base (soprattutto la petrolchimica)
e concentrandosi nelle specialità a più alto valore aggiunto - i farmaci, le biotecnologie, i materiali avanzati , spesso acquisendo aziende minori, pioniere in questi campi. In tal modo gli Stati Uniti restavano esportatori
nella chimica e riuscivano a resistere con successo all'intensificarsi della competizione internazionale.
CAPITOLO 15 – L’UNIOVE SOVIETICA: L’ANTAGONISTA
Dal Medioevo al comunismo
L'Unione Sovietica, il gigantesco Stato erede dell'impero russo che emerse dalla rivoluzione dell'ottobre 1917,
rappresentò la sfida più radicale a quel sistema capitalistico basato essenzialmente sulla proprietà privata dei
mezzi di produzione e sul mercato, all'interno del quale abbiamo considerato sino a ora l'evoluzione della
nostra unità d'analisi che è l'impresa. Lenin, il fondatore dello Stato sovietico, e i suoi seguaci bolscevichi
intendevano concretizzare le teorie di Karl Marx e Friedrich Engels, che vedevano nel capitalismo sfruttamento, disordine, impossibilità - dati i rapporti sociali - di sviluppare le potenzialità della tecnologia.
Il candidato ideale per questo paradiso in terra era l'Inghilterra, "officina del mondo" di metà Ottocento, o la
Germania post-bismarkiana o, ancora, gli Stati Uniti del big business. Lo stesso Marx, però, aveva preso in
considerazione la Russia zarista come un possibile candidato a questa tracimazione verso il comunismo.
Il capitalismo era ormai un sistema mondiale: se si fosse verificata la rivoluzione proletaria nel cuore del
sistema, in Inghilterra, nell'Europa centro-occidentale, o negli Stati Uniti, la Russia zarista sarebbe rapidamente passata dal Medioevo feudale alla più avanzata forma della modernità. Lenin era un fedele seguace
di questa visione, tant'è vero che affermava che il socialismo - anticamera del comunismo, una fase nella
quale a ciascuno è dato secondo il suo lavoro - era composto da due metà: quella politica in Russia, dopo la
presa del potere, e quella economica in Germania.
Nel 1919, ancora prima della nascita dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che è del 1922, veniva fondato il Komintern, ovvero l'Internazionale Comunista, come strumento per la rivoluzione mondiale.
In effetti, tentativi rivoluzionari si registravano in quel periodo in tutta Europa, in Ungheria, in Germania, in
Italia, mentre l'Armata Rossa giungeva fino alle porte di Varsavia; ma, in Occidente, la rivoluzione non si
affermava, e l'obiettivo era rimandato a tempi lunghi.
Si ebbe un ritorno, almeno sul versante economico: la NEP si basava infatti sulla cosiddetta "imposta in natura", per la quale ai contadini non veniva più requisito tutto il prodotto, tolto lo stretto indispensabile per
sopravvivere, ma, una volta pagata una tassa, o in natura o in danaro, tutto u resto rimaneva disponibile per
il libero commercio.
Egualmente si tollerava l'iniziativa della piccola impresa nell'industria nel commercio, mentre la grande impresa industriale era governata da trust, ovvero, un insieme di imprese aggregate per settore e per vicinanza
e0srafica. I trust, del resto, esistevano già nella Russia zarista di inizio secolo, un Paese che poteva vantare un
elevato livello di concentrazione industriale, se nel 1910 gli impianti con oltre 500 addetti impiegavano quasi
il 55% della forza lavoro industriale, contro poco più del 30% negli Stati Uniti. Nella Russia zarista i trust si
concentravano nella vendita di diversi prodotti, dividendosi quindi i profitti di tale attività.
Nei trust era collocato il meglio delle capacità tecniche dell'ex impero russo, tanto che, attorno al 1925, essi
incidevano per l'80% della produzione industriale lorda. Pur essendo di proprietà dello Stato, avevano lo
scopo di realizzare profitti, un obiettivo che il management poteva conseguire fissando liberamente i prezzi
(tranne che per le commesse dello Stato), anche quello del lavoro, che era il risultato della contrattazione
con i sindacati.
Tuttavia, in confronto alle organizzazioni capitalistiche, i trust presentavano due limiti precisi.
La prima era quella di Lev Trotzkij, un leader che quasi eguagliava Lenin per il prestigio che gli derivava dalle
doti intellettuali e dalle capacità concrete (era stato il fondatore dell'Armata Rossa).
Trotzkij sosteneva la necessità della rivoluzione permanente, ovvero un conflitto continuo con il mondo capitalistico; questa prospettiva, alla metà degli anni Venti, appariva priva di realismo, sia per i rapporti di forza
a livello internazionale sia per le condizioni del Partito, ripiegato su questioni interne.
La seconda posizione aveva l'esponente di maggior spicco in Nicolai Bukarin, come Trotzkij un brillante intellettuale; questi sviluppava le concezioni dell'ultimo Lenin, il quale, da buon marxista, sosteneva l'impossibilità
per la Russia di entrare da sola nello stadio del comunismo preconizzato da Marx in assenza di uno sviluppo
capitalistico.
Quella di Stalin, la terza posizione che spazzerà via le altre due, e che impronterà tutta la successiva storia
dell'Unione Sovietica, comprendeva lucidamente i limiti dei suoi rivali. Era d'accordo con Trotzkij sul fatto
che il confronto cruento con il mondo capitalistico fosse inevitabile, ma riteneva che l'Unione Sovietica
avrebbe potuto affrontarlo solo quando fosse stata un Paese industrializzato, militarmente forte. Per questo
era necessario il sacrificio dell'agricoltura, i cui prezzi dovevano essere tenuti artificialmente bassi nel confronto con quelli dei prodotti industriali. Un obiettivo del genere poteva realizzarsi solo eliminando qualsiasi
forma di capitalismo nelle campagne.
La dittatura del Piano
Il Piano (Gosplan) si collocava al massimo livello di governo ed era simile a un gigantesco ufficio centrale di
un'impresa multiunitaria. Coadiuvato dai diversi ministeri che si occupavano dei settori industriali, stabiliva
che cosa produrre, in quali quantità, con quali caratteristiche tecnologiche, in quali localizzazioni, a quali
prezzi, a quali salari e quindi, in definitiva, determinava la produzione complessiva e le linee di investimento.
Le imprese, riunite in unità amministrative di produzione territoriale (dlavk), non dovevano più concentrarsi
sui profitti, ma solo sulla realizzazione delle quantità produttive stabilite dal Gosplan.
Dei tre livelli del management tipici di un'impresa occidentale, l'impresa sovietica poteva contare solo sul
lower. Il middle e il top management erano fuori di essa, operando il primo nei dipartimenti funzionali, il
secondo nel Gosplan. Una conseguenza di tale assetto era la fluidità del-1 impresa in Unione Sovietica. Essa,
infatti, poteva essere chiusa o riaggregata ad altre entità aziendali come avveniva nell'economia capitalistica
Per un'unità operativa all'interno di un'impresa privata. Tutto ciò era un serio ostacolo all'acquisizione di
quelle capacità organizzative che costituiscono la forza delle imprese nelle economie di mercato.
L'economia di Piano riusciva anche a procurare un certo limitato benessere ai cittadini sovietici, con la diffusione di beni di consumo durevole. Diventava evidente, però, che un sistema cosi rigido, se funzionava efficacemente per un grande balzo in avanti o per obiettivi eccezionali, appariva inadatto a un progresso continuo ed equilibrato fra i diversi settori, sia quelli pesanti sia quelli dedicati al consumo diffuso. Con particolare
chiarezza emergeva poi il limite di un'impresa priva di capacità decisorie. Dopo la scomparsa di Stalin e con
l'ascesa al potere di Chruscév veniva compiuto un tentativo di limitare la forte centralizzazione delle decisioni
e della supervisione dell'attività economica. Venivano quindi soppressi i ministeri a cui facevano capo i vari
settori industriali e sostituiti da organizzazioni territoriali di gestione industriale (sovnarkhozy).
Anche le "associazioni per la produzione", tuttavia, presentavano caratteristiche che le differenziavano dalle
imprese occidentali e che costituivano un limite sulla via dell'efficienza. Esse, infatti, continuavano a detenere
una scarsa capacità decisionale per ciò che concerneva i salari, le assunzioni e i licenziamenti, e anche per la
destinazione degli investimenti. In realtà, i dipartimenti funzionali del Gosplan - il Gossnab e il Gostekhnika,
che si occupavano della fornitura alle imprese e della congruenza tecnologica dei prodotti finiti; il Goss-komtsen, che stabiliva il prezzo delle merci; il Gosskomtrud, che sovraintendeva alle condizioni e alla remunerazione del lavoro; il Gosstandard, che, invece, si dedicava al controllo della qualità e della standardizzazione
dei prodotti - conservavano tutto il loro potere. Si creava quindi una forte contraddizione fra questa sovrastruttura nazionale e le esigenze delle nuove organizzazioni.
L’assenza di una “comunità di imprese”
In un brillante saggio sull'evoluzione del sistema sovietico, l'economista russo Andrei Yudanov, sottolineava
il fatto che in Unione Sovietica non mancava la grande impresa, per quanto, come si è visto, ridotta soprattutto alle dimensioni della fabbrica. Ciò che era totalmente assente, rilevava lo studioso, era una «comunità
naturale» di imprese, le quali, perseguendo strategie competitive diverse, avevano creato la solidità del tessuto economico nelle realtà produttive dell'Occidente. Yudanov ci ricordava che in medicina le patologie
possono essere classificate come morfologiche o funzionali.
In Occidente possiamo individuare quattro principali tipi di strategia:
1. la strategia che punta sul volume, ovvero che si concentra sui prodotti standardizzati di massa, e il
cui obiettivo è di attrarre i consumatori con una giusta combinazione qualità/prezzo;
2. la strategia di nicchia, la cui forza deriva dal fatto che una fascia, per quanto limitata, di consumatori,
ritiene determinate merci indispensabili. Ci si concentra, quindi, su un piccolo segmento del mercato,
al quale si tende ad assicurare la maggior quota possibile di prodotto;
3. la strategia personalizzata, che si adatta a una produzione su piccola scala, non specializzata, e mira
a soddisfare qualunque richiesta del mercato, che, di solito, è un mercato locale. Questa strategia
richiede imprese dotate di grande flessibilità, determinate a ottenere il più elevato margine di profitto possibile;
4. la strategia che ha come obiettivo l'introduzione sul mercato di radicali innovazioni. È un orientamento ad alto rischio, e richiede anch'esso una specializzazione.
Prendiamo il caso di una delle imprese emblematiche dei nostri giorni, Mac Donald's ai suoi inizi. Il celebre
venditore di hamburger aveva bisogno di un tipo particolare di cheddar cheese. Rivoltosi al gigante Kraft, ne
otteneva un rifiuto perché per un'azienda alimentare di quelle dimensioni le quantità richieste da Mac Donald's erano troppo limitate. Rapidamente Mac Donald's trovava in un'azienda del Wisconsin, la Schreiber,
l'impresa di nicchia in grado di fornire, con notevole profitto, il formaggio per i suoi famosi cheese burger.
L'innovatore nella grande impresa è persona "non grata". Questo avveniva puntualmente anche in Unione
Sovietica, dove il burocrate, diffidente nei confronti di nuovi metodi produttivi o di nuovi prodotti, faceti per
molti versi, gli interessi della sua azienda. Nei Paesi occidentali, Però, grazie a forme di venture capital, erano
presenti piccole imprese esploratrici, che dimostravano la possibilità di commercializzare nuovi prodotti: in
seguito esse stesse, grazie al successo ottenuto sul mercato, acquisivano dimensioni adeguate per la produzione di massa, oppure venivano rilevate da grandi compagnie dotate delle strutture e delle risorse necessarie per fabbricare su larga scala i beni "sperimentati" dalle prime.
Una fine ingloriosa
Il dato di fondo nella storia delle imprese sovietiche, tuttavia, è la rigidità del Piano; i meccanismi di promozione dell'economia messi in atto in questo quadro si sono rivelati di grande efficacia nelle fasi eccezionali di
industrializzazione forzata o di guerra patriottica. In queste fasi, oltretutto, il regime politico totalitario godeva, nonostante la generalizzata e atroce opera di repressione, di un diffuso consenso, garantendo, per
esempio, una forte mobilità sociale. Figli di operai e di contadini si laureavano in legge, come Gorbaciov, o
diventavano ingegneri, come Breznev e Kosygin. Ma, a lungo andare, nei momenti in cui l'economia non era
chiamata a una straordinaria mobilitazione, l'"istituzione Piano" si rivelava nettamente inferiore "istituzione
Mercato".
La fine dell'Unione Sovietica è contrassegnata da risvolti che hanno connotazioni fra l'assurdo e il ridicolo,
ma che sono, soprattutto, tragici. L'aspetto ridicolo riguardava, per esempio, i tanti direttori di stabilimento
che pretendevano il premio di produzione perché avevano raggiunto le quantità stabilite, a prescindere dalle
caratteristiche e dalla qualità dei beni prodotti. Al responsabile di un calzaturificio, per esempio, non importava nulla di aver fabbricato migliaia di paia di scarpe da donna con il tacco nella parte anteriore...
L'aspetto tragico riguarda invece i gulag e il ferreo controllo sulla società operato dalle diverse polizie segrete:
la CEKA, poi la GPU, infine il KGB. Queste forme di gestione terroristica del potere appaiono inevitabili in una
società nella quale è lo Stato, unico datore di lavoro, a decidere dei bisogni dei cittadini. Si avverava infine la
profezia di Plekhanov, il marxista ortodosso che, all'inizio del secolo, polemizzava con Lenin, rimproverandogli di voler costruire, nelle concrete condizioni socio-economiche russe, non già il socialismo, ma «un impero
Inca».
CAPITOLO 16 – IL GIAPPONE LO SFIDANTE
Nei decenni intercorsi fra la fine dell'isolamento economico, alla metà dell'Ottocento, e il secondo conflitto
mondiale, il Giappone aveva conosciuto un notevole processo di maturazione industriale, culminato con l'ingresso nei principali settori della seconda rivoluzione industriale. La nazione asiatica era riuscita così a imboccare con successo un percorso di rapidissima modernizzazione sociale ed economica, che, tuttavia, alla
vigilia della guerra, non si è ancora dimostrata sufficiente per colmare interamente il gap nei confronti dell'Europa e degli Stati Uniti, dovuto al ritardo con cui il Giappone aveva mosso i primi passi verso l'industrializzazione.
Il periodo precedente non è privo tuttavia di eredità significative. In alcuni comparti dell'industria come la
meccanica pesante e l'elettromeccanica erano sorte aziende che integravano produzione e distribuzione alla
maniera americana. I due elementi più importanti, come si è visto in pre-faenza, erano però la presenza di
grandi gruppi che riunivano al proprio eterno attività commerciali, industriali, finanziarie (gli zaibatsu).
L'interventismo dello Stato si manifestava con particolare vigore, negli anni fra le due guerre, in un clima di
bellicoso nazionalismo, sia attraverso l'emanazione di una fitta rete di norme per il controllo e la regolamentazione dell'attività industriale, sia con la creazione di nuove istituzioni, la più importante delle quali fu il
Ministero del commercio e dell'industria: fondato nel 1925, nel secondo dopoguerra si trasformava nel Ministero dell'industria e del commercio internazionale (generalmente noto con la sigla MITI).
L'evoluzione dei gruppi di imprese in Giappone: dagli zaibatsu ai keiretsu
Dopo il 1945 gli zaibatsu venivano sciolti dal Comando alleato come misura di "democratizzazione economica"; nel sistema delle imprese giapponesi, però, il modo di operare per "gruppi" da parte di aziende scarsamente legate da vincoli formali rimase intatto. Nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale si affermavano così due nuove forme di organizzazione, che si differenziavano a seconda della direzione - orizzontale o verticale - in cui si instauravano i legami fra le imprese appartenenti ai gruppi, ma che finirono per
essere accomunate dal nome: keiretsu (letteralmente "lignaggi").
Oltre al possesso azionario diretto della famiglia e della società finanziaria al vertice, lo scambio di partecipazioni tra le imprese sussidiarie permetteva di controllare la quota di maggioranza all'interno del gruppo. Lo
scioglimento degli zaibatsu portava all'eliminazione del sistema di controllo incentrato sulle holding finanziarie e all'estromissione delle famiglie fondatrici attraverso il trasferimento coatto e la vendita sul mercato
delle loro azioni.
Si cercò quindi di non contrastarne troppo aspramente le tradizioni: venne per esempio soppressa la legge
antimonopoli emanata nel 1947 per proibire il possesso di pacchetti azionari da parte delle imprese, e di
conseguenza eliminare il meccanismo a partecipazioni incrociate.
Questa era l'origine dei tre principali keiretsu orizzontali ancora oggi esistenti: Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo.
In essi, alla struttura verticale si sostituiva una struttura orizzontale in cui i legami tra le società del gruppo si
mantenevano non solo tramite la rete di partecipazioni azionarie, ma anche attraverso l'integrazione dei
gruppi dirigenti, i prestiti infragruppo e le strutture di coordinamento, quali le riunioni periodiche del "Club
dei presidenti" delle maggiori società del gruppo.
La presenza di una struttura proprietaria frazionata tra un numero elevato di azionisti, e in assenza di una
forma permanente di controllo centrale, ogni investitore poteva avere un incentivo elevato a deviare dall'accordo di cooperazione reciproca. Se nei kinyuu keiretsu ciò non avveniva, lo si doveva all'esistenza di un rapporto fiduciario che derivava non solo dallo scambio di partecipazioni azionarie, ma anche dall'esistenza di
una fitta rete di relazioni finanziarie, commerciali e personali. Oltre alla rete di partecipazioni azionarie, ogni
gruppo era infatti caratterizzato dall'indebitamento delle imprese nei confronti delle istituzioni finanziarie
affiliate, da transazioni commerciali interne e dallo scambio reciproco di dirigenti fra le diverse società.
L'importanza della banca di riferimento era inoltre esaltata dal ruolo propulsivo giocato da alcune di queste
istituzioni finanziarie nella nascita, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, di keiretsu di
n
uova formazione, che rappresentavano una soluzione di continuità ricetto ai vecchi zaibatsu. I più importanti
fra questi "nuovi" keiretsu orizzontali - i gruppi Fuyo, Sanwa e Dai-Ichi - nascevano infatti tutti su iniziativa di
una banca, che inizialmente spingeva un gruppo d'imprese ad aggregarsi e in seguito assumeva il ruolo di
main bank del gruppo.
Le partecipazioni incrociate e le altre forme d'interdipendenza fra le imprese non solo assicuravano alle imprese stesse la protezione da eventuali acquisizioni ostili, ma garantivano anche l'autonomia del management nei confronti degli azionisti e la stabilità dell'organizzazione gerarchica interna. La legge giapponese,
sulla falsariga delle altre legislazioni societarie, assegnava il potere di nomina dei membri del Consiglio di
amministrazione - il più alto organo direttivo dell'impresa - all'assemblea generale degli azionisti; nelle imprese, però, e in particolare nelle imprese affiliate ai kinyuu keiretsu, i membri del consiglio di amministrazione non erano indicati dagli azionisti, ma venivano scelti fra i ranghi del management e cooptati nell'organo
direttivo dai membri del consiglio stesso.
Nell'impresa giapponese la responsabilità del management nei confronti degli azionisti era di conseguenza
limitata dal fatto che questi ultimi non avevano una reale capacità di influenzare la nomina dei vertici aziendali.
Di conseguenza chi controllava l'impresa non era l'azionista, ma l'insieme dei dipendenti, ossia di tutti coloro
che - al momento in cui entravano in azienda - assumevano l'impegno di dedicare tutta la loro vita lavorativa
alla stessa società. La filosofia dell'"impiego a vita" ha dominato il modello giapponese di organizzazione del
lavoro e gestione delle relazioni indù striali per lo meno fino all'inizio degli anni Novanta, quando l'entrata de
Paese in una spirale di serie difficoltà economiche ha progressivamente minato la sostenibilità di tale modello
da parte delle imprese. In cambio della garanzia di una relativa stabilità dell'impiego - se un'impresa del
gruppo era in difficoltà poteva trasferire i lavoratori in esubero a una società affiliata -, e di benefici, crescenti
nel tempo, in termini di welfare, erogati a livello aziendale ed estesi alle famiglie dei dipendenti, le imprese
appartenenti ai keiretsu hanno potuto disporre di una forza lavoro disciplinata, leale ed estremamente motivata: uno dei segreti del successo dell'industria giapponese nell'arena della competizione mondiale.
Un'ulteriore testimonianza di come l'attitudine del capitalismo giapponese a operare per gruppi non sia sfociata, come ci si potrebbe aspettare, in comportamenti collusivi e in un soffocamento della concorrenza, era
che al contrario abbia finito per rivelarsi in alcuni casi un formidabile strumento per aumentare l'efficienza e
la competitività dell'impresa, è forata dal secondo tipo di organizzazione di gruppi d'imprese sviluppatosi in
Giappone durante gli anni Cinquanta e Sessanta: i cosiddetti kigyoo keiretsu.
Questi ultimi erano raggruppamenti verticali d'imprese formati da una società capogruppo - in genere una
grande impresa manifatturiera e da decine, e a volte anche centinaia, di società collegate, che operano come
fornitori della gran parte dei componenti e dei semilavorati; i legami fra l'impresa capogruppo e le imprese
fornitrici erano quindi sostanziati da relazioni commerciali consolidate e, in diversi casi, dallo scambio di partecipazioni azionarie.
I gruppi verticali: il caso della Toyota Motors
L'esempio più radicale di una strategia buy, tipica dell'industria automobilistica giapponese, contrapposta a
una make, è concordemente identificato nella Toyota Motors, che comprava da altre aziende - sotto forma
di parti meccaniche, componentistica e servizi vari - circa l'80% del valore finale delle proprie automobili.
Il segreto della Toyota era rappresentato dalla vastissima rete di imprese collegate, riunite nell'associazione
dei fornitori che faceva capo alla Toyota stessa: alla fine degli anni Settanta si contavano 168 fornitori di
primo livello, che interagivano direttamente con la società principale, 5437 fornitori di secondo livello, che
producevano componenti per i fornitori di primo livello, e 41 703 fornitori di terzo livello - in gran parte
piccole imprese a conduzione familiare -, che rifornivano i produttori di secondo livello.
La mancanza di accordi a lungo termine non comportava nessun rischio per la Toyota, e rappresentava al
contrario una fonte di notevoli vantaggi: gli aumenti del costo del lavoro e delle materie prime erano a carico
dei fornitori, mentre esisteva un accordo implicito che prevedeva una diminuzione progressiva, nel tempo,
dei prezzi che la società principale doveva pagare per i propri acquisti. Come se ciò non bastasse, il controllo
qualità spettava interamente ai fornitori: la Toyota infatti non ispezionava le parti e i componenti acquistati.
I fornitori non solo combattevano per restare nella "famiglia", ma lottavano allo spasimo per scalare la gerarchia. C'era infatti una fondamentale distinzione tra i fornitori che producevano su ordinazione, in base ai
Progetti e alle specifiche fornite dalla Toyota Motors, e quelli dotati di know-how nel design e nella produzione, che erano in grado di prender? un'idea dalla Toyota per poi progettare e avviare la produzione di
corrispondenti in proprio.
Sarebbe tuttavia un errore pensare a un equilibrio di potere fra la società principale e i fornitori. Dal punto
di vista dell'impresa produttrice di automobili esistevano sempre fonti di approvvigionamento alternative, e
l'assemblatore finale determinava quali e quanti componenti erano necessari, e in quali tempi. Ciò nonostante, i fornitori godevano di vantaggi non trascurabili: un minor costo del lavoro, una maggiore produttività
nelle fasi specializzate del ciclo di fabbricazione di loro pertinenza, gerarchie manageriali più ridotte e meno
soggette a sclerotizzarsi nel formalismo burocratico.
Il ruolo dello Stato
Lo Stato giapponese ha svolto un ruolo molto importante e positivo per il mantenimento e l'incremento della
capacità competitiva di molti settori dell'industria giapponese, essenzialmente quelli orientati all'esportazione. L'opera del MITI, grazie a un'attenta analisi degli errori commessi in passato e quindi all'adozione di
criteri operativi più selettivi, ha registrato successi tali da farne un esempio a livello mondiale. Il caso più
importante d'interazione positiva tra il Ministero e le imprese è probabilmente dato dalla grandiosa crescita
del settore siderurgico.
Nel dopoguerra l'obiettivo primario del MITI era ottenere valuta straniera per finanziare la ricostruzione di
un Paese fino a quel momento del tutto dipendente dall'estero. In questa prospettiva, l'acciaio era considerato un prodotto strategico, perché in grado di fornire un valore aggiunto maggiore rispetto a quelli tradizionalmente destinati alle esportazioni, come i prodotti tessili.
Il MITI modificava sostanzialmente il quadro economico in base al quale i manager dell'industria dell'acciaio
giapponese erano chiamati a compiere le proprie scelte d'investimento. I passi principali che portarono all'attuazione della strategia furono tre. In primo luogo, il protezionismo più rigoroso: le importazioni venivano
vietate, in quanto avrebbero causato un calo dei prezzi interni e una sottoutilizzazione degli impianti In secondo luogo veniva disegnato un sistema di sostegno dei prezzi, che liberava le aziende dai pericolosi effetti
delle fluttuazioni economiche. Infine, e questo probabilmente era lo strumento di politica industriale più
innovativo fra quelli messi a punto dai burocrati governativi, il MITI costruiva un sistema che legava i permessi
di ampliare la capacità produttiva delle imprese ai risultati ottenuti in passato.
Il controllo del MITI sulle decisioni d'investimento delle imprese siderurgiche era fortissimo e tale rimaneva
almeno fino agli anni Sessanta, grazie alla particolare politica delle sovvenzioni statali. Gli investimenti in
nuova capacità produttiva dovevano infatti essere attentamente coordinati e pianificati in base all'andamento della domanda interna e mondiale.
L'obiettivo immediato delle imprese diventava così non più il profitto a breve termine, bensì la produttività
nel lungo periodo.
Il MITI aveva quindi creato un particolare ambiente economico, e le sue "raccomandazioni", per quanto non
vincolanti, finivano quasi sempre per rappresentare la sola alternativa praticabile. Infatti, dato l'ambiente in
cui si trovavano a operare, l'unico comportamento razionale per i manager era quello di un investimento
continuo in successive modernizzazioni, al fine di mantenere la quota di mercato, nonché la posizione occupata dalle proprie imprese all'interno dell'industria siderurgica nazionale.
A differenza delle imprese del mondo occidentale alle prese conio stesso dilemma, le aziende giapponesi
decidevano di smantellare impianti e macchinari appena acquistati e di sostituirli con versioni più moderne.
Nel 1960, per esempio, l'industria siderurgica giapponese aveva in dotazione 150 forni Martin-Siemens, più
di metà dei quali costruiti dopo il 1950. Nel 1980 tutti i forni Martin-Siemens del Giappone erano stati sostituiti con i più moderni e più efficienti forni a ossigeno. Nel caso della Kawasaki, questo aveva comportato la
demolizione di sei enormi forni costruiti solo pochi anni prima, fra il 1952 e il 1961; già nel 1964 l'azienda
iniziava a smantellarli e a sostituirli con nuovi forni a ossigeno.
Nel 1943 il Giappone produceva 8,5 milioni di tonnellate di acciaio, gli Stati Uniti 89. Quarant'anni più tardi i
due Paesi erano alla pari, con 115 milioni di tonnellate annue, ma gli Stati Uniti importavano il 20% del loro
fabbisogno interno, mentre il Giappone, grazie alle dimensioni delle unità produttive consentivano i costi
minori al mondo, esportava più di 22 milioni di tonnellate di acciaio.
Il “miracolo” giapponese
Nei fatti è possibile concludere che, al pari di quello americano, il capitalismo giapponese della seconda metà
del Novecento può essere definito manageriale e competitivo. L'economia del Paese, nelle sue componenti
più dinamiche, è stata contrassegnata da una vivacissima concorrenza, tanto che in diversi settori cruciali era
difficile rilevare il predominio di una o due imprese. Alimento decisivo della competizione era un mercato
interno vasto - che raggiungeva i 120 milioni di abitanti all'inizio degli anni Ottanta - culturalmente omogeneo, caratterizzato dalla mentalità "abbatti e ricostruisci"; un mercato in rapida e continua crescita nel ventennio successivo al 1950, proprio mentre altri mercati nazionali tendevano a stabilizzarsi.
La spinta potente alla crescita traeva origine, oltre che dalle condizioni esterne, da un clima di grande coesione all'interno delle imprese, un clima di collaborazione ricreatosi rapidamente, dopo aspri conflitti nell'immediato dopoguerra, fra imprenditori, manager e lavoratori.
Scrive Hidemasa Morikawa, uno dei maggiori storici d'impresa giapponesi: «A detenere il potere decisionale
al massimo livello nelle grandi imprese industriali del dopoguerra erano dirigenti non proprietari e fondatori.
Entrambi intrapresero quella politica di forti investimenti di cui si diceva, ed entrambi avevano in comune
una vasta esperienza di quella rete ineguagliabile di abilità tecniche creata all'interno dell'impresa industriale
giapponese ben prima della guerra.
Il punto d'arrivo dell'interazione dei fattori sino a ora menzionati e stato il raggiungimento di posizioni di
assoluto rilievo a livello mondiale in settori come il siderurgico, l'automobilistico, l'elettronica di consumo, u
comparto delle macchine per ufficio, la componentistica elettronica, le apparecchiature per l'elaborazione
dati e per le telecomunicazioni.
Nella prolungata fase di più accentuato dinamismo (1954-1971) il prodotto interno lordo è cresciuto a un
tasso annuo del 10,1 %. Il Paese, il cui reddito per abitante nel dopoguerra era la metà di quello italiano, alla
fine del secolo è diventato la maggior potenza economica del pianeta dopo gli Stati Uniti, che però ha superato nel reddito pro capite.
CAPITOLO 17 – L’IBRIDA EUROPA
Il progetto di Harvard
All'inizio degli anni Settanta la Divisione Ricerca della Harvard Business School (HBS) inaugurava un ambizioso
progetto mirato all'analisi in prospettiva comparata delle strategie e delle strutture delle grandi imprese in
quattro Paesi europei che avevano sperimentato due decenni di crescita: Regno Unito, Germania, Francia e
Italia. La ricerca prendeva quindi in considerazione l'economia europea al culmine dei "miracoli economici"
postbellici, quando aveva finalmente raggiunto un livello stabile di sviluppo economico e sociale. Il sistema
industriale era adesso popolato da grandi imprese, sia private sia a controllo statale, attive nei settori ad alta
intensità di capitale della seconda rivoluzione industriale, in grado di competere con successo sui mercati
internazionali.
Diversificazione e multidivisionalizzazione in Europa
L'evidenza empirica resa disponibile dal gruppo di Harvard sembrava in effetti confermare il successo delle
strategie di diversificazione fra le grandi imprese, accompagnato dal mutamento delle strutture organizzative
in direzione del modello multidivisionale. Nel 1950, soltanto un quarto delle aziende appartenenti al campione delle top 100 aveva diversificato le proprie attività, ma già nel 1960 si registrava un profondo cambiamento segnato dalla rapida diffusione della strategia di diversificazione, insieme alla forma organizzativa
multibusiness, che nel 1970 era ormai adottata da oltre il 70% delle principali imprese britanniche.
Il cambiamento delineato era solo in parte dovuto all'"americanizzazione" della cultura europea, e di quella
manageriale in particolare. Le origini di questa tendenza erano da ricercare nel processo di modernizzazione
delle economie europee iniziato nel secondo dopoguerra con l'avvio dell'European Recovery Program, (ERP,
meglio conosciuto come Piano Marshall, dal nome del proponente, il segretario di Stato americano George
C. Marshall).
L'obiettivo politico e ideologico del programma non venne accolto favorevolmente ovunque, anche perché
accompagnato da una forte pressione da parte del governo americano a smantellare tutte le barriere - che
impedivano la libera circolazione delle merci, delle risorse finanziarie e degli investimenti.
I vantaggi per le aziende europee furono innegabili: oltre a giovarsi bell'afflusso di materie prime e macchinari, gli europei presero familiarità con le tecniche organizzative, le conoscenze scientifiche e le tecnologie
operanti nelle imprese statunitensi. Parte integrante del Piano Marshall era infatti la U.S. Technical Assistance
and Productivity Mission, che si proponeva di rendere l'industria europea efficiente come quella americana:
con budget modesto - complessivamente una piccola frazione, pari all' 1,5 %, del totale degli aiuti - la Mission
era responsabile del trasferimento delle tecniche e delle pratiche organizzative, realizzato attraverso i viaggi
in Europa di imprenditori e manager americani, che offrivano informazioni sull'organizzazione della produzione di sistemi di controllo e di gestione, mentre gli europei attraversavano l'Atlantico per imparare l’American way.
Le imprese erano incoraggiate a intraprendere strategie d'integrazione per beneficiare delle economie di
scala e procedere a investimenti in nuovi impianti e in nuova tecnologia produttiva. Il progresso tecnologico
interessava quasi tutti i settori, ma era principalmente evidente nella produzione automobilistica e di altri
beni di consumo durevole e, soprattutto nei settori high-tech nati con la terza rivoluzione industriale (fibre
sintetiche, plastica, elettronica).
La diffusa "decartellizzazione" fu accompagnata dalla crescita e dal rafforzamento delle imprese europee first
mover. Una crescita costante della domanda (sia in termini quantitativi, sia qualitativi) non offriva solo nuovi
spazi di crescita ai produttori già affermati, ma anche nuove opportunità ai competitori, alcuni già in fase di
crescita attraverso processi di diversificazione. Questo si verificava in quasi tutti i comparti industriali, da
quello siderurgico all'automobilistico, dall'alimentare al chimico, al farmaceutico, dalla produzione di gomma
a quella degli elettrodomestici, dalla meccanica alla distribuzione di massa.
L'allargamento e il ritrovato dinamismo del mercato europeo ebbero anche altre conseguenze, prima fra
tutte il sostanzioso afflusso di investimenti diretti americani da parte delle corporation attratte dalla domanda crescente e dalla debolezza, nei primi anni dopo la guerra, delle imprese europee in svariati settori.
Le grandi aziende europee - private e pubbliche - trovarono infine nelle multinazionali americane dei partner
adatti a colmare lo scarto tecnologico attraverso accordi e società fra imprese. Gli investimenti americani e
la crescita interna ponevano in definitiva ai "campioni nazionali" europei una nuova, complessa sfida: adattare le proprie caratteristiche originarie alle esigenze della nuova situazione economica e di mercato.
Deviazioni
In realtà, negli anni del cosiddetto "miracolo europeo", la struttura a holding continuava a diffondersi rapidamente, anche se con ritmi e caratteristiche variabili a seconda dei contesti nazionali.
L'anomalia europea, con la sua evoluzione divergente rispetto al modello americano, si presentava in definitiva come una somma di varianti nazionali, sia nelle strutture proprietarie sia nelle culture manageriali. La
presenza attiva dello Stato e il controllo ancora esercitato dalle dinastie imprenditoriali (cfr. il capitolo II)
portavano un alto grado di concentrazione della proprietà, mantenuta anche tramite il diffuso impiego di
meccanismi di rafforzamento degli assetti proprietari consolidati, come i gruppi piramidali, i patti parasociali,
le partecipazioni incrociate e le differenti categorie azionarie.
Un'ulteriore divergenza fra i due modelli - statunitense ed europeo -emergeva dall'analisi dei diversi modelli
di specializzazione regionali, in quanto l'attenzione tutta europea per le capacità artigianali e l'importanza
delle industrie labour-intensive aveva effetti rilevanti sia sul modello di proprietà sia sulle dinamiche di diversificazione. Famiglie e singoli imprenditori erano ancora alla guida di importanti aziende europee proprio a
causa della loro dimensione media modesta, ben inferiore rispetto a quella delle controparti americane.
La svolta degli anni Ottanta
Nonostante le specificità continentali per quanto riguarda le strutture proprietarie, la dimensione media
delle imprese, gli assetti organizzativi, i ruoli e le competenze manageriali, nella seconda metà degli anni
Settanta la lenta e progressiva adozione della forma multidivisionale subiva un'accelerazione, proprio quando
i ricercatori di Harvard avevano ormai completato il loro rapporto. L'intera vicenda aveva un risvolto ironico,
perché l'affermazione della M-form in Europa stava avvenendo negli stessi anni in cui nella corporation americana iniziava un ripensamento delle strategie competitive in rapporto alle performance delle grandi imprese, e si cominciava a ridurre il grado di diversificazione, soprattutto fra le aziende che avevano intrapreso
il passaggio alla struttura conglomerata.
Nel Regno Unito i processi di diversificazione erano particolarmente evidenti alla metà degli anni Novanta,
quando 61 fra le prime 100 imprese adottavano strategie di diversificazione correlata, mentre 25 diversificavano in settori non correlati; venticinque anni prima le stesse categorie rappresentavano il 57 % e il 6% del
campione. Dal punto di vista organizzativo, queste percentuali rispecchiavano l'adozione della multidivisionale come struttura privilegiata dal 90% delle principali aziende inglesi nel 1993.
Lo Stato “interventista”
L'intervento statale - nella forma più diffusa, si trattava di investimenti nel settore pubblico - era motivato da
diverse istanze, prima fra tutte la necessità di politiche keynesiane anticicliche, destinate a sostenere la domanda e l'occupazione. In molti settori, in particolare quelli ad alta intensità di capitale e tecnologia, l'operatore pubblico era diventato presto il maggior cliente per le imprese private. La presenza di imprese statali ed
enti pubblici costituiva in definitiva la componente peculiare delle "economie miste" dell'Europa occidentale.
In Gran Bretagna il governo laburista lanciava nel 1946 un vasto programma di nazionalizzazioni: all'inizio
indirizzato alle miniere di carbone ai canali e alle ferrovie, veniva in seguito esteso al settore elettrico, mentre
dal 1948 il controllo statale arrivava a coprire acciaierie, aeroporti, linee aeree e autostrade, fino alla Bank of
England e a compagnie come la BP e Rolls Royce, fiori all'occhiello dell'industria nazionale.
La proprietà statale era presente anche in Germania, ma in misura meno estesa: all'inizio degli anni Cinquanta
la maggioranza di prodotti quali gas, alluminio, elettricità, automobili e acciaio proveniva da imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
In Italia e in Spagna erano state create prima della guerra grandi concentrazioni pubbliche: l'Istituto per la
ricostruzione industriale (IRE, nel 1933, cfr. il capitolo 11) e l'Istituto Nacional de Industria (INI, nel 1941) si
erano trovati a gestire vaste partecipazioni in quasi tutti i settori industriali.
Nel settore dell'energia, prima della nazionalizzazione dell'intera industria elettrica nel 1962, lo Stato italiano
aveva promosso nel 1953 la creazione di un gruppo verticalmente integrato - dall'estrazione del gas naturale
alla raffinazione petrolifera l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), guidato da un imprenditore pubblico carismatico, Enrico Mattei. Lo Stato spagnolo esercitava similmente il controllo su quasi tutti i settori capital-intensive, dal siderurgico al cantieristico, dal chimico all'automobilistico, al bancario. Nel panorama europeo industria pubblica era infine presente anche nei Paesi periferici, nella penisola scandinava, in Portogallo e in Grecia.
Lo Stato "imprenditore" aveva dunque esteso le sue attività in Europa sull'arco di trent'anni, a partire dal
decennio 1950; solo nei primi anni Ottanta le pressioni esterne e l'inefficienza interna (che analizzeremo
meglio nei capitoli seguenti) cominceranno ad assestare colpi decisivi ai vasti complessi aziendali pubblici.
Diverso in ogni Paese, il processo di privatizzazione portava di conseguenza effetti differenziati sulle strategie
e, soprattutto, sulle strutture organizzative e sugli assetti proprietari delle imprese già controllate dallo Stato:
durato quindici anni e tuttavia ancora incompleto, questo processo ha risentito dei vincoli che le condizioni
delle singole nazioni avevano posto nei dopoguerra ai rispettivi governi.
Nel Regno Unito le politiche di privatizzazione hanno avuto come esito l'emergere di società ad azionariato
diffuso {public company) sul modello americano. Il controllo degli investitori istituzionali (compagnie di assicurazione, fondi pensione e fondi di investimento) sul capitale totale delle società quotate cresceva infatti da
un terzo del 1963 al 56% del 2000.
In Italia lo scopo principale della politica di privatizzazioni era solo in parte la creazione di public company a
proprietà diffusa: molte aziende venivano infatti cedute attraverso offerte e accordi privati con singoli, famiglie o gruppi stranieri. Negli anni Novanta i lineamenti tradizionali del capitalismo italiano restavano essenzialmente intatti, soprattutto sul versante privato; il gruppo piramidale governato da una holding è ancora
oggi la regola fra le maggiori imprese - quotate e non quotate -, a conferma della tendenza del modello
italiano a favore della proprietà concentrata.
Un’impresa “europea”?
L'impatto della concentrazione proprietaria sulle performance aziendali è ancora meno chiaro: secondo alcune ricerche l'effetto è totalmente positivo, specialmente quando fra i principali azionisti sono presenti le
famiglie o gli individui che fanno parte del top management; questa prospettiva mette in seria discussione
ogni visione convenzionale che giudica inefficiente il modello di controllo familiare. Altri studiosi sottolineano
al contrario come l'assenza di un'adeguata cornice di regolamentazione abbia compromesso l'efficienza
dell'impresa europea, soprattutto per quanto riguarda la creazione e distribuzione di valore ai propri azionisti, in particolare a quelli di minoranza.
Una di queste configurazioni originali è denominata "multidivisionale a rete", in cui la M-form è sostituita da
una federazione di piccole e aggressive aziende "imprenditoriali". Nel caso della svedese Asea Brown Boveri
(ABB), né le considerevoli dimensioni né il grado di diversificazione appaiono importanti, perché il suo suc-
cesso è da attribuire alla peculiare struttura organizzativa progettata e sviluppata dal management, una struttura capace di "mettere insieme" in una vasta struttura a rete numerose aziende in crescita all'interno di
mercati dinamici e in continua evoluzione. Negli Stati Uniti è questo il caso della Silicon Valley. Questa potrebbe effettivamente essere l'onda del futuro, o forse è solo un'altra peculiarità dell’economia europea.
L'esempio più interessante di questo percorso è probabilmente quello italiano: qui, la presenza diffusa di
distretti industriali nel Nord-est e nel le regioni centrali è all'origine della performance inaspettatamente
positiva dell'economia nazionale negli anni Settanta, nonostante le difficoltà vissute dalle grandi imprese. La
struttura dei distretti industriali - piccole aziende flessibili e frammentazione del processo produttivo - era
particolarmente adatta alla fabbricazione e alla distribuzione di articoli differenziati e modellati sulle esigenze
della clientela, come attrezzature meccaniche speciali, prodotti per la persona (calzature e tessili, gioielli e
prodotti in pelle) o per la casa (piastrelle, mobili, ceramica).
Se i distretti industriali italiani, con la loro caratteristica cooperazione informale fra imprese, hanno rappresentato uno dei tratti peculiari del sistema economico europeo, un'analoga connotazione distintiva deve essere attribuita al capitalismo cooperativo che ha segnato la storia economica tedesca nei decenni dopo la
seconda guerra mondiale.
Il capitalismo tedesco, che poteva contare su una forza lavoro altamente specializzata, continuava a essere
orientato alle esportazioni, come era all'inizio del XX secolo, particolarmente nei settori della meccanica pesante e della chimica; l'industria tedesca è rimasta a lungo ancorata alla seconda rivoluzione industriale, e
non ha colto velocemente l'onda tecnologica dell'informatica e delle biotecnologie; già alla fine degli anni
Cinquanta ha impresso però una svolta di mercato sul versante della presenza pubblica nelle maggiori imprese, come dimostra il caso Volkswagen.
CAPITOLO 18 - DIVERSE STRATEGIE PER IL CATCHING UP:
COREA DEL SUD E ARGENTINA
Alla fine degli anni Settanta il termine "Terzo Mondo" - né Occidente né comunismo sovietico - appariva
ormai un contenitore inadatto a tenere insieme realtà geopolitiche ed economiche che stavano seguendo
percorsi differenti.
Il modello socialista sembrava sempre più inadeguato a garantire benessere ed emancipazione sociale; la
fortuna di disporre di preziose risorse naturali - come nel caso delle nazioni dell'OPEC - si dimostrava, da sola,
insufficiente a consentire una stabile prosperità; alcuni Paesi - nell'Africa equatoriale o nel subcontinente
indiano - risultavano sopraffatti dalla sproporzione tra popolazione e risorse, e altri - per esempio nell'America Latina - erano afflitti da una continua turbolenza politico-sociale, capace di rendere effimere fasi di crescita che pure presentavano tutte le sembianze del decollo economico.
Corea del Sud e Argentina, due nazioni che possono essere definite arretrate e periferiche rispetto al nucleo
centrale del capitalismo, hanno avuto performance economiche estremamente differenti nella seconda metà
del secolo scorso.
La Corea del Sud
Tra gli Stati asiatici che si sono distinti per un impetuoso sviluppo nella seconda metà del secolo scorso
emerge la Corea del Sud: Asia's Next Giant è il titolo di un volume a essa dedicato da una studiosa del Massachusetts Institute of Technology, Alice Amsden. Colonia giapponese fino al 1945, terra priva di risorse naturali, la Corea del Sud disponeva di un apparato industriale esiguo, dato che all'indomani della guerra le
maggiori fabbriche erano collocate nella parte settentrionale della penisola, dalla quale, come è noto, era
rigidamente separata a seguito del conflitto scoppiato nel 1950.
Un altro possibile fattore di progresso, costituito dal massiccio ingresso di imprese straniere, avrebbe altresì
urtato il senso di indipendenza e l'orgoglio nazionale. L'ostilità verso le imprese estere era tale, già durante
oli anni Cinquanta, che alle multinazionali era consentito solo di cooperare con aziende locali e in ruoli minoritari.
A differenza di quanto avveniva in Argentina, lo Stato coreano tuttavia raramente interveniva nell'azione
economica diretta facendosi imprenditore - l'unica impresa pubblica industriale degna di nota in questo
Paese era la Pohang Iron and Steel Company (POSCO) - mentre si impegnava in una costante attività di sostegno all'industria privata.
Abbiamo finora parlato del rapporto tra Stato e imprese. Si trattava in realtà di gruppi di imprese, i chaebol,
controllati da famiglie proprietarie coadiuvate da ampie gerarchie manageriali. Come i keiretsu giapponesi i
chaebol diversificavano le proprie attività in settori non correlati ma, diversamente dal caso giapponese, ai
gruppi in Corea non era consentito per legge possedere banche, che erano di proprietà pubblica: in tal modo
lo Stato manteneva saldamente in pugno la politica creditizia. Come in molti Paesi latecomer, la diversificazione non correlata traeva origine dall'impossibilità per le aziende, dati i limiti del mercato interno, di sfruttare appieno le economie di scala.
Due classici esempi di chaebol erano la Hyundai e la Samsung. Il primo, inizialmente attivo nel settore delle
costruzioni, cresceva rapidamente negli anni Cinquanta grazie ad alcuni importanti progetti commissionati
dal regime del generale Park: il primo ponte sul fiume Han, l'aeroporto internazionale Kimp'o e l'autostrada
Seul-Pusan.
Come per la Hyundai, l'abilità distintiva della Samsung diventava la diversificazione non correlata: nel 1965
entrava nella produzione di fertilizzanti e più tardi nell'elettronica, nella costruzione navale, nella chimica,
nella petrolchimica, nelle costruzioni, nell'industria aerospaziale. Alla metà degli anni Novanta la Samsung
era diventata il primo produttore al mondo di semiconduttori. Tanto la Hyundai quanto la Samsung, con il
progredire della loro attività economica, avevano aggiunto alla loro attività di esportazione l'apertura di filiali
all'estero: quelle aperte in Cina e in altri Paesi dell'estremo Oriente erano volte a minimizzare i costi di produzione, mentre negli Stati Uniti e in Europa puntavano a oltrepassare le barriere commerciali.
La rapidità dei progressi compiuti da questo Paese era impressionante: all'inizio del nuovo millennio un Paese
arretrato fino a pochi decenni prima si piazzava al primo posto al mondo nella costruzione di navi al sesto
nella produzione di acciaio, al quinto in quella degli autoveicoli e al secondo come assemblatore di semiconduttori.
Un altro dei punti deboli del sistema era inoltre la rischiosa politica delle banche nel finanziamento del tumultuoso processo di industrializzazione che, sommatosi alla congiuntura internazionale, rendeva la situazione coreana particolarmente difficile nel corso della crisi asiatica del 1997. 1998. L'elenco di piccole e medie
imprese, banche e chaebol falliti in quel periodo era molto lungo e quando la stessa sorte toccava nell'estate
del 1999 alla Daewoo, quarto chaebol del Paese, la Corea era oggetto di forti preoccupazioni da parte della
business community internazionale.
L'Argentina
A differenza della Corea del Sud, si tratta di un Paese ricco di risorse naturali. Nel corso del XX secolo ha
vissuto una sostanziale instabilità politica ed errori di politica economica hanno reso lo sviluppo industriale
argentino molto difficile e, nel lungo periodo, incompleto.
Alla fine del XIX secolo e nel corso dei primi decenni del Novecento, questa nazione era pienamente integrata
nell'economia internazionale e si collocava al sesto posto al mondo per reddito pro-capite. La prosperità di
questa fase non era tuttavia accompagnata dalla capacità di porre basi adeguate per un processo di industrializzazione solido nel lungo periodo.
Nonostante la rete ferroviaria avesse trasformato i segmentati mercati locali in un mercato nazionale integrato, la scarsità di materie prime e una legislazione aperta all'importazione di capitali, macchinari e risorse
umane estere non favoriva infatti lo sviluppo di industrie nazionali di larga scala, come quella dell'acciaio o
dei mezzi di trasporto.
La crisi degli anni Trenta apriva la strada a una serie di politiche economiche orientate alla sostituzione delle
importazioni, che nei decenni successivi avrebbero appoggiato con vari strumenti i più diversi attori e settori.
All'inizio del Novecento, le attività industriali di dimensioni maggiori all'interno del Paese erano svolte quasi
esclusivamente da grandi gruppi d’affari diversificati a proprietà famigliare, simili agli zaibatsu giapponesi e
ai chaebol coreani.
Nel settore dell'inscatolamento del-la carne, per esempio, all'inizio del secolo i grandi gruppi argentini hanno
dovuto fronteggiare la formidabile concorrenza di un'impresa quale la British & Argentina Meat Co., a cui si
aggiungevano in seguito filiali di importanti società statunitensi, come Armour e Swift. Grazie al boom dell'economia locale, l'insediamento delle multinazionali straniere diventava di particolare rilievo soprattutto negli
anni Venti, e non conosceva declino, nonostante la crisi, negli anni Trenta.
Con l'ascesa al potere di Juan Domingo Perón, nel 1946, la politica governativa portava sulla scena economica
argentina altri due importanti protagonisti: l'impresa pubblica e le piccole aziende locali. Lo sviluppo della
prima, avviata non solo secondo obiettivi economici, ma anche per ragioni sociali e militari, era volto alla
costituzione di grandi campioni nazionali in settori strategici e in comparti militari e legati alla difesa nazionale, quali l'acciaio, il petrolchimico, l'automobilistico, il trasporto aereo.
All'interno del Paese erano stabilite alte tariffe protezionistiche, consentendo però l'esenzione da dazi all'importazione di beni capitali, ed erano garantiti tempi brevi e facilitazioni per l'installazione di nuovi impianti.
Così, secondo il censimento del 1963, un quarto del totale della produzione industriale proveniva da imprese
straniere, metà delle quali operavano nel Paese da meno di quindici anni.
Alla fine degli anni Ottanta del Novecento sembrava non esserci più traccia della ricca economia di un secolo
prima. I diversi tipi di impresa che si erano sviluppati all'interno del Paese sembravano aver inequivocabilmente fallito, in un contesto di politiche economiche che, l'una dopo l'altra, si erano rivelate disastrose. I
grandi gruppi diversificati nazionali, protagonisti delle prime fasi di industrializzazione del Paese e tornati in
auge degli anni Settanta, non avevano raggiunto elevati livelli di competitività ed efficienza.
Le imprese pubbliche, che nel 1975 occupavano otto delle prime cinquanta posizioni nel ranking delle maggiori imprese industriali, soffrivano di problemi strutturali e non erano gestite con criteri di economicità, anche a causa dell'influenza di pressioni politiche sul management, per S'unta aggravate dall'instabilità politica
generale del Paese.
L'insuccesso dell'industria argentina nel lungo periodo era imputabile almeno a tre fattori. Il primo risiedeva
nella limitatezza del mercato nazionale, che certamente non ha favorito il costituirsi di un adeguato gruppo
di grandi imprese. Ancora nel 1960, la popolazione argentina raggiungeva appena un terzo di quella tedesca
e un quarto di quella americana d'inizio secolo. In secondo luogo, l'intensa attività di lobbying degli imprenditori privati si è rivelata estremamente negativa per lo sviluppo di imprese efficienti e solide nel lungo periodo, sia perché questa attività portava a politiche spesso dannose per il sistema economico nazionale nel
suo complesso, sia in quanto le energie dedicate a questo versante venivano sottratte all'impegno nella ricerca dell'efficienza.
Ma a differenza del Giappone, e ancor di più della Corea, i criteri utilizzati dal governo argentino per la definizione dei propri obiettivi sono stati orientati più da ragioni di consenso politico che non di razionalità economica. Per il suo atteggiamento "assistenzialista", il governo non ha voluto - o non ha potuto - far applicare
una linea di condotta che favorisse l'efficienza industriale, come invece accadeva in Giappone e in Corea.
L'industrializzazione attraverso la sostituzione delle importazioni, ma con la contemporanea crescita delle
esportazioni, che si era affermata in Giappone e in Corea, in Argentina non si è realizzata. Le imprese industriali sono andate incontro a ripetuti insuccessi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalle forme proprietarie, dalla nazionalità e dal management.
Nel 1959 il governo avviava un ampio programma di incentivi, concedendo licenze per la costruzione di automobili a 22 imprese, comprese 7 multinazionali. Ma il mercato interno argentino non era sufficientemente
ampio per assorbire l'offerta di tutti i costruttori di auto e, a loro volta, questi ultimi non avevano raggiunto
un'efficienza adeguata a competere sui mercati internazionali.
La forte mortalità di aziende sembrava inevitabile: quando l'industria automobilistica argentina toccava il suo
apice, ben 11 fabbricanti producevano un totale di soli 293 742 veicoli, 274 831 dei quali venduti sul mercato
interno. A causa delle ridotte dimensioni di questo, nemmeno produttori internazionali del calibro delle statunitensi Big Three erano in grado di mantenere una sufficiente efficienza operativa.
Le politiche governative avevano un impatto fortemente negativo anche sui settori dominati da piccole e
medie imprese. Nel caso della produzione vinicola, per meglio approfittare dell'appoggio e della protezione
dei governi populisti in un regime di sostituzione delle importazioni, si è configurato in Argentina, in maniera
del tutto anomala per questo tipo di settore, il modello fordista.
Nel contesto delle nuove politiche economiche emergevano più recentemente capacità imprenditoriali rimaste nascoste sotto gli errori nei decenni precedenti. Sebbene la maggior parte dei gruppi argentini non riuscisse a sviluppare competenze tecnologiche elevate e ad avere successo in ambito internazionale, salivano
alla ribalta gruppi di imprese che, non solo si diversificavano con successo in un'ampia varietà di attività manifatturiere e di servizi, ma dimostravano anche di saper eccellere in alcune attività a livello internazionale.
Anche il comparto automobilistico, dopo i disastri in cui era incorso, si trasformava rapidamente negli anni
Novanta, soprattutto grazie alla liberalizzazione commerciale del settore all'interno delle politiche doganali
del MERCOSUR.
Tabella 18.2 - Investimenti in macchinari e attrezzature, in Corea, Gian, pone, Stati Uniti e Germania, 19671987 (% del PIL)
Anno
Corea
Giappone
Stati Uniti
Germania
occidentale
1967
5.3
6.8
4
4.7
1969
5.7
8.5
3.8
5.9
1971
6.5
7.4
3.4
5.6
1973
8.1
6.8
3.5
4.3
1975
7.8
5.5
3.6
3.6
1977
10.8
4.7
3.6
3.7
1979
13.5
4.7
3.9
3.8
1981
10.2
5.5
4.2
3.8
1983
9.6
5.4
3.6
3.5
1985
9.7
6.6
4.4
3.7
1987
11.8
6
3.9
-
PARTE VI – LA GLOBALIZZAZIONE DEI NOSTRI GIORNI
CAPITOLO 19 - MULTINAZIONALI: QUID NOVI?
Dalla metà degli anni Ottanta all'inizio del nuovo millennio il flusso totale degli investimenti esteri fra economie sviluppate, economie in via di sviluppo ed economie in transizione è cresciuto vigorosamente, dall' 1 al
4,5% del prodotto lordo mondiale. La grande maggioranza di questi investimenti ha avuto come origine e
obiettivo i Paesi industrializzati, ma una simile, forte tendenza di crescita ha coinvolto anche i Paesi periferici
guadagnati al processo di globalizzazione iniziato dopo il secondo conflitto mondiale.
I trend di lungo periodo
Le innovazioni nel sistema dei trasporti e delle comunicazioni (cfr. il capitolo 7) avevano già semplificato nel
corso del XIX secolo il trasferimento di merci, persone e informazioni a livello mondiale, ma nei decenni dopo
la seconda guerra mondiale una nuova ondata di globalizzazione, integrazione economica e intensificazione
degli investimenti esteri ha movimentato l'economia mondiale.
Inoltre, il processo di "multinazionalizzazione" coinvolgeva sin dal XIX secolo tutte le economie industriali
"avanzate": europei e americani avevano operato pesanti investimenti all'estero, anche nei Paesi periferici
in rapido sviluppo del "vecchio mondo", come Russia, Scandinavia e quelli affacciati sul Mediterraneo. Investitori e imprese avevano inoltre individuato obiettivi in Africa, Asia e America del Sud, in aree particolarmente allettanti per la dotazione di risorse naturali, in particolare quelle minerarie e petrolifere.
La pratica di costituire società per azioni nei ricchi mercati europei, avviando una raccolta di capitali e varie
risorse finanziarie da investire poi all'estero, aveva dato origine alla diffusa presenza di imprese dalla fisionomia internazionale che non erano però cresciute su una precedente attività economica nei Paesi di origine,
secondo il modello della cosiddetta free-standing company. Il loro capitale sociale alla vigilia della prima
guerra mondiale ammontava quasi al 45% del totale degli investimenti esteri diretti (e questa percentuale
era destinata a crescere vertiginosamente dopo il secondo conflitto mondiale).
Dopo la seconda guerra mondiale la situazione viveva una schiarita sia sul versante politico sia su quello della
congiuntura economica internazionale. Il dollaro americano - a cui tutte le valute mondiali erano ancorate
dopo le decisioni di Bretton Woods - risultava sopravvalutato, mentre le imprese europee vivevano una fase
temporanea di debolezza. Questa situazione consentiva alle compagnie statunitensi di consolidare la loro
presenza estera, anche nei Paesi sviluppati dell'Occidente.
Nel 1970 la metà degli investimenti esteri diretti a livello mondiale faceva capo alle imprese statunitensi,
investimenti concentrati al massimo nell'industria, in cui più evidenti erano i vantaggi competitivi.
Poi, gradualmente, anche l'Europa cominciò a ritagliarsi un nuovo ruolo nel processo di espansione internazionale. Già negli anni Cinquanta e Sessanta molte imprese europee avevano recuperato le posizioni perse
nel dopoguerra, rilanciando la propria capacità competitiva su scala internazionale.
Gli anni Settanta vedevano anche la cospicua, crescita degli investimenti esteri diretti giapponesi, concentrati
in alcuni settori (soprattutto automobilistico ed elettronico), brandi imprese come Toyota e Matsushita riuscivano allora a sfruttare i Staggi sostanziali di una superiorità nella gestione e nell'organizzazione dei processi
produttivi industriali (cfr. il capitolo 12).
Organizzazioni multinazionali
La dinamica dell'insediamento prevedeva l'apertura di consociate, la costruzione di impianti completamente
nuovi (sfruttando i vantaggi del greenfield) o il supporto di partner locali per ridurre i margini di incertezza e
limitare i costi di transazione, mentre il quartier generale nella madrepatria manteneva il controllo sulle operazioni di tutte le sussidiarie straniere.
In Europa, grandi imprese localizzate in Paesi con mercati interni relativamente ristretti sviluppavano intanto
strategie commerciali e di investimenti per trarre vantaggio dall'esteso mercato internazionale. Fra le imprese olandesi, per esempio, erano gruppi emergenti come Philips e Unilever (una fusione anglo-olandese),
mentre in Svizzera l'espansione aveva protagonisti come la Nestlé, già da tempo un'azienda di dimensioni
internazionali: a un anno dalla sua fondazione, nel 1866, a opera di un immigrato tedesco a Ginevra, aveva
cominciato a produrre per clienti esteri, principalmente in Germania e in Francia.
In altri casi, le compagnie avevano cominciato a stabilire consociate all'estero per sfruttare un marcato vantaggio tecnologico, come nell'esempio dell'IBM, che, oltre a una consolidata posizione nel mercato americano delle macchine per ufficio, aveva da tempo un'attività multinazionale.
Al culmine dell'espansione delle multinazionali statunitensi negli anni Sessanta, lo studioso canadese Stephen
Hymer ha introdotto il concetto di «vantaggi di proprietà» per spiegare come mai le imprese americane decidessero di assumersi i rischi e i costi delle attività all'estero. Secondo questa prospettiva, il successo delle
multinazionali dipendeva dal possesso di superiori capacità tecnologiche, organizzative, finanziarie e di marketing, preventivamente sviluppate nel mercato interno.
Il modello interpretativo più efficace e ancora oggi valido era però quello elaborato da John Dunning negli
anni Settanta. Lo schema, ampio ed eclettico, analizzava la decisione di operare all'estero come compendio
di una serie variabile di motivazioni. Innanzitutto l'impresa poteva contare su vantaggi derivati dalle proprie
caratteristiche interne, intese come un assortimento di capacità e competenze, e definite «vantaggi di proprietà» (ownership advantage).
A seconda della forma assunta dalle operazioni estere - dalla semplice attività di esportazione fino all'integrazione verticale attraverso la proprietà diretta degli impianti - si definivano infine i «vantaggi di internalizzazione» (Internalization advantage) che, secondo Dunning, erano riferiti alla necessità di ridurre i costi di
transazione e proteggere gli asset strategici dell'impresa multinazionale.
Gli anni Settanta
Le multinazionali, in maggioranza caratterizzate da un'elevata centralizzazione e impegnate nello sfruttamento dei propri vantaggi comparativi, cominciarono a sperimentare un processo di trasformazione durante
la seconda parte degli anni Settanta.
I primi due ambiti - finanza e commercio - beneficiavano dell'accentuato movimento di deregolamentazione
e liberalizzazione dell'attività economica che accompagnava la seconda globalizzazione, mentre il terzo, che
includeva la consulenza aziendale, aveva visto una rapida espansione negli anni in questione. Insieme, queste
tre aree erano arrivate a rappresentare i due terzi degli investimenti internazionali nel settore dei servizi.
Dopo le banche e le compagnie di assicurazione, anche le imprese di distribuzione al dettaglio avevano destinato ingenti investimenti alle operazioni internazionali, sperimentando una rapida diffusione, in particolare dopo la liberalizzazione dei mercati europei dell'Est. L'internazionalizzazione spingeva presto i distributori a confrontarsi con culture di consumo sempre più complesse e variegate.
Dalla fine degli anni Settanta in avanti, un'area di promettente sviluppo degli investimenti internazionali era
quella relativa alla consulenza aziendale. Il fenomeno aveva avuto origine dalle richieste, da parte delle grandi
imprese statunitensi, di sofisticati servizi contabili e finanziari, nonché di informazioni relative alle nuove
pratiche di organizzazione e valutazione del lavoro (job organization e job evaluation), sia per la casa madre
sia per gli uffici esteri.
Anche se gli Stati Uniti e le multinazionali statunitensi continuavano a svolgere un ruolo importante in queste
dinamiche di cambiamento, gli anni Settanta segnavano nondimeno la fine del dominio americano in molti
settori.
Secondo le statistiche elaborate dalla United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), all'inizio degli anni Settanta le economie "in via di sviluppo", come le cosiddette "tigri asiatiche", partecipavano
agli investimenti diretti esteri per una quota trascurabile, prossima allo zero; solo dieci anni dopo la quota
era cresciuta così velocemente da superare il 12%.
Nuovi arrivati fra le multinazionali
L'emergere delle multinazionali dell'Asia orientale aveva ragioni diverse da quelle che avevano spinto l'internazionalizzazione delle imprese americane nei decenni precedenti. Le aziende giapponesi e asiatiche stabilivano le direttrici della loro espansione estera - in Asia, ma anche nell'iper-competitivo mercato statunitense
- sulla base di vantaggi spesso non correlati al possesso di una superiorità tecnologica.
Più recentemente, le multinazionali dei Paesi emergenti hanno avviato attività all'estero facendo leva su reti
di relazioni etniche, proponendo prodotti specificamente progettati per nuovi mercati, avvantaggiandosi di
un accesso privilegiato a risorse e mercati non ancora sfruttati.
Così è accaduto quando la compagnia cinese Lenovo ha acquisito gli impianti produttivi IBM per i personal
computer, diventando immediatamente uno dei maggiori protagonisti del settore.
E Mentre l'area dell'Asia orientale andava conquistando posizioni rilevanti nell'economia globalizzata, emergevano altre nazioni capaci di un'affermazione internazionale: a partire dall'anno 2000, le multinazionali di
Russia, Brasile, Cina e India hanno cominciato a far leva su vantaggi competitivi simili a quelli che avevano
assicurato il successo alle "tigri asiatiche" negli ultimi due decenni del Novecento: eccellente conoscenza dei
mercati emergenti, accesso privilegiato a risorse e mercati, sostegno governativo e sfruttamento di network
relazionali informali consentivano loro di procedere sulla via dello sviluppo, seguendo percorsi diversi da
quelli sperimentati dalle corporation occidentali, ma capaci di assicurare loro un indubbio successo.
Strategie e strutture in cambiamento
A partire dalla fine del decennio 1980 le multinazionali hanno adottato un'ampia varietà di nuove strutture
organizzative. Due studiosi di management internazionale, Chris Bartlett e Sumantra Ghoshal, hanno condotto diverse ricerche in questo ambito, individuando alla fine i quattro modelli organizzativi prevalenti delle
imprese multinazionali, internazionali, globali e transnazionali.
Il modello più "virtuoso" era quello transnazionale, che descriveva le modalità di azione di una compagnia
operante all'interno di un network di consociate indipendenti, tutte con competenze diverse, in rapporti di
collaborazione quanto a scambio di conoscenze e innovazioni. La compagnia madre esercitava in questo assetto un controllo molto leggero. Questo nuovo stile nei rapporti globali ha modificato il comportamento
delle multinazionali.
La rivoluzione di internet ha permesso alle multinazionali di organizzarsi in maniera efficiente riducendo una
delle voci di bilancio determinanti nell'integrazione internazionale: quella relativa ai costi di transazione, in
particolare quelli di controllo. Le nuove tecnologie, insieme al considerevole contenimento dei costi di trasporto, hanno quindi consentito la segmentazione della catena del valore e del processo produttivo, e la sua
ripartizione in piccole unità specializzate.
Le strutture organizzative a rete sono così diventate molto popolari fra le imprese internazionali, insieme alle
alleanze cross-border fra piccole e medie imprese: anche in questo caso, le nuove tecnologie informatiche
hanno portato aziende di dimensioni modeste a un elevato livello di specializzazione, mettendole in grado di
innovare e competere con successo sui mercati mondiali. Negli anni più recenti sono diversi gli esempi di
società di media dimensione che hanno incrementato l'attività internazionale.
L'accelerazione del processo di globalizzazione dalla fine degli anni Ottanta ha offerto a queste aziende la
chance di espandere le loro operazioni internazionali in aree di attività specializzate, mentre altre imprese
familiari in settori tradizionali come l'alimentare e l'abbigliamento hanno visto crescere la propria presenza
internazionale attraverso la creazione di marchi globali.
CAPITOLO 20 - NUOVE FORME DI IMPRESA
Alla stagione delle conglomerate multibusiness faceva seguito una fase molto intensa di rifocalizzazione, e
riorganizzazione delle imprese. Spesso esortato dalle medesime società di consulenza che avevano in precedenza incoraggiato strategie di espansione e diversificazione, il top management volgeva ora la sua attenzione a programmi tesi a migliorare l'efficienza e la performance aziendale.
Negli anni Novanta inoltre, altre dinamiche - di natura profondamente differente - condizionavano l'evoluzione strategica e organizzativa delle maggiori corporation: ancora una volta, erano sollecitazioni di tipo tecnologico - combinate con la possibilità di disegnare nuove architetture organizzative - ad accelerare il processo di trasformazione iniziato nel decennio precedente. In molti casi, le nuove tecnologie cominciavano
proprio allora a "sgretolare" le mura di cinta della monolitica impresa integrata, che aveva dominato i primi
tre quarti del XX secolo.
Nuove tecnologie e grandi imprese
Un elemento importante in questo panorama è l'impatto, per certi versi ambivalente, delle nuove tecnologie
della terza rivoluzione industriale sulle strutture della grande impresa moderna. In una prima fase, compresa
tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, gli incrementi di efficienza, la rapida diminuzione dei costi di trasporto
avevano sostenuto l'espansione delle aziende, sia in termini geografici, sia in nuovi campi produttivi attraverso la diversificazione.
I flussi degli investimenti diretti esteri mondiali balzavano da 13 miliardi di dollari (a prezzi correnti) nel 1970,
a 54 miliardi nel 1980, fino a superare i 207 miliardi nel 1990. In questa fase le multinazionali allargavano i
propri confini di attività, diventando davvero globali.
All'inizio degli anni Ottanta la terza rivoluzione industriale cominciava quindi a esercitare un grandioso impatto sulle strutture aziendali, promuovendo anche una diffusa riduzione del grado di integrazione verticale
e della dimensione media ottimale delle unità produttive.
Questa tendenza continuava negli anni Novanta, coinvolgendo molti dei settori tipici della seconda rivoluzione industriale: in passato dominati dalla grande impresa integrata a controllo centralizzato, cominciavano
ora a sperimentare il decentramento, con il risultato che molti comparti, per esempio la produzione di elettricità, alcune lavorazioni chimiche, farmaceutiche, meccaniche, elettroniche e di beni durevoli, erano sottoposti a interventi di riduzione di scala, accompagnati da una crescente diversificazione.
Anche la deregulation e le privatizzazioni contribuivano ad accelerare processi di questo tipo. In altri casi,
inoltre, la riduzione della scala ottimale di produzione supportava l'adozione di strategie di specializzazione
prima impraticabili.
La storia dell'IBM vede fin dalle origini la compagnia portatrice di una marcata tendenza all'integrazione verticale, che l'aveva portata a produrre tutte le componenti necessarie al suo core business all'interno del perimetro aziendale; all'inizio degli anni Novanta l'IBM inaugurava una svolta rispetto a questa rigida strategia,
incoraggiando le diverse unità a collocare autonomamente sul mercato i propri prodotti, dai software alla
componentistica. Al culmine di questo processo la Big Blue - il nome con cui era nota l'azienda - vedeva lo
slittamento del proprio focus competitivo dalla produzione di hardware e software alla fornitura di servizi di
consulenza informatica alle imprese.
Deverticalizzazione, outsourcing e hollowing-out
Le nuove tecnologie, in particolare quelle portatrici di un incremento di efficienza nei trasporti e nelle comunicazioni, influenzavano anche altri aspetti dell'attività economica che, cumulati, avevano un impatto considerevole sulle strutture interne delle grandi imprese.
Alla specializzazione delle unità si affiancava infatti una diffusa tendenza alla "disintegra-zione": la graduale
erosione dei confini perimetrali della grande compagnia avveniva inizialmente sotto la pressione delle scelte
di esternalizzazione e/o delocalizzazione (outsourcing), intraprese per alleggerire la struttura dei costi, fissi e
variabili. Il fenomeno era più evidente in settori quali la meccanica, i trasporti, l'elettronica, la farmaceutica
e la chimica, tutti tradizionali roccaforti della grande dimensione a integrazione verticale, in cui l’outsourcing
era in questa fase anche un mezzo per acquisire innovazioni dall'esterno.
Negli anni Novanta diventava poi pratica comune per molte imprese automobilistiche l’esternalizzazione di
alcune fasi del processo produttivo, attraverso l'acquisto di componentistica presso fornitori estranei alla
struttura integrata aziendale.
Sviluppi simili coinvolgevano intanto i settori impegnati direttamente con le nuove tecnologie, come i vari
comparti dell'elettronica di consumo e della microelettronica: qui, analogamente a quanto accadeva in ambiti come la moda e il design, molti produttori puntavano a trattenere funzioni strategiche come la progettazione e il marketing, affidandosi all’outsourcing per le attività di produzione specializzate.
È interessante notare come la de-verticalizzazione non abbia comportato una riduzione del volume dei flussi
produttivi: nel 2009 Cisco - leader statunitense nelle reti di comunicazione e uno degli esempi più riusciti di
ristrutturazione basata su networking e outsourcing - si collocava nella classifica delle maggiori compagnie
americane al cinquantaseiesimo posto, con entrate vicine ai 40 miliardi di dollari.
Network e nuove forme organizzative
L’outsourcing si fondava sulla presenza di fornitori specializzati a cui viene affidata la produzione di specifici
componenti o l'erogazione di determinati servizi: queste imprese avevano sviluppato competenze e abilità
uniche nella fabbricazione di articoli specifici, talvolta adattati alle esigenze particolari del committente; questo li rendeva "generalisti specializzati", differenti dai semplici "terzisti" o subfornitori (subcontractor), perché potevano contare su competenze distinte sviluppate internamente, collaborando attivamente con il
cliente maggiore nelle fasi del design, della progettazione e della realizzazione del prodotto o servizio finale.
Un altro aspetto della trasformazione in atto fra le grandi imprese riguarda la costruzione dì nuove architetture organizzative, pensate per sfruttare a pieno i vantaggi del decentramento. I prodotti modulari, formati
da componenti assemblati tramite interfaccia standardizzata, si affermavano nel corso degli anni Novanta.
Uno dei vantaggi della modularità risiedeva nel fatto che il processo di innovazione si svolgeva all'interno del
singolo modulo, mentre il mantenimento dello standard nell'interfaccia ampliava il ventaglio delle soluzioni
tecnologiche disponibili per il sistema o il prodotto.
La produzione dei personal computer rispecchia al meglio l'evoluzione dal processo di fabbricazione verticalmente integrato all'introduzione del design modulare, che è all'origine di alcune sensazionali vicende di successo imprenditoriale, come nel noto caso della Dell.
L'esempio più efficace di questo percorso è fornito dall'elaborazione di software complessi, costituiti da moduli sviluppati da sub-contractor specializzati, che consente, alla fine, la produzione di pacchetti di software
personalizzati sulla base delle esigenze dei singoli acquirenti.
Il processo di specializzazione e deverticalizzazione descritto ha avuto un impatto considerevole sulle linee
strategiche e strutturali delle società attive nei settori della new economy, ma i modelli modulari e reticolari
hanno profondamente mutato anche le pratiche competitive e la forma aziendale dei competitori più dinamici in molti settori della seconda rivoluzione industriale.
Un processo di tale portata, tuttavia, non avrebbe potuto svolgersi senza costi e potenziali problemi. Questi
sono evidenti nei Paesi che hanno vissuto con maggiore intensità la trasformazione, compromettendone anche la capacità competitiva, come è successo negli Stati Uniti negli anni Novanta.
Le "competenze collettive" in precedenza concentrate in aree come la Silicon Valley o la Route 128 in Massachusetts sono state ora in parte de-localizzate in altri Paesi, con il risultato che la bilancia commerciale
statunitense nei prodotti ad alta tecnologia ha segnato un saldo negativo a partire dal 2002, superando i 50
miliardi di dollari, quasi il 7% del deficit totale.
Nel 2007 gli Stati Uniti importavano da Cina, Messico e Paesi del Sud-est asiatico più di quanto esportassero
in categorie di prodotti come quelli legati alle scienze della vita, quelli dell'optoelettronica, dell'informatica
e delle telecomunicazioni, dei materiali avanzati e della tecnologia nucleare.
La grande impresa nell'era della new economy
All'interno dei network e delle forme di produzione decentrata, un ruolo particolarmente delicato spetta a
coloro che hanno la responsabilità di coordinare l'intero processo, e di gestire lo sviluppo del progetto a
partire dal centro della rete.
Tuttavia la grande corporation non è scomparsa, bensì in molti casi ha solo modificato la sua struttura organizzativa, insieme al suo approccio alle occasioni di mercato e al processo di innovazione. In queste nuove
configurazioni la grande impresa ha assunto il ruolo di coordinamento e distribuzione dei compiti, mantenendo al suo interno il controllo di funzioni cruciali come la ricerca e sviluppo. L'era della General Motors ha
lasciato il campo all'era della Dell e della Intel. È un mondo nuovo, sia per le imprese sia per i consumatori.
CAPITOLO 21 - I "RUGGENTI" ANNI NOVANTA
Il ritorno dell’America
All'inizio del terzo millennio gli Stati Uniti si presentavano ancora una I volta come leader globali. La comparazione fra le maggiori economie mondiali era eloquente: fatto pari a 100 il reddito pro-capite americano,
quello francese si attestava a 75, il giapponese a 74, quello britannico a 72 e a 67 quello della Germania. Fra
le prime 500 corporation mondiali classificate in base al fatturato, più di 160 avevano base negli Stati Uniti,
in Giappone non raggiungevano le 80, e nei Paesi europei complessivamente erano poco più di un centinaio.
La prosperità degli anni Novanta poggiava su una combinazione di fattori in parte di natura intrinseca al sistema industriale, in parte esterni alle dinamiche dell'economia americana. Gli Stati Uniti mostravano una
maggiore prosperità in un confronto con le altre economie industriali perché la vitalità del sistema economico
si mostrava ancora in grado di creare numerosi posti di lavoro, fino a 18 milioni nel decennio 1995-2005, con
un tasso di crescita simile a quello registrato in Europa, a fronte però di un superiore livello di produttività,
in crescita del 2,5% annuo nello stesso periodo.
Le dimensioni del mercato interno, la pressione della concorrenza estera, la presenza di una cornice istituzionale efficiente e di mercati dei capitali flessibili contribuivano in maniera decisiva al successo americano,
senza dimenticare l'azione determinante delle politiche pubbliche di procurement, di garanzia della proprietà
intellettuale e a sostegno della ricerca scientifica. Il vantaggio competitivo acquisito in questi anni consentiva
agli Stati Uniti di sostituire il Giappone nella leadership mondiale per quanto riguardava la produzione di
apparecchi per le telecomunicazioni e di computer.
Il consolidamento della posizione americana era rispecchiato nell'aumento dei flussi commerciali e degli investimenti diretti all'estero.
Solo fortuna?
Per spiegare i successi dell'economia statunitense nel decennio considerato è necessario arricchire il contesto
con alcuni fattori esogeni. In primo luogo, i freni che avevano rallentato l'andamento economico nei decenni
precedenti - Settanta e Ottanta - venivano meno all'aprirsi degli anni Novanta, quando gli Stati Uniti riuscivano a sfruttare appieno le opportunità offerte da un incremento del volume degli scambi mondiali senza
precedenti, la "nuova globalizzazione" (cfr. il capitolo 13).
Queste condizioni favorevoli erano potenziate dalle vigorose scelte dell'amministrazione Clinton, insediata
all'inizio del decennio. Il democratico Bill Clinton aveva enunciato già durante la campagna presidenziale le
linee programmatiche di una nuova politica industriale, che prevedeva il sostegno alla creatività imprenditoriale individuale - e quindi l'incremento della produttività e della ricchezza - attraverso investimenti capaci di
potenziare l'efficienza di infrastrutture chiave per l'attività economica, in particolare i network di comunicazione a banda larga.
La new economy
Il concorso di queste condizioni esogene favorevoli faceva dunque da sfondo a un processo di crescita caratterizzato da un notevole vigore e da una nuova effervescenza imprenditoriale: il decollo della c.d. new economy.
Gli effetti registrati erano notevoli a vari livelli del sistema economico. La produttività del lavoro cresceva da
un indice medio annuo attestato sull'i-1,5% tra il 1973 e il 1994 a una percentuale superiore al 2,5 negli ultimi
cinque anni del secolo. La new economy stimolava inoltre la creazione di nuovi posti di lavoro e nuove imprese, in particolare nel comparto delle ICT. Secondo alcune stime, tra il 1985 e il 1995 le imprese con meno
di 100 addetti erano in grado di occupare 15 milioni di nuovi dipendenti, mentre un eccezionale ritmo nella
formazione di nuove imprese registrava il numero di 1,3 milioni ogni anno.
Fondata alla metà degli anni Settanta da due giovani appassionati di informatica - Steve Jobs e Steve Wozniak
- la Apple era una delle tante, piccole, nuove imprese californiane, alle quali era necessario un capitale per
sviluppare un progetto imprenditoriale creativo. Immediatamente dopo aver definito l'organizzazione della
nuova società, Jobs entrava in contatto con una società di investimento guidata da un ex dipendente della
Intel, un'altra azienda high-tech. Il finanziatore era Mike Markkula il quale, intravedendo le potenzialità della
Apple, decideva di investire nell'impresa circa 90 000 dollari.
Per attirare e trattenere manager competenti e ingegneri, e coinvolgerli nel progetto imprenditoriale, la Apple introduceva allora la pratica di distribuire stock option, vale a dire l'opportunità di acquistare azioni della
società a un prezzo basso, con la prospettiva di realizzare un guadagno sul capitale qualora la quotazione
delle stesse fosse aumentata. Questa operazione contribuiva a legare le prestazioni dei manager alla performance della start-up e a ottenere dagli stessi un impegno elevato per il suo successo.
All'inizio del nuovo millennio, a dispetto della prevedibile - e, secondo alcuni commentatori, inevitabile contrazione del mercato della new economy, i fondi di venture capital mantenevano rendimenti elevatissimi,
nell'ordine del 30-40% annuo.
Nell'agosto del 1995, la Netscape, una società che produceva e commercializzava un browser, cioè un software che consentiva a ogni computer la libera navigazione su Internet, veniva quotata con grande successo
al Nasdaq, il mercato borsistico dei titoli tecnologici.
Nella seconda metà degli anni Novanta si moltiplicavano le iniziative imprenditoriali basate sullo sfruttamento delle potenzialità della rete: nel 1999 l'indice Dow Jones segnava un livello tre volte superiore a quello
raggiunto all'inizio del decennio, mentre l'indice Nasdaq balzava da 1000 a 5000 punti.
La new economy pativa una pesante flessione a partire dal 2001, una crisi che doveva causare numerosi fallimenti e perdite ragguardevoli, di miliardi di dollari. Nonostante ciò, un numero significativo di iniziative
imprenditoriali degli anni Novanta - per esempio eBay, Amazon, America Online, Yahoo! e Google - era in
grado di beneficiare del collasso del mercato e, quindi, di consolidare la propria leadership.
Un altro riflesso dello sviluppo della new economy riguardava l'introduzione di profonde trasformazioni in
settori considerati ormai stabili e consolidati. Un forte impatto avevano per esempio le nuove tecnologie
sulla grande distribuzione organizzata, un ambito in cui la gestione informatizzata delle vendite, degli acquisti
e del magazzino portava al successo globale corporation come la Wall-Mart.
La Dell era stata fondata nel 1984 da uno studente dell'Università del Texas, ad Austin, Michael Dell: questi,
dopo i primi risultati positivi, aveva ottenuto dalla famiglia un sostanzioso contributo di denaro (circa 300
000 dollari) per finanziare l'attività. L'idea alla base della start-up era di realizzare un sistema di vendita personalizzata di computer, assemblati secondo le richieste di ogni cliente. Il successo della strategia portava
alla quotazione della società, i che registrava immediatamente una capitalizzazione di mercato di 30 milioni
di dollari.
La ristrutturazione della grande impresa
L'intensa stagione della new economy non esaurisce tutti gli aspetti della ripresa economica statunitense
degli anni Novanta. Il successo nei setto-i tecnologicamente all'avanguardia era raggiunto in gran parte grazie
a una radicale ristrutturazione delle corporation, il perno della leadership economica globale esercitata
dall'America fra gli anni Sessanta e gli anni ottanta.
Nella nuova congiuntura, la capacità di invertire efficacemente alcune tendenze in atto e intraprendere strategie veramente nuove rappresentava il discrimine per differenziare l'abilità dei leader a capo delle imprese.
La vicenda della GE, sotto la salda guida di Jack Welch dall'inizio degli anni Ottanta, aveva tutt'altro segno. La
strategia perseguita da Welch prevedeva infatti di rifocalizzare l'impresa attorno a poche, profittevoli attività.
Questo comportava massicci licenziamenti (dal 1980 al 1984 la forza lavoro totale della GE era ridotta da più
di 400 000 dipendenti a 330 000), ma permetteva al management di concentrare gli sforzi in quei settori nei
quali la compagnia avrebbe potuto occupare la prima (o, almeno, la seconda) posizione in relazione alle quote
di mercato.
La trasformazione della GÈ era paradigmatica del radicale cambiamento che accomunava le vicende di molte
grandi imprese statunitensi in quegli anni. Obbligate ad affrontare la sfida che imponeva di adattarsi alle
nuove regole del gioco competitivo, o riuscivano a trasformarsi, come la GÈ, o erano destinate a soccombere,
come la Westinghouse; era una sfida a cui nessuno poteva sottrarsi, e anche marchi consolidati, con alle
spalle un'antica e onorata tradizione, erano evidentemente a rischio.
Con la new economy si moltiplicavano le opportunità per gli imprenditori di talento, destinati a emergere e
costruire in breve tempo grandi imperi economici. Uomini come Bill Gates alla Microsoft, Steve Jobs alla
Apple, Jeff Bezos alla Amazon e Andy Grove alla Intel sono stati capaci di sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte dal nuovo scenario.
Gli imprenditori della new economy erano studenti di scienze informatiche ed elettroniche, come Dell, Jobs
e Gates, laureati, come Bezos, o accademici e scienziati, come i cofondatori della Intel: Gordon Moore era un
chimico e Bob Noyce un fisico, mentre Andy Grove, che si univa a loro subito dopo, era un ingegnere chimico.
La competenza nelle tecnologie di frontiera conferiva a questi imprenditori la capacità di individuare nuovi
segmenti di mercato in cui si annidavano enormi potenzialità espansive, qualcosa che mancava nelle disponibilità delle imprese consolidate della old economy.
Le imprese innovative della new economy, dopo il processo di start-up supportato da società di investimento
disposte a rischiare e ad impegnarsi nelle iniziative, sempre più spesso arrivavano a quotarsi in borsa e presto
diventavano attraenti per gli investitori: nella seconda metà degli anni Novanta si registrava un forte incremento del livello di attività speculativa nel settore, il cui esito era una vera "bolla", proprio al volgere del
secolo. Fra il 1998 e il 2000 l'indice Nasdaq, che includeva compagnie come Microsoft e Intel, cresceva quasi
del 150% in soli due anni prima di crollare improvvisamente nel biennio seguente, ritornando allo stesso
livello dei primi mesi del 1998.
Il capitalismo degli investitori
Nel 2000, fondi comuni, fondi pensioni e compagnie di assicurazione avevano in portafoglio oltre la metà di
tutte le partecipazioni emesse sul mercato statunitense e controllavano circa il 70% del capitale complessivo
delle principali imprese del Paese (quelle incluse nelle classifiche di "Fortune").
Prima degli anni Settanta gli investitori istituzionali - che operavano nel sistema statunitense già nel periodo
fra le due guerre - tendevano a preferire le obbligazioni; l'aumento della pressione inflazionistica seguito agli
shock petroliferi e la fine della stabilità monetaria avevano però indirizzato i loro interessi al mercato borsistico.
Alla fine degli anni Ottanta e nel decennio seguente questi investitori avevano svolto un ruolo importante,
destinando risorse finanziarie alla new economy: il capitale di rischio e i fondi di investimento che avevano
sostenuto l'espansione delle start-tip della Silicon Valley avevano infatti canalizzato capitali raccolti dagli investitori istituzionali (soprattutto fondi pensione).
Anche se raramente un singolo fondo arrivava a possedere consistenti pacchetti azionari delle imprese in cui
investiva (dopo il 1974 l'Emploiyee Retirement Incoine Security Act, o FRISA, regolava l'attività dei fondi pensione limitando le dimensioni del singolo investimento e imponendo la diversificazione del rischio), l'aggregato degli investitori istituzionali aveva un'influenza considerevole.
La ricerca dell'efficienza finalizzata alla creazione di valore era condotta anche attraverso il miglioramento di
alcune operazioni, reso ora possibile dall'introduzione dei sistemi di automazione. Nuove procedure - come
il Total Quality Management e le pratiche di outsourcing - erano basate sulle nuove tecnologie di comunicazione che, a loro volta, influenzavano le possibilità di condividere le informazioni e diffondere le conoscenze
all'interno delle organizzazioni. Questa dinamica induceva un mutamento radicale nelle relazioni fra management e azionisti.
L'enfasi sulla "creazione di valore" era spesso accompagnata da nuovi sistemi per fissare appropriati incentivi
per i manager, come i piani di retribuzione attraverso stock option. Le aziende arrivavano così a dirigere crescenti quote della ricchezza prodotta verso gli azionisti, sia nella forma di dividendi sia attraverso il riacquisto
di azioni, con il doppio vantaggio di mantenere alto il prezzo delle azioni e offrire ai manager i benefici derivati
dal possesso delle loro quote.
Nel 2001, a fronte di ricavi computati in circa 100 miliardi di dollari, Enron, una delle più famose compagnie
statunitensi nel settore dell'energia e delle comunicazioni, andava incontro al fallimento, dopo la dimostrazione che gli enormi profitti erano in larga parte il risultato di una complessa frode contabile. L'esito della
vicenda era una perdita secca per gli azionisti, per i creditori e, ovviamente, per i dipendenti; lo scandalo
coinvolgeva anche Arthur Andersen, una delle società di consulenza e contabilità più potenti a livello internazionale, a causa della negligenza nella revisione dei bilanci della Enron e, probabilmente, della complicità
nelle pratiche di malversazione del management.
CAPITOLO 22 – LO SVILUPPO FRENATO: EUROPA E GIAPPONE
La notevole performance dell'economia statunitense negli anni Novanta appare ancora più rimarchevole se
confrontata con gli andamenti che nello stesso periodo si osservavano in Europa e in Giappone.
L’Europa in vendita
I profondi rivolgimenti dello scenario politico internazionale tra la fine del decennio 1980 e l'inizio del decennio 1990 erano destinati a provocare alterazioni decisive sulla performance economica delle maggiori economie del continente: della Germania, innanzitutto, impegnata nella gestione di un processo di riunificazione
estremamente costoso, e poi dell'Italia, la cui tenuta strutturale, a livello politico, economico e sociale, era
profondamente scossa da una serie di scandali che andavano rivelando - attraverso le indagini della magistratura - una densa rete di corruzione ; e concussione tra partiti e ambienti imprenditoriali; la crisi arrivava
a travolgere il sistema politico che aveva retto le sorti del Paese dalla fine del secondo conflitto mondiale.
Gli Stati europei usciti dalla seconda guerra mondiale avevano infatti sviluppato dei sistemi economici fortemente redistributivi, imperniati su articolati sistemi di welfare, sul mantenimento di alti livelli occupazionali
e su una pervasiva presenza pubblica nei settori "sensibili" dell'energia, dei trasporti e delle utility.
Il primo pilastro del capitalismo europeo a crollare sotto la pressione del rallentamento ciclico era l'impresa
pubblica, una realtà comune a quasi tutte le economie del continente (cfr. il capitolo 17). A partire dalla fine
degli anni Settanta e con una crescita regolare nella prima metà degli anni Ottanta, i diversi Paesi davano
inizio a energiche politiche di privatizzazione: dapprima in Gran Bretagna e in Francia e, dopo pochi anni, in
Italia e in Spagna, l'estensione della proprietà statale veniva fortemente limitata nel settore bancario e in
quello assicurativo, nell'industria e nei servizi, fino ai cosiddetti monopoli "naturali" (le infrastrutture di trasporto e le reti per la distribuzione dell'energia e dell'acqua).
Dai primi anni Ottanta all'inizio del nuovo millennio si erano concluse nell'Europa occidentale più di mille
operazioni di privatizzazione. Il capitale totale coinvolto superava i 600 miliardi di dollari, una cifra che si
avvicinava al 50% del totale mondiale, e il Regno Unito da solo incideva per quasi un quarto dell'intero ammontare europeo. Si trattava, con ogni evidenza, di una straordinaria trasformazione degli assetti economici,
con implicazioni profonde per le strutture sociali e politiche.
Spesso, nonostante la limitazione della proprietà diretta, gli Stati mantenevano il controllo sulle attività privatizzate: per esempio, attraverso il sistema della golden share, o con altri artifici e relazioni informali, i governi si assicuravano una posizione privilegiata nel processo decisionale delle aziende poste sul mercato; gli
imprenditori privati arrivavano inoltre ad acquisire le società attraverso un sistema di aste e, talvolta, con
trattative private.
La ritirata dello Stato dalla proprietà diretta delle grandi imprese imponeva ovunque contestuali politiche di
liberalizzazione che, di regola, comportavano la creazione di autorità di vigilanza incaricate di monitorare il
funzionamento dei mercati e l'efficienza dei servizi forniti ai consumatori.
Contemporaneamente, la rigidità dei mercati del lavoro e di quelli finanziari rallentava la creazione di nuove
iniziative imprenditoriali. Queste dinamiche europee si approfondivano proprio quando l'economia americana cominciava a decollare.
II punto di snodo di queste tendenze divergenti riguardava la persistente, sostanziale differenza fra le strutture economiche europee e americane.
Questi tratti erano caratteristici di diverse economie del vecchio continente, ma erano particolarmente evidenti, per esempio, nel caso italiano: qui, il settore manifatturiero era in maggioranza composto da industrie
mid-tech ad alta intensità di capitale, con una popolazione di imprese low-tech di piccole dimensioni che
articolavano il sistema economico nei comparti del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, dell'arredamento e di altri prodotti del made in Italy.
Anche il freno alla crescita della produttività in Europa contribuiva a indebolire la sua reattività economica,
in particolare se confrontata con quella statunitense. Secondo alcune stime, fra il 1995 e il 2000, la produttività oraria in America cresceva più del 2,5% all'anno, mentre il tasso medio europeo era incomparabilmente
inferiore. La perdita di competitività sofferta dalle economie europee, in particolare nei confronti delle economie emergenti, si rispecchiava con evidenza nei trend della bilancia dei pagamenti, che nel corso degli anni
Novanta registravano ovunque - con la sola eccezione della Germania - saldi negativi.
Alla fine del decennio, comunque, anche l'Italia cominciava a soffrire l'aspra concorrenza del nuovo competitore cinese sui mercati globali, e proprio nei suoi settori di maggior successo la bilancia commerciale italiana
segnava crescenti saldi negativi.
Il Giappone e il “decennio perduto”
Il 1989 è stato un anno cruciale anche per l'economia giapponese, perché ha segnato l'esaurimento di una
lunga fase di costante crescita iniziata negli anni Sessanta. Al successo del modello economico giapponese
avevano contribuito quattro tratti fondamentali:
una politica industriale che incoraggiava le imprese nazionali a competere sui mercati esteri;
la presenza dei keiretsu, con i loro densi network di partecipazioni incrociate e legami informali;
un sistema di relazioni industriali partecipativo, rinforzato dalla pratica dell'impiego sicuro per tutta
la vita
un efficiente sistema bancario che, attraverso il credito "interno" (inside lending) da parte di ogni
banca collegata al suo keiretsu, garantiva le risorse finanziarie necessarie alle politiche di investimento a lungo termine delle imprese.
L'origine della recessione andava rintracciata nello scoppio di una bolla speculativa sui titoli immobiliari, che
si era gonfiata ininterrottamente tra la fine del 1985 e gli ultimi mesi del 1989. In meno di quattro anni gli
indici di borsa erano più che triplicati, mentre il valore dei terreni per uso commerciale e residenziale era
aumentato di quasi quattro volte.
I problemi derivati da questa tendenza erano poi ingigantiti dalla politica di deregolamentazione del settore
finanziario, intesa dalle autorità economiche come "modernizzazione", per favorire la concorrenza all'interno
di un sistema bancario tradizionalmente rigido.
Gli istituti di credito cominciavano quindi a realizzare aggressive politiche di investimento, che sostanzialmente andavano nella direzione del finanziamento delle società immobiliari e quindi della speculazione. La
bolla era destinata a scoppiare nel momento in cui la Banca del Giappone, temendo una crescita dell'inflazione, decideva di aumentare nuovamente il tasso di sconto e, contemporaneamente, il Ministero delle Finanze fissava delle limitazioni al coinvolgimento degli istituti bancari nel finanziamento delle operazioni immobiliari.
II dispiegamento della crisi portava quindi gravi conseguenze per l'intera architettura del modello capitalistico giapponese, a cui era dovuto il successo economico del Paese nei decenni precedenti, e veniva ora
scosso nelle sue fondamenta sociali, politiche e culturali.
Le difficoltà del sistema bancario
Le banche dei keiretsu erano le prime a subire le conseguenze della crisi: una percentuale molto elevata - fra
il 5 e il 10% - di tutti i crediti concessi nella seconda metà degli anni Ottanta si rivelava inesigibile. I danni
andavano quindi a riflettersi immediatamente sull'industria, che perdeva il supporto vitale dei finanziamenti
delle banche.
Venendo meno il sostegno delle banche e la loro fiducia, i manager delle imprese erano portati a guardare
con crescente attenzione alla riduzione dei costi e alla redditività, alle quote di mercato e ai ricavi, mentre
erano alla ricerca di fonti di finanziamento alternative a quelle tradizionali, per esempio mediante il ricorso
al capitale straniero.
Come era prevedibile, gli investitori stranieri esercitavano subito sui manager una pressione indirizzata a
modificare i rapporti informali e la scarsa trasparenza nella gestione delle relazioni fra imprese, mettendo
così in discussione uno dei fondamenti del capitalismo giapponese, vale a dire le pratiche cooperative e collusive. La necessità di garantire un flusso costante di risorse finanziarie dall'estero aveva un impatto notevole
anche sulle istituzioni statali, primo fra tutti il Ministry of Economy, Trade and Industry (METI, in precedenza
noto come Ministry of Trade and Industry, MITI), che cominciava allora a incoraggiare l'adozione di una governance aziendale più aperta.
Smantellare i keiretsu?
In seguito alla crisi del settore finanziario, i grandi keiretsu erano costretti a correggere le tradizionali modalità di approccio ai mercati dei capitali e alla governance aziendale. Un'indubbia eredità della fase di stagnazione era quindi l'indebolimento progressivo della densa rete di partecipazioni incrociate che legavano reciprocamente le banche e le imprese, e le stesse imprese tra loro. Gli intrecci di partecipazioni si riducevano
così, nel corso del decennio, dal 20 all'11% circa del capitale azionario totale dei maggiori gruppi giapponesi.
Nonostante la portata dei cambiamenti in atto, la forza della tradizione risaltava in una considerevole path
dependency: al di là delle riforme, infatti, un efficiente controllo sull'operato della direzione aziendale era
virtualmente assente in Giappone (Witt 2006, p. 46), e difficilmente il management inefficiente sarebbe andato incontro al licenziamento, anche nel caso di una riuscita scalata ostile.
Lo sgretolamento delle relazioni industriali
Nel settore dell'elettronica di consumo, per esempio, leader globali come Matsushita, Toshiba e Hitachi cominciavano a ridurre la dimensione degli impianti operativi all'interno del Paese, nel tentativo di riguadagnare competitività, mentre puntavano a espandere gli investimenti esteri per diversificare i rischi e comprimere i costi.
Come nel caso del sistema di finanziamento alle imprese, tuttavia, il ritmo, la direzione e l'intensità della
trasformazione avviata devono ancora essere valutati compiutamente. Anche in questo, come in altri casi, la
crisi potrebbe rivelarsi insufficiente a erodere completamente il modello giapponese di relazioni industriali,
profondamente radicato sui legami sociali e personali all'interno delle imprese.
Durante gli anni della crisi, per esempio, la bilancia commerciale manteneva un segno positivo soprattutto
grazie ai settori mid-tech, e nei primi anni del nuovo secolo la quota di valore aggiunto dei comparti hightech giapponesi si attestava approssimativamente sul 15% del totale, meno della metà della corrispondente
quota statunitense. La peculiarità di questo vantaggio competitivo - in sostanza, non molto dissimile dalla
situazione europea - continua a essere un tratto originale della struttura economica del Giappone.
CAPITOLO 23 - NUOVI PROTAGONISTI: CINA E INDIA
Il grandioso passaggio della storia economica mondiale non fa che rimettere le cose a posto, perché almeno
nei tre millenni precedenti il XVIII secolo Cina e India vantavano un'indiscussa superiorità sull'Europa e sulle
sue appendici. Cinesi e indiani sono oggi tre miliardi e mezzo - un aggregato umano nettamente più giovane
rispetto alla popolazione dell'Occidente - al cui interno si contano ancora masse enormi di poveri e disperati,
ma in cui sono ampiamente diffuse cultura, conoscenza scientifica e capacità tecnologica.
È proprio la dimensione delle popolazioni "nascoste" nelle campagne - 800 milioni di persone in Cina, 700
milioni in India - che fa comprendere quali saranno le proporzioni del balzo in avanti dei due colossi nel corso
del XXI secolo, dato che per ogni contadino che entra in fabbrica la produttività aumenta di sette volte. Del
resto, già oggi Cina e India sono l'obiettivo privilegiato degli investimenti delle multinazionali.
Il successo dell'India è più recente, parte dalle riforme economiche dei primi anni Novanta. Nel 1998 l'India,
con 320 000 miliardi di dollari di prodotto interno lordo, era la quindicesima economia del mondo; oggi, con
806 000 è la decima. La Cina, invece, oggi è la quarta, con 2 234 000 miliardi di dollari. Nel 2005 e nel 2006
ha superato l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna. La rincorsa della Cina è cominciata all'inizio degli anni Ottanta, quando si è disfatta la camicia di Nesso del maoismo. Fra il 1980 e il 2005 l'economia del Paese è
cresciuta con un tasso medio annuo del 9,6%.
La Cina
Non è facile, guardando alla storia cinese degli ultimi trent’anni, delineare un modello, inteso come un insieme coerente di azioni di politica economica che pervengano a risultati ben definiti. Una costruzione concettuale di questo tipo è stata possibile, lo si è constatato, per cogliere i tratti salienti del "miracolo" giapponese e dell'inaspettata ascesa delle "tigri" asiatiche:
1. un rapporto di do ut des fra le grandi imprese e lo Stato: le prime erano protette con alte tariffe
doganali, agevolate con finanziamenti ad hoc o con un facile accesso al credito, addirittura sottratte
alle fluttuazioni della domanda mediante un sistema di prezzi amministrati, ma costrette dal potere
politico a competere sul mercato globale con obiettivi precisi di esportazione;
2. la scelta dei rami produttivi in cui ottenere un vantaggio competitivo, avendo riguardo a rimanere
nell'ambito di tecnologie "medie", non troppo difficili da applicare, per le quali fosse possibile il massimo sfruttamento delle economie di scala (i settori maturi della seconda rivoluzione industriale);
questa scelta era accompagnata da un'estrema attenzione alla fase produttiva - alta qualificazione
tecnica e coesione sociale dei lavoratori -, nella convinzione che non fosse possibile utilizzare proficuamente un impianto semplicemente acquistandolo "chiavi in mano";
3. il sostegno ai grandi gruppi, ritenuti il miglior interlocutore per una politica di rapido sviluppo; era
richiesta loro una speciale abilità, quella di padroneggiare la gestione di grandi dimensioni d'impresa
in processi di diversificazione non correlata.
Se il Giappone e la Corea del Sud hanno tenuto lontano le multinazionali temendo per la propria indipendenza, la Cina nei loro confronti ha applicato la politica della "porta aperta". Se i firstcomer dell'industrializzazione asiatica hanno agito attraverso una politica economica fatta di interventi sistematici, di guide-line, e
di moralsuasion (è il cosiddetto developmcntal state) la Cina ha soprattutto mirato a scatenare gli animai
spirit repressi negli anni della rivoluzione culturale.
E su questo terreno che sono emersi veri e propri imprenditori "schumpeteriani" come Ma Yun, figlio di genitori poveri e mediocre studente, ma con una buona conoscenza della lingua inglese: questo lo portava a
contatto con la rivoluzione delle ICT che si stava affermando negli Stati Uniti e quindi a ideare il sito Alibaba.com, capace dì diventare un serissimo competitore di colossi quali eBay, Yahoo e Amazon, un sito dove
ogni giorno si incontrano due milioni di imprese cinesi con sette milioni di importatori provenienti da duecento Paesi.
Alcuni, come Ma Yun, sebbene ricchissimi, nella più pura tradizione asiatica cercano di farsi notare il meno
possibile, di star nascosti. Altri invece sono legati al mondo della politica, spesso da vincoli di parentela (il
30% degli imprenditori cinesi ha la tessera del PCC). Altri, all'opposto, sfidano le angherie del potere, come è
capitato a Sun Dawu, un agricoltore che ha fondato una grande impresa alimentare e denunciato i leader di
partito che gli hanno chiesto tangenti.
Ma Yun, che con 100 000 dollari di profitto netto al giorno è probabilmente il comunista più ricco del mondo,
veniva dalla provincia di Hangzhou, un'area a nord di Shanghai, che nel 2004 ha registrato un incremento
della produzione industriale del 30%, grazie anche a compensi di 100 euro al mese per i lavoratori, e 300 per
i manager.
Il ridottissimo costo del lavoro è da considerare una componente essenziale del "miracolo cinese"; uno strumento non secondario è però stata la politica d'apertura nei confronti degli investimenti stranieri che si concretizzava sin dal luglio del 1979, con l'approvazione di una legge che rendeva possibili società a capitale
misto con partner esteri.
Nel decennio seguente esenzioni fiscali o assenza di diritti doganali venivano progressivamente revocati; restava però la piena libertà imprenditoriale e gestionale e l'impegno a non nazionalizzare le imprese a capitale
estero o a capitale misto, per le quali si annullava anche la clausola dell'obbligo della presidenza cinese. La
politica di apertura internazionale aveva conseguenze inequivocabili: fra il 1979 e il 1999 il surplus commerciale cinese toccava i 40 miliardi di dollari.
Del resto, l'economia cinese ha potentemente favorito i I consumatori degli Stati Uniti e degli altri Paesi occidentali realizzando la commodization di prodotti che prima erano solo di marca, dagli elettrodomestici agli
orologi, dai giocattoli agli articoli di pelletteria. Di fatto si è creato un legame simbiotico fra i produttori cinesi
e la più grande impresa di distribuzione americana, la Wal-Mart, che ha il suo punto di forza nella determinazione a offrire al consumatore il prezzo più basso possibile. Naturalmente il "prezzo cinese", ovvero la
possibilità di produrre ormai quasi tutto il ventaglio dei beni - sia di consumo sia industriali - al 50-70% di
costi in meno rispetto alle possibilità dei Paesi occidentali, è un dato inconfutabile che non può non suscitare
diffusi timori.
Ma la "paura" economica, se vista in una prospettiva di medio-lungo periodo, non sembra del tutto sostenibile. Del "fattore Cina" dovrebbero beneficiare sia la domanda sia l'offerta dei Paesi occidentali. I consumatori, che già oggi possono acquistare comodamente una gamma di beni impensabile fino a qualche anno fa;
le imprese, che si avvantaggiano dei drastici ribassi del costo dei fattori della produzione e intravedono la
straordinaria opportunità del mercato cinese.
L'India
Sotto il profilo politico l'altro gigante asiatico sembra possedere un sicuro vantaggio. L'India è infatti lo Stato
democratico più popolato del mondo, ed è stato capace di far convivere gruppi etnici e religiosi le cui differenze e rivalità sono potenzialmente esplosive.
Questo non impedisce comunque che gli strati inferiori della società possano godere del diritto di voto e della
rappresentanza politica, strumenti di notevole efficacia nella battaglia per la mobilità sociale e l'eguaglianza
effettiva.
Come la fitta rete ferroviaria (ormai decisamente invecchiata), il sistema politico che tutela i diritti e le libertà
individuali, che assegna il governo alla maggioranza ma garantisce la presenza della minoranza nel parlamento e nella competizione elettorale, è un'eredità del colonialismo britannico: di questo periodo della sua
storia l'India non dimentica le durezze, ma non ne disconosce i meriti, come non manifesta quegli atteggiamenti vittimistici, alla perenne ricerca di risarcimento, che in altri Paesi servono per lo più a mascherare le
responsabilità delle classi dirigenti post-coloniali.
Diversamente dalla Cina, che si è avvantaggiata della corsa dei Paesi occidentali - e in particolare degli Stati
Uniti per affermarsi come "la fabbrica" del mondo, l'India, partendo dai centri di assistenza telefonica attivi
24 ore (i call center), ha finito per occupare il campo del terziario avanzato, dalle analisi finanziarie alle ricerche di statistica attuariale, dalle consulenze legali e fiscali alle analisi mediche e al supporto scientifico delle
case farmaceutiche.
Ma “l’industria dell'immateriale", ovvero la produzione di software, nella quale l'India occupa ormai una posizione di assoluto rilievo, è anche il frutto di scelte concrete. Come quella della famiglia Tata, la maggiore e
la più longeva dinastia imprenditoriale del Paese, che addirittura prima dell'indipendenza creava a Bangalore
l'Indiati Institute of Science (US).
Ormai tutti i grandi dell'informatica, a iniziare da Bill Gates, riconoscono che le proprie strategie future non
possono prescindere da quanto accade a Bangalore, gemella di Silicon Valley. Il caso di Pitroda non era certo
isolato.
Il governo indiano si è impegnato con vigore per il rientro di una diaspora verso l'Occidente di tecnici e di
scienziati, rientro che effettivamente si è verificato, dimostrando anche la lungimiranza di una classe dirigente nel non temere la concorrenza.
Il più grande soggetto economico privato, per esempio, il gruppo Tata, è stato fondato un secolo e mezzo fa
dal figlio di un ricco commerciante di Bombay, Jamsetji Nusserwanji Tata; questi, pioniere in ogni campo, si
lanciava nella creazione di un gruppo estremamente diversificato che comprendeva impianti siderurgici, centrali elettriche, stabilimenti tessili, cementifici, una compagnia di navigazione. I suoi successori ampliavano
poi il raggio d'azione al settore bancario, alla petrolchimica, al trasporto aereo, alla produzione di automobili.
L'elemento di maggior interesse a proposito degli imprenditori indiani è il forte tratto etico che caratterizza
la loro azione. Sin dagli esordi, le aziende dei Tata praticavano un illuminato paternalismo. Venivano costruiti
alloggi per i dipendenti, concesse le otto ore giornaliere di lavoro, l'assistenza per la maternità, la partecipazione agli utili. In onore del fondatore, si progettava una città modello, Jamshedpur, oggi considerata dalle
Nazioni Unite fra i capolavori di pianificazione urbana.
Anche il ricchissimo Mukesh Ambani, imprenditore petrolchimico, vuole dare un'anima al capitalismo, perseguendo ostinatamente la ricerca di energie alternative. Ambani finanzia istituti di ricerca che studiano la
possibilità di ottenere carburante dai prodotti agricoli raccolti massicciamente nei villaggi.
E persino Vijay Mallya, il pittoresco proprietario di Kingfisher, un tycoon dai modi - definiti dai media- "troppo
esuberanti", si fa eleggere in parlamento, dove si batte in favore dei contadini poveri a cui procura l'acqua
potabile e la corrente elettrica, mentre ottiene il miglioramento delle condizioni di lavoro degli "intoccabili"
occupati nelle discariche.
L'India deve affrontare ancora enormi problemi: la povertà, la disuguaglianza sociale, l'inquinamento ambientale (la tragedia di Bhopal non è poi così lontana). È bene essere scettici sulle previsioni diffuse secondo
le quali sarà appaiata agli Stati Uniti e alla Cina come prima economia del mondo alla metà del XXI secolo.
Tuttavia, il cammino percorso negli ultimi tre lustri non può non essere oggetto dell'approfondito studio
dell'economista e dello storico.
CAPITOLO 24 - UNO SGUARDO CONCLUSIVO
Il lungo cammino che abbiamo percorso sinora è stato possibile grazie all'intreccio di tre elementi. Intreccio
è la parola giusta perché nella realtà essi non sono separati e si influenzano reciprocamente. Tuttavia, per
ragioni analitiche e di chiarezza espositiva, dobbiamo scioglierli e considerarli separatamente.
Il primo è il sistema tecnologico visto nella sua evoluzione. La tecnologia è un prodotto umano determinato
da abilità tecniche, da conoscenze scientifiche, da attitudini sociali. In un dato momento, tutto ciò precipita
in un "paradigma" ovvero in una serie di elementi coordinati sistematicamente che ne fanno qualcosa di altro
da noi.
A questi paradigmi diamo il nome di "rivoluzioni industriali" ed è intrinseco a esse il carattere della globalità,
Nei suoi tratti fondamentali la tecnologia è la stessa in tutto il mondo: l'acciaio non si fa in giardino, come
hanno imparato a proprie spese i cinesi governati da Mao Tse Tung.
Il secondo elemento è, possiamo dirlo, il nostro "primo attore", ovvero l'impresa, un insieme di uomini e di
strumenti di produzione ordinato gerarchicamente. Essa esiste da sempre, diventa un po' più visibile nell'età
della prima rivoluzione industriale perché si appoggia a un nuovo e "grande" luogo di produzione, la fabbrica.
Non tutti i settori vengono toccati dalla seconda rivoluzione industriale e in ogni caso emerge con chiarezza
il fatto che un'economia, per essere sana e vitale, necessita della presenza di una "comunità di imprese",
ovvero di imprese di diverse dimensioni che perseguano obiettivi diversi. Tuttavia, dal momento che la nostra
ha la pretesa di essere la narrazione di una vicenda globale, dobbiamo affermare con chiarezza che la grande
impresa è il motore insostituibile dello sviluppo, lo strumento grazie al quale le nazioni competono per l'egemonia mondiale.
Il terzo elemento è il contesto locale. Non vogliamo intendere l'aggettivo "locale" in senso diminutivo. La
nozione di contesto locale si identifica per noi prevalentemente con la dimensione nazionale. Tuttavia potrebbe anche superarla, tant'è vero che in diversi capitoli parliamo di Europa. Il contesto locale pone in rilievo
a sua volta tre variabili:
1. i mercati, considerati nella loro dimensione, ovvero popolazione + reddito prò capite, ma soprattutto
nella loro dinamicità;
2. il rapporto fra potere politico e mondo dell'impresa, visto sia come regolamentazione della competizione (antitrust), sia come un complesso di azioni da parte della politica che arrivino sino all'intervento diretto e alla formazione dello stato imprenditore;
3. la cultura, intesa come complesso di valori, come attitudini ad accettare 1'"istituzione mercato", la
capacità di adattarsi alle regole universalistiche richieste dalla crescita di impresa.
La storia si fa più interessante con la prima rivoluzione industriale, che si profila in Inghilterra alla fine del
Settecento. Il fatto che, come già ricordato, questa imponga un luogo di produzione centralizzato, la fabbrica,
fa sì che l'impresa acquisti consistenza, qualcosa che gli intellettuali, i politici, i testimoni del tempo, devono
seriamente considerare. Il grande gioco, però, inizia nell'ultimo ventennio del XIX secolo.
Sulle sorti dell'impresa, della grande impresa, si decide in effetti della supremazia mondiale. L'Inghilterra, che
alla metà dell'Ottocento è "l'officina del mondo", non riesce a cogliere le occasioni più importanti della seconda rivoluzione industriale, non sviluppa la nuova siderurgia a ciclo integrale, la meccanica a produzione
continua e di massa, la chimica organica.
Questo accade perché l'economia inglese soffre i tipici "svantaggi del pioniere", è troppo ricca, urbanizzata,
caratterizzata da valori anti-industriali, governata da partiti politici che non hanno interesse a regolamentare
la competizione. In Europa la supera la Germania, affamata di ferrovie, strutture urbane, e quindi di acciaio,
impianti elettrici, prodotti chimici.
L'economia tedesca contrappone all'individualistico capitalismo inglese la cooperazione fra banche, aziende,
associazioni imprenditoriali e professionali e, presto, anche le organizzazioni dei lavoratori. Ma sia l'Inghilterra sia la Germania vengono nettamente sopravanzate dagli Stati Uniti d'America che, quando scoppia la
prima guerra mondiale, sono nettamente la prima economia del pianeta.
Hanno concorso a questo risultato:
1. mercati prodigiosamente dinamici (fra 1870 e 1913, la popolazione e il reddito pro-capite degli Stati
Uniti aumentano di quasi tre volte, mentre l'estensione della rete ferroviaria è più di 10 volte quella
dell'Inghilterra);
2. l'antitrust, una severa regolamentazione della competizione che costituisce in un certo senso il paradosso americano. L'antitrust, motivato da valori ideali e da interessi concreti, nasce per frenare la
crescita dell'impresa, ma ottiene il risultato opposto: non potendo accordarsi con altri per controllare
il mercato, l'impresa ne va alla conquista rafforzandosi al proprio interno, e quindi acquisendo dimensioni sempre più grandi;
3. le culture, i valori orientati a una search forwarder, ovvero a una burocratizzazione in senso weberiano, che attraversa tutte le componenti della società americana - partiti, sindacati, associazioni
professionali, istituti di formazione -, alla ricerca di una definizione di precisi canali di autorità e comunicazione che è assolutamente indispensabile all'avvento e al consolidamento della grande impresa.
Tuttavia l'Europa si configura in modo diverso dagli Stati Uniti. Permane più vigoroso il controllo familiare,
così come l'attitudine agli accordi per il controllo del mercato. Paesi che vogliono giocare la partita dell'industrializzazione partendo da posizioni più arretrate vedono emergere un protagonista diverso, lo Stato.
Nazioni come il Giappone, la Russia, l'Italia, certamente differenti una dall'altra per tradizioni e peso geopolitico, non intendono rinunciare alla grande partita. Per esse il problema cruciale è quello del rapporto fra
Stato e mercato: in Russia dalla fine degli anni Venti il potere sovietico abolisce il mercato, instaurando un'economia pianificata basata esclusivamente sulla grande impresa.
Alla meta del XX secolo gli Stati Uniti hanno lo stesso peso che l'Inghilterra aveva cent'anni prima, con il 10%
della popolazione mondiale vantano la metà dell'output industriale del pianeta. La storia non è mai definitiva.
Negli anni Sessanta un diverso scenario competitivo, un'ulteriore diffusione della proprietà dell'impresa (l'emergere prepotente dei fondi pensione e dei fondi di investimento), una diversa composizione del management, che enfatizza la possibilità di gestire qualsiasi azienda di qualsiasi settore, un nuovo orientamento
dell'antitrust, che punisce più la dimensione che la collusione, portano la grande impresa americana a imboccare la strada della diversificazione non correlata.
L'Unione Sovietica, che pure sino agli inizi degli anni Sessanta ha raggiunto grandi risultati, entra ora in una
crisi irreversibile, condannata dall'assoluta rigidità dell'economia di piano e dalla mancanza di una comunità
di imprese. Lo sfidante è piuttosto il Giappone, con i suoi gruppi, che si basano su rapporti stabili e visione di
lungo termine, con i lavoratori legati a vita all'impresa, con il do ut des fra Stato e grandi aziende: il primo le
sovvenziona, le protegge, le toglie addirittura dalle fluttuazioni del mercato, ma pretende da esse l'impegno
nella più radicale razionalità produttiva e, soprattutto, la competitività a livello globale. Del resto, questa è la
via che seguono i cosiddetti NIC (new idustria-Uzed countries), ovvero le "tigri asiatiche" (Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore). Queste nazioni dimostrano che si può uscire dal sottosviluppo.
Si è parlato di "sindrome vittoriana" degli Stati Uniti. Ma non è detto che la storia si ripeta. È quanto in effetti
accade dall'ultimo decennio del Novecento a oggi. La globalizzazione, irrefrenabile dopo la caduta del muro
di Berlino e, soprattutto, dopo la diffusione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione (internet) penalizza il capitalismo neo-mercantilista del Giappone e delle "tigri asiatiche", e rilancia portentosamente gli Stati Uniti, il Paese che sa cavalcare l'ondata del nuovo paradigma tecnologico: è la terza rivoluzione
industriale, quella che fa "lo spazio stretto".
Si avvia un processo drammatico che vede gli azionisti riappropriarsi dell'azienda nei confronti di un management "grasso e soddisfatto", un vasto movimento di deconglomerazioni (il ritorno al core business), ma
soprattutto la spietata applicazione all'interno dell'impresa delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, un reengineering che significa la perdita del posto di lavoro per milioni di persone.
CAPITOLO 25 - E L'ITALIA?
L'Italia è un Paese di piccole e medie imprese. È opinione corrente, sia degli studiosi sia del più vasto pubblico,
un'opinione "sigillata" da un capitolo dell'autorevole libro di Michael Porter Il vantaggio competitivo delle
nazioni. In effetti, fra le nazioni avanzate l'Italia ha un vero e proprio record, con oltre il 60% della forza lavoro
che si concentra in imprese con un numero di addetti inferiore a cinquanta.
Il nostro problema è che questa opinione prevalente si è tradotta anche in una prospettiva storiografica.
L'idea di fondo è che esista un modello dei Paesi avanzati e l'Italia ne sia rimasta fuori. In realtà, quello dell'Italia - per dirla con Giorgio Fuà -è un "modellacelo". L'Italia ha provato a inserirsi nella corrente delle nazioni
di prima fila e stava per riuscire, ma poi qualcosa è andato storto.
L'Italia e la seconda rivoluzione industriale
I lineamenti importanti del modello dei Paesi avanzati si riscontrano, a cavallo del 1900, anche nell'evoluzione
del sistema economico italiano.
Come negli altri Paesi, anche da noi la prima grande impresa era una società ferroviaria, la Strade ferrate
meridionali, ovvero la cosiddetta Bastogi dal nome del suo fondatore Pietro Bastogi, ministro delle Finanze
nel primo governo dello Stato unitario presieduto da Cavour. La Bastogi costruiva la ferrovia da Ancona a
Brindisi entro il 1867, e in seguito realizzava la Napoli-Foggia, non senza scandali e malversazioni.
Nel 1905, quando le ferrovie venivano nazionalizzate, essa riversava gli indennizzi nell'emergente settore
elettrico, restando quindi una potenza finanziaria di prima grandezza nel panorama economico italiano. Nel
1962, nazionalizzata a sua volta l'industria elettrica, la Bastogi dirigeva le sue risorse verso la chimica-, ma in
questo caso il diverso scenario competitivo rendeva il passaggio molto più problematico.
Nel 1884 nasceva la Edison, la più grande impresa elettrica italiana, presto raggiunta dalla Sip, dalla Sade e
dalla Sme. Nel 1888 era fondata la Montecatini, che in seguito, insieme alla Snia, sarà di gran lunga la più
importante impresa chimica italiana. Già nel 1872 era nata la Pirelli. Nell'ultimo anno del secolo veniva fondata la Fiat che, alla vigilia della prima guerra mondiale, produceva la metà degli autoveicoli italiani, per raggiungere subito dopo il conflitto il controllo di quasi il 90% del mercato nazionale.
Nel contempo si profilava a livello settoriale il predominio dell'Italcementi, mentre acquistava consistenza
un'impresa produttrice di macchine per ufficio, la Olivetti. Anche la grande distribuzione con dimensioni e
ritmi industriali nasceva in questi anni. Sulle ceneri della ditta Bocconi nel 1917 veniva creata La Rinascente,
da cui a sua volta, per mitosi, nel 1931 aveva inizio la Standa,
In definitiva, tranne ENI e Fininvest, per evidenti motivi, sebbene con nomi diversi e con pur notevoli trasformazioni societarie, all'inizio del secolo erano presenti tutti gli attori che domineranno la scena industriale
sino all'ultimo decennio del Novecento. La presenza della grande dimensione è quindi simile a quella di Stati
Uniti, Inghilterra e Germania, con un'importante differenza: in Italia la struttura oligopolistica era ancora più
ristretta, data la relativa povertà del mercato interno. Inoltre, la concentrazione era spesso nascosta dalla
forma a gruppo, che portava a distinguere il soggetto giuridico da quello economico.
Gli attori
Ora, in Italia attorno al 1900 era grande il contributo della banca universale, soprattutto della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano, alla fondazione di interi settori e alle più importanti iniziative industriali. Ma era soprattutto lo Stato il fattore decisivo, quello al quale la stessa banca guardava come rete
protettiva di ultima istanza.
Tuttavia, negli anni Ottanta dell'Ottocento il potere politico compiva una vera e propria forzatura verso la
nascita di serie iniziative industriali. La rivoluzione nelle comunicazioni e nei trasporti, notevole esempio di
globalizzazione, provocava la massiccia immissione sul mercato italiano di prodotti agricoli provenienti da
oltreoceano, "sommergendo" in tal modo il modello di un'Italia esportatrice di beni del settore primario.
Questa ragione - oltre a quelle relative a esigenze di politica internazionale- porta nel 1884 alla creazione
della prima impresa industriale moderna del Paese, la Terni. Si tratta di un episodio strategico della storia
economica italiana, perché alla Terni lo Stato non concedeva solo sovvenzioni, commesse, protezione doganale; quando, tre anni dopo la nascita, nel 1887, l'impresa era sull'orlo della bancarotta, lo Stato provvedeva
al "salvataggio" utilizzando la Banca Nazionale, in seguito Banca d'Italia, con l'emissione di nuove banconote.
Un'operazione di questo genere - il salvataggio attraverso l'intervento della banca centrale - in mezzo secolo
veniva attuata quattro volte: nel 1887 veniva salvata un'impresa, la Terni; nel 1911 era la volta di un intero
settore industriale, il siderurgico; nel 1922 il privilegio toccava alle attività industriali afferenti a due grandi
banche, la Banca Italiana di Sconto (dentro c'era la maggiore azienda italiana, l'Ansaldo) e il Banco di Roma;
infine, ne! 1933 l'ultimo e più grande salvataggio, quello delle imprese legate alle tre grandi banche miste, la
Commerciale, il Credito Italiano, il Banco di Roma.
Il capitalismo politico
La pervasiva presenza dello Stato ha avuto un forte impatto sull'agire imprenditoriale. Mentre nei Paesi avanzati la crescita era perseguita per ragioni squisitamente economiche, ovvero il taglio dei costi unitari, non di
rado in Italia si assisteva a tentativi di espansione per meglio contrattare con il potere politico. All'inizio del
secolo gli imprenditori siderurgici erano consapevoli del fatto che le caratteristiche del mercato non richiedevano la costruzione di nuovi impianti, e tuttavia decidevano di espandere la produzione perché sapevano
che presto o tardi si sarebbe arrivati a un accordo arbitrato dal governo, e sarebbe stato meglio arrivarci più
"abbondanti" possibile.
Significativo è l'esempio della Terni nel periodo immediatamente successivo al primo conflitto: venivano
meno le ragioni economiche della siderurgia bellica e il suo leader, Arturo Bocciardo, la portava a operare nel
campo della produzione di energia elettrica e, di risulta, in quello elettrochimico.
La siderurgia bellica però veniva mantenuta in attività, in quanto formidabile strumento di pressione nei confronti del governo fascista. Era un do ut des: la Terni continuava a offrire armamenti anche quando non aveva
alcuna convenienza economica, ma il governo garantiva buone condizioni per le forniture di energia elettrica,
un terreno di prezzi amministrati, e buone posizioni all'interno dei cartelli chimici.
La Montecatini era l'epitome dell'"impresa fascista", in particolare per la produzione di azoto sintetico, che
corrispondeva a tre idee-forza del regime: ruralismo, bellicismo, e infine autarchia, dati gli ingredienti necessari. Nulla veniva dato per gratuito, però. In cambio della protezione tariffaria il governo chiedeva alla Montecatini una serie di salvataggi: l'ACNA, impresa produttrice di coloranti; la Montevecchio, che in Sardegna
gestiva giacimenti piombiferi; le maggiori aziende attive nel settore marmifero carrarese.
Era questa l'origine del fallimento che portava nel 1966 alla disastrosa fusione con la Edison. SÌ ricordi infine
la vicenda della chimica italiana negli anni Settanta, quella che è all'origine del famoso processo IMI-SIR. Tre
aziende - Montedison, ENI e SIR di Nino Rovelli - costruivano tre impianti simili nello stesso luogo, Ottana, al
centro della Sardegna. Non c'era razionalità economica, ma solo ragioni strategico-politiche. Nel complesso,
se il capitalismo americano può essere definito manageriale, se quello inglese è un capitalismo personalfamiliare, e il tedesco può essere indicato come capitalismo cooperativo, non pare esagerato definire quello
italiano un capitalismo politico.
Il grande capitalismo privato
Non c'era solo questo in Italia, ma anche una grande industria orientata al mercato. Giovanni Battista Pirelli
consolidava e ampliava la propria azienda sin dall'ultimo ventennio dell'Ottocento, rispondendo a commesse
pubbliche nel settore dei cavi telegrafici e telefonici. Pirelli, tuttavia, costruiva ben presto un'impresa capace
di competere sul mercato internazionale, costruendo stabilimenti in Spagna, in Sud America, addirittura in
Inghilterra, nel cuore del capitalismo globale.
La Fiat era senz'altro un'impresa "nata bene": fra gli azionisti erano i migliori nomi dell'aristocrazia e della
borghesia torinese, e all'inaugurazione del primo stabilimento erano presenti due altezze reali.
Tuttavia la Fiat era l'impresa egemone dell'industria automobilistica italiana già alla vigilia della prima guerra
mondiale, quando produceva la metà dei veicoli nazionali, grazie a un imprenditore, Giovanni Agnelli, il primo
in Italia a comprendere che l'automobile non sarebbe rimasta a lungo un "giocattolo per ricchi", ma era destinata a diventare un tipico prodotto di massa della seconda rivoluzione industriale.
Il mercato interno ristretto
Perché questo capitalismo, pur orientato al mercato, non si trasforma in capitalismo manageriale all'americana o familiare-manageriale alla tedesca? Appare decisiva in questo senso la ristrettezza del mercato interno; se all'inizio degli anni Venti si fissa pari a 1 il reddito pro-capite italiano, si deve assegnare U doppio a
quello inglese e francese e un 3,6 all'americano.
E tutto ciò non sembrava esagerato, dato che alla produzione di 2000 automobili giornaliere della Ford ne
corrispondeva una di 300 della Fiat. È il Paese, l'Italia, nel quale la maggiore impresa chimica, la Montecatini,
aveva alla base dei suoi affari la produzione di concimi - «con la calciocianamide il villano se la ride», recitava
un celebre slogan -, mentre era ben visibile la debolezza della chimica industriale. L'Italia era il Paese in cui
una catena di grande distribuzione, la Rinascente, non riusciva a puntare sui magazzini di lusso, e riusciva
quindi a salvarsi dalla grave crisi dei primi anni Trenta solo con la riconversione verso i negozi popolari della
Upim (Unico prezzo italiano Milano).
Si potrebbe sostenere che un'alternativa possibile alla ristrettezza del mercato interno era rappresentata
dalle esportazioni: per esempio, la Fiat collocava all'estero nel 1922 il 70% della propria produzione. Il mercato internazionale si presentava però caratterizzato da forti incertezze e fluttuazioni e quando, nel 1926, il
governo italiano decideva di sostenere la lira, probabilmente oltre i limiti del ragionevole, il settore automobilistico, fra gli altri, riceveva un durissimo colpo.
Il settore elettrico cuore del potere economico
Alla vigilia della seconda guerra mondiale il capitalismo industriale italiano sembrava regredire verso forme
feudali: è quanto affermava il magnate dell'industria elettrica Ettore Conti in una celebre pagina del suo Taccuino di un borghese; egli sosteneva che, mentre in Italia si celebrava un sistema politico ed economico che
andava «verso il popolo», la realtà mostrava interi rami dell'industria governati da un singolo uomo: Agnelli,
Pirelli, Donegani, Falck, Cini, Volpi.
Un miracolo che viene da lontano
Protagonista di un percorso tutt'altro che lineare, quando iniziava la seconda guerra mondiale l'Italia era però
l'unico Paese del Mediterraneo ad avere raggiunto uno stabile stadio di industrializzazione. Non ce l'ha fatta
la Spagna, per esempio, che forse si era affidata troppo alle multinazionali. Per l'Italia era stato il primo conflitto mondiale, con le commesse della Mobilitazione Industriale, il punto di non ritorno, al termine del quale
la nazione era fra le otto più industrializzate del mondo.
Ma già negli anni immediatamente precedenti la Grande guerra il Paese era autonomo per una produzione
essenziale come quella siderurgica, mentre un'impresa come l'Ansaldo, nonostante la megalomania dei suoi
capi, aveva impianti che suscitavano l'ammirazione degli addetti militari tedeschi.
Nel corso della prima metà del XX secolo si formavano in Italia importanti forze produttive, che si concretizzavano soprattutto nella costituzione di coorti manageriali. Erano, per esempio, gli "uomini del Professore",
ovvero i dirigenti della Fiat che affiancheranno Vittorio Valletta nella grande performance degli anni Cinquanta. Quasi tutti entravano in azienda all'inizio degli anni Venti per rispondere alle esigenze create dall'inaugurazione del Lingotto, il più moderno impianto automobilistico d'Europa.
Erano i "siderurgici" di Oscar Sinigaglia, il "samurai" che aveva individuato nell'acciaio la questione economica
fondamentale dell'economia italiana. Sinigaglia, sin dal 1910, esponeva un lucido programma di sviluppo e
specializzazione degli impianti a ciclo integrale capace di dare al Paese prodotti siderurgici su vasta scala, di
buona qualità e a basso prezzo. Particolarmente importante era la sua opera all'interno della Sofindit, la
finanziaria che raggruppava le partecipazioni industriali della Banca Commerciale Italiana all'inizio degli anni
Trenta.
La grande impresa protagonista del “miracolo”
Gli anni a cavallo del 1960 sono ricordati come il periodo del "miracolo economico" italiano. Indiscussi protagonisti sono stati imprenditori che giocavano "in sensibile grande" e non vedevano il mercato frenato da
vincoli insuperabili. Perseguivano quindi le economie di scala e di diversificazione lanciandosi nella costruzione di grandi impianti e grandi organizzazioni. Non vedevano nella contrattazione con il potere politico
l'essenza del proprio agire imprenditoriale. Questa era data piuttosto da produzioni di massa che rendessero
accessibili beni essenziali alla maggioranza dei consumatori.
Oscar Sinigaglia realizzava un piano per la siderurgia degno di un John Rockcfeller: costruiva un grande impianto a ciclo integrale presso Genova, a Cornigliano, secondo lo stato dell'arte della tecnologia; specializzava
la produzione degli altri impianti, chiudeva quelli obsoleti licenziando migliaia di operai. Sinigaglia era molto
sensibile ai costi sociali, e a chi gli obiettava le conseguenze della sua azione in questo campo rispondeva che,
offrendo acciaio di buona qualità e a basso prezzo, avrebbe sviluppato potentemente l'industria meccanica,
ottenendo quindi un massiccio incremento dell'occupazione. Un altro grande "primo attore" di questa fase
era il leggendario Enrico Mattei, il fondatore dell'ENI, che realizzava a vantaggio dell'industria settentrionale
una fitta rete metanifera, mentre attuava un'efficace politica nel settore del petrolio grazie a geniali e rischiosi accordi con i Paesi produttori.
Mattei si avvaleva anche della sua posizione in campo metanifero per strappare alla Montecatini, a vantaggio
degli agricoltori italiani, la leadership nei concimi chimici azotati. Nel 1956, infatti, costruiva a Ravenna un
impianto petrolchimico con un investimento di 60 miliardi; sei anni prima la Montecatini aveva speso per un
analogo stabilimento a Ferrara 18 miliardi: le economie di scala realizzate dall'ENI erano però imbattibili.
Un quarto indimenticabile protagonista del "miracolo" era Adriano Olivetti, l'imprenditore più consapevole
delle conseguenze sociali dell'industrializzazione, ma così concreto da realizzare nel campo dei prodotti per
ufficio una multinazionale da 50 000 dipendenti, tale da acquisire alla fine degli anni Cinquanta una delle
maggiori imprese americane del settore, la Underwood. Importante è notare come non ci sia differenza, in
questa golden age, fra privato e pubblico (a questo proposito potremmo aggiungere il caso dell'Alfa Romeo
di Giuseppe Luraghi).
Un approdo "giapponese"?
Un reddito nazionale che in vent'anni (1950-1970) cresceva mediamente del 6% annuo; la Fiat, quinta impresa automobilistica mondiale, potenzialmente in grado di competere sul mercato internazionale con l'esperienza acquisita nel segmento delle small car; la Olivetti, che primeggiava sui mercati internazionali con
le sue macchine per scrivere e con le sue calcolatrici, tanto da acquisire una corporation americana di primo
rango; Enrico Mattei, protagonista della politica petrolifera internazionale; la siderurgia, che passava dal
nono al sesto posto nel mondo; il nucleare, che vedeva il Paese all'avanguardia in Europa; la formazione di
nuovi settori industriali, come quello degli elettrodomestici e il generale irrobustimento della struttura produttiva cosicché i sarti diventavano industriali dell'abbigliamento, i falegnami mobilieri, i calzolai calzaturieri.
Tutto questo dava la sensazione che l'Italia potesse spingersi sino alla frontiera dell'economia mondiale,
come il Giappone, un Paese certo lontano, ma per molti versi vicino, data la periodizzazione del suo sviluppo
industriale, dato il ruolo giocato anche qui dall'attore pubblico. La chiave per comprendere i diversi esiti dei
due Paesi è nell'elemento politico-istituzionale. Negli anni Trenta in Giappone l'azione dello Stato era troppo
pervasiva: una selva di leggi e regolamentazioni finiva per ingessare l'economia nazionale.
Si delineava una sorta di "quadratura del cerchio", per cui lo Stato proteggeva e sosteneva le grandi imprese,
ma le obbligava a confrontarsi con il mercato globale. In un tentativo di storia controfattuale si potrebbe dire
che in Italia lo Stato avrebbe dovuto ritirarsi dall'intervento diretto e dedicarsi alla creazione di un quadro di
regole all'interno delle quali la grande impresa potesse prosperare. Sarebbe stata necessaria quindi un'efficace protezione degli investitori in Borsa; la promozione di investitori istituzionali; la revisione della legge
bancaria con il ripristino della cosiddetta haus bank; una legislazione antitrust; il governo delle trasformazioni
sociali e del conflitto.
Uno Stato politicizzato
La società italiana, date le caratteristiche del processo che ha portato alla formazione dello Stato unitario, si
è sempre contrassegnata per la sua frammentazione localistica, tale da non sopportare un rapporto diretto
fra Stato e cittadini, necessitando invece di una mediazione da parte della politica. Quando si parla di "pubblico" in Italia, quando si parla di Stato, è sempre necessario intravedere l'azione e la discrezionalità della
politica. Si prenda il caso di quello che diverrà il sistema delle Partecipazioni Statali.
La fase della "negligenza benigna" da parte dei politici non durava molto a lungo, Già alla metà degli anni
Cinquanta si intravedeva uno spoll system che segnerà pesantemente l'intera costruzione. E, dato il cosiddetto "bipartitismo polarizzato", che la natura del maggiore partito di opposizione, il Partito comunista italiano, rende inevitabile, si tratta di uno spoll system a senso unico, che ha finito per rendere irresponsabili
governo e opposizione. Lo Stato imprenditore diventava in questo quadro sempre più uno strumento per il
consenso, ovvero cresceva per incrementare l'occupazione, sicuro grimaldello del successo elettorale.
Nel 1956, con la nascita del Ministero delle Partecipazioni statali, veniva creata una catena di comando che
nel corso degli anni si rivelerà micidiale. Prendiamo il caso del settore siderurgico. Alla fine degli anni Cinquanta era necessario incrementare sostanzialmente la capacità produttiva. Veniva quindi effettuata un'indagine fra i maggiori dirigenti della Finsider, la finanziaria siderurgica dell'IRI: il responso era quasi unanime
e prevedeva il raddoppio dello stabilimento di Piombino, un sito di antica industrializzazione.
Era la produzione di massa a basso costo, con la quale si sarebbe arrivati a sicura sconfitta da parte dei concorrenti asiatici. L'occupazione aumentava, ma per la Finsider era l'inizio della fine, che arrivava con la "bancarotta" del 1988, e un debito di 25 000 miliardi. Una sorte simile rischiava l'ENI, che, obbligata a salvataggi
da leggi del parlamento - un vero e proprio metodo "sovietico" di esproprio delle prerogative di impresa veniva trasformata di fatto da azienda a ente per lo sviluppo.
L’approdo mancato
L'incapacità di raggiungere i risultati del Giappone si concretizzava in cinque grandi episodi:
1) La degenerazione dello Stato imprenditore, di cui si è parlato nel paragrafo precedente.
2) Il fallimento dei progetti di frontiera tecnologica. La Olivetti, dopo l'improvvisa scomparsa del suo
leader, Adriano Olivetti, non riusciva a concretizzare l'occasione della pionieristica produzione di
computer, un'iniziativa i cui costi andavano ben oltre le disponibilità di un'impresa familiare. Su un
altro versante, si verificava l'aborto del grande progetto di dotare il Paese di una rete di impianti
nucleari, che solo una determinata e unitaria politica industriale poteva rendere realistico.
3) Le conseguenze della nazionalizzazione dell'energia elettrica. Era il risultato della decisione caldeggiata dal governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, di indennizzare le aziende e non gli azionisti.
Carli pensava di ripetere l'operazione del 1905, quando gli indennizzi della nazionalizzazione delle
ferrovie si erano riversati nell'emergente industria elettrica.
4) La crisi delle grandi famiglie, che si verifica negli anni Sessanta fra vecchie e nuove dinastie industriali.
5) Il "lungo autunno", il periodo che iniziava con la vertenza Fiat del settembre 1969 e si concludeva,
sempre alla Fiat, con la cosiddetta "marcia dei quarantamila" nell'ottobre del 1980. Era un periodo
di importanti conquiste sociali per i lavoratori, ma anche di tragici conflitti, come la diffusione del
terrorismo. Ciò che risaltava alla fine era l'incapacità di incanalare politicamente e istituzionalmente
giustificate rivendicazioni, alla maniera tedesca, con la cogestione.
Una vera e propria fortuna per l'Italia era rappresentata dalla piena adesione al progetto europeo, con l'accordo di Maastricht. Esso portava non solo alla moneta unica, ma anche - finalmente - all'instaurazione di
regole, come l'antitrust, il rafforzamento della Consob, la legge sulle SIM, la nuova legge bancaria, la legge
sulla corporate governance. Ma, ormai, "i buoi erano scappati". La grande impresa era irrimediabilmente
depotenziata. Nel 1997 la Montedison cedeva le attività chimiche. Quasi nello stesso periodo, la Fiat entrava
in una crisi di cui non è ancora chiaro l'esito, mentre le prime imprese italiane risultavano quelle come l'ENI
e la Telecom, che nella realtà usufruivano di forti posizioni di rendita.
La scoperta della piccola impresa
L'Italia degli anni Settanta era un mistero. Sembrava afflitta da tutti i mali e da tutte le crisi, ma continuava a
crescere, seconda solo al Giappone fra i Paesi dell'OCSE. Si "riscopriva" allora la piccola impresa, spesso organizzata nella forma del distretto industriale, un territorio definito dedicato alla produzione di un bene per
la quale viene realizzata una divisione del lavoro sia orizzontale sia verticale, ovvero, oltre al bene, si fabbricano anche le macchine per la sua realizzazione.
Nel 1991, quando il parlamento approvava una legge che Intendeva tutelarli, venivano censiti 199 distretti
che contavano 2 200 000 addetti, ossia il 4.5% dell'occupazione manifatturiera complessiva. Erano i distretti
a indirizzare le proprie risorse verso la produzione di beni per la persona e per l'abitazione, fino a diventare
protagonisti nell'ascesa del made in Italy.
Importanti erano anche l'antica consuetudine di una raffinata domanda urbana e l'attitudine al commercio
cosmopolita. In ogni caso, quello dei distretti era un successo che non si spiegava solo con la quantità e la
qualità dei fattori individuali. Decisivo era l'apporto di un'istituzione come la famiglia, in aziende nelle quali
padroni e operai erano spesso parenti, Così come in primo piano era la comunità locale, per cui la concorrenza era bilanciata da un senso di solidarietà e le conoscenze tecniche e professionali erano "nell'aria".
II quarto capitalismo
Dai distretti sono emerse non di rado imprese che in essi hanno creato precise gerarchie. Tali attori sono stati
definiti "quarto capitalismo" perché non potevano essere identificati né con la grande impresa privata, né
con quella pubblica, né con la piccola impresa. Alla fine degli anni Novanta erano attive in Italia un migliaio
di aziende che fatturavano fra i 300 e i 3000 miliardi di lire.
Due erano le caratteristiche fondamentali: una grande abilità tecnica, di origine addirittura artigianale - si
pensi a Leonardo Del Vecchio e alla sua Luxottica - oppure una straordinaria capacità commerciale - come
nel caso della Divani&Divani di Pasquale Natuzzi. La formula del successo di questo quarto capitalismo era la
concentrazione su una nicchia, ma di livello globale, come sanno i produttori fabrianesi di cappe aspiranti.
Alcuni osservatori del quarto capitalismo hanno sostenuto che l'Italia stia subendo una metamorfosi, più che
un declino. In realtà questo nuovo protagonista deve affrontare ancora due nodi irrisolti. Il primo riguarda
quella che oggi viene definita governance, ovvero il modo in cui si rende armonico il rapporto fra proprietà,
controllo e gestione d'impresa.
Il secondo aspetto critico riguarda i settori in cui esso attualmente opera -tessile, abbigliamento, calzature,
pelli e cuoio, legno e mobili, ceramiche e marmo, oreficeria, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi,
giocattoli -, ovvero quelle produzioni a cui si accennava in precedenza riferendosi ai distretti, produzioni che
non sono certo quelle di frontiera, e che tuttavia consentono all'Italia di collocarsi fra le prime otto economie
mondiali.
Un discorso su grande e piccola impresa deve essere inquadrato almeno all'interno del processo di integrazione europea. Se questo si realizzerà senza riserve, potremo accettare quello che Porter definisce il nostro
«vantaggio competitivo».