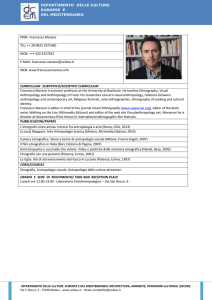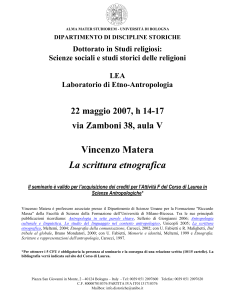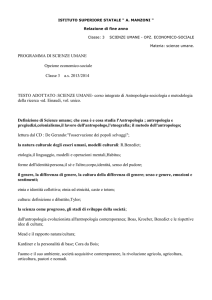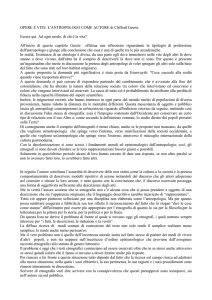Università di Siena
Università di Cagliari
Università di Perugia
Seminario di Pontignano
DOTTORATO IN METODOLOGIE DELLA RICERCA ETNOANTROPOLOGICA
19/20 DICEMBRE 2005
CAMPO, SPAZIO, TERRITORIO
RIFLESSIONI PRELIMINARI DEI DOTTORANDI SUL TEMA GUIDA
DELL’ANNO A.A. 2005/2006
1
Indice
Il campo multisituato
- Cristina bezzi
Il territorio in movimento e il senso di possibilità”. Due note per
la discussione su campo, spazio, territorio – Alex Koensler
Pag. 3
Pag. 7
Riflessioni – Danila Cinellu
Pag. 11
Territorio, spazio e campo – Michela Badii
Pag. 14
Riflessione sui concetti di “spazio”, “territorio e “campo”
- Signe Stroem
Pag. 18
Un viaggio multivocale attraverso la polifonia dello spazio e del
territorio nell'antropologia contemporanea
Pag. 21
Sul “campo”, lo “spazio”, il “territorio”... - Andrea Ravenda
Pag. 26
Campo, spazio, territorio – Daniele Cestellini
Pag. 31
– Daniela Valentina Fiegna
Spazio, Territorio, Campo. L'antropologo di fronte allo spazio turistico
e alla percezione territoriale degli Hosts – Francesca Mariotti
Della perduta tenda. Famiglie di concetti: Spazio, campo, territorio.
- Sergio Contu
La politica del territorio: spazio di dominio, spazio di identità.
Pag. 38
Pag. 40
Note per la discussione sulle categorie di territorio, spazio, campo.
- Umberto Pellecchia
Pag. 46
Campo – Alberto Acerbi
Pag. 48
Riflessioni – Teodora Mocan
Pag. 50
Pratiche spaziali e relazioni di potere. Corpi e macchine
Pag. 54
Note su campo e territorio - Francesca Polidori
Pag. 57
Riflessioni - Claudia Avitabile
Pag. 60
E’ l’antropologo a scegliere il proprio “campo”, o il “campo” il
suo antropologo? - Giulia Pedone
Pag. 63
Spazio sovrapposto: lo studio delle reti di relazione parentale in
Toscana - Sara Testi
Pag. 65
– Roberta Pompili
2
Il campo multisituato
Cristina bezzi
Partirò in questa esposizione da alcuni dubbi espressi dall’antropologa Joanne Passaro(1997) nel
suo articolo: You can’t take the subway to the field!: village epistemologies in the global village,
nel quale problematizza la sua esperienza di ricerca etnografica tra gli homeless di New York
city. Prendo spunto da questo articolo non soltanto perché ritrovo delle similarità con la mia
esperienza di ricerca etnografica sulle strade di Bucarest, ma anche perché mi sembra un modo
utile partire da questioni che nascono direttamente dall’esperienza sul campo per attraversare
quelle più teoriche che ci siamo propositi di affrontare in questo seminario.
Passaro evidenzia il suo disagio di fronte alla reazione stupita di molti antropologi accademici
quando alla domanda se lei durante la sua etnografia avesse mai dormito sulla strada, lei
rispondeva con un “no mai”, oppure quando un altro antropologo le aveva fatto notare: “You
can’t take the subway to the field. What kind of fieldwork can you do in such an uncontrolled
environment?” (Passaro, 151). L’antropologa evidenzia quindi due aspetti che mi sembrano
fondamentali che ruotano intorno a due concetti, tra essi collegati, il lavoro sul campo ed il
campo, problematizzandoli e mettendo criticamente in evidenza come i loro significati siano
spesso ancora impregnati da un visione del mondo colonialista (148).
IL fatto di dormire sulla strada, di esporsi al pericolo poteva forse essere visto come un rito di
passaggio indispensabile del fieldwork, legato ad una idea romantica del sancire il passaggio
all’interno di quel gruppo sociale?
In secondo luogo il fatto di avere deciso di non focalizzare la sua osservazione su uno specifico
gruppo di homeless, per esempio all’interno di uno shelter di donne senza tetto, ma invece di
rompere i confini e seguire a più ampio raggio quelle reti e punti di incontro a cui gli homeless
partecipavano in diverse parti della città sembrava scatenare un altro elemento di conflitto con
l’idea di campo che gli antropologi con cui si era confrontata avevano.
Passaro quindi evidenzia come la nozione di campo, che continua a rimanere il simbolo
principale della disciplina, sebbene abbia assunto nuovi significati e incluso nuovi luoghi
allontanandosi da quegli assunti coloniali dell’esotico e del primitivo, continua a portare in se
quegli assunti coloniali da cui è partito, l’antropologia infatti sembra avere la necessità di
delimitare aree e siti e campi/laboratorio” in cui poter studiare “ coherent people and necessay
others” ( 148).
[…] the process of taking anthropology out of the field- the geographical distant and exotic
lands of others - is far easier than taking “the field”, i.e., colonial thinking, out of anthropology.
(ibid, 1997: 148).
Sicuramente non voglio attribuire a Passaro il merito di avere portato alla luce la problematicità
della nozione di campo e di pratica etnografica, ma ho voluto partire con il suo articolo per
evidenziare alcuni nodi davanti a cui mi sono trovata io stessa nell’affrontare la mia ricerca e
quindi la mia intenzione è di tentare di passare da un piano di significati teorici senza perdere di
vista la dimensione della pratica etnografica.
Nel panorama delle rivisitazioni critiche della disciplina antropologica che hanno fatto nascere
anche l’esigenza di riaffermare alcuni capisaldi metodologici all’interno di essa, sicuramente la
nozione di campo considerato nella sua duplice accezione di “ideale metodologico” e di luogo di
3
concreta attività “professionale” (Clifford,1999) rappresenta uno degli elementi centrali di tale
dibattito. Se da un lato il campo rimane un elemento distintivo potremo dire marcatore di
“autenticità” della disciplina antropologica, dall’altra la sua classica accezione Malinowskiana
del risiedere e lavorare in modo intensivo in una comunità lontano da casa, in uno spazio anche
se solo apparentemente neutro e apolitico (nota.Come nota Clifford (1999) “non è che le cose
d’un tratto abbiano assunto una coloritura politica, mentre in passato la ricerca sarebbe stata in
un certo senso neutrale […] ciò che voglio dire è semplicemente che la sicurezza del campo
come un luogo di residenza e di lavoro, come sito in cui ci si adoperava a produrre una scienza
sociale neutrale, apolitica era essa stessa una creazione storica e politica ), è stata rivisitata dai
lavori di numerosi antropologi (alcuni Gupta and Ferguson, 1997, Marcus, 1995, Clifford 1999,
Appaduray, 1999).
Sicuramente queste rivisitazioni nascono anche dalla necessità di un rinnovarsi della tradizione
per riadattarsi e ricontestualizzarsi all’interno di un nuovo ordine sociale in cui i confini tra
“locale” e “globale” sono stati ridefiniti dai processi dell’economia capitalista e da flussi sempre
più fitti di oggetti, informazioni e persone che collegano anche le realtà, i “territori” più sperduti
degli angoli del pianeta.
Gupta e Ferguson (1997) asseriscono criticamente che l’antropologia necessariamente deve
riconsiderare la nozione di un “campo delimitato” e pensare piuttosto a delle “localizzazioni
mutevoli”, allentandosi quindi dall’ideale classico del campo chiuso, neutrale ed esotico in cui il
ricercatore maschio/bianco svolge la sua osservazione partecipante. Sebbene sia riconosciuto che
l’”esoticizazione” del campo sia un prodotto storico legato al colonialismo gli autori continuano
criticando il fatto che molti di quei presupposti coloniali continuano ad essere perpetrati
all’interno della disciplina. Infatti essi mettono in luce che l’idea che ciò che è considerata una
“real anthropology” sia ancora legata per molti versi a quegli ideali classici e ad un idea di
fieldwork per molti versi compreso ancora come rito di passaggio (che deve in qualche modo
includere elementi di pericolo e di eroismo), e questo è riscontrabile nel fatto che nella pratica
poi esistano delle gerarchie dei differenti “field sites”. Per esempio quei campi legati alle
questioni più politiche o i lavori della antropologia applicata sono tuttora meno apprezzati
nell’ambito della antropologia accademica.
Lontani dal volere decostruire il lavoro sul campo e il campo come elementi fondanti della
disciplina essi ne propongono una rivisitazione critica ed un adeguamento al nuovo contesto
storico/politico. Il “campo” dunque non come un luogo specifico ma piuttosto come un modo di
studio come il “site of anthropological knowledge”. E questa conoscenza dal loro punto di vista
non può più avere come fine una ricerca astratta della verità ma deve piuttosto avere come
obiettivo il raggiungimento di fini politici.
Ritornando al articolo di Passaro intendo ora ricollegarmi alla mia esperienza di ricerca a
Bucarest.
Il pericolo messo da lei in evidenza di rischiare di riprodurre in nuovi contesti, “campi” quelle
nozioni oramai ampiamente criticate del primitivo e dell’esotico è sicuramente uno di quelli in
cui sono incorsa quando per la prima volta sono arrivata a Bucarest con l’intenzione di condurre
la mia osservazione partecipante all’interno di un gruppo di “bambini di strada”.
Pur non essendo partita con l’idea di svolgere la mia osservazione partecipante in uno spazio
chiuso, anche per il fatto stesso che il luogo fisico in cui mi muovevo era la strada, ma volendo
intendere il “campo”, (inteso sia come luogo che come pratica), come un qualcosa di aperto,
relazionale e processuale, devo ammettere che inizialmente tentavo ostinatamente di creare dei
4
confini se non altro mentali attorno a quel tappeto d’erba all’uscita del metrò dove il gruppo
viveva. In un certo senso stavo cercando di ricreare all’interno della città di Bucarest, degli spazi
delimitati entro cui focalizzare la mia osservazione partecipante anche per non disperdere il
“campo”, nella vastità di quella città, dappertutto e da nessuna parte, ma in quel modo mi resi
ben presto conto stavo cercando di costringere quel gruppo di persone estremamente in
movimento entro i confini di una sorta di “subcultura” marginale.
Le mie visite quotidiane all’interno di questo gruppo, incominciarono ben presto a destare
l’attenzione di vicini e passanti, che a volte reagendo anche in modo violento, mi sembravano
frapporsi tra me e il mio campo interferendo con quel piccolo spazio di osservazione che mi ero
creata. Soprattutto nei primi tempi, dopo che l’educatore di strada che mi aveva introdotto al
gruppo se ne era andato in vacanza, mi ero proposta di passare con loro il maggior tempo
possibile affinché i bambini riconoscessero la mia presenza come famigliare e attraverso qualche
sorta di “rito di passaggio” mi rendessero partecipe almeno in parte delle dinamiche del loro
gruppo. Fui costretta dopo poco ad abbandonare il gruppo, in seguito all’intervento di un uomo
ubriaco che indispettito dalla presenza di una ragazza, evidentemente non romena, che se ne
stava seduta a chiacchierare e disegnare con quei “delinquenti”, “aurolaci” (nota: da aurolach, la
colla che molti “bambini di strada” inalano da sacchetti di plastica, da qui il termine
stigmatizzante con cui molti li definiscono), incominciò a picchiare i bambini con un bastone.
Nei miei tentativi di placare l’ira di quell’uomo, compresi che lui, almeno così diceva, lavorava
alla televisione ed era stufo che nel mondo si parlasse della Romania solo come del paese dei
bambini di strada.
Nell’impossibilità di continuare l’osservazione con quel gruppo, incominciai a rivolgermi ad
altre ONG che avevano alcuni progetti di educativa di strada per evitare di tornare sulla strada
da sola e sperando di trovare con il tempo un valido intermediario. Per l’ennesima volta fui
aggredita verbalmente da un capo progetto romeno che mi disse: “ Voi occidentali volete venire
qui nel nostro paese a vedere la miseria in cui vivono questi bambini perché è più esotico.
Perchè voi antropologi volete venire qui in Romania per studiare questi bambini come se
fossero dei selvaggi delle tribu africane?”
Nel frattempo continuavo a prendere nota di tutto quello che succedeva, dei vari incontri e
scontri che quotidianamente dovevo affrontare, a sbobinare le interviste che avevo
incominciato a rilevare con gli operatori di diverse ONG, ma avevo come l’impressione che
quella non fosse una vera etnografia, una “real anthropology”. Dove era finito il mio campo?
Quello che avevo pensato prima di arrivare a Bucarest ispirandomi anche alle etnografie di altri
antropologi che avevano lavorato in contesti simili?
Dopo il primo mese di etnografia, muovendomi da un posto all’altro della città, frequentando
diverse ONG, centri diurni per bambini che vivevano sulla strada, progetti del ministero per la
protezione dell’infanzia, raccogliendo articoli di giornale, ritornando occasionalmente sulla
strada accompagnata da qualche operatore mi sentivo completamente persa.
Quando poi incontrandomi con una studentessa romena, che stava svolgendo la sua etnografia
all’interno di un accampamento di rom nelle vicinanze di Bucarest, mi disse molto convinta:
“ma come puoi fare una etnografia su questi bambini se non puoi partecipare alla loro vita di
gruppo a tempo pieno?” , mi sembrava di avere ricevuto una conferma quasi accademica del
fatto che non stavo facendo una etnografia reale. Non mi soffermerò ora sugli ulteriori risvolti
della mia ricerca che ridefinirei ora che sono fuori dal “campo” come una etnografia processuale
(Moore, 1997) e multisituata (vd. Marcus, 1995), ma vorrei brevemente soffermarmi sulle
5
modalità con cui ho dovuto modificare i presupposti da cui ero partita per ritornare poi alla
nozione di “campo” come “habitus”.
Ricapitolando, il progetto di ricerca che mi ero proposta di portare a termine presupponeva
forse un’ idea classica di lavoro sul campo come rito di passaggio, la mia illusione di poter
svolgere la mia osservazione cercando di delineare uno spazio situato era profondamente
ingenua e impossibile da praticare. L’intervento del giornalista è stato forse solo il più evidente
che mi ha necessariamente portato a reimpostare e comprendere quell’etnografia come un
processo di negoziazione continua, come un campo conflittuale, processuale in cui la mia
presenza ben lontano dall’essere neutrale era investita da significati politici e simbolici con cui
non soltanto mi dovevo confrontare ma che diventavano parte dello stesso “campo” oggetto
della mia indagine. Quel conflitto esplicito che la mia presenza faceva scaturire sottendeva
infatti delle dinamiche politiche molto più grandi di me, del giornalista o dell’operatore romeno
che mi aveva aggredita. Prima del mio arrivo a Bucarest nel 1999, quel campo che io stavo
cercando di decifrare era già stato attraversato da frotte di giornalisti e altri attori sociali che
avevano diffuso ampiamente le “miserabili” condizioni dei bambini di strada (conosciuti in tutto
il mondo come i bambini delle fognature) e inoltre la questione dell’infanzia in Romania è stata
per anni una questione centrale nelle trattative di accesso del paese all’Unione Europea. Tutte
queste dinamiche internazionali, transnazionali, delocalizzate erano profondamente inscritte in
quello spazio di relazioni sociali in cui ero andata ad inserirmi, ed inevitabilmente sono
diventate esse stesse oggetto di indagine.
Per concludere vorrei ritornare brevemente, dopo avere attraversato parte del mio percorso di
ricerca, a riflettere sulla nozione di campo, riprendendo il suggerimento di Clifford il quale pur
sostenendo la necessità di confrontarsi con campi che non sono più localizzati e situati ribadisce
anche che questa apertura pone dei problemi di autodefinizione della disciplina. E’ necessario
quindi di rivalutare le tecniche classiche in un nuovo contesto in cui la localizzazione è
continuamente in movimento. Egli suggerisce quindi di considerare il “campo”, piuttosto che
come un luogo situato, come un habitus cioè come un gruppo di disposizioni d’animo e di
pratiche disciplinari fatte proprie, incarnate.
Concludo esprimendo il mio interesse ad approfondire teoricamente durante questi gruppi di
lavoro questo concetto di “habitus”, problematizzando la “pratica” di una etnografia multisituata
e processuale.
Bibliografia
− Clifford, 1999, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del XX secolo, Bollati Boringhieri,
Torino.
− Gupta A. and Ferguson J., 1997, Discipline and Practice: “The Field as Site, Method and
Location in Anthropology, in Gupta A. and Ferguson J. (1997), Anthropological
Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science, University of California Press,
London .
− Marcus, G.E., 1995, Ethnography in /of the World System: The Emergence of a Multisited Ethnography, in Annual Reviuw of Anthropology, 1995, 24: 95-117.
6
− Moore, S. F., 1997, Explaining the Present: Theoretical Dilemmas in Processual
Ethnography. American Ethnologist 14 (4): 727-736.
− Passaro J., 1997, “You Can’t Take the Subway to the Field!”: “Village” Epistemologies in
the Global Village, in Gupta A. and Ferguson J. (1997), Anthropological Locations.
Boundaries and Grounds of a Field Science, University of California Press, London
Il territorio in movimento e il “senso di possibilità”
Due note per la discussione su campo, spazio, territorio
Alex Koensler
1. “Tutto potrebbe essere anche diversamente”
“All fixed, fast-frozen relations are all swept away, all new formed ones become antiquared
before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy becomes profaned.”
K. Marx, F. Engels (citati in: Lash, Urry 1987:312)
Non soltanto queste righe di Marx e Engels, al tempo scritte pure senza “l’esperienza di
villaggio” (M. Squillaciotti) -vale a dire ricerca sul campo-, sembrano penetrate dalla profonda
consapevolezza della fluidità e dei mutamenti delle espressioni culturali, ma anche una buona
parte delle nostre riflessioni iniziate su “campo, territorio e sazio”. Se, attraverso una prospettiva
temporale, lo spazio può diventare “un fattore creativo della realtà sociale” -come scrive
Valentina- allora questa verità antropologica implica le infinite forme in cui le realtà sociali
possono essere costruite dagli attori. Michael Carrithers definisce in “Anthropology as a Moral
Science of Possibilities” (2005) “senso di possibilità” anche una delle caratteristiche centrali
dell’impresa antropologica, richiamando la storia dell’”Uomo senza qualità” di Robert Musil. Il
personaggio di questo libro, l’”uomo senza qualità” trascorre il tempo fantasticando su in che
modo diverso potrebbe anche essere la realtà. Il “senso di possibilità”, questo sapere scivoloso, è
caratterizzato dall’abilità di vedere le abitudini, i valori e le esperienze come attraverso una
“quarta dimensione” (ibid: 433) in cui svaniscono le certezze e le pretese. Esso si definisce in
contrapposizione ad un netto “senso di realtà”. Qui si mostra la vulnerabilità di tutte le regole
dell’impero del hic et nunc e quindi anche, per esempio, dei suoi confini territoriali. Per
Carrithers, la sensibilità derivata dal “senso di possibilità” comporta anche una responsabilità
morale: la necessità di interrogare le strategie persuasive attraverso cui si determina la realtà
sociale. In altre parole, “relativismo culturale” sì, ma “relativismo morale” no (ibid: 434).
Ora, vedere lo spazio -in cui si inserisce sia il “territorio” percepito sia il “campo” etnografico
costruito- attraverso questa “quarta dimensione” può offrire una prospettiva analitica di
particolare rilievo per l’antropologia del mondo postmoderno. Mi sento estremamente attratto
dalle prospettive svelate dal “senso di possibilità” e di seguito cercherò di spiegare il suo valore
analitico.
Lo spazio postmoderno, in cui si cristallizza oggi il campo etnografico, viene attraversato
dai processi di “deterritorializzazione” e “riterritorializzazione”, cioè dai processi di dislocazione
economica e culturale, da un lato, e le politiche di differenza, località e identità dall’altro. In
7
altre parole, lo spazio nell’era virtuale e postmoderna non sembra diventato inconsistente, esso
invece si presta come oggetto per politiche di territorio e identità in modi che “non
corrispondono all’esperienza dello spazio nella modernità”. (Gupta e Ferguson 1992: 8-12). Uno
spazio che subisce, quindi, al livello economico, una “compressione delle relazioni spaziotempo” prodotto dalla “specializzazione ed accumulazione flessibile” (Harvey 1989) delle forme
di lavoro postfordistiche e, al livello socio-culturale, attraversato da una “diffidenza verso le
grandi narrazioni” ideologiche (Lyotard).
Analizzando le forme frammentate e flessibili di produzione economica in relazione ai flussi
culturali, emerge uno scenario socio-politico che sembra caratterizzato, in modo particolare,
dalla trasgressione dei confini: tra rappresentazione e realtà, tra dentro e fuori, tra “est” e
“ovest”, tra “noi” e “gli altri”. Che significato assumono i legami con il territorio in cui la
iperrealtà invade la realtà, India invade Londra e Hollywood invade Calcutta e in cui il grano
per la pasta “italiana” viene prodotto per il 60% nell’Ucraina1? Quali nuovi sincretismi diasporici
e nuovi movimenti sociali nascono dietro gli sradicamenti e le alienazioni, spesso in modo
trasversale rispetto alle categorie moderne?
E’ questo il quadro, in cui concetti profondamente prospettici come “etnorami”, “mediorami” o
“tecnorami” (Appadurai 2001) assumono un senso cruciale per la comprensione dei flussi
culturali globali, cercando di liberare i “nativi” dall’”incarceramento spaziale” (ibid). In questa
sorta di spazio trasversale diventa forse più facile immaginare che “tutto potrebbe essere anche
diversamente”.
Di fronte a questa situazione, il “senso di possibilità” dell”uomo senza qualità” sembra
trovare in approcci antropologici contemporanei un’applicazione in almeno due modi diversi. In
primo luogo, il movimento della “critica culturale” (Marcus e Fischer 1986) cerca di basare una
critica implicita alla “nostra” società attraverso il confronto con un’”altra” società: attraverso un
dialogo tra due società si può mettere in discussione i propri schemi mentali. Altri definiscono
l’impegno dell’antropologia come mirato a “costruire un ponte concettuale con l’Altro”. Questa
prospettiva genera la sua forza dalla differenza tra “noi” e gli “altri”. Ma fino a che punto lo
spazio postmoderno deterritorializzato ha anche destabilizzato i punti fissi tra “noi” e “gli altri”?
Come si può problematizzare il rapporto tra territorio e differenza culturale? Quali confini
circonda l’indeterminatezza spaziale?
Un altro modo di intendere il “senso di possibilità”, euristicamente diversa, potrebbe essere
ritrovato nei tentativi di “denaturalizzare” categorie a noi familiari. Per quanto riguarda la
categoria dello spazio, Akhil Gupta e James Ferguson (1992) propongono di superare
l’assunzione di un sostanziale legame tra luogo e persone, sfidando “l’isomorfismo tra spazio e
differenza culturale” (ibid: 43). In questa ottica, ripensare le differenze culturali diventa
necessario perché
“(t)he presumption that spaces are autonomous has enabled the power of topography to conceal
the topography of power. (…) For if one begins with the premise that spaces have always been
hierarchically interconnected, instead of naturally disconnected, then cultural and social change
becomes not a matter of cultural contact, but one rethinking difference through
interconnections.”
(ibid: 67)
1
Internazionale 615/13, 4-10 novembre2005
8
L’enfasi in questo approccio insiste sulle pratiche e retoriche di divisione e mette a fuoco il
campo di forze delle relazioni di potere che mantiene e genera le stesse differenze culturali.
Cercando di superare una visione di “mosaico” delle comunità, esso presenta lo spazio non più
nei come un mappamondo tradizionale, ma come una zona continua, ma gerarchicamente
interconnessa.
In questa visione, il “senso di possibilità” offre la possibilità di politicizzare il sapere
antropologico sulle differenze culturali, mettendo in questione i presupposti che legano una
cultura ad un determinato territorio. Interrogare i meccanismi del sistema di dominio e di
divisione spaziale diventa un compito politico continuo: “Chi dispone del potere di trasformare
lo spazio in territorio? Chi lo contesta?” (ibid: 68)
Un orientamento teorico, che riprende questo approccio alle differenze culturali, nasce
soprattutto negli ambienti accademici europei a volte da una prospettiva costruttivista, a volte
dagli scritti di Foucault su potere e discorso, o dalla “teoria dei sistemi” di Luhman. In questa
ottica, differenze etnico-culturali assumono soltanto un valore nella descrizione
multiculturalista della realtà, ma non nelle esperienze quotidiane di migranti o classi sociali. La
differenza culturale viene rafforzato attraverso discorsi e pratiche dall’esterno, da istituzioni e
apparati burocratici che formano l’identità dei gruppi sociali (Wimmer 2004). Spesso
esattamente in questo modo si rafforzano i fenomeni di emarginazione.
Michel Foucault (1989: 238-240), disegnando una “nuova economia del potere”,
propone di mettere in luce le forme di resistenza dei soggetti alle differente forme di potere, di
rintracciare gli antagonismi, i rifiuti delle “pratiche di divisione” e le “lotte trasversali”. Mettere
in questione le relazioni di potere, in questo senso, non costituisce soltanto un compito
“inerente ad ogni esistenza sociale” (ibid 250) ma anche la possibilità di immaginare
un’alternativa. In altre parole, Foucault sembra difendere il “senso di possibilità” di Musil. Ma le
pratiche trasformative ed i rifiuti dell’esistente possono assumere una vasta gamma di forme
molto diverse tra loro. Come anche le tecnologie del controllo possono assumere forme molto
diverse, dalla coercizione diretta alla persuasione indiretta, così anche le forme di resistenza
possono esprimersi attraverso gesti impliciti e attraverso silenzi, ricordano Jean e John Comaroff
(2004). Il linguaggio della resistenza può essere condizionato dai meccanismi egemonici in cui si
inserisce. Ma le modalità di resistenza, protesta e rifiuto mirano a una vasta gamma di obiettivi,
che va dal sconvolgimento politico fino alla riproduzione e all’imitazione delle strategie di
dominio. Come diventa possibile cogliere gli obiettivi delle forme di rifiuto e di resistenza?
2. “Pratiche culturali non appartengono a persone specifiche”
L’abilità dei soggetti, dei movimenti e delle istituzioni di sfidare le divisioni spaziali
egemoniche emerge con particolare urgenza nelle “zone di frontiera” (Rabinowitz 1997), in
particolare i confini economici tra “nord” e “sud” che vengono sfidati dai movimenti
postcoloniali. Ma essa si esprime anche ai confini dell’Europa -per esempio nella fortezza
assalita di Mellilla- e nelle strategie con cui i migranti attraversano la recinzione tra gli Stati
Uniti e Messico. Una situazione di notevole carico simbolico si trova anche nella zona di
frontiera tra Israele e mondo arabo-palestinese. L’obiettivo del progetto su cui sto lavorando è
indirizzato a comprendere meglio i limiti e le possibilità delle pratiche trasformative sia delle
reti di attivismo transculturali sia delle pratiche quotidiane che cercano di mettere in
9
discussione i confini. In Israele e Palestina, i progetti di attivismo transculturale sono molto
diffusi e comprendono approcci e strategie molto diverse tra loro. Inoltre, dietro le barriere
egemoniche si genera uno “spazio postmoderno” in cui esiste una vivace realtà di soggetti e
gruppi che non corrispondono agli schemi e rappresentazioni ufficiali. Loro di solito non
appaiono nelle immagini che i media proiettano verso l’esterno.
I cittadini beduini nel Negev, una minoranza di arabo-palestinesi sul territorio ufficialmente
israeliano, fanno parte di questi gruppi. Alcuni di loro sono impegnati in forme di attivismo
transculturale, come ho potuto rendermi conto durante la ricerca sul campo per la tesi di laurea
(2004). Spesso le loro enclave non sono riconosciute né dalle autorità israeliane né dalle autorità
palestinesi, di conseguenza questi gruppi si trovano a volte sul “limbo”, ovvero nello “spazio
vuoto” tra i due mondi “ufficiali” ed egemonici.
Una ricerca al fine di individuare un “sapere di frontiera” potrebbe partire da una serie di
domande specifiche. Come possono rifiutare i “micro-progetti” di solidarietà transculturale le
“pratiche di divisione”? Quali nuovi significati sociali, cioè altre “possibilità, si generano in
opposizione al “senso comune” dei confini mentali, economici e geopolitici? Come penetrano le
culture marginali e ibridi nei centri del potere? E, sopratutto, fino a che grado si riflettano le
pretese e le certezze egemoniche nei saperi alternativi?
Per rispondere a questi interrogativi tali dinamiche dovranno essere considerate inserite in un
contesto in cui devono misurarsi con i riflessi sul territorio delle relazioni di potere, ovvero con
i processi di “territorializzazione”. Da un lato, al livello etnografico, bisognerebbe individuare
questi sperimentali sincretismi dell’attivismo che sembrano offrire una nuova alternativa, per
esempio all’interno delle, a volte vivaci, attività dei “Forum interculturali”, etc. Bisognerebbe
considerare le fratture di classe e genere all’interno dei gruppi come indicatori d’analisi.
Bisognerebbe comprendere i fattori materiali e simbolici che contribuiscono a costruire il senso
di appartenenza dei gruppi transculturali. Dall’altro, al livello teorico, bisognerebbe mettere a
fuoco i dibattiti che mettono in discussione i confini politici e mentali rigidi, tra cui per esempio
i cosiddetti “dibattiti postsionisti”, spesso poco conosciuti o sottovalutati all’esterno, che
mettono in discussione la storia ufficiale e l’identità nazionale in Israele (Silbersetin 1991).
Forse coltivare una sensibilità per le “possibilità” -nel senso di Musil- potrebbe diventare
cruciale per rintracciare le realtà trasversali nascoste dietro il mondo “ufficiale”. Forse i nuovi
“luoghi della cultura” (Bhabha 2001) confondono anche le linee tra “noi” e “gli altri”. In modo
particolare in Israele e Palestina, gli spazi fluidi in cui si generano le nuove identità sperimentali
ed “meticce” in incessante trasformazione, potranno forse dare un apporto alla ridefinizione
sociale, ovvero contribuire a “destrutturare la modernità occidentale”. In altre parole, il “senso
di possibilità” apre la prospettiva di partire dalla premessa che le pratiche culturali e sociali non
appartengono né a persone particolari né a territori specifici. In che modo si può discutere su
questa premessa?
Bibliografia
− Appadurai, A., 2001, La modernità in polvere. Roma, Meltemi
− Bhabha, H., 2001, I luoghi della cultura. (tr. it.) Roma, Meltemi
− Carrithers M., 2005, Anthropology as a Moral Science of Possibilities, in: Current
Anthropology 46/3: 433-456
10
− Comaroff J. & Comaroff J., 2004, “Criminal justice, cultural justice. The Limits of
Liberalism and the Pragmatics of Difference in the New South Africa”, in: American
Ethnologist, Vol. 31,2: 188-204
− Foucault M., 1982, "Il soggetto e il potere", in: Dreyfus, Hubert, Rabinow, Paul "La
ricerca di Michel Foucault", Ponte delle Grazie, Firenze
− Gupta A., Ferguson, 1992, “Beyond ‘Culture’: Sapce, Ientity and Politics of Difference”,
in: Cultural Anthropologist 7/1,
− Harvey, J., 1989, The Condition of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of
Cultural Change. Blackwall, Oxford,
− Lash S. & Urry J., 1987, “The End of Organized Capitalism” University of Wisconson
Press, Madison
− Rabinowitz D., 1997, “Overlooking Nazareth. The Ethnography of Exclusion in Galilee”.
Cambridge, Cambridge University Press
− Silberstein L. J., 1991, “The Postzionism Debates: Knowledge and Power in Israeli
Culture”, New York-London, Routledge
Riflessioni
Danila Cinellu
In procinto di continuare a dar forma alle idee, mi dovrei forse scusare se il modo in cui
sperimento l’ “incastonamento” del mio progetto all’interno del dibattito che verte sui temi
“campo”, “spazio” e “territorio” non ha ancora raggiunto una fase di fluidità. E spero che questa
mancanza di fluidità possa essere superata confrontando con altri il mio “campo”. Quel “campo”
cioè (che, a differenza del “vezzo disciplinare”, ingloba semanticamente anche la prospettiva del
mio lavoro) inteso come “spazio ordinato secondo proprie procedure teorico-metodologiche”,
come ha scritto Antonio. In realtà, non intendo soffermarmi su questa accezione del termine
“campo” (che mi pare calzare ai più svariati campi disciplinari), né tentare di fornirne altre dal
momento in cui ritengo sia assolutamente opportuna (e condivisibile da parte mia) la scelta di
molti di demarcare – laddove il “campo” è l’oggetto di discussione- una sfera semantica protetta
attorno alla pratica etnografica e le problematiche che essa comporta.
Pur lasciando a voi il “campo”, sento tuttavia la necessità di trattare a mio modo di una delle
tematiche da voi individuate: il potere. Penso sia un buon punto da cui partire per tentare di
approfondire la riflessione dello scorso intervento ed, allo stesso tempo, chiarire in quali termini
intenderei rapportarmi al tema della “regalità sacra” in una prospettiva transculturale;
prospettiva che, ai fini del nostro lavoro, adotto per esplicitare con quali spunti mi accosto ad un
certo materiale indianista (affinché io riesca a trovare punti di incontro con Valentina e Serena,
le quali ringrazio) e ad un certo materiale africanista. Per quanto riguarda quest’ultimo, esplicito
il mio interesse nei confronti del lavoro di Umberto Pellecchia, anche perché devo, in una certa
misura, alla lettura del suo intervento una motivazione ulteriore per affrontare il problema del
potere come motivo, per così dire, collante fra il concetto di spazio e quello di territorio…o
meglio, di “spazio sacro” e territorio.
11
Sempre cosciente di quanto più che i campi etnografici siano le impostazioni teoricometodologiche a distanziarci, mi avvio ad una “contestualizzazione”. Utilizzando il metodo
comparativo per far luce su quelli che potrebbero essere definiti come tratti distintivi di un
peculiare fenomeno quale quello che va sotto la categoria “regalità sacra”, parlo di “contesto”
parafrasando la definizione datane da uno fra i più importanti esponenti della rivisitazione
frazer-hocartiana. Seguendo l’indianista Jean-Claude Galey, tratto dunque il “contesto” come
una particolare associazione fra fatti ed interpretazioni correlate dalla cui combinazione si possa
stabilire un “modello unificante” capace di accomodare dati simili di provenienza eterogenea,
ognuno con la potenzialità di “shed some light on their respective blind spots” (Galey, 1990:
128).
Ora, ancorandomi ai presupposti “religiosi” del mio lavoro, chiarisco brevemente che la nozione
di potere che preferisco valorizzare nella discussione che verte sui temi “spazio” e “territorio” è
da intendersi come sinonimo di quella che Galey chiama lordship come contrapposta al
concetto di chiefdom. Non entrando nel merito delle modalità con cui le due realtà si
escludono, ma allo stesso tempo si articolano a vicenda nelle operazioni di legittimazione delle
relazioni di potere, nella manipolazione ideologica e nella definizione identitaria del “territorio”
del Garhwal studiato da Galey, è comunque di grande rilevanza, per me, che l’utilizzo del
termine lordship sia volto a mettere in luce la dipendenza dei network politici
dall’identificazione religiosa, dall’unità cultuale dunque (cfr. Galey, 1990: 163). Quello che più
mi interessa, in altre parole, è che la stessa definizione di lordship, come aspetto ontologico
della figura del re, sembra rinviare fortemente all’assunzione hocartiana secondo cui “The
temple and the palace are indistinguishable” (Quigley, 1993: 119). In questo frangente, lo
“spazio sacro” è quindi il palazzo reale-tempio. Parlando della valenza simbolica di questo
“spazio sacro” trova anche qui ragion d’essere l’idea di Cristina Bezzi di pensare lo spazio “come
rappresentazione microscopica del più ampio territorio”. Ai fini di un “modello unificante”, il
rapporto, per così dire, speculare fra “spazio sacro” e “territorio” potrebbe essere sintetizzato
omologando, a titolo illustrativo, la simbologia che caratterizza la regalità nepalese alla
dimensione semiotica messa in opera in peculiari momenti rituali come lo Yam Festival di cui ci
informa Umberto. In effetti, mentre leggevo un passo dell’articolo The Transgressive Nature of
Kingship in Caste Organization: Monstrous Royal Doubles in Nepal dove la Lecomte-Tilouine
ricorda che non soltanto dhungo (“pietra”) è la rappresentazione minimale della regalità Shah,
ma che lo stesso termine veniva utilizzato per designare l’intero regno, non ho potuto far a
meno di ripensare a quel seggio regale rappresentativo della comunità sefwi. Per farla breve, il
discorso retorico che mi si prospetta davanti è che il rapporto metonimico fra seggio e re, o fra
dhungo e re, (come entità rappresentative dello “spazio sacro”) coincide con quella che è la
portata sineddochica dello stesso “spazio sacro” in relazione all’intero “territorio”.
Mi preme precisare che l’interpretazione che adopero trattando di tale apparato retorico vuole
anche essere un preambolo rispetto alla linea di indagine che vorrei fare mia nel momento in
cui mi troverò ad argomentare in maniera più accurata e approfondita sulla nozione di potere
applicabile a quelle cosiddette “monarchie sacre” i cui tratti distintivi si stanno spiegando oggi –
per l’appunto, con un forte rinvio alle teorie frazeriane- in termini di “fenomeno di capro
espiatorio”. Si tratta di una linea di indagine che, in linea di massima, sacrifica l’attenzione che
potrebbe essere data al potere come forza strutturante ‘dall’alto’ e le relative sfaccettate
strategie, per concentrarsi piuttosto su quella regalità che, come scrive Declan Quigley,
12
“provides an indispensable mechanism for transcending political division” e che è “a shared
symbol of a sacred authority above politics or personal power” (Quigley, 2005: 1).
Detto questo, cercherò ora nel possibile di mettere in rilievo il filo di continuità che lega la
breve riflessione dello scorso intervento con l’attuale; di riflettere cioè su come la simbologia
denotante l’indivisibilità o, anche, l’uguaglianza fra “spazio sacro” come palazzo reale e
“territorio” regnato, assuma un carattere pragmatico nella pratica rituale, dal momento in cui le
dramatis personae in essa coinvolte rinviano, almeno a livello ideale, ad un preciso “territorio”.
Un caso emblematico a riguardo mi pare si possa riscontrare nella cerimonia di intronizzazione
del sovrano nepalese. La compartecipazione dei quattro varna nel quadro di questo “rito di
rinnovamento”, di creazione di questa figura extra-personale che è il re Shah, può forse essere
interpretata come una agengy sociale di tipo metetico. Questa in sé metterebbe in rilievo che
uno dei motivi-cardine dell’ideologia della “regalità sacra” è l’identificazione del “territorio” e
gli attori sociali da cui è vissuto con lo “spazio sacro”, dal momento in cui saranno gli stessi
attori (almeno per il tramite dei loro rappresentanti) ad essere i protagonisti di una renovatio il
cui interesse è evidentemente pubblico.
Mi rendo conto che con questa staticità di approccio, mi trovo nella situazione di proporre che
“a theory of interaction ritual is the key to microsociology, and microsociology is the key to
much that is larger” (Collins, 2004: 3). Eppure, riprendendo una riflessione scritta la scorsa
volta, il “dramma plastico” che si compie in uno “spazio” ben definito potrebbe -nel suo
“conservatism of stasis” (ibidem)- comunque essere uno still point a cui ricorrere per mettere in
luce da una parte i mutamenti già avvenuti e dall’altra i mutamenti che si sovrappongono a
quelli già trascorsi. In questo senso, oltre che apprezzare l’attenzione riservata da Oestigaard
(che si rifà a Hocart) alla morfologia dei ghats nel tentativo di ricreare una morfologia
territoriale assente perché mutata, cerco di accostarmi a mio modo alla linea che (se non ho
capito male) si sta privilegiando. Col presupposto che il nostro possa essere un lavoro fra
“sensibilità comunicanti” (come ha scritto il Prof. Solinas nella “Presentazione” degli interventi
dello scorso anno), mi viene da pensare che, in effetti, il rilevamento del change-in-the-making
sul “campo” e l’ancoraggio a tratti conservativi (che si accompagna alla ricerca disperata di
missing links) siano forse le due facce della stessa medaglia. La diagnosi dei sincretismi, e delle
de-territorializzazioni che vi stanno alla base, penso ci accomuni. Così come penso che
personalmente trarrò giovamento dall’ascoltare, in modo particolare, gli indianisti che lavorano
in luoghi di cui pian piano sto venendo a conoscenza…per confrontarci e per correggermi
laddove farò cattivo uso delle fonti bibliografiche a cui anche loro sono affezionati.
Dato che a causa della mia deformazione mi sento ancora in una fase di “lallazione” per quello
che riguarda il lessico propriamente antropologico, vi lascio con l’auspicio di poter ricavare dai
vostri interventi un modo “comodo” (e se a riguardo avete suggerimenti da darmi di persona, ve
ne sarò grata) per parlare, per esempio, di qualche contributo che un “diffusionismo” alla
Hocart può averci lasciato. Una disamina delle rivendicazioni del metodo archeologicoculturale potrebbe essere un modo per riflettere, anche se in maniera retrospettiva, sulle
potenzialità dell’analisi antropologica. Anche se a riguardo ancora non saprei ancora da dove
partire, mi sembra l’unico modo efficace per mettermi al passo con la prospettiva che si sta
tentando di mettere in opera e per non incorrere in ulteriori contorsionismi.
13
Bibliografia
− Collins, R., 2004, Interaction Ritual Chains, Princeton and Oxford, Princeton University
Press.
− Galey, J.C., 1990, Reconsidering Kingship in India: An Ethnological Perspective in J.C.
Galey (ed.) Kingship and the Kings, Harwood Academic Publishers: 123-187.
− Lecomte-Tilouine, M., 2005, The Transgressive Nature of Kingship in Caste
Organization: Monstrous Royal Doubles in Nepal in Declan Quigley (ed.), The Character
of Kingship, Oxford, Berg: 101-121.
− Quigley, D., 2005, Introduction: The Character of Kingship in Deglan Quigley (ed.) The
Character of Kingship: 1-23.
− Quigley, D., 1993, The Intrpretation of Caste, Oxford, Clarendon Press.
− Pellecchia, U., I “discorsi del passato”. Rito, potere e memoria tra i Sefwi del Ghana
Territorio, spazio e campo
Michela Badii
Territorio, spazio e campo sono categorie che da punti di vista diversi implicano il rapporto che
intercorre tra soggetti sociali, ricercatore e contesto d’indagine, quest’ultimo inteso come
contesto socio-economico, geografico e storico - culturale.
Alla luce del dibattito sulle trasformazioni dell’etnografia e, in particolar modo, quelle relative
all’”essere là” del ricercatore, è molto difficile, oggi, tratteggiare i confini delle nozioni di spazio,
campo, territorio, senza considerare la molteplicità dei punti di vista, tra loro opposti, che la
critica antropologica ha prodotto e tuttora produce, in merito alle ridefinizioni delle categorie
“classiche” delle discipline etnoantropologiche. Potrebbe essere questa una fase di assimilazione,
nei termini di un “nuovo” rapporto tra l’etnografo e l’oggetto di indagine. Infatti, leggendo i
contributi di antropologi contemporanei tra i quali - per citarne soltanto alcuni - Geertz,
Appadurai, Hannerz, Augé o Palumbo, si assiste alla formulazione o alla ridefinizione di certe
categorie come: “soggettività”, “interpretazione”, “etnorami”, “locale”, “globale”, “nonluoghi”,
“iperluoghi”, “rituali contemporanei”, che conferiscono nuove sfumature ai “tradizionali”
concetti di cui si sono avvalse fino a poco tempo fa le scienze sociali.
Questo “nuovo” lessico antropologico, si origina da un ripensamento del sistema teoricometodologio antecedente, a fronte di nuovi scapes, molto più fluidi e complessi, rispetto al
passato, che si manifestano anche in panorami analitici particolaristici, siano essi terreni europei
o “altri”. In questa “declinazione” del linguaggio antropologico, le posizioni assunte hanno
raggiunto il loro culmine nella messa in discussione della figura stessa dell’antropologo, quasi
fino a decretarne una crisi identitaria; non è possibile restituire oggettivamente un’esperienza
etnografica, per cui l’aspetto empirico dell’osservazione potrebbe non essere sufficiente a
garantire la comprensione dell’“oggetto”, giungendo persino a dubitare dell’autorevolezza
scientifica del dato etnografico. Questo dibattito ha costretto l’antropologo a “guardarsi allo
specchio”, ingenerando discussioni molto produttive e interessanti tra gli addetti ai lavori. Allo
stesso tempo, tuttavia, ha rischiato di trascinarlo in speculazioni epistemologiche sterili,
14
favorendo la nascita di un nuovo filone della letteratura antropologica che si potrebbe definire
“antropologo-centrica”: dove l’antropologo mette in dubbio la propria soggettività, in rapporto
all’interazione con l’oggetto e di conseguenza i propri strumenti d’analisi. Fortunatamente
leggendo i contributi etnografici ci si accorge che, nonostante la comparsa di nuovi orizzonti
metodologici, vecchie e nuove categorie coesistono: ad esempio, alla frammentazione di
significanti e significati, denunciata dalla corrente postmodernista, esistono delle scelte teoricometodologiche grazie alle quali è ancora possibile tracciare dei percorsi etnografici concreti.
I tre concetti spazio, campo, territorio allora, potrebbero risiedere nell’interstizio tra le
macrocategorie del globale e del locale, assumendo specifiche implicazioni in base all’oggetto di
ricerca. La globalizzazione è un concetto universalmente riconosciuto, poiché i suoi processi
dinamici e le reti di relazioni che ne fondano il concetto interessano ogni angolo del mondo,
contaminandosi in loco con le molteplici realtà; ed assumendo forme, tempi e spazi, in modalità
diverse, in base alle culture locali; la cultura intesa come storia, economia, ecologia, tecnologia
di un gruppo in un determinato territorio.
Il territorio, dunque, comprende sia un aspetto geografico sia uno simbolico; esso è uno spazio
soggettivo e soggettivizzato che rimanda a più livelli di significazione, che a loro volta ha
connessioni con la società: la concezione dello spazio, lo sfruttamento delle risorse,
l’etnoscienza. Il territorio, nella sua gestione e organizzazione, è l’espressione emica del
rapporto tra soggetti sociali, risorse e sviluppo tecnico-economico. Nel territorio l’antropologo
opera delle scelte di selezione in base all’oggetto di indagine; scelte che permettono di
individuare il fenomeno o il gruppo sociale, nonché i luoghi in cui si manifestano produzioni di
“senso” significative e pertinenti al proprio tema. Contemporaneamente, lo sguardo al territorio
nella sua interezza permette di comprendere i flussi culturali, le relazioni intersoggettive, gli
scambi, le produzioni culturali che distinguono un gruppo.
Lo spazio è il luogo per eccellenza dove si producono o ri-producono i tratti distintivi di una
società, come afferma Leroi-Gourhan: “Lo spazio è l’immagine umanizzata del territorio”.
L’addomesticazione dello spazio (e del tempo) ha fatto sì che nascesse uno spazio umanizzato, in
altre parole la creazione di un habitat (e di un habitus). Lo spazio diviene dunque spazio sociale:
rituale, privato, pubblico, che unitamente al tempo costituisce e fonda i ritmi di un gruppo.
Considerando i livelli sopra esposti, può essere utile comprendere come la distribuzione e
l’organizzazione degli spazi sociali contribuiscano alla comprensione dell’identità stessa del
gruppo: il concetto di persona, le rappresentazioni simboliche (identità, potere, conflitti,
divisioni di genere, luoghi della memoria, spazi abitativi, luoghi di socializzazione). Lo spazio
dunque è reale, nel suo aspetto geografico, tanto quanto è simbolico al momento della sua
“umanizzazione”.
Mi sembra, invece, che la categoria di campo rappresenti più uno spazio concettuale: un nonluogo, un “metaspazio”, in cui si sviluppano dinamiche di relazione dialogica tra i soggetti-attori
- e portatori - di una cultura, e il ricercatore che, a sua volta, oltre a porsi in relazione con la
comunità, può essere anch’esso parte della cultura che sta indagando. Con l’espressione campo si
sancisce l’inizio della fase di osservazione dell’oggetto, e del rapporto tra etnografo e oggetto; in
questo senso dunque non esistono spazi “neutrali”, a meno che non si consideri come spazio
“simbolico” quello del diario di campo, che rimane una zona franca, senza implicazioni
intersoggettive, che si presta a contenitore di reazioni emotive e impressioni personali.
Soprattutto vi si riportano, ricordo i diari di Malinowski, situazioni di conflitto che restano
irrisolte dentro di noi o nel rapporto con “l’altro”. Ma chi non ha provato nel suo percorso,
15
breve o lungo, di antropologo o aspirante tale, un senso di rifiuto, paura, ingestibilità dei
sentimenti davanti “all’altro”. L’inserimento all’interno di un gruppo è già, per i soggetti che vi
partecipano, una prova del coinvolgimento dell’antropologo. L’esplicitazione della “presenza” è,
in alcuni casi, una fase molto difficile della ricerca etnografica, poiché costituisce il momento
della messa in scena del sé, dell’io del ricercatore, portatore di conoscenza e rappresentazioni;
ma anche un momento in cui si negoziano identità e saperi tra le due parti. Da parte dei soggetti
sociali “osservati” c’è spesso una tendenza a salvaguardarsi da eventuali rischi o effetti
indesiderati causati dall’estraneo, nel caso in cui l’antropologo assuma posizioni incontrollabili
da parte dei centri di autorità e potere.
L’etnografo che si confronta con dei terreni più “familiari” o vicini affronta in ogni caso delle
problematiche trasversali a tutta l’etnografia”. Forse può apparire un vantaggio la conoscenza
della lingua, la delimitazione del territorio e dei suoi spazi, la conoscenza dei tratti culturali
(regole prossemiche, codice dell’ironia, interdizioni, tabu, parentela, forme di vita,
organizzazione politica), la comprensione del senso comune; tuttavia questi vantaggi possono
produrre anche delle controindicazioni, fino a condizionare inconsciamente gli approcci
analitici e interpretativi del ricercatore.
Infatti, per quanto riguarda la mia indagine sul campo, non è stato molto semplice gestire
rapporti con le autorità e con i soggetti sociali, senza incorrere nel “rischio” di essere a mia volta
“oggetto di interesse”. Nel corso dell’esperienza etnografica ho constatato una certa difficoltà nel
percepire e comprendere la figura dell’”antropologo”. La mia indagine - “Spazi e tempi
tradizionali del cibo nella contemporaneità. Processi di patrimonializzazione nel Valdarno
aretino” – si sta concentrando particolarmente sulle dinamiche che si instaurano tra pratiche del
cibo, attori sociali, istituzioni, saperi e reti di relazioni, attraverso cui si riproduce e si ripropone
il passato nella dimensione locale. Sono le retoriche sul cibo, in particolare, che mettono in luce
le politiche e le strategie identitarie. Soprattutto l’autorità tende ad escludere l’interesse critico
del ricercatore davanti al fenomeno che dichiara di osservare. In perfetto passo con i tempi, si
crede che il presunto oggetto di interesse dell’antropologo risponda in qualche modo ad una
passione, ad un desiderio di promozione e “tutela” del fenomeno del “tradizionale”, che spesso
coincide con il “pluriconnotato” e abusato termine di “prodotto tipico”. A questo livello
subentra una richiesta implicita di aiuto reciproco, in cui le due parti si scambiano informazioni
vicendevolmente; con la differenza che le figure sociali appartenenti ad enti pubblici, nella
figura di autorità o semplici funzionari, tendono a carpire informazioni utili per acquisire una
maggiore competenza sul loro operato e sulle scelte future, e si trovano contemporaneamente
spiazzati dalla banalità, talvolta, delle domande che si pongono loro: ad esempio legami
familiari, rapporti di scambio, composizione delle famiglie, o delle aziende, articolazione dei
pasti, preferenze, gusti etc.. Lo stupore, forse, è dettato dall’idea che il sapere scientifico si
occupi di problemi più elevati rispetto alle questioni private familiari o, come nel caso specifico,
dei soggetti implicati nella catena di produzione o promozione delle filiere dei prodotti. Nozioni
come antropologia, sociologia sembrano approcci analitici poco fruibili rispetto alla storia, che
sembra l’unica prospettiva scientifica conosciuta ed accettata. Non a caso, i soggetti più “colti”
ritengono la conoscenza della storia locale l’unico vantaggio possibile nella costruzione
dell’identità del territorio. Ma, allo stesso tempo, percepiscono il mio interesse come una forma
di sapere su cui investire, in un processo di negoziazione continuo, conferendomi l’accesso a
riunioni o ad associazioni, in cambio di una mia partecipazione “attiva”. Come ha detto un’
autorità pubblica: “Adesso dobbiamo valorizzarti, sei un patrimonio anche tu…”
16
In questo senso le nozioni di spazio, campo, territorio, per quanto riguarda questa indagine, mi
hanno condotto a fronteggiare attivamente non solo il campo inteso come spazio di rapporti
intersoggettivi e dialogici tra ricercatore e comunità, ma anche le relazioni spazio-temporali in
senso diacronico, i processi di trasformazione, il rapporto natura-cultura, la microstoria
l’economia (tempi e luoghi di scambio, trasmissione del sapere), la tecnologia, la memoria e il
senso comune.
Mi sono chiesta se le scelte di selezionare e privilegiare determinati spazi all’interno del
territorio fossero dettate dalla vivacità di certe politiche: sedimentazioni di potere e fenomeni
particolarmente significativi per l’oggetto indagato, che si riproducono in determinati luoghi
piuttosto che in altri. Sicuramente non è molto semplice, oggi, rintracciare gli spazi
“tradizionali” di quella che forse impropriamente si definisce ancora “cultura popolare”. Infatti,
dalla timida subalternità delle mezzadre che ho intervistato per la tesi di laurea, mi sono
imbattuta in una nuova generazione di “contadini” che tra una semina e una raccolta trovano il
tempo per fare un salto a Londra, ad una fiera enogastronomia internazionale per promuovere il
proprio prodotto, alcuni parlano inglese; altri partecipano a trasmissioni per la promozione dei
prodotti del territorio, tengono corsi presso le scuole e poi balzano di comune in comune e di
provincia in regione partecipando a riunioni con le autorità locali; spesso è la moglie che
gestisce attivamente l’azienda agricola, mentre al caldo di un caminetto ristrutturato si tessono
relazioni sociali con chissà quale personaggio dello spettacolo eletto ad icona del “loro”
territorio. Davanti a tutto ciò è chiaro che l’oggetto si complica, ma, soprattutto, l’oggetto
richiede la considerazione di più categorie analitiche. Per questo, nel caso specifico, ho optato
per un’analisi delle trasformazioni e del mutamento degli spazi e dei tempi del cibo tradizionale
nella contemporaneità mantenendo come termine di raffronto – ma anche di continuità
aggiungerei - le pratiche alimentari mezzadrili dagli anni Trenta fino al loro declino negli
Settanta. Analizzare gli spazi e i tempi del cibo tradizionale nella contemporaneità potrebbero
far credere possibile un legame di continuità con i mezzadri, che sono il passato prossimo di
queste nuove figure e forme di “vita contadina” che oggi mi trovo ad osservare. Ma rispetto ad
un tema come la mezzadria - un oggetto frequentato da tutte le scienze umane, da vari punti di
vista teorico-metodologici - mi trovo adesso a impiegare categorie metodologiche
completamente diverse e ulteriormente complesse, rispetto agli strumenti “classici” di approccio
al folklore. Nonostante si tratti di una o due generazioni successive a quella dei mezzadri - figli e
nipoti - l’oggetto chiama comunque in causa molteplici livelli apparentemente lontani, che
risiedono nell’interstizio teorico, oramai quasi universalmente accettato, del locale e globale.
Quello che suscita maggior curiosità e motivo di riflessione è vedere come certe categorie, che
hanno goduto di stabilità nel tempo hanno subito o stanno subendo profondi mutamenti (in
questo caso particolare penso a quella di folklore) Da qui forse nasce l’interesse ai “processi”,
dove è il sostantivo, piuttosto che gli aggettivi che lo seguono, a sottolineare una tendenza
“generale”, che va oltre i territori singoli di indagine. Dunque, “flusso”, “rete”, “relazioni” sono i
comuni denominatori dei nostri “campi”…? Forse si. Se penso alle politiche messe in atto da
Slow Food, nel creare una rete globale con il nome di “Comunità del cibo”, in cui
ricomprendere tutti i particolarismi delle produzioni “difese” dall’associazione: un modo di
creare connessioni tra gli agricoltori e i contadini di tutto il mondo, mantenendo i tratti
distintivi delle varie produzioni; penso anche alla diffusione sovranazionale dei prodotti,
attraverso la soluzione politico-retorica dei Presidi, oppure i cosiddetti “gemellaggi” tra prodotti
di diverse culture.
17
Reti, processi, relazioni potrebbero dunque essere questi i comuni denominatori delle nostre
esperienze etnografiche; con la consapevolezza, tuttavia, della diversità delle risposte che, nel
tempo e negli spazi eterogenei, si hanno rispetto a certi fenomeni e all’importanza che questi
ultimi assumono all’interno di ciascun contesto.
Bibliografia
− Augè, M., 1992, Non luoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità,
Elèuthera, Milano, 1993
− Augè, M., 1994, Storie del presente. Per un’antropologia dei mondi contemporanei,
Milano, Il Saggiatore, 1997
− Bourdieu, P., 1979, La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983
− Bourdieu, P., 1972, Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila, Milano,
Raffaello Cortina, 2003
− De Certeau, M., 1994, L’invention du quotidien, Paris, Gallimard
− Fabre, D. (a cura di), 1996, L’Europe entre cultures et nations, Paris, Editions MSH
− Hannerz, U., 2001, La diversità culturale, Il Mulino, Bologna
− Kilani, M., 1994, L’invenzione dell’altro. Saggi sul discorso antropologico, Bari, Dedalo,
1997
− Leroi- Gourhan, L., 1965, Il gesto e la parola, 2 voll., Torino, Einaudi, 1977
− Palumbo, B., 2003, L’Unesco e il campanile. Antropologia politica e beni culturali in
Sicilia orientale, Roma, Meltemi
− Segalen, M., 1998, Riti e rituali contemporanei, Bologna, Il Mulino, 2002
− Geertz, C., 1973, Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 1988
Riflessione sui concetti di “spazio”, “territorio” e “campo”
Signe Stroem
Appadurai descrive nel suo libro Modernity at Large (1996) i molteplici flussi globali, descritti
con i termini di “etnorami”, “mediorami”, “tecnorami”, “ideorami”, che ormai hanno messo in
crisi l’immagine del mondo come diviso in singole culture, come unità chiuse, ancorate in
territori circoscritti. Nel contesto della mia ricerca questi flussi sono molto visibili e mettono in
evidenza l’importanza di non considerare più la ricerca etnografica come situata in una singola
località, ma studiare anche le connessioni tra molti luoghi e fenomeni attraverso i flussi di
persone, metafore ed altri processi transnazionali come suggerito da Marcus (1995).
Pur riconoscendo il rischio di entrare troppo nei dettagli della mia ricerca (“turismo e
condizione femminile in Talek Community, Maasailand”) e della mia esperienza sul campo,
vorrei in queste pagine discutere la deterritorializzazione, riterritorializzazione e i flussi globali
partendo da un contesto concreto. In particolare vorrei illustrare come il territorio è costruito,
come osservato tra altri da Gupta e Ferguson, (1997), storicamente, politicamente e in base a
rapporti di potere; e come la concezione di questo, e i valori con cui viene rivestito, cambiano
18
con l’andamento dei movimenti ideologici a livello internazionale. Quindi vorrei sottolineare
l’importanza di un approccio interdisciplinare nella ricerca antropologica, che prende in
considerazione studi compiuti negli ambiti della storia, dell’ecologia e di altri settori. In
particolare ritengo opportuno considerare il campo dei media studies, in quanto l’idea che molte
persone hanno del mondo “is shaped by books, postcards (…) evening news”, come ha detto
Appadurai (1986).
Il nome inglese del territorio dove si svolge la mia ricerca, Maasailand, riflette l’idea
dell’isomorfismo tra cultura e territorio (Gupta e Ferguson, 1992), ormai superata in
antropologia, ma che esiste ancora come luogo comune. I confini del Maasailand sono un
risultato di eventi storici e dinamiche politiche più che un dato naturale: con la colonizzazione
europea, la territorializzazione della “cultura masai” fu rafforzata e inoltre la popolazione fu
divisa dalla frontiera degli stati che attualmente si chiamano Kenya e Tanzania. In Kenya, le
aree in cui vivevano i pastori masai erano considerate importanti per l’agricoltura e vaste
porzioni di terreno furono trasformate in aziende agricole. In aggiunta a ciò, la popolazione fu
controllata e portata a vivere in riserve chiuse in base all’ ”origine etnica” e i loro spostamenti e
contatti con gli altri gruppi della popolazione furono controllati; al contrario i masai, che
percepivano, diversamente dai colonizzatori, la loro identità come fluida, avevano sempre
avuto rapporti e scambi di beni di consumo e matrimoniali con altri gruppi e godevano di una
grande mobilità geografica.
Attualmente i rapporti tra i pastori e gli altri gruppi della popolazione sono conflittuali in primo
luogo per la scarsità di terra, che rappresenta un problema molto sentito in Kenya. I Masai sono
conosciuti come poco disposti a cambiare e tradizionalisti; ad esempio non emigrano nelle città
nella stessa proporzione di altri kenioti, che si spostano ed immigrano anche nelle aree di
popolazione masai. Percio’ si è creato un clima di tensione in cui i pastori ritengono che il loro
territorio, adibito a pascolo, si sia ridotto con l’arrivo degli agricoltori. Inoltre, i Masai
rivendicano il diritto di un vasto territorio ora a disposizione di proprietari di grandi aziende
agricole, che fu “affittato” per 99 anni agli Inglesi, tramite un contratto con un leader locale.
Allo scadere del contratto nell’ agosto 2004, il governo ha dichiarato che i grandi proprietari
non devono lasciare la loro terra; il contratto durerà ancora 900 anni!
Dagli anni ‘70 il turismo ha avuto un’importanza crescente per il paese e si è deciso, a livello
politico, di seguire l’ideologia ambientalista, importante per i buoni rapporti con l’Europa e con
gli USA: perciò, si è deciso di trasformare territori prima destinati al pascolo in riserve naturali e
così impedire l’accesso a risorse naturali importanti per i locali. Una delle motivazioni per
questa esclusione è stata probabilmente che i turisti non vorrebbero vedere mucche sulla
savana. Questa politica viene giustificata come finalizzata alla protezione della biodiversità
utilizzando concetti tramandati dal periodo coloniale come “over-stocking”, “over-grazing” e si
considerano i modi di usufrutto locali come irrazionali, in quanto la combinazione fra proprietà
privata del bestiame e accesso comune a risorse come pascoli e acqua porterebbe
necessariamente ad uno sfruttamento ecologicamente insostenibile di queste risorse. Al
contrario degli ambientalisti, che ritengono che i Masai abbiano troppi capi di bestiame e che le
loro pratiche pastorali danneggino l’ambiente, molti autori sostengono che attualmente la
pastorizia tradizionale sia la forma di sfruttamento delle risorse naturali migliore per le zone
aride e semi-aride del Maasailand (Kimani e Pickard, 1998).
19
Questi concetti riguardanti l’irrazionalità del sistema di pastorizia locale vengono utilizzati
anche come argomento per sostenere la politica governativa della privatizzazione della proprietà
terriera attualmente in atto nel Maasailand keniota, che mette ancora più in crisi la sussistenza
della popolazione.
In questo contesto il turismo sta assumendo sempre più importanza da un punto di vista
economico per gli abitanti delle aree masai, in particolare per le comunità adiacenti ai parchi
naturali. Come osservato da Appadurai (1997:5) i flussi globali hanno fortemente condizionato
l’immaginario che ora non e’ piu’ un fenomeno circoscritto all’arte, alla mitologia e alla
ritualita’, ma e’ diventato “a part of the quotidian mental work of ordinary people in many
countries” importante per la maggior parte della popolazione mondiale; le persone viaggiano
come anche le immagini, e in questo contesto specifico i turisti, prevalentemente europei ed
americani, vengono a vedere gli animali e conoscere “la cultura masai”, famosa in tutto il mondo
attraverso i media. Nelle rappresentazioni che vengono proposte dai mezzi di comunicazione, il
legame tra i Masai e il loro territorio viene descritto come naturale, e questo è, secondo
Appadurai (1988:37) una caratteristica delle raffigurazioni delle popolazioni indigene, intese
come quelle residenti in aree del mondo non ancora industrializzate. Infatti, l’autore osserva
come i nativi vengono visti come “incarcerated”, “confined” nei luoghi, ossia come
immobilizzati dalla loro appartenenza al territorio, che allo stesso tempo limita le loro
possibilità di azione e intervento su questo. Gupta e Ferguson (1997:7) osservano come, in
antropologia, si tende a creare una dicotomia tra “the local” caratterizzato come autentico,
naturale e originario e “the global” che viene descritto in termini opposti. Secondo me questa
dicotomia è presente in grande misura nelle società europee in generale e, anche se viene
estrinsecata soltanto di rado esplicitamente, fa però parte dell’immaginario e la “nostalgia del
rurale” (ibid) spinge molti turisti ad andare in posti come il Maasailand.
Risulta palese da questi accenni la mia ricerca riguarda anche processi politici, storici, ideologici
e relazioni di potere che si realizzano a livello nazionale e globale. Come suggerito da Gupta e
Ferguson (1997:35) viviamo in un “interconnected world” e parlando del “campo” della ricerca
antropologica si può mettere in dubbio se l’antropologo esce mai da questo; il campo inteso
come “the where” (ibid:2) dell’indagine etnografica risulta molto più complicato e differenziato
di quanto spesso si crede. I vari luoghi del mondo sono ovviamente connessi in vari modi e in
vari gradi: i flussi globali investono Talek Community ad una scala molto piu’ ridotta rispetto ai
paesini dell´Italia, però l’interconnessione c´è, e questa influisce sulla mia ricerca. Si può dire
che una parte consistente del “mio campo” sono le relazioni interpersonali stabilite a Talek, cioè
i “travel encounters” come suggerito da Clifford (1997:1998), che continuano a svilupparsi,
tramite le reti di comunicazione (internet, telefono, posta) nonostante i miei spostamenti
geografici. Inoltre, i flussi di immagini e di informazioni dei mass-media creano una continuità
del campo anche attraverso i confini nazionali: guardando ed analizzando trasmissioni televisive
come la Talpa, Geo-geo, leggendo giornali e riviste che parlano dei Masai e dei loro conflitti per
il diritto al territorio etc, mi sento ancora “sul campo”, che risulta così, più che una località
geografica, un insieme di scambi interpersonali e mediatici.
20
Bibliografia
− Appadurai, A., 1988, Place and Voice in Anthropological Theory, in Cultural
Anthropology Vol. 3, No. 1, 36-49
− Appadurai, A., 1997, Modernity at Large. Minneapolis: University of Minnesota Press
− Clifford, J., 1997, Spatial Practices: Fieldwork, travel, and the Disciplining of
Anthropology, in Gupta, A. & Ferguson, J. eds. Anthropological Locations: boundaries
and grounds of a field science. London: University of California Press
− Gupta, A. & Ferguson, J., 1992, Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of
Difference, in Cultural Anthropology, Vol. 7, No. 1, 6-23
− Gupta, A. & Ferguson, J., 1997, Discipline and Practice: “The Field” as Site, Method, and
Location in Anthropology, in Gupta, A. & Ferguson, J. eds. Anthropological Locations:
boundaries and grounds of a field science. London: University of California Press
− Kimani, K. & Pickard, J., 1998, Recent trends and implications of group ranch subdivision and fragmentation in Kajiado District, Kenya. The Geographical Journal 164 (2),
July: 202-213.
− Marcus, E. G., 1995, Ethnography in/of the World System: The Emergence of MultiSited Ethnography, Annual Review of Anthropology, Vol.24, 95-117
Un viaggio multivocale attraverso la polifonia dello spazio e del territorio
nell’antropologia contemporanea
Daniela Valentina Fiegna
La dimensione spaziale delle pratiche e delle credenze culturali ha occupato, da sempre, un
posto centrale negli interessi degli antropologi: dalle più classiche descrizioni del paesaggio
naturale e delle condizioni di vita all’interno di determinati luoghi, alla più recente presa di
coscienza del fatto che lo spazio è un componente essenziale e fluido di ogni rappresentazione
socioculturale.
I territori non sono contenitori inerti e immobili, pure ambientazioni per le azioni, scene in cui
accadono le cose: sono paesaggi mutevoli, carichi di significati politici, storici, economici,
sociali, religiosi. All’interno del dibattito più recente Appadurai (1988) definisce il problema del
territorio come «the problem of the culturally defined locations to whitch ethnographies refer ».
Critica il fatto che alcuni luoghi siano diventati metonimie per certe idee e immagini
antropologiche -ad esempio l’India per il concetto di gerarchia - suggerendo che la polifonia
che è stata riconosciuta all’atto comunicativo andrebbe applicata anche allo spazio: i luoghi
come concetto antropologico sono una voce complessa, locale e multipla.
I territori e le voci non sono una semplice creazione accademica. Le realtà fisiche, emozionali,
di esperienze che si incontrano in paesaggi lontani andrebbero comprese e vissute non come
semplice scenario per una ricerca etnografica. Come suggerisce Margaret Rodman (1992),
«while anthropologist indeed create places in ethnography, they hold no patent on placemaking».
21
In questo breve contributo vorrei affiancarmi agli autori che hanno trattato la tematica dello
spazio e del territorio in maniera critica, non potendo prescindere dal considerare anche alcune
dimensioni ad essa connesse, come la corporeità, la temporalità e le relazioni di potere.
Come può dunque, uno studio antropologico sul territorio, relazionarsi in maniera non
unilaterale, statica e scontata con le esperienze di vita che si creano, svaniscono e s’intrecciano
in quel luogo particolare? Mi appoggio a Nancy Munn (1990) nel suggerire una possibile
risposta: esplorando l’idea di una multilocalità «as one way of constructing regional worlds in
experience». I luoghi non sono dati, ma vissuti in forme discrete e in continuo movimento,
quindi creati, nella pratica della vita di tutti i giorni. Lo spazio occupato dal corpo - e la
percezione e l’esperienza di questo spazio - si contrae e si espande in stretta relazione con le
emozioni, lo stato della mente, la coscienza di sé, le relazioni sociali e le predisposizioni
culturali. I movimenti e le attività fisiche creano e sono create dallo spazio del loro
concretizzarsi, in questo modo il corpo è continuamente investito da significati culturali spaziali
e lo spazio da significati corporei.
Già Marcel Mauss (1950) ragionava sul fatto che le abitudini acquisite dal proprio contesto
sociale e le caratteristiche somatiche, che lui chiamava «tecniche del corpo», includono tutte le
“arti culturali”, atte a usare il corpo ed essere nel corpo e nel mondo.
Pierre Bourdieu usa il termine habitus per esprimere il modo in cui, attraverso i corpi, gli esseri
umani interiorizzano tratti culturali e appartenenza a strutture sociali, riproducendoli per
adattamenti successivi all’ambiente circostante. L’habitus si costituisce attraverso le pratiche
della vita di tutti i giorni ed è sempre esposto alla possibilità di ricevere sanzioni negative,
quando l’ambiente in cui si confronta realmente è troppo distante da quello per cui sarebbe
adatto. La pratica è il prodotto della relazione dialettica tra una situazione e un habitus,
«funziona in ogni momento come matrice delle percezioni, delle valutazioni e delle azioni e
rende possibile il compimento di compiti indifferentemente differenziati, grazie al trasferimento
analogico di schemi che permettono di risolvere i problemi aventi la stessa forma e grazie alle
correzioni incessanti dei risultati ottenuti […]» (Bourdieu, 2003: 211). Anche per Nancy Munn
questo adattamento si costruisce attraverso l’esperienza pratica che si ha di quello che ci accade,
collegandolo con le possibilità passate e quelle future. Le relazioni che si creano tra spazi vissuti
avvengono attraverso l’esserci del corpo in un territorio e la facoltà di evocazione, attraverso la
memoria corporea, di altri avvenimenti e di altri luoghi, rendendo possibili attraverso i ricordi,
le valutazioni per il futuro.
Rabinow (1988: 356) elabora l’idea di horizons per spiegare il linguaggio di relazioni attraverso
cui le persone creano il mondo così come lo conoscono, affermando che ogni mondo possibile
appare solo esaminando le frontiere del presente, che funzionano come limite a quello che
sappiamo, speriamo, facciamo. Questi mondi costituiscono i confini della nostra esperienza. Per
questa ragione i luoghi dove gli esseri umani imparano a conoscere la loro cultura sono la
«scuola del mondo», in cui l’universale e il particolare, il passato e il futuro, sono congiunti in
un’unica relazione che si manifesta nel presente. Come fare per dare voce a tutte queste “scuole
del mondo”, senza farle diventare dominio dell’occidente attraverso le nostre parole?
Secondo Edward Said l’unico modo che abbiamo di comprendere il mondo attraverso il filtro
della nostra cultura è quello di riconoscere il contesto imperialista che gli ha dato forma e che
continua a formarla. In questo modo di vedere, per esempio, i caratteri dell’India che per noi
sono più rilevanti - come le come le caste, la spiritualità, la trasmigrazione, il karma - sono
frutto di una retorica occidentale che si guarda allo specchio e usa catalogare e classificare il
22
diverso per riaffermare la propria identità e il proprio dominio. George Marcus (1989: 25)
propone una strada per andare oltre questo problema suggerendo che ogni attività o identità
culturale è costruita da una moltitudine di agenti, in vari contesti o luoghi. L’etnografia che ne
consegue dovrebbe essere concepita strategicamente, per rappresentare questa molteplicità,
dando valore sia ai risultati desiderati corrispondenti alle nostre aspettative sia a quelli
inaspettati: «an ethnography that while it encompasses local conditions, is aimed at
representing system or pieces of system». Tuttavia Marcus non ci fornisce una spiegazione per
quello che intende come sistema… Giddens (1979 e 1990), attraverso il concetto di “locale” ci
fornisce un possibile aiuto per trovare un legame tra l’individuo e quello Marcus potrebbe voler
intendere: «the physical setting of social activity as situated geographically» (Giddens 1990: 18).
Giddens va oltre, suggerendo che lo svuotamento del concetto di tempo, caratteristico dei nostri
giorni, ci porta a un contemporanea astrazione nel considerare lo spazio, separandolo dal
territorio. Nelle società “tradizionali” le attività umane caratteristiche di un territorio davano
forma allo spazio. Con l’allentarsi e il distanziarsi dei legami umani, nel mondo di oggi,
assistiamo a una rivoluzione che crea nuove aree spaziali e confini temporali (basti solo pensare
alle cosiddette realtà virtuali). Quello che bisogna esplorare, attraverso analisi decentrate,
diviene la multilocalità degli spazi, che per Giddens sono luoghi fantasmagorici in cui
l’esperienza dell’esserci si confronta continuamente con il cambiamento e la processualità del
reale, dando vita a una complessa successione di immagini. Seguendo le orme di Giddens e
Marcus, Margaret Rodman ci invita a pensare sul fatto che il concetto multilocalità è esso stesso
multiplo e quindi a esplorarlo seguendo varie direzioni: attraverso analisi decentrate che ci
diano modo di dar voce sia alle rappresentazioni occidentali che a quelle non occidentali;
combinando analisi comparative e etnologie contemporanee; cercando un rapporto riflessivo
con i luoghi e valutando le distorsioni che possono nascere dal confronto tra il familiare e il non
familiare; e infine considerando che ogni territorio esprime significati polisemici per ogni
differente attore che vi si trova. Come suggerisce Fabian (1990), per raggiungere un’etnografia
efficace bisognerebbe pensarla come una pratica per farci sentire “gli altri” come presenti,
invece di creare rappresentazioni che ci fanno percepire, degli altri, solo l’assenza. La
multilocalità ci aiuta così a guardare il mondo attraverso il confronto di esperienze e racconti di
vita che accadono in territori diversi e più o meno distanti, per poi riconoscere, in fin dei conti,
che facciamo tutti parte dello stesso pianeta.
Note per un territorio ai confini dell’India: spazi esclusi nella valle di Malana.
Malana è un villaggio sperduto sull’ Himalaya indiano, a nord-ovest della valle di Kullu, nello
stato dell’Himachal Pradesh. E’ un luogo solitario, isolato dal resto dell’India e del mondo. La
gestione della vita sociale all’interno del paese è democratica (Sharma P., Chauhan N. S., Lal B.,
2004) e c’è chi dice che gli abitanti siano di origine greca, disertori dell’esercito di Alessandro il
Macedone che si sono sposati con donne locali. I malani sono intoccabili, non nel senso classico,
che li rappresenta come ultimo gradino della scala sociale. Non possono essere toccati perché il
loro potente dio Jamlu, che guarda tutto dall’alto come un enorme occhio invisibile, non lo
permette. Non possono mangiare alcun cibo se non quello cucinato all’interno delle loro
abitazioni, trovandosi spesso nella condizione di offrire senza poter ricevere da nessuno. Anche
le loro case non possono essere toccate dagli stranieri, compresi gli indiani di altri paesi e chi vi
trasgredisce deve essere giudicato al cospetto della defta, il consiglio degli anziani, attraverso cui
23
parla Jamlu stesso. Quando si va a fare la spesa nei piccoli negozi del villaggio, la mercanzia
acquistata non viene mai passata di mano in mano, ma posta per terra, per poi essere raccolta
dall’acquirente. In fondo, i veri intoccabili sono i forestieri…
I Malani parlano una propria lingua, completamente diversa dall’Hindi e dagli altri dialetti
locali. Raccontano che nella notte dei tempi, quando Jamlu era ancora un rishi2, decise, dopo
aver patteggiato con suo fratello, di occupare la parte alta della vallata dove oggi è il paese.
Questa landa era occupata da un rakshasa3 che sbranava tutte le persone che provavano ad
avvicinarsi al suo territorio. Quando Jamlu arrivò al suo cospetto, gli disse che avrebbe sbranato
anche lui… Il demone iniziò a tagliare tutti gli alberi della valle per fare un grande fuoco, poi
prese una pentola enorme e iniziò a cuocere Jamlu. Passarono mille anni: il fuoco continuava a
bruciare e il rakshasa continuava a tagliare alberi e ogni tanto alzava il coperchio per vedere se
Jamlu era pronto… Poi ne passarono altri mille e quando il demone vide che Jamlu era ancora
vivo si arrese, dicendogli che era troppo potente per lui e che non poteva mangiarlo, poiché non
riusciva a cuocerlo. Gli propose di provare lui a bruciarlo e, nel caso ci fosse riuscito, gli promise
di andarsene. Allora Jamlu fece un fuoco piccolissimo con pochi bastoncini di legno e alcune
pagliuzze e disse al demone di metterci sopra soltanto il mignolo del suo piede. Immediatamente
il rakshasa si bruciò e accettò di andarsene a dormire in cima alla montagna, dall’altra parte del
fiume Parvati che scorre a fondo valle, a patto che tutti i discendenti di Jamlu avessero parlato la
sua lingua.
Il modo in cui gli abitanti di Malana considerano il territorio nella vita di tutti i giorni è
strettamente connesso con il potere di Jamlu e con questa divisione ancestrale, creando delle
interdizioni a muoversi in alcune aree, in alcuni momenti, in parte uguali per tutti, in parte
differenziate. Oltre alle proibizioni che derivano dal credere che lo spazio circostante,
corrispondente alla zona in cui dorme il demone, abbia un valore negativo e di pericolo, ve ne
sono altre in qualche modo più fluide: Jamlu non ha volto e non può essere rappresentato ma la
sua presenza è particolarmente evidente in alcuni luoghi, come la pietra nera al centro della
piazza del paese, tutte le case degli anziani, la fontana principale e alcuni alberi che sono
all’entrata e all’uscita del villaggio. Particolari e mutevoli forme spaziali sono il risultato: i
territori in cui si può muovere una persona variano a seconda del sesso, dell’età raggiunta, di
particolari momenti della vita e dell’anno e soprattutto dall’essere o non essere un abitante
originario.
Per capire il rapporto che i Malani hanno con la loro terra la nozione antropologica di tabù e il
concetto di luogo sacro, ci possono venire in aiuto, ma solo se le dissolviamo in più generali
confini spazio-temporali di durata relativa e consideriamo lo spazio-tempo come un nesso
simbolico di relazioni create dall’interrelazione di attori fisici e spazi terrestri. Le proibizioni
spaziali divengono dei limiti alla presenza di una persona in particolari luoghi. Per
comprendere queste pratiche bisogna considerare il problema del territorio sotto un duplice
aspetto: quello di “essere un luogo” e quello di “esserci delle persone” nel luogo. Questa
ambivalenza è alla base di ogni spazio sociale, pensato sia come “base per le azioni” che come
“campo per le azioni”, «places whence energies derives and whiter energies are directed ».
(Lefevre 1991: 191 e Munn 1992). Nella formulazione di uno spazio-tempo esclusivo si crea una
dinamica di interrelazioni tra due modalità di spazio contemporaneamente operative: il “campo
per le azioni” è lo spazio mobile creato dagli abitanti in rapporto con determinati luoghi, cose o
2
3
Saggi che secondo la tradizione videro misticamente rivelati gli inni vedici
Demone
24
persone; la “base per le azioni” sono i territori materiali che si prestano, in ogni momento, alla
possibilità di movimento delle persone. Il territorio può essere definito facendo riferimento ad
un attore sociale, che ne diviene il centro organizzato di percezione, manipolazione,
riproduzione, e può essere compreso come spazio corporeo creato dall’agente in rapporto a
distanze esterne e al valore simbolico attribuito a determinati luoghi, dando vita a particolari
azioni o posture, in un luogo dato, o come movimento attraverso i luoghi. Questi campi di
azione sono tracciati lungo traiettorie ipotetiche, che hanno i loro centri nei corpi, con i loro
movimenti, le loro capacità tattili e percettive, e la possibilità di andare oltre il proprio essere,
con lo sguardo, l’udito, la voce. In questo modo il corpo diviene impregnato di significati
spaziali e il campo spaziale di significati corporei. Quando i malani devono percorrere un
territorio con valore negativo, come la zona in cui dorme il demone, o vogliono sostare
all’interno delle case in cui vivono stranieri, stanno sempre attenti allo sguardo vigile di Jamlu
cercando di interpretare quale sia il comportamento giusto per il dio, valutando quale sia la
pericolosità reale dell’azione da compiere, i vantaggi e gli svantaggi che ne potrebbero derivare,
per poi escogitare strategie nel comportamento. Spesso per accontentare Jamlu è sufficiente
lavarsi con cura dopo essere stati in luoghi pericolosi e sacrificare una o più pecore alla defta per
“lavare” dei luoghi in cui vi hanno abitato i “non malani”. Per i forestieri la regola è il generale
divieto a toccare qualsiasi luogo o persona all’interno del villaggio, con particolare pericolosità
per alcuni punti. La pena è di offrire dei soldi o un sacrificio alla defta proporzionati alla
sacralità della parte di territorio o della parte del corpo che si è toccata. In caso di rifiuto si viene
legati e spinti a calci e sassate giù dalla vallata con il divieto assoluto della defta di farvi ritorno.
Questa è la legge che vige sul territorio di Malana. A fondo valle tutto svanisce e dove l’occhio
di Jamlu non arriva anche i malani vivono senza restrizioni.
Anche l’aspetto ecologico del territorio di Malana è molto complesso e singolare, poiché negli
ultimi anni la vallata è divenuta uno dei luoghi di massima produzione di charas: le piantagioni
locali di patate e miglio sono state sostituite, quasi interamente, da campi di marijuana,
provocando una serie di modifiche al paesaggio e alla vita all’interno del villaggio. Gli abitanti
si sono notevolmente arricchiti e sono diventati abili nel commercio, sempre più stranieri vi
arrivano per acquistare droga, molti nepalesi vi si sono trasferiti per lavorare nei campi di
cannabis e il governo indiano ha incominciato a interessarsi a quest’area, dimenticata per secoli,
per arrestare la produzione e il commercio di stupefacenti. Le irruzioni dei poliziotti e la
distruzione di ettari di piantagioni sono diventati sempre più frequenti. Recentemente è stata
costruita una strada asfaltata che permettere di raggiungere Malana in sole due ore di cammino
a piedi, invece delle sette di solo qualche anno fa. Sono anche stati messi cartelli in cui si
avvisano i visitatori stranieri delle proibizioni e delle restrizioni a percorrere e toccare
determinati luoghi all’interno del villaggio. Cosa ancora più preoccupante i discendenti di jamlu
hanno imparato a parlare in hindi e qualche parola di Inglese e quindi il demone dovrebbe
essersi svegliato. I malani non avrebbero voluto tutto questo, consideravano la produzione di
charas in armonia con il paesaggio e l’isolamento del loro villaggio. Dal loro punto di vista
avrebbero, un po’ più ricchi, continuato a seguire le loro regole e le loro interdizioni senza
l’intromissione della legge indiana, da cui si vogliono separare e che non credono possa
rappresentarli.
25
Bibliografia
− Appadurai, A., 1988. Introduction: Place and Voice in Anthropological Theory. Cultural
Anthropology 3(1): 16-20.
− Bourdieu, P., 2003. Per una Teoria della Pratica. Milano: Raffaello Cortina Editore.
− Giddens, A., 1979. Central Problems in Social Theory: Action, Structure and
Contradictions in Social Analysis. Berkley: University of California Press.
− Giddens A., 1990. The Consequences of Modernity. Stanford, CA: Stanford University
Press.
− Lefebvre H., 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell.
− Marcus, 1989. Imagining the Whole: Ethnography’s Contemporary Efforts to Situate
Itself. Critique of Anthropology 9(3): 7-30.
− Mauss., M., 1950. Le Techniques du corps. Sociologies et Anthropologie. Paris : Presses
Universitaire de France.
− Munn, N., 1990. Constructing Regional Worlds in Experience: Kula Exchange,
Witchcraft and Gawan Local Events. Man 25: 1-17.
− Munn, N., 1996. Excluded Spaces: The Figure in the Australian Aboriginal Landscape.
Critical Inquiry 22: 446-445.
− Rabinow P., 1988. Beyond Ethnography: Anthropology as Nominalism. Cultural
Anthropology 3: 255-364.
− Rodman M., 1992. Empowering Place: Multilocality and Multivocality. American
Anthropologist, 94(3), 640-656.
− Said E., 1989. Representing the Colonized: Anthropology’s Interlocutors. Critical
Inquiry 15: 205-225.
− Said E. 2001., Orientalismo. L’ Immagine Europea dell’Oriente. Milano: Feltrinelli.
− Sharma, P., Chauhan N. S., Lal B. 2004. Malana : An Abode of Unique Democracy in
High Mountains of Western Himalaya. Man in India vol.84, n. 34: 341 351.
Sul “campo”, lo “spazio”, il “territorio”…
Andrea Ravenda
Come detto nel mio precedente intervento, in antropologia, discutere sulle nozioni di
campo, spazio e territorio significherebbe ripercorrere la storia della disciplina, ponendo questi
temi di dibattito, come problemi di natura teorica, epistemologica e anche politica, dove per
“politica”, facendo riferimento a Foucault, intendo il quadro dei rapporti di forza nell’ambito, in
questo caso, delle produzioni scientifiche. Non vi è etnografia, infatti, che non si produca
attraverso una ricerca sul campo: stabilendo una distanza da percorrere verso il soggetto (o il
fenomeno) di interesse in uno spazio fisico e culturale; radicandosi e radicando l’oggetto di
studio nel territorio inteso nelle proprie molteplici componenti di natura geopolitica, storica e
culturale. Al tempo stesso, il “campo”, lo “spazio”, il “territorio” (come affermato nell’abstract,
concreti o simbolici che siano), nel modo in cui sono definiti, prodotti ed immaginati
all’interno del dibattito disciplinare e nella pratica etnografica, tanto quanto nelle scelte
26
istituzionali delle varie scuole ed accademie, possono essere resi problematici divenendo essi
stessi oggetti di indagine ed analisi. Ritengo che l’occasione offerta dal dibattito in corso e
dall’incontro di Pontignano in particolare, possa essere utile più che al fine di una definizione
dei concetti citati – tentativo che potrebbe essere considerato come velleitario – come
discussione sulla pratica etnografica stessa, su come il trattamento di queste nozioni influenzi il
lavoro che nei vari campi di ricerca siamo soliti affrontare. Ovviamente non è mia intenzione
sciogliere i problemi posti in questo intervento, il mio intento è quello di sottolineare la
complessità delle possibili relazioni tra le tre nozioni, e di come queste possano essere affrontate
e discusse, ma soprattutto rese dinamiche all’interno di una pratica etnografica, divenendo al
contempo limite e possibilità del nostro agire. Sarei risoluto, dunque, a porre la mia riflessione
proponendo alcune osservazioni sulla costruzione del campo etnografico.
Il fieldwork, si presenta nel proprio prodursi storico come cardine indissolubile dalla
pratica etnografica e della formazione di ogni studioso della relativa disciplina, come vero e
proprio rito di passaggio (Clifford 1997), basti pensare ad esempio, alla presenza continua ed al
riferimento al modello Malinowskiano, appunto di ricerca sul campo, come “mito immaginario
antropologico” (Stocking 1992): “piantare la propria tenda al centro del villaggio” in una
relazione biunivoca tra lo studioso e l’oggetto di indagine, amplificata dalla dimensione della
distanza geografica e culturale. Caratteristiche oramai condivise di questo archetipo (Gupta,
Ferguson 1997) potrebbero essere considerate in maniera schematica: il viaggio (nella
contrapposizione field\home), la permanenza prolungata in un dato luogo ben definito e
l’osservazione partecipante, caratteristiche queste poste nell’ambito della definizione della
scienza antropologica, come peculiari differenze tra i propri metodi di ricerca e quelli delle
altre scienze umane; se da un lato è quindi l’antropologia a definire i metodi e le tecniche del
fieldwork, dall’altro è questo che stabilisce la specificità della disciplina. Questo approccio, che
trova nei contesti della sua contemporaneità le proprie ragioni, ha spesso prodotto, anche
attraverso processi di reificazione postumi, una antropologia in cui il campo è stato considerato
come uno spazio chiuso dove incontrare ed analizzare culture confinate; identificazione questa
tra il luogo scelto, una “cultura” particolare e lo sguardo del ricercatore.
Nelle contemporanee etnografie, però, la tendenza maggiore è stata sempre più quella a
ripensare il citato approccio (Appadurai 1991, 1996, Clifford 1997, Clifford e Marcus 1986,
Gupta e Fergusson 1992, 1997, Marcus 1986, 1998 solo per citarne alcuni), aprendo un intenso
dibattito finalizzato ad una vera e propria esplosione del concetto di campo. Le ragioni di questa
scelta atta a problematizzare, sono rintracciabili su diversi percorsi seguiti da più studiosi;
questioni riguardanti la costruzione del campo tanto in contesti postcoloniali o di
globalizzazione, quanto in relazione allo studio di fenomeni processuali che di per se risultano
frammentati su più contesti transnazionali, come ad esempio la migrazione (tanto per citare il
mio campo di ricerca) o come nel caso del movimento Nko mandingo (Amselle 2001) o situate
in veri e propri non luoghi (Augè 1992) come ad esempio le sale d’attesa di un aeroporto, fino ad
ipotizzare eventuali campi di ricerca che potrebbero situarsi su internet (in Clifford 1997). Ma
in maniera più semplice, senza addentrarmi in analisi che meriterebbero una sede certamente
più adatta rispetto a questo rapido intervento, vorrei riportare un passaggio di un articolo
dell’antropologo statunitense Robert M. Hayden (Hayden 2005 ):
<<Quando
un antropologo americano di origine indiana, facendo ricerca nell’India
meridionale, scopre che il sacerdote del tempio che vuole incontrare si trova nel Texas
27
(Appadurai 1991, p. 201), non occorre forzare troppo il concetto di lavoro sul campo per
suggerirgli di andare in Texas ad intervistare il sacerdote>>
Non da meno, la considerazione di un campo frammentato o inteso in localizzazioni mutevoli,
va riletta a mio avviso, anche in un ottica transdisciplinare, questo soprattutto in riferimento a
contesti nei quali – l’etnografo di certo non è solo – possono operare storici, giuristi, politici,
esperti locali, membri di associazioni non governative e così via, tutti soggetti attivi ed “in
campo” che producono discorsi ed analisi con i quali il ricercatore, onde rischiare un approccio
solipsistico, è tenuto a confrontarsi, esplorando ed inserendosi in reti di analisi e di posizioni
anche politiche.
Mi riferisco ad una antropologia in cui il campo è considerato come uno “spazio
relazionale”, dialogico e conflittuale (Marcus 86, 98, Palumbo 91). L’etnografo, quindi, presente
come corpo e con il proprio habitus di studioso (Clifford 1997), negozia il proprio
posizionamento all’interno, si confronta con altri soggetti, contribuisce egli stesso alle
produzioni discorsive e simboliche; si stabiliscono in questa complessa rete di relazioni i
“confini del campo etnografico”. In questo contesto, inoltre, il ricercatore affina e corregge le
proprie tecniche metodologiche e le proprie teorie rendendo il campo un vero e proprio
laboratorio di antropologia. Al contempo questo “spazio relazionale” è radicato in un territorio,
che è multisituato, tra “luoghi” geografici ed immaginari, tra produzioni culturali e posizioni
politiche. A tale proposito, come già citato, vorrei richiamare alcune nozioni di antropologia
relative alla questione della corporeità, in particolare quella di “incorporazione” e quella di
habitus (Mauss 1965, Bourdieu 1972), ovvero quella capacità dei corpi di apprendere, di
elaborare tecniche attraverso una esposizione all’ambiente sociale (Pizza 2005). Nozione di
habitus che nella rielaborazione di Pierre Bourdieu non è considerata soltanto nell’ottica di un
assorbire strutturato, ma come pratica, come continuo interscambio tra il corpo ed il mondo
fatto di percezioni, ma anche di valutazioni ed azioni. Siamo corpi ed è il corpo storico, nel suo
essere <<schema di riferimento adottato per produrre modelli d’ordinamento e di
classificazione>> (Pizza 2005, corsivo mio), a vivere il mondo a conoscere gli spazi.
Farò riferimento al mio caso di ricerca, in altre parole ad un’etnografia di un Centro di
permanenza temporanea per migranti. Il CPT è un’istituzione totale alla quale è molto difficile
accedere e che in quanto tale fa della limitazione e della definizione dello spazio e degli spazi,
una sua caratteristica peculiare (Goffman1961). Ad esempio la caratterizzazione relativa allo
spazio abitabile per i trattenuti (migranti privi di permesso di soggiorno e con decreto di
espulsione), potrebbe essere definita attraverso la relazione tra l’esterno e l’interno
dell’istituzione stessa, relazione posta come differenza da tutta una serie di barriere simboliche e
concrete (sorveglianza armata, alte mura di recinzione, filo spinato, ma anche legge sulla
privacy dei trattenuti). Se dell’interno sono caratteristiche le pratiche e i conflitti relativi alle
relazioni tra i trattenuti, lo staff dell’ente gestore e le forze dell’ordine atte alla sorveglianza,
proprio dell’esterno è il radicarsi dell’istituzione nel territorio, ovvero, in un determinato
contesto storico e geopolitico identificabile in una “località” ma anche nell’insieme dei discorsi
(spesso concepiti in polemica ideologica) e delle pratiche relative al tema della emigrazioneimmigrazione prodotte da molteplici soggetti, sia a livello nazionale che internazionale.
Il centro nel quale ho avuto modo di fare ricerca, si caratterizzava al 2004 per alcune
caratteristiche particolari, il direttore, infatti con alcuni suoi collaboratori ed alcuni agenti di
28
sorveglianza, era indagato in diversi processi con accuse (tra le altre) di falso ideologico, abuso
nelle pratiche correttive, crudeltà nell’agire, relativamente ad azioni finalizzate a sedare un
tentativo di fuga di alcuni trattenuti. Bene, se da un lato come detto, in questi centri è molto
difficile entrare ed ottenere notizie, quello in questione svolgeva una intensa attività di uscite
pubbliche finalizzate ad una apologia dalle accuse che venivano rivolte ai membri dello staff
dell’ente gestore. Frequenti erano incontri con giornalisti locali, visite al centro da parte di
scolaresche, pubblicazioni di libri da parte del direttore, ed addirittura il montaggio,
autoprodotto, di un film documentario sul centro appunto. Sono risuscito ad entrare nel CPT
attraverso una lunga negoziazione con il direttore; se da un lato ho dovuto costruire il mio
habitus di ricercatore, in funzione ad una “assoluta scientificità” della disciplina alla quale mi
riferivo, distanziandomi dalle posizioni che nel dibattito pubblico si erano poste contrarie
rispetto ai CPT ed in particolare a quello in questione, dall’altra sapevo che la mia figura sarebbe
rientrata in quella sopraccitata attività di apologia svolta dal centro su più livelli. Vi è una totale
identificazione tra le uscite pubbliche del direttore e le interviste che mi ha rilasciato. Non solo,
questo mio ingresso negoziato con l’istituzione ha portato la mia figura ad essere considerata da
parte dei trattenuti come facente parte dell’ente gestore, stimolando diffidenze e continue
richieste di aiuto e comprensione al fine di una possibilità di uscita dal centro. Allo stesso modo,
l’essermi avvicinato alla figura del direttore dell’istituzione, unico mio tramite per accedere al
centro, e quindi al campo da me scelto, mi ha allontanato da tutte quelle associazioni radicate
nel territorio e contrarie all’istituzione, con le quali inizialmente avevo lavorato a stretto
contatto. Ora, senza voler relazionare sulla mia esperienza etnografica, ciò che vorrei mettere in
evidenza è come le scelte che spesso siamo costretti a prendere nella performance della ricerca
possono influenzare e modificare le dimensioni e le caratterizzazioni del campo, non da meno le
nostre posizioni all’interno del territorio in cui operiamo, intesi, sia il campo che il territorio
come spazi di relazione tra molteplici soggetti. Se non avessi negoziato con l’istituzione, non
sarei mai potuto entrare nel centro ed avere informazioni dirette su di esso, non avrei avuto la
possibilità di osservare, questa mia scelta però ha inevitabilmente condizionato un cambiamento
nella posizione nel campo che per me avevo immaginato e inizialmente tentato di costruire.
Esiste, però un problema che volontariamente ho omesso fino a questo punto, ovvero
come ricondurre, un fieldwork finora descritto come multisituato, frammentato, e prodotto su
un livello performativo – sia dall’etnografo che dagli altri soggetti in campo – ad un lavoro
scritto, ad una etnografia, una monografia o un saggio, che sia considerato antropologico? Che
rientri ovvero in parametri accettabili per una scienza in così continua mutazione come
l’antropologia, che possa essere accettato da istituzioni accademiche. E da un altro punto di vista
come presentare un campo così considerato all’interno di progetti di ricerca finalizzati alla
richiesta di finanziamenti?
Pongo questi problemi non in polemica con l’istituzione, ma perché a mio avviso è anche in
queste relazioni, per ritornare al nostro punto di partenza, che si possono costruire e definire le
nozioni di “campo”, “spazio” e “territorio”.
29
Bibliografia
− Appadurai, A., 2001, Edizione italiana Modernità in polvere, Meltemi, Roma, edizione
originale (1996) Modernity at Large : Cultural dimension of Globalization, University of
Minnesota Press, Minneapolis-London
− Augè, M., 2002, Non-Luoghi, Elèuthera Milano, edizione originale (1992) Non-lieux
Seuil Parigi
− Bourdieu, P., 2003, Edizione italiana Per una teoria della pratica, Raffaello Cortina
Milano, edizione originale (1972) Esquisse d’une Théorie de la Pratique, Edition du
Seuil, Paris
− Clifford, J., 1999, Edizione italiana Strade, Viaggio e traduzione alla fine del secolo xx
Bollati e Boringhieri Torino Edizione originale (1997) Routes Travel and Translation in
the Late Twenty century Harvard University Press, Cambridge- London
− Gupta, A. & Ferguson, J., 1997, Discipline and practice <<The Field>> as site, Method, and
Location in Anthropological Location: Boundaries and Grounds of a Field Science,
University of California
− Foucault, M.,1977, Microfisica del potere. Interventi politici, Einaudi Torino (ed. orig.
1971)
− Haiden, R.M., 2005, Comunità immaginate e vittime reali: autodeterminazione pulizia
etnica in Jugoslavia in a cura di Fabio Dei, Antropologia della violenza Meltemi Roma
− Marcus, G. E. & Fisher, M., 1998, Antropologia come critica culturale Roma Meltemi.
(ed. orig.1986) Anthropology as a Cultural Critique. Experimental Moment in the
Human Sciences, Chicago, Chicago University press
− Marcus G. E., 1998, Ethnography Through Thick & Thin, Princeton University Press
− Mauss, M., 1965, Le tecniche del corpo, in M. Mauss, Teoria generale della magia e altri
saggi, Einaudi, Torino
− Palumbo, B., 1991, “You are going really deep”: conflitti, pratica e teoria in etnografia.
Alcune riflessioni a partire dal caso Nzema, <<L’Uomo >> , IV, Nuova s, 2 pp. 235-270
− Palumbo, B., 2003, L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in
Sicilia orientale, Meltemi Roma
− Pizza, G., 1998, a cura di, Figure della corporeità in Europa, “Etnosistemi. Processi e
dinamiche culturali”, anno V, n. 5 ,CISU Roma
− Pizza, G., 2005, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Carocci
Roma
− Stocking, G., 1992, The Etnographer’s Magic and Order Essays in the History of
Antropology, University of Wisconsin Press, Madison
30
Campo, Spazio, Territorio
Daniele Cestellini
Mi sembra che si tratti innanzitutto di argomenti molto interessanti: sono concetti complessi,
articolati e non liberi da una componente di astrazione. Così come sono spesso termini e
sostegni significanti della retorica e delle argomentazioni antropologiche.
In questo caso, immagino una direzione di argomentazione fondata su un’analisi linguistica e
terminologica, volta a decomprimere la parola e a rilevarne i significati negli usi a fronte di
diverse competenze, si potrebbe dire votata alla de-astrazione lessicale e semantica, una sorta di
analisi riflessiva che partecipa del pensare criticamente la disciplina antropologica, le sue
categorie interpretative, e il sapere che questa produce anche utilizzando (in nuove accezioni) i
termini del linguaggio comune.
Molto probabilmente, la percezione dei temi in questione – almeno per quanto mi sembra di
intendere in questo momento di scrittura che riordina formalmente, e quindi irrigidisce e non
necessariamente chiarifica la riflessione – è filtrata da specifici ambiti di ricerca, frequentazioni
bibliografiche, esperienze relazionali, umane ed etnografiche.
Può forse apparire scontato, come l’esito di un ragionamento ovvio o addirittura superficiale, ma
credo che un atteggiamento importante in un momento di raffronto, come quello che si
prospetta, è filtrare il ragionamento su temi complessi come quelli in questione, attraverso una
sorta di “interiorità antropologica”, che permetta di problematizzare i termini e gli ambiti
concettuali a cui rimandano, agendo proprio nella singola esperienza intellettuale, legata
chiaramente al quadro etnografico personale e partecipe allo stesso tempo di una organizzazione
collettiva del sapere specialistico.
Proverei allora a scrivere di queste problematiche in quanto – prossimo alla stesura della tesi (ad
una schematizzazione calligrafica di un piccolo sapere) – mi sto interrogando sull’uso dei
termini e sto esperendo l’esercizio singolare di una ricerca etnografica e di una riflessione, che
ha un certo grado di continuità, su un “campo” specifico.
Sto cioè praticando un fieldwork (in cui si opera fisicamente, attraverso l’azione corporea
dell’“esserci”, insinuandovi cioè una personale “presenza storica”): un “campo” che la retorica
antropologica tende a delineare come una o più superfici reali fisicamente arginate, e che si
configura come soprattutto un ambito relazionale complesso, continuamente pervaso da
pratiche culturali multiple e da dinamiche di negoziazione, anche politiche, che coinvolgono
vari soggetti, compreso me ovviamente. E allo stesso tempo pratico un “campo” di studi, quello
dell’antropologia (senza aggettivi aggiunti, per il momento), cui si aderisce (e qui il termine
“campo” perde già la sua fisicità a vantaggio di un’immagine che ne delinea le caratteristiche di
sfera, di ambiente arginato sì, ma non materialmente) per vocazione intellettuale, per attitudini
o passione, per affinità ideologica con alcune scelte di interpretazione avallate dalla teoria
antropologica.
In questo caso allora, come studioso di antropologia devo interrogarmi sui significati che
l’antropologia stessa ha prodotto, e credo che in qualche modo sia ciò che ci si propone di fare se
ad animare i dibattiti e i confronti sono questioni quali “campo”. La mia riflessione è spinta
verso l’analisi di ciò che realmente faccio, per questo credo che i concetti debbano filtrarsi
attraverso la soggettività e l’esperienza personale: perché approvo lo statuto etico-scientifico di
questa disciplina che permette ad ognuno di costruire una antropologia agita nel tessuto di
pratiche relazionali, culturali, politico-economiche, sociali, di potere, che noi rappresentiamo
31
come “campo” attraverso le nostre performance narrative e l’affidamento dei nostri dialoghi al
linguaggio corrente; perché in qualche modo ciò che esperisco come ricercatore (l’etnografia)
mi permette di costruire una rete di connessioni a riflessioni e rimandi anche non specifici di
quell’esperienza; perché concordo pienamente con quanto afferma Giovanni Pizza in un suo
saggio di qualche anno fa, ovvero che l’etnografia può essere considerata come la costruzione
della teoria.
Questo per sottolineare la proposta di riflessione sui termini in questione: dal mio punto di vista,
si rende necessario l’intento di interrogare il proprio modo di fare e gestire l’esperienza di
ricerca, nel senso che è attraverso i nessi che si tracciano nelle fasi etnografiche e di riflessione
su di esse che si delineano questioni e problematiche importanti, le quali animano poi da un lato
la teoria del lavoro e, dall’altro, agiscono nelle pratiche di relazione con i nostri interessi di
studio, ri-funzionalizzando la lettura dei contesti di “campo” ad esempio in termini di “spazi”
relazionali in cui sono agite pratiche “territorialmente” circoscritte. Nella pratica, poi, si
affrontano sempre una pluralità di aspetti legati al “campo” di ricerca, che non è guardato (e
agito) in una prospettiva di chiusura, è anzi analizzato in una prospettiva storica con costante
riferimento alle dinamiche di trasformazione, alle “dinamiche esterne” con cui quell’ambito
socio-culturale, quelle pratiche di rappresentazione e comunicazione (performative, nel caso
specifico della mia ricerca, verso la descrizione della quale mi avvicino gradualmente, per
aiutare il ragionamento), si confronta. Si polverizza in questo modo, insieme all’assetto
territoriale “tradizionale”, la grammatica stessa delle pratiche generate in un preciso ambito
culturale “spazialmente” delimitato, in quanto molti procedimenti vengono abbandonati, e si
affronta la modernità (il flusso delle informazioni trans-locali) anche attraverso le capacità e le
conoscenze individuali: si genera cioè agli occhi del ricercatore un “campo” multiforme e
geograficamente articolato, una struttura dei saperi e delle azioni che si definisce proprio
attraverso la “processualità delle relazioni sociali”, l’agilità della comunicazione, il reale sforzo
“locale” di codifica del “globale” (e viceversa).
La ricerca che sto effettuando pone in essere delle problematiche che si esplicano in uno
“spazio” relazionale per certi aspetti geograficamente circoscritto, in cui le pratiche che sto
analizzando sono strettamente connesse ad un “territorio” specifico – la periferia industriale
dell’area vesuviana – che ha generato, in un determinato momento storico, dei particolari
bisogni sociali. In questo caso, la definizione di un “territorio” andrebbe forse elaborata, allora,
in relazione alla definizione di un processo storicamente individuabile che ha determinato delle
aspettative, degli atteggiamenti di critica in qualche modo “ritualizzati”, o, in altre parole,
rappresentati attraverso la performance teatrale e musicale.
Allo stesso tempo, contestualmente ad una prospettiva analitica che connetta tali pratiche ad un
contesto più ampio, ad una macro-scena delle relazioni, l’indagine incontra la necessità
metodologica di un punto di vista trans-locale (extra-territoriale, che fenda alcuni argini del
field-work), in quanto il fenomeno in questione si configura anche attraverso una relazione
(non importa se positiva o oppositiva) con dinamiche di interazione internazionale.
Inoltre, il mio “campo” di studi è la musica, che, è forse superfluo ricordarlo, si definisce
proprio in base ad una comunicazione che non conosce confini prestabiliti, anche laddove si
voglia pensarla (e rappresentarla) come espressione stretta su una realtà socio-culturale
riconoscibile e in qualche modo delimitabile; in questi termini le nozioni di “spazio” o
“territorio” mi appaiono costantemente mutabili, necessitano periodiche riletture proprio in
32
base alle direzioni analitiche che lo stesso “oggetto di studio” costringe a seguire, causa la sua
complessità e permeabilità.
Ciò che le indagini etnomusicologiche hanno pubblicato, o reso accessibili, come “fonti
etnomusicali”, d'altronde può essere considerato – inevitabilmente, a mio avviso, scivolando in
un’ azione di critica al purismo filologico – come lo stadio “ultimo” (che ne precede in quello
stesso momento, e attraverso la stessa azione della registrazione, un successivo) di un processo
reale di trasmissione di determinati comportamenti effettivamente leggibili come “permanenze
di eredità tradizionali” (come sottolinea Leydi), vale a dire forme artistiche di una creatività
rispecchiante una realtà complessa e problematica che va analizzata nei suoi costanti rapporti
con espressioni estranee alla cultura di tradizione orale di oggi ma anche di ieri.
Se leggiamo ciò che appare attraverso la ricerca come il risultato di successivi processi storici e
come attestazione di uno specifico momento della storia e della creatività, allora possiamo
studiare le registrazioni di un determinato periodo storico come il risultato di evoluzioni e
modificazioni: non soltanto interne alla specificità della cultura di tradizione orale, ma anche
esterne ad essa, indicatori interessantissimi cioè della componente dinamica e mutante di tali
musiche, subordinate all’intersezione di molteplici fattori. Se si accetta questo paradigma,
atteggiamento indagante e analitico, e lo si considera come plausibilmente alternativo ad una (a
mio avviso) fuorviante e restrittiva indagine volta allo studio chiuso (che delimita anche la
distribuzione spaziale) della forma “autentica” non “corrotta” e non “mistificata”, si potrà allora
tenere in alta considerazione l’osservazione e lo studio di un fenomeno che comprende anche
manifestazioni attualizzate nelle forme e nei canali della moderna comunicazione musicale.
Oppure, in una prospettiva storico-antropologica, si porrà attenzione a fattori esterni alla
“creatività popolare” che, articolati su vari livelli di intervento, hanno agito sulle espressioni
musicali tradizionali sfruttandone la loro caratteristica di impatto e ampia diffusione,
trasformandole per così dire in supporti e canali dell’interiorizzazione della retorica politicocommerciale e folcloristica, oppure, nel caso opposto, della retorica di militanza politica attiva e
di critica alle modalità di gestione e mantenimento dei poteri.
Come detto, il mio è un progetto sulla musica. Il tema della ricerca è la “world music”, un
termine che, tradotto in Italia (come in Francia), rivela subito l’ambiguità lessicale, ma anche
semantica, che lo pervade, in quanto la “musica del mondo” (o “dal mondo”) frena subito la
volontà di definizione, e immediatamente apre lo scontro con una disorientante terminologia
che rimanda anche alla arbitrarietà di altri vocaboli e concetti, necessariamente da ripensare,
visto che i loro significati di riferimento decadono inesorabilmente. Allora il “campo” è molto
vasto, come sempre d’altronde: è sì quello etnografico, che si sceglie di frequentare fisicamente e
praticare, ma flette continuamente verso uno “spazio” di riferimento che, inevitabilmente,
considera appunto la “mondialità” cui si allude nella definizione di quelle musiche; le pratiche
che un antropologo indaga si determinano come circoscrivibili in un “territorio”
geograficamente riconoscibile, ma contemporaneamente si generano (e assumono una rilevanza
antropologica, ovvero attraggono la mia personale attenzione) anche perché sono riconducibili
ad una circolazione internazionale di idee e di stili che forgia, in modi diversi, la stessa creatività
artistica. La “world music” è una categoria musicale che, come tutte le categorie, tende ad
irrigidire e semplificare ciò che è stata chiamata a descrivere: in questo caso, a mio avviso, un
sistema molto complesso che riflette diversi interessi e varie competenze, un processo di
interazione internazionale, una modalità – riprendendo alcune intuizioni di Diego Carpitella, il
padre dell’etnomusicologia italiana – inter-culturale di produzione musicale.
33
“World music” è una etichetta di mercato, una categoria commerciale e di marketing «dominata
dai processi di fusione di un pop “globale” e, in particolare, da musiche che enfatizzano
mescolanze interculturali, diasporiche, migranti, urbane e cosmopolite» (Feld 2003: 50).
«Anche se è ormai un luogo comune, è comunque innegabile che gli stili e le identità musicali
siano oggi più visibilmente transitori, in stato di costante fissione e fusione sul piano sonoro, di
quanto non sia mai accaduto nella storia dell’umanità. Molti studiosi collegano questa
condizione alla cosiddetta “globalizzazione”. I segni onnipresenti del fenomeno noto con questo
nome si possono fondamentalmente rintracciare in un capitalismo di portata mondiale, in reti
vastissime che collegano quelli che un tempo erano chiamati “centri” e “periferie”, e in una
straordinaria mobilità di popoli e cose attraverso le frontiere. Ma l’aspetto di questo processo
che più ha a che fare con la musica è il flusso transnazionale di tecnologie, media e culture
popular» (Idem: 49).
Le condizioni di una ricerca su un argomento così cangiante e “inglobante” risentono
sicuramente della necessità di interrogarsi sulle definizioni di termini come “territorio”,
“spazio”, “campo”: si delineano, credo, delle reti “globali” in cui le musiche si osservano,
registrano, commercializzano, decostruiscono, attraverso dei processi complessi che riconsiderano il carattere stesso dei confini e, di conseguenza, di coloro che li attraversano. Il
“dove” necessita di un riesame critico, perché siamo tutti attraversati (le nostre immaginazioni e
le idee) da una dimensione spaziale assoluta, non condizionata dalla superficie reale (come dire,
geografica). Ecco quindi che si incrina la propensione della ricerca a pensare fenomeni su scala
ridotta, privi di contatti, a presumere la possibilità di vedere luoghi, persone, relazioni statiche e
isolate. E credo che questa dinamicità ribalti anche la possibilità di pensare ad ambiti relazionali
avulsi dal flusso storico e da dinamiche di economia politica trans-locale; così come, per gli
stessi motivi, impone alla moderna etnomusicologia, e all’antropologia della musica, di occuparsi
più a fondo dei processi di produzione musicale, che coinvolgono i ricercatori stessi, nel
momento in cui si anima il dibattito su questioni centrali: come ad esempio, le politiche della
proprietà della musica di tradizione orale, della musica non occidentale, e il rapporto tra la
produzione e diffusione contemporanee di musica di tradizione e il mercato discografico
internazionale (multinazionale).
È a questo punto che esplode il “campo”, sia come riferimento geografico, sia come richiamo
teorico, divenendo una specie di prototipo ancora da modellare infinite volte; non è più
“localizzabile” uno “spazio” culturale “concreto” (la cui concretezza e tangibilità sono sempre
state un miraggio retoricamente costruito); non è immaginabile un “territorio” se non come
espanso e soprattutto umanizzato, in cui la musica, ad esempio, va letta come un “oggetto
culturale complesso” (non come un’astrazione con una vita propria e indipendente), non
valutabile nelle sue molteplici articolazioni se non attraverso un atteggiamento analitico che lo
connetta alle realtà (multiple) che lo producono, ovvero attraverso un approccio non solo
musicologico (specialistico anche con il prefisso “etno”, tendente a rilevare principalmente
caratteristiche interne, coerenze, incoerenze, ecc.), ma soprattutto di antropologia della musica,
più articolato (come l’oggetto che vuole studiare) che consideri cioè gli aspetti di tipo sociale,
culturale, politico-economici che (“trans-localmente”) lo pervadono.
Nel caso specifico della mia area di indagine, si assiste ad una costruzione retorica del mio
“campo” di studi, in quanto uno degli aspetti che alimenta la mia analisi è lo studio di dinamiche
di ri-configurazione di alcuni tratti culturali, quelli inerenti la musica, che vengono spinti in un
flusso comunicativo al fine di internazionalizzarne i contenuti, ovvero, di renderli accessibili,
34
far si che essi comunichino messaggi comprensibili a dei ricettori collocati in uno “spazio” molto
dilatato. «In questo scenario, la figura del “buono” e/o “cattivo” è rappresentata dall’industria
discografica, che sembra trionfare in eguale misura nella diffusione di una cultura popular
globale e nel sogno capitalista di realizzare un’espansione illimitata del mercato e
un’integrazione tra prodotti e tecnologie. Questa vicenda è vista da alcuni come la storia
meravigliosa del successo del capitale, della “transculturazione”; per altri invece è una storia più
oscura, fatta di corporativismo e di imperialismo culturale. La conseguenza è che la
globalizzazione musicale è vissuta e narrata tanto con esaltazione, quanto con inquietudine; e
questo perché tutti possono avvertire i segnali di un incremento, e allo stesso tempo di una
diminuzione, delle diversità musicali. Questo fatto ci impone una riflessione critica sul concetto
stesso di world music» (Feld 2003: 49).
In che modo viene prodotta musica, e con quali risultati, nel momento in cui questa,
strettamente legata ad un ambito culturale circoscritto (“locale”) – uno “spazio”in cui cioè le
conoscenze e le pratiche erano veicolate attraverso una comunicazione orale – viene inserita in
un circuito di trasmissione “trans-locale”? quali sono gli elementi che rimangono, quelli che
scompaiono o vengono enfatizzati? Quali sono le strutture che funzionano nella
“contaminazione”?
Il focus del mio progetto di ricerca è un gruppo musicale e teatrale, il Gruppo Operaio ‘E Zezi di
Pomigliano D’Arco, il quale produce musica dalla prima metà degli anni ’70 del Novecento, ed è
stato protagonista, nell’estate del 2000, di una scissione interna, seguita a disaccordi di tipo
politico-economico, e artistico-culturale, legati alla proposta di produzione da parte di una
multinazionale discografica inglese.
Il gruppo opera nell’interland napoletano (l’area che è divenuta il mio field-work), ed è
composto, in parte, da operai. L’area in questione è stata infatti interessata, sin dagli inizi del
‘900, da una forte industrializzazione che ha gradualmente sostituito l’assetto produttivo
“territoriale”, annettendo le forze lavoro locali dentro i sistemi di produzione industriale, che,
negli anni, hanno quasi completamente sostituito quelli legati alle attività agricole (questo è un
caso in cui il “territorio” cambia, più o meno radicalmente, si trasformano gli “spazi” che lo
costituiscono, in termini di relazioni, di produzione e di rappresentazione di conoscenze, di
rivalutazione di alcune pratiche: si verifica un processo evolutivo che determina nuove
percezioni del “territorio” in cui si vive, si agisce, si producono significati, cultura). In questo
ambito sociale industriale, sotto molti aspetti in evoluzione, si generano nuovi bisogni e disagi,
ci si confronta con una sistemazione del lavoro differente: si sviluppa, negli anni ’60 e ‘70 in
particolare, una nuova coscienza politica, che, all’interno di uno dei numerosi stabilimenti
industriali dell’area, confluisce in un progetto interessante e innovativo sotto molti punti di
vista, un ensamble musicale e teatrale appunto, costituito da operai, i quali iniziano fin da subito
a sperimentare, e a rappresentare, la complessità e le multiple articolazioni del “loro”
“territorio”. Anzi, incarnano fin da subito questa complessità, proprio con la scelta del nome del
gruppo, nel quale convivono il rimando al mondo contadino – ‘e zezi erano teatranti di strada
che rappresentavano, fino all’inizio degli anni ’50, la storia della Zeza, moglie di Pulcinella – e a
quello industriale, che si risolve appunto nella rivendicazione di una appartenenza di status,
politica e di classe, collettiva – quella al “gruppo” degli operai. Loro stessi impersonano le
contraddizioni del “territorio”, di due fasi socio-culturali che si attraversano costantemente,
essendo parte di quella generazione che per prima, in quell’area, ha sperimentato il cambio nella
produzione e nella gestione dell’economia locale.
35
La connessione tra questo focus sugli Zezi e i quesiti sollevati dai processi in atto di critica e
problematizzazione della “world music”, si evidenzia in due direzioni. Innanzitutto si risolve
attraverso la questione della scissione del Gruppo Operaio. Questa è scaturita – almeno così è
apparsa nella sua componente pubblica – da una fallita transizione che ha generato un conflitto
causato dall’incontro tra le dinamiche di produzione, diffusione e regolamentazione del mercato
discografico internazionale, da un lato, e gli ambiti di produzione musicale “locale”, dall’altro.
Tale conflitto ha aperto uno scambio dialettico – che ha coinvolto musicisti, giornalisti, fans,
antropologi – che ha reso visibili alcune questioni strettamente legate al dibattito sulle “musiche
dal mondo”, quali ad esempio: la proprietà intellettuale dei brani di tradizione orale e problemi
di copyright, evidenziando alcune lacune del diritto internazionale in merito alle opere
folkloriche, e quindi di riflesso ponendo l’attenzione sulla necessità di una definizione delle
stesse in termini giuridici.
In secondo luogo, il focus sugli Zezi si lega all’impianto teorico generale, in virtù del fatto che il
gruppo in questione ha sempre lavorato su dei moduli musicali “interculturali” (per i motivi cui
si accennava poco sopra), avendo utilizzato il patrimonio musicale di tradizione orale all’interno
di un progetto più ampio di militanza politica, di “critica rappresentata”, di emancipazione –
come loro stessi amano definirlo – della stessa classe operaia.
Da trent’anni, e ancora oggi, il Gruppo Operaio agisce concretamente in quel complesso
“territorio”, è presente come militante politico e produttore musicale, opera costantemente un
conflitto con chi regola la gestione culturale locale e l’accesso alle risorse da investire negli
ambiti della socialità. Allo stesso tempo, però, se sono fortemente definiti dalla loro concreta
presenza in quel “territorio”, sono essi stessi a ri-definire costantemente quest’ultimo, attraverso
le canzoni e le opere teatrali, tramite la loro arte, in virtù, potremmo dire, del loro talento:
incorporano e sostengono un’azione artistica e politica plurima, che incrina le
concettualizzazioni di un’identità rigida e intimamente radicale (escludente e differenzialista),
sottolineando come il sentimento di appartenenza (identitaria, culturale) sia alimentato da
scelte, anche politiche, storicamente determinate, e strategie ideologicamente costruite.
Così si esprime uno dei fondatori del gruppo:
« Allora, si potrebbe dire così: noi si aveva in qualche modo un progetto tracciato indipendentemente
dalla miseria e dalle difficoltà che poteva essere, considerata la guerra che in Italia è stata fatta sia ad
esperienze in queste direzioni…cioè in una nazione dove una malavita e una criminalità ha piegato il
popolo in una maniera spaventosa e poi le istituzioni gli hanno tolto, agli stessi ceti popolari e proletari,
tutte le strutture aggregative, particolarmente al sud. Non parliamo di Toscana, Umbria o Bologna,
parliamo del sud, dove la malavita organizzata e istituzionale ha menato pesante, togliendo anche quelle
piccole occasioni che erano lo scambio, all’interno di una cultura popolare che viene da tanto lontano,
della gente di incontrarsi e di ripassarsi ancora queste esperienze di comunicazione e di espressione, non
diciamo solo esperienze musicali. E allora fin dal primo momento sapevamo in quali ambiti ci si andava a
muovere, […] diciamo che a determinare una morbosa necessità di trovare delle forme di espressione è
stato proprio il vivere in un posto dove si veniva ad impiantare una grande fabbrica con tutti i
presupposti di andare, di fare un intervento… per cui noi ci siamo accorti che tutto ci sfuggiva dagli
occhi, tutti si andava là dentro per lavorare, tutti si toglievano i vecchi lavori, tutto si toglieva per far
posto ad una fantomatica altra idea che era l’industrializzazione. Industrializzazione in forme moderne,
perché poi Pomigliano non è che era la Cenerentola, Pomigliano aveva già una serie di fabbriche…
l’Alfaromeo e gli altri stabilimenti, del resto è la cintura di Napoli quindi è più una necessità della città,
anche gli insediamenti presi sede a Poligliano erano sempre in funzione della grossa urbanizzazione della
città che doveva avere degli sbocchi poi organizzati di produzione. Quindi noi ci siamo mossi subito per
36
contrastare questo ulteriore violentissimo attacco alla gente, che gli sottraeva tutto compreso le capacità
espressive dei codici di comunicazione interpersonali e sociali della zona, di per sé già immiseriti da anni
e anni di delinquenza, di camorra ecc…quindi diciamo che il nostro approccio a prendere la tradizione e
i moduli comunicativi era necessario e opportuno, ma tentare anche subito di intervenire per mettere in
mezzo le grosse altre questioni che venivano poste, allora abbiamo campicchiato e vissuto parallelamente
a tutti i movimenti di emancipazione, popolari, operai, studenteschi ecc…».
Bibliografia
− Carpitella, Diego, 1992, Conversazioni sulla musica. Lezioni, conferenze, trasmissioni
radiofoniche 1955-1990, Ponte alle Grazie, Firenze
− Feld, Steven, 2003, Chitarre nella foresta. La nascita di una nuova musica in Nuova
Guinea, in EM, Rivista degli Archivi di Etnomusicologia, Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, n. 1, Squilibri Editore, Roma
− Franchi, Ivo – Guaitamacchi, Ezio (a cura di), 2002, 100 dischi ideali per capire la World
Music, Editori Riuniti, Roma
− Leydi, Roberto, 2001, Guida alla musica popolare in Italia, Libreria Musicale Italiana,
Lucca
− Pizza, Giovanni, 2001, Retoriche del tarantismo e politiche culturali, in Ragnatele,
Adnkronos Libri, Roma
− Zemp, Hugo, 1996, The/An ethnomusicologist and the record business, in Yearbook for
Traditional Music 1996, Los Angeles
37
Spazio, Territorio, Campo
L’antropologo di fronte allo spazio turistico e alla percezione territoriale degli Hosts
Francesca Mariotti
“Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili,
intangibili, mai toccati e quasi intoccabili,
immutabili, radicati; luoghi che sarebbero punti di
riferimento e di partenza, delle fonti:
Il mio paese natale, la culla della mia famiglia, la casa
dove sarei nato, l’albero che avrei visto crescere (che
mio padre avrebbe piantato il giorno della mia
nascita), la soffitta della mia infanzia gremita di
ricordi intatti…
Tali luoghi non esistono, ed è perché non esistono
che lo spazio diventa problematico, cessa di essere
evidenza, cessa di essere incorporato, cessa di essere
appropriato. Lo spazio è un dubbio: devo
continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai
mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo.”
(Georges Perec, Specie di spazi, Bollati Boringhieri,
Torino, 1989, p. 110)
Nell’affrontare il tema dell’interrelazione tra i concetti di spazio, territorio e campo vorrei
utilizzare l’idea dello spazio così come descritto da Georges Perec, ossia come un’entità
continuamente soggetta a trasformazioni e negoziazioni all’interno della quale gli individui
percepiscono se stessi in una prospettiva che potremmo definire sia relazionale sia storica.
All’interno dello spazio, l’individuo non ha certezze di appartenenza date una volta per tutte, da
qui l’esigenza di costruire sempre nuovi punti di riferimento di cui appropriarsi per sentirsi
parte di una comunità e per condividere con essa una storia che dia forza alle proprie origini.
Strettamente collegata all’idea di spazio sarà, quindi, l’idea di tempo; la storia fornisce infatti una
memoria sociale, necessaria a rafforzare il senso di appartenenza.
Partendo da questa prospettiva, vorrei proporre l’immagine del territorio come di una parte
dello spazio più concreta, delimitata da punti di riferimento simbolici, politici, sociali ed
economici in cui gli individui riconoscono se stessi come comunità.
Se consideriamo questa appartenenza come un sentimento necessario all’essere umano ma allo
stesso tempo fortemente instabile, risulta evidente la necessità di analizzare i meccanismi che ne
condizionano la concretizzazione.
Tra le varie cause che determinano l’insorgere di questi meccanismi vorrei prendere in esame lo
sviluppo turistico, fenomeno da me analizzato durante la ricerca relativa alle trasformazioni
socio-culturali apportate dalla nascita dell’agriturismo in una zona della Maremma grossetana.
Il turismo deve essere visto come parte integrante del più generale processo di globalizzazione.
Le strutture turistiche fanno parte di quelli che Marc Augé definisce i non luoghi, ossia spazi
che non possono essere definiti né identitari, né relazionali, né storici4. Così come il processo di
globalizzazione porta su vasta scala la rivendicazione delle particolari identità nazionali5, allo
4
5
Augé M., 1993, p. 73.
Cfr. tra gli altri: Anderson B., 1996; Featherstone M., 1996; Geertz C., 1999; Gellner E., 1997.
38
stesso modo la trasformazione di un territorio secondo gli standard turistici avrà come
conseguenza lo smantellamento del vecchio legame tra la comunità e il territorio e la
rivendicazione di una nuova identità territoriale.
Come agente del processo di globalizzazione, anche il turismo genera la reazione contraria alla
sua intenzione primaria: di fronte ad una realtà sempre più omologata e senza barriere,
prendono forza movimenti tesi a mettere in evidenza la differenza, processi attraverso cui un
gruppo si autoattribuisce una omogeneità interna e – contemporaneamente – una diversità nei
confronti degli altri6. Nel caso del turismo, il paradosso del processo di globalizzazione è reso
ancora più forte dal duplice piano su cui si muove. Da un lato, ritroviamo le rivendicazioni
identitarie territoriali di coloro che vivono nei territori turistici; dall’altro, è presente un
paradosso interno allo stesso mercato turistico: condizione indispensabile per il suo sviluppo è,
infatti, l’abbattimento di tutte le barriere che rendono difficili gli spostamenti e il passaggio di
informazioni, ma accanto a questo presupposto troviamo la necessità di mettere in evidenza il
particolarismo locale dal quale dipende il potere attrattivo di un territorio. La negoziazione
territoriale derivante dal turismo avverrà, quindi, su due differenti livelli e ad opera di soggetti
diversi: da un lato, avremo la costruzione dell’immagine che gli operatori turistici proiettano sul
territorio e che, in alcuni casi, i residenti faranno propria; dall’altro avremo la rivendicazione
territoriale dei locali che non si riconoscono nell’immagine turistica e che reagiranno a questa
proiezione attraverso un rafforzamento dei significati simbolici, politici e sociali che “da
sempre” 7 legano la comunità al territorio in cui vive.
Come sostiene Burns8, il turismo non è solamente un insieme di affari commerciali, un
processo, o un insieme di pressioni, bensì un complesso insieme di sistemi che include
l’ambiente costruito e naturale, il possesso di modelli, le relazioni tra i paesi da cui proviene e in
cui arriva il turista, la relazione tra la località turistica e la più ampia società. L’introduzione di
un territorio all’interno del mercato turistico comporta, quindi, inevitabilmente un processo di
trasformazione territoriale che include sia l’ambiente costruito che naturale sia l’ambiente
antropico, rendendo necessaria una nuova definizione del proprio territorio all’interno dello
spazio.
Nel momento in cui l’antropologo si accinge alla ricerca sul campo di un’area turistica, si troverà
quindi di fronte ad una realtà in cui convivono – in modo più o meno pacifico – diverse
immagini territoriali appartenenti ai diversi soggetti, legati al territorio da interessi di differente
natura. Il campo dell’antropologo verrà, quindi, a configurarsi come un luogo di
incontro/scontro tra costruzioni territoriali diverse. In un tale contesto, sarà quindi inevitabile
per l’antropologo essere inserito all’interno delle dinamiche territoriali di potere.
Come già sottolineavo nel primo contributo sul tema spazio-territorio-campo, i rapporti di
potere costituiscono un elemento essenziale nella ricerca antropologica, sia come “oggetto di
conoscenza” sia come “strumento di conoscenza”. Tali rapporti hanno, infatti, un ruolo
fondamentale nel delineare l’aspetto politico, sociale, economico e culturale di un territorio,
così come svolgono una funzione di legittimazione del lavoro svolto dall’antropologo,
delimitandone e caratterizzandone il campo di indagine. L’antropologo sarà quindi condizionato
da coloro che, rendendo possibile la sua permanenza sul campo, chiederanno in cambio
6
Fabietti U., 1998 (ed. or. 1995), p. 21.
Non è questo l’ambito in cui inserire il tema dell’autenticità della tradizione. Per approfondimenti in proposito
rimando a Hobsbawm J., Ranger T., 2002 (ed. or. 1983).
8
Burns P. M., 1999, p.1.
7
39
dell’autorizzazione data alla ricerca la legittimazione della propria funzione politica, economica,
sociale o culturale svolta in seno alla comunità. Per l’antropologo sarà dunque tutt’altro che
facile procedere alla decostruzione delle immagini territoriali prodotte dai vari soggetti,
collocandosi al di sopra delle parti e mantenendo il contenuto della propria ricerca il più
neutrale possibile.
Mi rendo conto di aver messo molta “carne al fuoco” e di avere dato solo brevi accenni ad ogni
elemento chiamato in causa. Il tema spazio-territorio-campo è chiaramente un tema vastissimo
e, se anche viene ristretto il campo di applicazione, rimanda comunque ad una miriade di temi
ad esso collegati. Spero comunque di aver fornito uno spunto di riflessione per nuovi produttivi
dibattiti.
Della perduta tenda
Famiglie di concetti: spazio, campo, territorio.
Sergio Contu
Dopo tutto, il terreno dell’antropologia è limitato solo dall’uomo.
Non dipende dal tempo – va indietro nella geologia fino alle prime tracce
di esistenza dell’uomo. Non limitata dal territorio, riguarda il mondo intero.
L’antropologia si è specializzata sui primitivi perché nessun altra scienza si
voleva seriamente occupare di loro, ma non ha mai rinunciato all’intenzione
di studiare anche le altre civilizzazioni. L’antropologia è interessata a ciò che
è più esotico dell’umanità, ma anche a noi, qui, ora, a casa.
Kroeber – Anthropology today
Tracciare un quadro prospettico che abbia come punti di fuga - da una parte, il dispositivo
umano –
e dall’altra dei luoghi, vuol dire confrontarsi con una linea d’orizzonte che razionalmente va
molto oltre i punti di fuga indicati. Per tanto inserire entità descrittive all’interno del supposto
quadro risulta essere un operazione alquanto complessa, dove la rappresentazione oggettiva dei
fenomeni sociali e culturali è costantemente in bilico fra illusione e distorsione. Per ciò occorre
triangolare il punto di vista dell’osservatore con i punti di fuga, limitando una zona del quadro
in cui lo spazio è inteso come prodotto sociale.
Uno sguardo paleo-antropologico – da etnologia del profondo – come quello di Leroi-Gourhan
fa emergere in questa limitazione d’orizzonte una dimensione quasi ontologica, perché la dove
lo spazio si umanizza, si va oltre la semplice facilitazione tecnica, ma come per il linguaggio si
ha l’espressione simbolica di un comportamento completamente umano.
Comportamento che al di la delle configurazioni etniche, risponderebbe ad una triplice
necessità:
creare un ambiente efficiente dal punto di vista tecnico, fornire un inquadramento al sistema
sociale,
mettere ordine a partire da un punto dato nell’universo circostante (Leroi-Gourhan, 1977: 374).
Ciò che pone in rilievo l’autore di Il gesto e la parola, ha come matrice ideale il concetto di
morfologia sociale.
40
Concetto comune a molte discipline di studi umani, ha come centro d’interesse la distribuzione
territoriale dei fenomeni sociali, a partire dalle forme di insediamento della popolazione, e in
genere della configurazione e localizzazione spaziale di collettività, gruppi, attività economiche
politiche e culturali, processi sociali, istituzioni, associazioni, di una determinata società o area
culturale [Gallino, 1983: 499].
La nozione fu elaborata dalla scuola sociologica francese, e da Durkeim a Mauss passò e si diffuse
all’interno del dibattito internazionale grazie alle autorevoli voci che ruotavano attorno alla
rivista “Annales”. Il complesso rapporto fra spazio e gruppo umano non fù più letto in termini
essenzialmente geografici, ma in termini relazionali, sommando alle coordinate disposizionali
l’insieme delle relazioni economiche, sociali e culturali caratteristiche del gruppo considerato.
Seguendo questa lettura l’organizzazione spaziale di un gruppo umano diventava elemento
strutturante nel momento in cui era assimilato al fatto sociale totale maussiano.
Sul finire degli anni ’50 furono alcuni antropologi americani a rinnovare l’interesse per i
rapporti ambiente spaziale –cultura. Julian Steward fu uno dei primi sostenitori
dell’impostazione d’indagine nota come ecologia culturale.
Incentrata sull’analisi delle relazioni cultura e ambiente, secondo Steward, alcuni aspetti della
variabilità culturale potevano essere spiegati attraverso il rilevamento dei processi di
adattamento del dispositivo umano al suo ambiente spaziale specifico. Le proposte di Steward
furono seguite da una personale verifica empirica, i cui resoconti non mancarono di destare un
certo interesse, tanto che nel corso degli anni ’60 diversi studiosi si mossero nella direzione da
lui aperta.
Andrew Vayda e Roy Rappaport, decisi a convogliare i principi dell’ecologia biologica nelle
impostazioni dell’ecologia culturale. Rappaport con il suo Maiali per gli antenati, monografia
etnografica dedicata agli orticoltori melanesiani Tsembaga, contribuii alla diffusione della
nozione di ecosistema come unità d’analisi, che più della concezioni legate alla morfologia
sociale era in grado di spiegare le relazioni tra assetto demografico, istituzioni e ambiente.
Altri studiosi che si erano formati con Steward alla Columbia University trovarono la sua
proposta di ecologia culturale poco attenta alla storia e agli equilibri internazionali. Alcune di
queste figure divennero i rappresentanti dell’approccio economico- politico in antropologia
spostarono la loro attenzione dal rapporto fra spazio naturale e spazio sociale a l’impatto sociale
e politico che su di esso proiettavano, attraverso il colonialismo, le potenti società statuali.
Seguendo queste impostazioni divennero celebri i lavori di Eric Wolf e Sidney Mintz su una
comunità presa in esame a Puerto Rico o di Eleonor Leacock sugli indiani naskapi del Labrador,
o a livello di messa in discussione di problemi più generali, i lavori di André Frank e Immanuel
Wallerstein.
La prospettiva dell’economia –politica e del sistema mondo ha reso evidente il peso storico dei
processi politici ed economici, sconfessando il mito che raccontava le società extraeuropee come
entità isolate, immobili e prive di storia. Steward, Wolf e Wallerstein hanno dimostrato che il
mitico villaggio isolato è stato raggiunto da tempo e che la sua storia e anche quella delle strade
che lì ci hanno condotto, perché come scrive Lenclud (citato da Lai,2000: 26):
L’analisi etnologica dello spazio non inizia veramente se non quando colui che la conduce si sforza di
accedere al punto di vista indigeno e si interroga sulle determinazioni in funzione delle quali gli uomini
studiati costituiscono il loro spazio, delimitandolo, designandolo, pensandolo in tutte le forme e in tutti i
suoi aspetti, imprimendovi insomma il marchio rivelatore della loro identità.
41
Ed è cosi che quelle stesse strade si sono aperte su un altro spazio, che abbiamo imparato a
chiamare campo.
Da unità significante del lessico antropologico tradizionale, sottoposta ad una molteplicità di
pratiche che ne volevano modificare il significato, l’espressione campo, ha assunto significati
polivalenti, finendo per indicare tanto uno spazio geografico, il luogo in cui si conduce la
ricerca, quanto l’oggetto stesso della ricerca. Dietro quella che può sembrare un banale
scivolamento metonimico possiamo scorgere le tracce di un movimento di portata più ampia
che, dalla rivoluzione etnografica malinowskiana e alla conseguente fondazione della retorica
di campo, ha portato verso un idea di campo come sola costruzione retorica.
Nella ormai celebre introduzione di Argonauti del Pacifico occidentale l’antropologo polacco
scriveva:
Nessuno si sognerebbe mai di dare un contributo sperimentale alla fisica o alla chimica senza
fornire un resoconto dettagliato di tutti i preparativi degli esperimenti e una descrizione esatta
degli strumenti adoperati, del modo in cui le osservazioni sono state condotte, del loro numero
[…] in altre scienze […] questo non si può fare con lo stesso rigore, ma ogni studioso farà del
suo meglio per rendere comprensibile al lettore tutte le condizioni in cui l’esperimento o le
osservazioni sono state compiute. In etnografia, dove è forse anche più necessaria, un
esposizione senza pregiudizi di tali dati non è mai stata fornita in passato con sufficiente
generosità e molti autori non illuminano con piena sincerità metodologica i fatti in mezzo ai
quali si muovono, ma ce li presentano piuttosto come se li tirassero fuori dal capello del
prestigiatore (1978: 38)
Alla netta presa i posizione nei confronti degli armachair anthropologists, il nostro fa seguire
l’enunciazione delle tre pietre angolari del lavoro sul campo ovvero, avere un oggetto e un
metodo, vivere in mezzo agli indigeni ed applicare un certo numero di metodi per raccogliere
informazioni.
La necessita di un contatto diretto con la vita locale corrisponde a quella che Malinowschi
chiama la pietra angolare più elementare che, con il suo piantare la tenda al centro del villaggio
fonda il paradigma in cui l’esperienza di campo è l’espressione stessa dell’autorità etnografica.
Abbandonato il progetto ottocentesco di perseguire una scienza generale dell’uomo, l’etnografo
oriento i suoi sforzi verso un nuovo genere di olismo, non più teso alla formulazione di giudizi
universalmente validi, ma orientato alla rappresentazione di un particolare modo di vivere nella
sua forma più completa, contestualizandone e sistematizandone gli elementi socio-culturali.
Ciò fu possibile solo stabilendo una connessione profonda fra lavoro sul campo e scrittura
etnografica. Scrittura che incorporando i dettami del paradigma malinowschiano comincia sul
campo. È qui che ciò che viene fissato – dialogo, commento, descrizione – diverrà metafora e
modello. Il campo è lo spazio in cui si dispone la scrittura.
La definizione professionale, la competenza e la pratica dell’antropologia si concretizza in un
dispositivo narrativo in cui il corpo di una cultura prende forma nella testimonianza competente
del professionista. In ciò il campo risulta essere una versione della realtà sociale dalla
rappresentazione testuale che la produzione e la diffusione del sapere antropologico richiede
alla monografia di campo.
42
La monografia standard, indipendentemente dal campo in cui è maturata, si propone come un
lavoro di sintesi e analisi, che dalle condizioni di lavoro sul campo apre un piano di osservazioni
descrittive, limitato nello spazio e nel tempo, su cui passa l’immagine di una società o di una
cultura che, veicolata dalle convenzioni narrative è del tutto indipendente dalle metodologie di
rilevazione.
Tramite la retorica dello sguardo (“Ero là, mi accadde là tal cosa”), anch’essa emanazione di una
teoria della conoscenza che esalta l’importanza del vedere, la monografia crea l’illusione
dell’immediatezza del rapporto con l’oggetto, facendo così dimenticare la distanza storica e la
distanza della scrittura. In altri termini, è la scrittura con le sue procedure di schematizzazione,
l’elemento indispensabile per organizzare l’esperienza dell’antropologo sul campo e per
trasformarla in un prodotto intellettuale (Kilani, 1997: 41)
La scrittura del testo monografico classico trasforma le forme sociali e culturali in entità
descrittive che, sottratte al tempo e alla dimensione locale si configura, nella retorica del
presente etnografico, ad una rappresentazione concreta che annulla ogni eterogeneità fisica e
temporale fra tempo del lavoro sul campo e tempo della scrittura.
Su questo genere di riflessione si è costituito il retroterra culturale nel quale si è venuta ad
impiantare, da prima l’antropologia interpretativa geertziana, poi quella parte della teoria postmoderna che vedeva nella critica culturale e nella sperimentazione testuale gli strumenti più
adatti a decostruire i presupposti e le categorie alla base dell’analisi e della scrittura antropologia
occidentale.
Ma la realtà contemporanea, anzi la surmodernità come la ha definita Augé, non è strutturata su
opposti chiaramente contrapposti e definibili, ma produce “immagini in movimento che
incrociano spettatori deterritorializzati” (Appadurai) fruitori di contenuti altrettanto
deterritorializzati, ma immessi in flussi distributivi in cui l’immaginazione, la finzione
costruttiva – poietica – (Remotti) ancora gli spazi d’azione.
Malgrado sia difficile negare l’avanzato stadio di deterritorializzazione della cultura, esso sfugge
quando si è posti di fronte alla dicotomia occidente – non-occidente in quello che Scott
definisce “la localizzazione del soggetto e oggetto antropologico”, e nonostante i territori non
possano essere gli unici contenitori delle culture si continua a pensare ad una stretta analogia fra
cultura, popolo e territorio
Nel 1936 in Introduzione al pensiero matematico Friedrich Waismann propone una metafora
che chiama famiglia di concetti:
[…]i vari concetti di numero (numero cardinale, numero intero, ecc.) formano una famiglia, i cui
membri hanno gli uni con gli altri una certa somiglianza famigliare. In che cosa consiste la somiglianza
reciproca dei membri di una famiglia? Alcuni hanno lo stesso naso, altri le stesse sopracciglia, altri lo
stesso modo di camminare ecc.; e, di queste somiglianze, una non esclude l’altra. Non possiamo affermare
affatto che tali componenti abbiano tutti in comune una certa proprietà; e se anche esistesse questa
proprietà comune, nulla ci assicura che essa sola esaurirebbe in sé tutta la somiglianza famigliare. Proprio
in questo significato, noi diremo che il termine “numero” non denota un concetto (nel senso della logica
classica), ma una “famiglia di concetti”. Con ciò vogliamo affermare che i diversi tipi di concetti sono
legati l’uno all’altro in modi diversi, non essendo affatto necessario che essi posseggano tutti una stessa
proprietà né uno stesso carattere. La medesima cosa può ripetersi per i termini “aritmetica”, “geometria”,
“calcolo”, “operazione”, “dimostrazione”, “problema” ecc. Essi denotano “famiglie di concetti”, e non ha
43
alcun interesse il discutere sulla loro precisa delimitazione. Se – poniamo – si vuol spiegare il concetto di
aritmetica, ci si riferirà a qualche esempio concreto, e si estenderà poi al concetto in questione fin dove si
estende la somiglianza con gli esempi considerati. Il carattere di indeterminatezza proprio di questi
concetti ha, del resto, esso pure il suo lato vantaggioso; dobbiamo infatti a tale carattere se la nostra
lingua riesce ad inserire nuove scoperte in schemi già noti (1944: 315-316).
Leggendo il passo di Waismann ci rendiamo conto che le considerazioni epistemologiche poste
in evidenza hanno una valore euristico che può essere esteso anche al pensiero antropologico.
Semplicemente sostituendo al lessico matematico quello etno-antroplogico è resa evidente la
somiglianza familiare che può essere rintracciata anche nella nostra triade concettuale.
Nelle sue analisi anche l’antropologia come le scienze matematiche si serve di processi deduttivi,
processi che a loro volta sono basati su processi di comparazione che, assegnando
corrispondenze fra domini può creare similarità concettuali.
La comparazione –corrispondenza ha origine da un primo elemento che stabilisce il primo
dominio dal quale un giudizio categoriale diretto ad un secondo dominio stabilisce una
corrispondenza unidirezionale, il qui grado di somiglianza è tale da essere considerati parte di
una stessa categoria (concetto). Questa generale assimilazione cognitiva assume una certa
valenza nei procedimenti di comparazione etno-antropologici quando i domini su cui si opera
sono assimilabili alle polarità emico, etico.
Nei casi etnografici l’assimilazione a priori decade e si fa contesto-dipendente ed il tipo di
similarità cambia a seconda dell’oggetto, della sua entità e a seconda dell’osservatore-autore, che
può disporre alternativamente similarità globali o similarità parziali, geertzianamente partite in
similarità superficiali (attribuzioni) e similarità profonde (relazioni).
Nel nostro caso sembra che gli elementi percettivi e gli elementi concettuali che, in
comparazione e singolarmente, concorrano a definire la nostra triade concettuale facendo
riferimento ad un'unica immagine-schema che un passo di Remoti sintetizza verbalmente:
Ogni società è fatta di luoghi e di corpi, ovvero di corpi che vivono, operano, interagiscono,
abitano certi luoghi. […] Come non possiamo pensare a una società se non in quanto costituita
da individui che coincidono visibilmente con i loro corpi, così non possiamo considerare una
società se non occupante un certo spazio, e più precisamente luoghi dello spazio (Remoti, 1993:
31)
Tutto ciò può essere ipotizzato perché nella realtà empirica le categorie non si formano in base
al possesso di un certo numero di tratti sufficienti e necessari, ma a partire da prototipi (Piasere).
Il prototipo è l’elemento che meglio rappresenta il proprio dominio di appartenenza, da cu in
posizione privilegiata primeggia nelle elaborazione dei giudizi categoriali; assunto che vale
anche nel caso della nostra triade:
Una molteplicità di pratiche rende sfuocato il significato di “lavoro sul campo”e ne esclude una
definizione netta […] Le definizioni basate sul concetto assumono un prototipo, spesso un immagine
visiva, per stabilire un nucleo centrale su cui vengono poi giudicate le varianti. La famosa foto della
tenda di Malinowski piantata nel mezzo di un villaggio delle Trobriand è stata considerata a lungo come
una forte immagine mentale del lavoro sul campo in antropologia […].
Ci sono state altre immagini: rappresentazioni di interazione personale: per esempio le foto di Margaret
Mead che si piega affettuosamente verso una madre balinese e il suo bambino.
44
[…] la stessa parola “campo”evoca immagini mentali di uno spazio sgombero, di coltivazione, di lavoro,
di terreno. Quando parliamo di lavoro nel campo, o di andare nel campo, attingiamo a immagini mentali
di un luogo distinto con un interno e un esterno, che raggiungiamo con pratiche di movimento fisico.
Queste immagini mentali focalizzano e costringono le definizioni. Esse, per esempio, ci fanno
considerare improprio affermare che un antropologo, uomo o donna, che assume informazioni per
telefono dal suo studio stia svolgendo lavoro sul campo, anche se quello che sta compiendo in effetti è la
raccolta disciplinata, interattiva, di dati etnografici. Le immagini materializzano i concetti,producendo
un campo semantico che appare ben chiaro al “centro” e più incerto sui “margini”. La stessa cosa si
verifica con concetti più astratti. Un ventaglio di fenomeni sono raccolti intorno a prototipi; per
deferenza verso Kuhn […], parlerò di esemplari. Allo stesso modo in cui un pettirosso viene considerato
più tipico come uccello rispetto a un pinguino e aiuta a definire il concetto di “uccello” , così alcuni
esemplari di lavoro sul campo consentono di tenere insieme esperienze eterogenee. Il lavoro sul campo
di tipo “esotico”, condotto per un periodo continuativo
di almeno un anno, ha costituito per qualche
tempo la norma su cui altre pratiche vengono giudicate. Misurate su questo esemplare, diverse pratiche
di ricerca interculturale appaiono come un lavoro sul campo meno “reale”. […]
Nel tentativo di cogliere le tracce del mutamento delle relazioni dell’antropologia con il viaggio, può
tornarci utile pensare al “campo” come un habitus piuttosto che a un luogo, come cioè un gruppo di
disposizioni d’animo e pratiche fatte proprie, incarnate (Clifford, 1999: 73-74; 93)
Per un lessico antropologico del XXI secolo sembra utile sostituire i prototipi con nuovi
attrattori semantici capaci di andare al di la degli habitus, per uno spazio d’azione condiviso
dove l’indeterminatezza, per dirla con Waismann, riesca ad inserire nuove scoperte
in schemi già noti.
Bibliografia
− Aime, M., 2004, Eccessi di culture, Torino, Einaudi
− Clifford, J., 1999, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, trad. it. Torino,
Bollati Boringhieri
− Ember, C. R. & Ember, M., 2000, Antropologia culturale,trad. it. Bologna, il Mulino
− Kilani, M., 1997, L’invenzione dell’altro, trad. it.,Bari, Dedalo
− Lai F., 2000, Antropologia del paesaggio, Roma, Carocci
− Marcus G. E. & Fischer M.M. J., 1998, Antropologia come critica culturale, trad. it.
Roma, Meltemi
− Mauss, M., 2002, Saggio sul dono, Torino, Einaudi
− Piasere, L., 2002, L’etnografo imperfetto, Bari, Laterza
− Remotti, F., 1993, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del potere,
Torino, Bollati Boringhieri
45
La “politica” del territorio: spazio di dominio, spazio di identità.
Note per la discussione sulle categorie di territorio, spazio, campo.
Umberto Pellecchia.
Le brevi note che seguono prendono avvio dallo stimolo maturato nel corso del Dottorato di
Ricerca in Metodologie della Ricerca etno-antropologica e si basano su una serie di riflessioni
che il mio campo di ricerca mi ha offerto e tutt’ora continua ad offrirmi su un tema classico ma
non inattuale dell’antropologia africanista, il concetto di territorio.
All’interno delle innumerevoli connessioni che mi vengono in mente riguardo un concetto
estremamente ampio come questo, ho cercato di ritagliare una serie di spunti etnografici e
bibliografici che cercano di individuare il territorio come concetto politico, ovvero come spazio
di pratiche e discorsi che stabilisce le fondamenta ideo-logiche delle relazioni sociali e che ne
determina il senso.
Dando uno sguardo alla storia della mia area di ricerca – quello che potremo chiamare il mio
campo – ovvero l’area Sefwi del Ghana sud-occidentale appartenente al ceppo etnico Akan - ci
si rende conto che il territorio quale è concepito attualmente è frutto di una serie di percorsi
storici iniziati con la volontà di conquista da parte di alcuni gruppi che si autoidentificavano
secondo un unico criterio parentale, ovvero una comune appartenenza matrilinea. Questi
gruppi, che chiamerò di conquista, hanno condotto la loro espansione territoriale grazie a due
modalità: in primo luogo – naturalmente – la guerra; in secondo luogo attraverso una serie di
alleanze matrimoniali sia con i residenti autoctoni sia con immigrati provenienti da fuori.
Questo gruppo – chiamato asankera – è, secondo l’ideologia locale tutt’ora diffusa dal Potere, il
gruppo fondatore e quindi quello da cui discende l’attuale famiglia matrilinea dei detentori di
autorità9. La logica era sinteticamente questa: un Capo appartenente al gruppo asankera sposava
una donna del gruppo autoctono o immigrato costituendo un sistema di alleanze basato sulla
parentela. La parentela è servita quindi come mezzo di umanizzazione di un luogo, come
criterio di imposizione di una identità e, in definitiva, come logica di dominio.
Sulla base di queste logiche si sono venuti a costituire i primi regni e si è iniziata a fondare
quella che a mio parere può essere intesa come la struttura portante della logica del potere
locale, ovvero la territorializzazione, che permetteva non solo uno sfruttamento particolare
delle risorse (agricoltura, commercio) ma anche un criterio di identità, basato su “chi è membro”
e “chi non lo è”, una sorta di prima forma di etnicizzazione (Mbembe, 2004).
Sulla base di questa, con la colonizzazione britannica, si è avviato un secondo e più ampio
processo di etnicizzazione del territorio, basato sullo stabilire in maniera precisa confini, cariche
e identità. L’autorità coloniale ha congelato consuetudini e pratiche locali attraverso una regola
fondata sull’ordinamento di norme e cariche, che permettevano - nella logica coloniale –
l’amministrazione del territorio. L’indirect rule, come tradizionalmente viene definita questa
forma amministrativa con una accezione che credo sia troppo sintentica, non ha creato qualcosa
dal niente: ha avviato quello che molti Autori, credo giustamente, hanno definito un processo di
costruzione (Viti, Adas, cit. in Boni, 1999).
Ad oggi, nella coesistenza di due regimi politici – quello “tradizionale” e quello governativo – il
concetto di territorio e il conseguente criterio legato all’autorità, ciò che ho chiamato
9
L’autorità di cui parlo, tanto per intenderci, è quella definibile “tradizionale”, costituita su un ordinamento simile al
regno, con un Re e dei sotto-capi per ogni villaggio. A fianco di questa sussiste oggi il sistema governativo, altrimenti
definibile “moderno”.
46
territorializzazione, mantiene ancora una valenza “politica” che determina conflitti e dissensi.
L’Autorità esercita, infatti, un dominio sul territorio, che non è solo economico – e con ciò
intendo territorio come terra, suolo, risorsa economica - ma anche identitario, in un ultimo
senso, politico.
Oggi viene a mancare indubbiamente il momento della conquista, per cui lo spazio diventa
apparentemente solo spazio di identità: in realtà, a ben vedere, se si analizza l’etnografia, il
territorio rimane ancora uno spazio conteso e quindi uno spazio di dominio. Due esempi per
tutto, presi un po’ dal “tradizionale” un po’ dal “moderno”10: da un lato abbiamo numerosissime
dispute tra Capi-villaggio su questioni fondiarie. Dall’altro abbiamo il territorio come oggetto
elettorale, per i partiti di ispirazione (e solo di ispirazione!) democratica, con una accesa contesa
su chi manovra meglio l’elettorato.
Ancora, quindi, i poteri si contendono il territorio, preso vicendevolmente come spazio di
dominio e la creazione di identità - mobili e porose al loro interno ma rappresentate come fisse,
etniche, ancora oggi – non è ancora cessata.
In quanto oggetto etnografico, il territorio è un campo di indagine. Con il concetto di campo
non mi riferisco tanto ad un contesto geograficamente posizionato, quanto a un ambito teorico,
ad una dimensione etnologica dove il ricercatore, come dice Piasere, “curva il suo spazio-tempo
per andare a co-costruire esperienze con persone che non fanno parte della sua giornata
abituale” (Piasere, 2002: 45).
Questo forse intende quel tipo di antropologia legata allo strumento teorico della rete, quando
parla di multiposizionalità, che, a mio parere, è tanto dell’attore quanto del ricercatore, il quale
si situa su un punto di osservazione che gli consente di vedere più dinamicità che staticità. Da
ciò discende non solo un ripensamento delle categorie metodologiche ed etnografiche ma anche
una riconcettualizzazione costante delle categorie di analisi, siano esse potere, parentela,
identità.
L’osservazione etnografica del territorio ritengo si basi, innanzitutto, nel concepirlo nella sua
dimensione storica e quindi in connessione alla categoria di tempo. Il territorio è fonte
simbolica, dimensione storicizzata dalla società che vi vive. Il territorio in quanto storia funge
da memoria sociale, è lo spazio di contesa ideologica al cui interno le varie memorie giocano a
contendersi dimensioni politiche e sociali: le genealogie - frutto costante di ripensamenti
ideologici, di costruzioni politiche e di retoriche – sono lo strumento privilegiato di dominio
nella mia area di ricerca: la ricaduta sta nella differenza che si viene a creare tra chi si vuole
discendente dei fondatori – e quindi in “vantaggio storico” – e chi di immigrati o schiavi. Questa
differenza crea dipendenza, laddove la dipendenza si basa sul ricordo, politicamente esercitato,
di un passato strumentale all’accesso delle risorse.
La nozione di spazio è stata utilizzata in questo breve scritto nel senso di concetto teorico,
strumento per territorio e campo. In effetti mi sembra la nozione più teorica e ampia, che spazia
(appunto) dall’antropologia politica a quella cognitiva. Lo spazio è creato nonostante l’assenza di
supporto fisico, che mi sembra invece centrale nel territorio: la lettura di genealogie e la
narrazione di tradizioni orali creano uno spazio che ha il vizio della non-più-esistenza perché
relegato nel passato, ma la cui valenza è assolutamente presente in quanto crea autorità.
10
Quando parlo di “tradizionale e moderno”, beninteso, seguo semplicemente l’ideologia locale, prendendola come dato
etnografico.
47
In conclusione, ciò che qui ho inteso come politica del territorio è un oggetto etnografico in
grado di individuare, attraverso vari mezzi di indagine, lo spazio della conquista e del dominio
che consente al Potere di esercitare la sua autorità e che, allo stesso tempo, determina nella
pratica sociale quotidiana la scelta degli attori, la loro strategia, il senso sociale delle loro azioni:
in definitiva, il loro spazio di identità.
Bibliografia
− Augè, M., 2004, Poteri di vita, poteri di morte, Raffaello Cortina, Milano, (ed. or. 1973);
− Boni, S., 1999, La struttura tradizionale sefwi tra invenzione e ordinamento, in Africa
(Roma);
− Boyardin, J. (ed.), 1994, Remapping memory. The politics of time-space, University of
Minnesota Press, Minnesota;
− Izard, M., 1985, Gens du pouvoir, gens de la terre. Institutions politiques de
l’ancien royaume du Yatenga (Bassin de la Volta Blanche), Cambridge University
Press-Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Cambridge-Paris ;
− Izard, M., 1994, Del trattamento politico dello spazio, in Etnosistemi 1, 1: 6-12;
− Mbembe, A., 2005, Postcolonialismo, Meltemi, Roma, (ed. or. 2000);
− Piasere, L., 2002, L’etnografo imperfetto, Laterza, Roma-Bari;
− Vincenti, J.F., Dory, D. & Verdier, R., (eds.), 1995, La construction religieuse du
territoire, L’Harmattan, Paris ;
− Viti, F., (1998), Il potere debole. Antropologia politica dell’Aitu Nvle, Franco
Angeli, Milano;
Campo
Alberto Acerbi
L'immagine popolare dell'antropologo è quella di un uomo (nel senso di "maschio"), che rimane
da solo, per mesi - o anni in casi rari - tra estranei ("Altri"), con un taccuino in mano, un
giubbotto fornito di numerose tasche e un cappello per ripararsi dal sole. Quanto è distante
questa immagine dalla realtà? Gli antropologi non sono certo esclusivamente uomini (al
contrario, potrebbe esserci un'inversione di tendenza, almeno rispetto all'immagine popolare:
nel nostro dottorato, per esempio, negli ultimi tre cicli, le donne rappresentano circa il 60%
degli iscritti), i taccuini sono sempre più spesso sostituiti da computer portatili e i giubbotti con
le tasche sembrano passati di moda. Quello che rimane (oltre al cappello) è il fatto che agli
antropologi sembra venire in effetti richiesto di fornire descrizioni dettagliate di fenomeni
estremamente complessi attraverso ricerche condotte per lo più in solitudine.
Nel mondo della ricerca, oggi, "interdisciplinarità" è una parola magica: in un progetto della
commissione europea, con scadenza febbraio 2006, per finanziare ricerche su "Cultural
dynamics: from transmission and change to innovation" (tema quindi congeniale agli
antropologi) si legge, nel paragrafo 4 ("WHAT KIND OF RESEARCH *WILL NOT* BE
48
PURSUED?") che non verrà nemmeno presa in considerazione una ricerca "which is monodisciplinary, or where there is no substantial interdisciplinary dialogue across conceptual
boundaries"!
Ma, quali sono i vantaggi dell'interdisciplinarità? Due motivi mi spingono a pensare che l'
interdisciplinarità non sia qualcosa di buono *per sé*. Innanzitutto, come afferma il filosofo della
mente Jerry Fodor, non è necessario conoscere la botanica per studiare astronomia (e viceversa),
ossia non è detto che una disciplina abbia per forza qualcosa da dire ad un'altra; in secondo
luogo, sebbene sia plausibilmente vera l'affermazione "la realtà non è disciplinare, la scienza sì"
(altra frase magica, questa di Domenico Parisi), coloro che la studiano - la realtà - non possono
sapere tutto di tutto e potrebbe convenire, in molti casi, dividersi il lavoro.
Tuttavia, sembra che l'antropologia, proprio per il suo oggetto di studio (faccio finta di avere le
idee chiare su quale sia) è, almeno intuitivamente, una delle discipline che avrebbe più da
guadagnare adottando un'ottica interdisciplinare. Allo stesso modo, almeno da parte delle
cosiddette "scienze umane", è sempre più chiara la povertà di uno studio degli esseri umani che
ne mutili le componenti socio-culturali.
L'unico esempio recente di interdisciplinarità "forte", almeno a mia conoscenza, che gli
antropologi abbiano messo in atto è quello con gli studi letterari. Di questo io non parlerò.
Altri esempi, che ritengo molto più produttivi, riguardano, per esempio, collaborazioni tra
antropologi, scienziati cognitivi e psicologi evoluzionistici, finalizzati a una migliore
comprensione dei meccanismi e degli effetti della trasmissione e dell'evoluzione culturale o,
ultimamente, tra antropologi ed economisti (soprattutto esperti di game theory) che hanno
prodotto notevoli risultati (vedi per esempio "Foundations of Human Sociality: Economic
Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies", Oxford University
Press, 2004).
Non è possibile qui entrare nel dettaglio e motivare perchè in questi casi mi sembra che le
ricerche interdisciplinari stiano funzionando (lo ho fatto altrove più in dettaglio per il primo dei
due, che è quello che conosco meglio).
Ciò nondimeno, questi rimangono casi abbastanza isolati, almeno nel nostro panorama: per
quali motivi? Potrebbe essere (come afferma l'etnobiologo e antropologo cognitivo Scott Atran,
al quale ho rubato anche la comparazione tra immagine popolare e reale dell'antropologo) che le
ricerche interdisciplinari richiedono uno sforzo organizzativo - e, soprattutto, economico molto maggiore delle ricerche tradizionali. Oppure, potrebbero esserci ragioni più sostanziali, o
teoriche, sulle quali si potrebbe riflettere. O, semplicemente, non ci sono ragioni particolari e, in
questo caso, quali potrebbero essere le collaborazioni più interessanti, e in che casi specifici?
49
Riflessioni
Teodora Mocan
I temi di cui ci stiamo occupando quest'anno sono, come per tanti altri dottorandi, al centro
della mia ricerca su cui ultimamente sto riflettendo in una maniera più approfondita. Premetto
che stiamo parlando di temi molto interessanti e complessi, perciò altrettanto ambigui e difficili
da delimitare in una maniera netta e chiara. Cercherò in seguito di dare un contributo al nostro
incontro di Pontignano e, nello stesso tempo, di "svelare" alcuni tratti del mio campo di ricerca.
Per quanto riguarda il campo (inteso come luogo della propria ricerca), il mio lavoro di
ricerca si svolge nell' area di Codru dove sto esaminando le forme e i processi con cui alcuni
personaggi, ribellatisi al potere costituito del loro tempo e definiti haiduci,1 viteji, curajosi,
fantastici, puternici, ecc. e il modo in cui sono entrati successivamente a far parte della memoria
collettiva delle comunità locali e di una più ampia comunità nazionale che, anche attraverso la
patrimonializzazione di queste “figure del ricordo” (ASSMAN J. 1997) hanno costruito e
continuano a costruire la loro appartenenza identitaria. Più in particolare il mio lavoro è stato
incentrato sulle figure di Pintea e Blidaru, entrambi vissuti nell’ area montana di Codru2, in
Transilvania.
Gli haiduci romeni, i briganti italiani, i cangaçeiros brasiliani, i bandoleros andalusi o i
rasboiniki e i cosacchi russi - e si potrebbe naturalmente continuare - hanno esercitato e
continuano ad esercitare un prolungato fascino fondato anche sulla loro ambigua appartenenza
e alterna fortuna. Si tratta di soggetti che, spesso provenienti dalle classi popolari, attraverso
mezzi violenti, combattimenti, aggressioni, rapine, si pongono in conflitto con il potere
costituito, ma per alcuni gruppi sociali e per diverse ragioni essi assumono un valore positivo o
vengono in epoche successive riabilitati. Sono considerati ribelli contro il potere costituito, ma
anche difensori dei deboli; sono combattuti e sconfitti ma anche talora riabilitati e considerati
eroi; sono personaggi pittoreschi ma vengono anche assimilati a figure fantastiche; sono attori di
eventi “meravigliosi”. Anche la loro vita si trova al confine di mondi diversi: i briganti vivono
una vita di difficoltà e disagi che li accomuna ai ceti più umili, ma ottengono talora anche
improvvise ricchezze. Sono crudeli e violenti e, allo stesso tempo anche combattenti coraggiosi
in difesa della patria e dei deboli e attori di vicende eccezionali che diventano meritevoli di
essere narrate. Non stupisce dunque che essi in molti casi si siano venuti a costituire come
“figure del ricordo” elaborate e costruite attraverso varie modalità comunicative, dalle
narrazioni e racconti popolari ai fogli volanti, dai testi letterari, ballate e canzoni alle stampe e
1
haiduc (pl. haiduci) potrebbe essere tradotto in italiano con brigante, ribelle e il DEX (Dizionario Esplicativo della
Lingua Romena) del 1998 ne da questa definizione: 1.“ uomo che, mettendosi contro un regime, lascia la sua casa e va a
nascondersi nelle foreste, da solo o in gruppo, rubando dai ricchi per aiutare i poveri”; 2. soldato mercenario; (dalla
parola bulgara “hajduk”). Secondo Hobsbawm, sono singoli o gruppi di uomini liberi, “armati e agguerriti; si formarono
in seno a coloro che erano stati cacciati dalle loro terre o che si erano sottratti alla servitù, in un primo tempo
spontaneamente, più tardi in forme organizzate” (HOBSBAWM E. J. 1959: 65)
2
Sulle “comunità di memoria” si veda IRWIN - ZARECKA Iwona - Frames of remembrance: the dynamics of
collective memory (1994) si Eviatar ZERUBAVEL - Social mindscapes: an invitation to cognitive sociology (1997)
50
dipinti, fino alle produzioni teatrali e cinematografiche di cui essi sono protagonisti. Sono figure
che assumono rilievo nella memoria collettiva di intere comunità in quanto vengono condivise,
non solo nei contenuti ma anche nelle forme, dagli individui che ne fanno parte che si
costituiscono come “comunità di memoria”.
In Romania, tutti i ribelli sono stati denominati haiduci, indifferentemente dal periodo
storico in cui hanno vissuto o dai caratteri del potere costituito al quale si sono opposti. La
categoria di haiduc ha un carattere costruito e ambiguo come le altre categorie di “brigante" che
nel resto d’ Europa hanno accomunato personaggi che si ribellavano all’ ordine costituito per
finalità sia di interesse personale, per sfuggire alla povertà o per vendicarsi di un torto subito, sia
per impegnarsi in lotte politiche e in difesa di particolari categorie di cittadini per lo più deboli e
oppressi. Ricostruire le vicissitudini di questa rappresentazione, ovvero l’invenzione e il
successo del termine haiduc è un’ impresa difficile, da delimitare e da articolare per la corposa
letteratura di saggistica storica che è stata prodotta, a cui si aggiungono narrazioni e ballate
popolari e per la necessaria interpretazione del discorso politico, che ne costituisce lo sfondo, e
che, via via, sancisce la fortuna o l’ occultamento delle gesta dei singoli personaggi. Il fatto che
essi siano entrati a far parte della memoria di un gruppo e quindi del riconoscimento di un suo
passato collettivo e di una sua identità è l’esito di un processo non automatico, ma frutto di
scelte selettive e di altrettante “dimenticanze”.3 Anche oggi siamo di fronte ad iniziative locali di
patrimonializzazione, da parte di comunità locali che si riappropriano della storia di briganti che
in quelle comunità sono nati o vissuti, per trasformarla in risorsa culturale, rivendicandone
l’appartenenza comune e l’ancoraggio in una realtà locale. Tracce della memoria, narrazioni e
documenti si trasformano in “beni culturali” da valorizzare per le nuove generazioni, segno
distintivo di identità locale rispetto ad altri territori, perciò segno di un territorio particolare.
Uno dei primi studiosi che analizza il fenomeno del brigantaggio e del banditismo
comparandolo in paesi diversi e che analizza in questo contesto anche l’ haiducia è Eric J.
Hobsbawm che nel 1959, pubblica I banditi. Il banditismo sociale nell’età moderna. Partendo
dalla convinzione che il banditismo sociale (con cui identifica quasi tutte le forme storiche del
brigantaggio), sia “una forma piuttosto primitiva di protesta sociale”, che si riscontra
universalmente “in tutte le società fondate sull’agricoltura” Hobsbawm considera il ribelle
strettamente legato alle condizioni delle masse contadine e, per questa ragione, il banditismo e il
brigantaggio gli appaiono come “uno dei fenomeni sociali più universali della storia,
caratterizzato da una straordinaria uniformità”. Questa uniformità, è il riflesso di situazioni
simili che si possono verificare “all’interno di varie società contadine”.(HOBSBAWM 1959,
p.12) Per questa ragione cerca di individuare, in una prospettiva comparativa, i tratti comuni del
fenomeno presente in differenti aree del mondo, dall’Europa - Grecia, Italia, Spagna, Bulgaria,
Russia, Turchia - all’India e Tunisia o ai paesi dell’America Latina ai Balcani.
Per quanto riguarda l’etimologia della parola haiduc, Traian IONESCU – NISCOV (1958),
folclorista e letterato romeno vissuto nella prima metà del secolo scorso, suggerisce alcuni spunti
che ritrova in ambito pastorale e cerca di analizzare il carattere ambiguo e polisemico del
termine. Le sue ricerche si indirizzano verso un’etimologia ungherese della parola, che sarebbe
3
Il rapporto tra memoria e identità collettiva è stato per la prima volta messo in luce da Maurice HALBWACS (Les
cadres sociaux de la mémoire, Paris, 1925; Conscience individuelle et esprit collectif, Paris, 1939; La mémoire
collective, Paris, 1950)
51
penetrata in Romania nel XVI secolo attraverso le spedizioni militari compiute sul territorio
della Transilvania. Nel XV secolo un grande numero di pastori serbi, croati fuggivano
dall’invasione turca verso le pianure ungheresi, dove le parole slave dell’ambito pastorale,
hayto, heido, haido, trovarono una sintesi nella parola ungherese haydu, che aveva con esse una
radice comune. Si venne così formando una specifica categoria di persone, che si occupava della
vendita degli animali nel mercato europeo, da Venezia alla Moravia, dall’Ungheria alla
Germania. Questi mercanti di bestiame erano chiamati heyducks ed erano reclutati non solo tra
i pastori e i capi di bestiame delle pianure ungheresi, ma anche tra gli abitanti dei villaggi liberi.
Alcuni di loro, per difendersi dai ladri, che spesso li attaccavano durante i loro viaggi si
armavano e si organizzavano in gruppi. All’inizio del XVI secolo, a seguito di numerose
restrizioni, cominciò a declinare il mercato del bestiame e i pastori, rimasti senza il loro lavoro,
cominciarono a compiere razzie nelle campagne.
Il mio sguardo si è rivolto, in questi anni di ricerca sul campo, verso la figura di Blidaru,
brigante di una personalità ambigua, considerato oggi, a 50 anni della sua morte eroe
anticomunista e spia nello stesso tempo. Nel trentennio successivo tra la sua morte, avvenuta nel
1958 e la caduta del regime, sulla sua figura era calato il silenzio da parte delle istituzioni e delle
fonti ufficiali, mentre a livello locale l’ identificazione con alcuni brigati vissuti
precedentemente consentiva di mantenerne la memoria. La caduta del regime ha segnato una
nuova fase relativa alla costruzione della sua memoria e che è rivolta alla sua
“patrimonializzazione”, una fase che è ben lontana dall’ essere conclusa e a cui partecipano in
vario modo diversi soggetti. A livello più generale essa si inserisce nel quadro di un progetto di
revisione della storia recente e più precisamente della storia del periodo comunista ad opera
degli istituti internazionali e nazionali di storia recente, come per altro in tutto il resto dell’
Europa dell’Est. In Romania vedono la luce negli ultimi anni numerosi studi sulla letteratura
carceraria, sulla resistenza armata nelle montagne, sulle biografie di haiduci più o meno noti.
Si tende a valorizzare il conflitto, la ribellione, la resistenza contro il vecchio regime e le
sue testimonianze che entrano a far parte del patrimonio locale e nazionale: dalla
documentazione d’ archivio, alle fonti orali, alle biografie. Nello stesso tempo anche nella zona
di Codru la memoria di Blidaru non viene conservata solo attraverso i racconti popolari di cui si
è detto, trasmessi in ambito familiare e locale, ma anche attraverso iniziative pubbliche e la
costituzione di pubblici "luoghi di memoria” luoghi che catalizzano e vivificano le memorie.
Tali possono essere considerati le lapidi che nel suo paese natale sono state collocate ad opera
dei figli sia in luoghi pubblici (come, per esempio, la croce imponente in marmo che lo ricorda,
collocata nel perimetro della chiesa locale), sia in luoghi privati (come la stele collocata di fronte
alla casa del figlio o come il monumento funerario nel cimitero del paese a sua moglie morta nel
1997). Ma anche a livello urbano nella città più vicine, molti ricordano di avere incontrato
Blidaru nel periodo in cui era in clandestinità e ne traggono motivo di vanto. Naturalmente la
memoria di questo personaggio viene nutrita in modi differenti da diversi gruppi sociali che
utilizzano anche differenti modalità di trasmissione. Essa vive sia nell’ interazione quotidiana
sociale e linguistica di singoli individui sai nella diffusione di forme scritte, visive o nella
costruzione di manufatti. Si tratta di forme diverse di produzione e uso della memoria, a partire
da oggetti, luoghi, eventi, personaggi, a cui la figura dell’ haiduc offre un ricordo fondante
(ASSMANN 1992), confermando l’ attualità di una riflessione su questo fenomeno.
52
Bibliografia
− Assman, J., 1992, Das kulturelle Gedachtnis. Schrift, Erinnerung und Politische Identitat
in fruhen Hochkulturen, Munchen, .Ch. Beck’ sche Werlagsbuchhanblung
− Blok Anton (1974) The mafia of a sicilian village 1860-1960, New York Harper & Row
Publisher
− Boyardin, J. (ed.), 1994, Remapping memory. The politics of time-space, University of
Minnesota Press, Minnesota;
− Burawoy, Michael, & Verdery, Katherine, 1999, Uncertain transitions. Ethnographies of
change in the postsocialist world, Rowman&Littlefield, Lanhan
− Cheater, Angela, 1999, The Anthropology of Power. Empowerment and
disempowerment in changing structures, Routledge, New York
− Ferguson, James & Gupta, Ankhil, 1992, Space, identity and the politics of difference, in
Cultural Anthropology 7 (1)
− Hobsbawm, Eric J., 1966, I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, Torino, Einaudi ed.
originale (1959) Primitive Rebels, Manchester, Manchester Universiy Press
− Hobsbawm, Eric J., 1971, I banditi. Il banditismo sociale nell’ età moderna, Torino,
Einaudi ed. originala (1969) Bandits, London, Weidenfeld and Nicolson
− Halbwachs, Maurice, 1950, La mémoire collective, Presses Universitaires de France,
Paris
− Irwin & Zarrecka, I., 1994, Frames of remembrance: the dynamics of collective memory,
New Brunswick, N. J. Transaction
− Ionescu & Niscov, Traian, 1958, Haiducia si cantecele haiducesti, in “Revista de Folclor",
anul III, n. 2, p. 113 - 126
− Lefebvre, Henri, 1991, The production of space, Cambridge
− Stocking, George W. Jr., 1998, Bones, Bodies, Behaviour. Essays on Biological
Anthropology, University of Wisconsin Press, London
− Verdery,Katherine, 1999, The political lives of dead bodies. Reburial and Postsocialist
Change, Columbia University Press, New York
− Verdery,Katherine, 1996, What was socialism and what come next?, Princeton
University Press, Princeton
− Zerubavel, E., 1997, Social mindscapes: an invitation to cognitive sociology, Cambridge,
Mass., Harvard University Press
53
Pratiche11 spaziali e relazioni di potere. Corpi12 e macchine13.
Brevi note su campo, spazio e territorio
Roberta Pompili
Lo spazio è fondamentale in ogni forma di vita comunitaria; lo spazio è fondamentale in ogni
esercizio di potere….Ricordo che nel 1966 un gruppo di architetti mi invitò a fare uno studio
dello spazio, di un qualcosa che all’epoca chiamavano “eterotopie”, quegli spazi singolari che si
trovano in certi spazi sociali e le cui funzioni sono diverse se non adirittura opposte ad altre. Gli
architetti lavoravano a questo e alla fine dello studio un tale- uno psicologo sartriano- mi assalì
dicendo che lo spazio è reazionario e capitalistico mentre la storia e il divenire sono
rivoluzionari. (Foucault 1984 citato in Harvey 2002).
Le pratiche spaziali e temporali non sono mai neutrali per quanto riguarda gli aspetti sociali.
Esse esprimon sempre un certo contenuto di classe o un contenuto sociale di altra natur, e sono
spesso al centro di una intensa lotta sociale. (Harvey 2002)
Vorrei partecipare a questa discussione partendo da un punto di vista particolare e situato.
Osservo alcune delle fotografie che anni fa ho realizzato insieme ad un amico e che riguardano
alcune strade dove le donne lavoravano e in parte ancora lavorano durante la notte. Seleziono
delle immagini che mi aiutano a tornare in luoghi in cui è avvenuta una parte significativa del
mio lavoro, del mio campo.
Sebbene il materiale14 sia diacronico, sfocato, in una certa misura storicizzato e fittizio (si tratta
di foto scattate di giorno e volutamente senza la presenza delle sex workers) esso evoca alcune
riflessioni a mio avviso pertinenti ai nostri temi di lavoro di Pontignano.
Dove lavorano, o meglio -visto che la mobilità non è solo un tratto distitintivo della nostra
epoca ma riguarda concretamente anche i corpi flessibili di chi vende le proprie prestazioni in
strada- dove lavoravano le sex workers fino al 2000 nella citta di Perugia? Perché quei luoghi e
non altri? Quali sono state le mie frequentazioni, i miei viaggi, le mie andate e ritorno per
incontrarle? Quali attori costituivano concretamente la scena del mio oserei dire “campo di
battaglia”?
Cercherò di fare solo alcune brevi osservazioni partendo con l’intento di indicare alcuni ipotesi
di lavoro.
Decido di scegliere di partire dalle foto, come ho detto, e di dare un ordine alla narrazione. Esso
non è casuale, ma riguarda sempre una scelta, una scelta legata ad alcune assenze ed alcune
presenze degli scatti. Una scelta che è soggettiva e insieme politica. E che mi aiuta a ripensare il
11
Mettere in evidenza le pratiche è un modo di studiare (de Certau1980, Bourdieu 1995) un fare senza partire dal suo
prodotto. Il concetto di pratica per de Certau si giustifica attraverso il concetto di tattica, intesa come arte della
resistenza, della differenza e del detournement. La pratica implica i concetti strategici dello scarto, dell’infrazione, e
della destrutturazione. La pratica altera un luogo ma non ne fonda nessuno. De Certau 1980
12
Utilizzo il termine corpi riferendomi alla biopolitica di Foucault, come tratterò in seguito , il riferimento è ai corpi in
quanto soggetti localizzati (Appadurai 2001), ossia che imparano ad appartenere ad un insieme di reti e relazioni situate
attraverso un processo di incorporazione.
13
Questo titolo provvisorio sulle mie osservazioni non vuole focalizzare la mia ricerca in una semplice
contrapposizione dicotomica della realtà.
14
Correrò per qualcuno il rischio di mettere in scena un artificio retorico che nasconde una “mia” verità. D’altra parte se
concordo con un’ottica processuale e dinamica della realtà che renda conto delle pratiche come orizzonti di attività,
sono tesa a demistificare una certa apologia del postmodernismo e del postcolonialismo che copre il reale ordine del
presente costituito dal dominio dell’astrazione capitalistica (Zizek 2003)
54
“campo” come un sito in grado di produrre significati molteplici e di cui mi soffermo ad cercare
di afferrare almeno qualcuno di questi piani.
Ore 15.30 un pomeriggio di inverno (anno 2000) Zona Trasimeno Ovest una via nella zona
industriale che da Perugia va verso i capannoni industriali delle Officine Piccini, cancello
chiuso qualche abete i lampioni che illuminano la strada, le strisce pedonali davanti alla fabbrica
e un segnale di attraversamento pedoni. Nessuno attraversa la strada. Nessuno in strada. Non ci
sono marciapiedi. Solo macchine. Macchine. Davanti al cancello della fabbrica uno slargo dove
ho incontrato più volte delle donne. Più avanti Il Cache Cache negozio di abbigliamento con
piccolo parcheggio. Adesso come di notte è chiuso ma il suo parcheggio e luogo di incontro e di
via vai tra corpi e macchine.
Ripercorro la strada all’indietro nel mio ricordo e prendo la foto della stessa strada nello
svincolo che conduce da una parte alla superstrada e dall’altra al quartiere Ferro di cavallo.
Macchine. Su di un lato cammina su un piccolo marciapiede solo un uomo. Sotto i semafori un
migrante vende fazzoletti di carta e accendini. Un po’ più avanti una piazzola di sosta dove si
sno verificati molti incontri tra operatori e donne. Operatori in camper e donne a piedi.
Una zone un po’ periferica, piano dove il precedente sviluppo industriale aveva cercato di
decollare (più avanti ancora c’è la fabbrica simbolo della città la Perugina) e che ora si sta
convertendo in luogo del consumo massificato soprattutto diurno, (spaccio delle fabbriche che
vendo al minuto, alcuni grandi negozi, nella stessa zona c’è la Warner Village)
Quelle stesse strade che collegano le nuove cattedrali del consumo e i vecchi luoghi della
produzione sono percorso attualmente solo da macchine e spesso dalla “nuda vita” dei migranti
(Agamben 1995). Migranti che tornano a piedi a casa con le buste, uomini che lavano i vetri o
vendono accendini. Di notte quel luogo diventa/va il luogo di vissuti, di esperienze e di vita di
molte donne provenienti da diversi Paesi (in particolare la Trasimeno Ovest è frequentata da
donne che potremmo definire15 genericamente proveniente dai Paesi dell’Est come Ucraina,
Moldavia, Romania, Polonia…) Corpi-merci esotici esposti nella vetrina urbana del consumo
sessuale.
Un altro salto indietro nella memoria e ritorno al camper degli operatori attorno al quale si
avvicinano alcune donne per prendere preservati. Qualcuna dice Oggi ci sono poche macchine.
Oppure ho fatto tot macchine, riferito al numero dei clienti. Lo sguardo delle donne reifica il
corpo del cliente nella metafora della macchina. Per attirare l’attenzione dei clienti, quando non
ci sono macchine, alzano le gambe e ne ostacolano il passaggio in strada, urlano, chiamano
Gianfranco!!! le macchine. Si affiacciano nei finestrini delle macchine invadendo lo spazio
dell’altro. Negoziano lo spazio e il territorio in una perenne scena di conflitto latente. Quando
arriva una macchina della polizia cercano di nascondersi e fuggono superando il gard rail
dirigendosi verso la campagna, lontano dalla strada, lontano dallo spazio urbano.
15
Gli stati-nazionali non sono mai stati realtà omogenee ed unitarie, ma costruzioni imposte ad un certo punto dallo
sviluppo delle forze produttive. Attualmente i cambiamenti sociale economici hanno portato alla decompressione dello
spazio tempo ( tra gli altri Harvey 2002. Appadurai 2001) e la conseguente crisi dello stato-nazione. Le migrazioni sono
una forma di attraversamento dei confini territoriali e culturali che si avvicina un’idea di movimento e nomadismo
resistente all’imposizione di un controllo egemonico (Deleuze e Guattari 1987) D’altra parte il dibattitto su
colonialismo e postcolonialismo (Young 2001) ricorda come le logiche di dominio tipicamente coloniali siano tracimate
al di fuori degli spaziin cui hanno avuto origine, fino ad investire la metropoli. Si tratta più o meno delle modalità di
messa a valore della forza-lavoro migrante, così come ancora nella organizzazione delle funzioni di controllo delle
cittadinanze autoctone in occidente (Mezzadra 2001)
55
Nel 2000 nasce un Comitato cittadino che si pone il problema di arginare la presenza delle
donne in strada, perché quando la miseria “circola nuda”16 è scandalosa.
Con un'altra operatrice conduciamo delle interviste ad alcuni abitanti di un’altra zona in cui
lavorano le prostitute.
…Hanno fatto anche una raccolta di firme, a Colleumberto, Pantano, sulla zona lì, perché una
cosa così, ci sono i ragazzini, è…uno spettacolo che non è bello. Poi ci sono stati anche gli
incidenti, nel senso che arrivano i clienti, vedono quella che è più appariscente di un’altra e
bum si fermano. Oppure addirittura argirano sulla strada lì, quella è una strada parecchio
transitata. Diciamo che fa il raccordo tra l’E7 e la Superstrada che va a Bettolle, quindi tagliano
di là e ci sono parecchi camion parecchio traffico, è pericoloso, ci è successo anche un incidente
mortale ultimamente, poi lo saprete.Anche perché quella zona lì, che c’erano i contadini, era
una zona di campagna, tutta tranquilla, è diventata tutto il contrario. Ventitrè anni che fo
quella linea lì e conoscevamo tutta la gente…invece un cambiamento repentino, co tutte ste
donne, con tutto sto via vai di macchine…
Una donna racconta di essere andata in strada a fare delle foto alle ragazze che poi sarebbero
state pubblicate sul giornale, e conclude il suo racconto dicendo: ci siamo presi tante di quelle
sassate che praticamente ho dovuto svuotare la macchina dalle sassate che ci avevano lanciato.
De Certau (1980) mette in evidenza come la pratica spaziale possa essere definita un modo d’uso
della città che mira ad appropriarsene. Si potrebbe mettere a confronto le politiche urbane che
offrono simulacri di comportamento e le pratiche di attori sociali che si pongono in conflitto
con essi. Il conflitto si definisce in un confronto in cui oltre agli attori sociali umani anche gli
oggetti, le stesse macchine oggetto di interesse e di manipolazione acquisiscono molteplici
significati.
Osservare le foto per rievocare la memoria del “campo”, ripercorrere i diari delle osservazioni e
dei dialoghi delle mie frequentazioni di campo, rileggere i dialoghi con altri attori sociali. La
pratica etnografica non è necessariamente legata ad un luogo preciso. Il campo ha molteplici
collocazioni. Gupta e Ferguson (1997) insistono su un’antropologia centrata su localizzazioni
più che campi delimitati.
Se il confine della ricerca è instabile e continuamente rinegoziato …può tornarci utile pensare
al campo come a un habitus piuttosto che a un luogo, cioè un gruppo di disposizioni d’animo
profondamente incarnate (Clifford 1996). Il corpo dell’etnografo rispecchia esso stesso i limiti di
“essere” situato in un contesto sociale e attraversato da differenze (di sesso, di razza,…)
Bibliografia
− Appadurai, A., 2001, Modernità in polvere, Meltemi, Roma
− Bourdieu, P., 2003, Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila,
Raffaello Cortina
− De Certau, M., 2001, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma
16
Evidentemente le donne spesso per attirare lo sguardo dei clienti vanno in strada “poco” vestite.
56
− Clifford, J., 1996,Strade. Viaggio e traduzione alla fine del XX secolo, Bollati Boringhieri,
Torino
− Foucault, M., 1984, The Foucault reader (a cura di Rabinow), Harmondsworth
− Gupta, A. & Ferguson, J, 1997, Discipline and Practice: “ The field as Site, Method and
Location in Anthropology, in Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a
Field Science, University of California Press, London
− Harvey, D., 2002, La crisi della modernità. Riflessioni sull’origine del presente, Ed NET,
Milano
− Mezzadra, S., 2001, Diritto di fuga. Migrazioni,cittadinanza, globalizzazione, Ombre
Corte, Verona
− Young, R. J. C., 2001, Postcolonialism. An Historical Introduction, Ma Blachwell Oxford,
Malden
− Zizek, S., 2003, 13 volte Lenin. Per sovvertire il fallimento del presente, Feltrinelli,
Milano
Note su campo e territorio
Francesca Polidori
Il mio lavoro di ricerca in Rwanda mi ha posto molte volte di fronte a degli interrogativi riguardo ai
concetti di spazio, campo e territorio. L'oggetto della mi ricerca sono i rimpatriati Tutsi che hanno
lasciato il paese agli inizi degli anni Sessanta a seguito dei primi massacri dei quali sono stati
vittime e che, dopo più di trent'anni di esilio, alla fine di una guerra da loro stessi scatenata e vinta,
sono tornati a vivere in Rwanda. E' facile quindi capire come il problema del territorio sia centrale
alla mia indagine. Si tratta di una popolazione che in parte ha subito ed in parte è stata protagonista
attiva di un processo di deterritorializzazione e riterritorializzazione, di una comunità multisituata
sia nel tempo -esilio e ritorno in Rwanda- che nello spazio- diversi i paesi di esilio sia in Africa che
in Europa, diversi i luoghi di residenza, campo o città, prima e dopo il ritorno- che negli anni si è
costruita su di un senso di appartenenza ad un luogo mitico, il Rwanda, “paese del latte e del
miele”, ma che è riuscita a riconquistare la patria tanto agognata grazie ad una mobilitazione
avvenuta attraverso reti transnazionali (parentali, etniche, religiose, politiche). La diaspora all’estero
ha fondato la sua identità sulla sua esclusione dal territorio di origine e sull’idealizzazione di una
patria perduta ma, una volta rientrata, ha dovuto cominciare un processo di reintegrazione
economica, sociale, culturale e simbolica, riappropriandosi di un luogo ormai sconosciuto e certo
molto diverso dall’immagine idealizzata che era stata trasmessa di generazione in generazione.
Molti studi sui rifugiati abbracciano quella corrente dell’antropologia post moderna che si
occupa di identità diasporiche, ibride e di frontiera che sfidano l' "ordine nazionale delle
culture" (Malkki, 1995) e “l'isoformismo tra spazio e cultura” (Gupta e Ferguson, 1992)
considerato come naturale. I rifugiati sono spesso considerati come non persone in quanto prive
di luogo, costituisco una sorta di “umanità in esubero” (Rahola, 2003) nel sistema internazionale
delle nazioni e per questo gli antropologi, e non solo, si sono interessati alle loro strategie
identitarie, strategie fondate su reti di relazione che spesso valicano le frontiere e che
“trascendono i limiti imposti, i confini del campo e della nazione ospitante, in un panorama […]
che effettivamente ridefinisce un senso di località e di comunità” (Van Aken, 2005). Nonostante
questa consapevolezza esistono due argomenti che sono stati trascurati dai “refugees studies”,
studi che raccolgono al suo interno molteplici discipline (economia, geografia, storia,
57
antropologia, psicologia…) ed entrambi gli argomenti riguardano da vicino la mia attuale
ricerca: i rimpatriati e i self settled refugees, cioè coloro che non vivono nei campi. Questo
scarso interesse può forse trovare due tipi di spiegazioni, la prima di natura epistemologica,
l’altra metodologica. Innanzitutto perché i rimpatriati, una volta tornati nel loro paese di
origine rientrerebbero nell’ordine internazionale delle nazioni, nella casella che spetta loro
nell’organizzazione mondiale secondo la quale ad ogni cultura deve corrispondere un dato
territorio: se i rifugiati sono vittime in quanto persone “fuori territorio”, il ritorno a casa
rovescia il loro status di vittima, e con esso non cessa soltanto il dispositivo umanitario che li
aveva assistiti fino a quel momento ma anche l’interesse di molti studiosi nei loro confronti.
Secondariamente, e questo riguarda molto da vicino la nostra discussione, i rimpatriati e i self
settled refugees sono difficili da trovare e da studiare poiché abitano in città oppure sparsi in
zone rurali. Paradossalmente il campo dei rifugiati corrisponde in tutto e per tutto all’ideale del
campo malinowskiano, in quanto luogo apparentemente isolato dal mondo circostante e
governato da logiche proprie: è per questo che la maggioranza degli antropologi ha preferito
compiere ricerche all’interno di campi, per ritrovare, nonostante l’intenzione di studiare un
fenomeno transnazionale, un ambiente facilmente circoscrivibile perché già delimitato dalle
pratiche e dai discorsi dell’azione umanitaria (ed è proprio l’analisi di tali pratiche e discorsi,
delle forme di resistenza e appropriazione messe in atto dai rifugiati ed del loro progressivo
divenire da oggetti a soggetti che sono il centro di questi studi)
Siamo quindi arrivati al secondo concetto guida della nostra riflessione, cioè quello di campo:
come abbiamo già ampiamente sottolineato, fenomeni quali la globalizzazione, l’urbanizzazione
, le migrazioni, forzate o no, hanno portato ad un ripensamento critico di quella esperienza (la
pratica etnografica) che può essere considerata come il fondamento stesso della nostra disciplina
Per quanto mi riguarda, non solo il mio campo è cambiato nel corso degli anni in quanto si è
trasformato l’oggetto dei miei studi e la sua collocazione nello spazio ma anche il territorio nel
quale mi sono trovata a fare ricerca ha subito delle trasformazioni oggettive, direi quasi
strutturali, che hanno profondamente mutato il paesaggio, lo stile abitativo e conseguentemente
la percezione e l’utilizzo dello spazio da parte degli attori sociali. La mia prima esperienza
etnografica in Rwanda, nel 2002 per la tesi di laurea, si è svolta in un ambiente rurale e
relativamente isolato, anche se vicino ad una cittadina, Butare. Con l’inizio della ricerca di
dottorato ho deciso, inseguendo i miei nuovi interessi, cioè i rimpatriati ai quali ho accennato
sopra, di spostare il mio “campo” dalla campagna alla città e alle zone ad essa limitrofe. Infatti
gran parte di coloro che sono tornati dopo l’esilio si sono trasferiti in città oppure in dei villaggi
raggruppati (umudugudu/pl. imidugugu) costruiti dall’UNHCR dopo la fine della guerra. In
Rwanda tradizionalmente, e così è stato fino al 1994, i villaggi non esistono e l’abitato è sparso
sulle colline: la nuova politica aveva come scopo non solo quello di fornire una casa a coloro
che l’avevano persa durante la guerra e il genocidio o che erano tornati dall’esilio, ma anche di
rendere più “razionale” l’utilizzo dello spazio. Gli imidugudu avrebbero permesso una più facile
distribuzione di acqua e energia elettrica e attraverso la netta separazione tra terre abitabili e
coltivabili avrebbero risolto l’annoso problema della carenza di terra e di pascoli (ovviamente
niente di tutto ciò è avvenuto). Il mio “campo” era quindi multisituato in quanto i rimpatriati
abitano in zone diverse della città e in imidugudu distanti tra di loro e questo inizialmente mi
procurava, oltre che problemi di natura logistica, anche un certo fastidio: ho passato i primi
mesi della mia ricerca tormentata dal problema di non trovare un luogo adatto a diventare il
“mio campo”, dove compiere perlomeno un tentativo di osservazione partecipante. Andando
58
avanti nel lavoro mi sono resa conto di come ogni tentativo di delimitazione fittizia di un
territorio in quanto spazio circoscritto per compiere una ricerca sia vano e ho spostato sempre
di più la mia attenzione su quelle reti di relazioni che attraversano il territorio rendendolo
significativo. Il fatto di aver abitato in diversi luoghi nella stessa zona (città, campagna,
imidugudu) mi ha aiutato a vedere come questi luoghi fossero fittamente collegati tra di loro da
connessioni di diverso tipo come reti familiari, migrazioni lavorative anche transnazionali, flussi
di commercio etc.: in altre parole le colline rwandesi, viste dalla città, non sono poi così isolate
come mi erano parse quando avevo compiuto la scelta masochistica di soggiornarvi per la mia
prima ricerca sul campo. Tutto questo mi ha portato a riflettere su come il nostro sguardo, che
si presume essere scientifico, sia sempre orientato dagli scopi che ci prefiggiamo, sulla difficoltà
ad avere uno approccio olistico al nostro oggetto di studio (come ci suggeriva l’ideale
malinowkiano) e su come il campo non sia altro che un insieme di relazioni coltivate (con
fatica) dall’antropologo al fine di produrre conoscenza in "una dialettica tra esperienza e
interpretazione” (Clifford, 1988). E attraverso il rapporto spesso problematico ma non per
questo privo di frutti tra questo due poli (e così anche campo e scrittura, etnografia e teoria…)
che si costruisce la nostra disciplina. La prima volta che sono arrivata in Rwanda, un vecchio
professore mi ha accolto dicendo che la mia ricerca era destinata sicuramente a fallire dal
momento in cui non avrei mai potuto “leggere dentro il cuore dei rwandesi” perché straniera,
bianca, donna e giovane: il fallimento pareva essere già scritto nelle mie caratteristiche innate.
Durante il mio ultimo soggiorno un vicino di casa che mi stava dando un passaggio in macchina,
scoprendo che ero antropologa mi ha chiesto se attraverso le mie ricerche ero già riuscita a
“cogliere il mistero del genocidio rwandese” a trovare delle spiegazioni per un fatto che a lui
stesso, pur avendolo sperimentato, pareva folle e privo di senso: “il problema è che noi rwandesi
siamo incapaci di comprendere perché siamo troppo all’interno della logica che lo ha
generato...quando qualcuno corre veloce con la macchina non si rende conto della velocità e
rischia di fare un incidente, la velocità è percepita più facilmente da chi resta sulla strada, ma
non troppo lontano, giusto sul bordo…”. Mi è piaciuta questa immagine dell’antropologo come
qualcuno che entra nella macchina, che prova a cogliere il punto di vista emico ma che al
momento giusto, prima di fare un incidente, torna sulla strada cercando di recuperare la giusta
distanza tra sé ed il proprio oggetto di studio e che in seguito, attraverso la scrittura, cerca di
rendere comprensibili i fenomeni osservati dandone un’interpretazione che vada oltre il senso
comune.
In conclusione vorrei proporre altri due temi di discussione, che in parte siano già stati sollevati,
il primo relativo al concetto di campo, il secondo a quello di territorio. Quando si parla di
campo sarebbe interessante anche mettere l’accento sull’ultima fase del nostro lavoro cioè il
passaggio necessario e non privo di difficoltà da esperienza di campo a descrizione etnografica e
teoria antropologica che si compie con l’elaborazione di un prodotto scritto possibilmente
compiuto ed unitario. Per quanto riguarda spazio e territorio mi piacerebbe invece affrontare il
tema della mobilità, lo studio delle popolazioni “fuori territorio”, partecipi di processi di
deterritotializzazione e riterritorializzazione in spazi di frontiera, tema che tra l’altro mi pare
accomunare molte delle nostre ricerche.
59
Bibliografia
− AAVV, 2005, Rifugiati, in Antropologia, anno 5, n.5
− Gupta A. & Ferguson J, 1992, Beyond "Culture": Space, Identity and the Politics of
Difference, in Cultural Anthropology, vol.7, n.1, pp.6-23
− Malkki L, 1995, Purity and Exile. Violence, Memory and National Cosmology among
Hutu Refugees in Tanzania, University Chicago Press, Chicago
− Rahola, F, 2003, Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell'umanità in eccesso,
Ombre Corte, Verona
Riflessioni
Claudia Avitabile
La comunità nella quale ho svolto la ricerca di dottorato, nello Yucatán, ad Oxkutzcab, è
composta di circa 24.000 abitanti, è ad economia prevalentemente agricola, ma questa riesce ad
essere scarsamente competitiva per la mancanza di tecnologie che incrementino la produzione e
ne assicurino la costanza.
Un fattore sociale ed economico forte nella comunità, di conseguenza, è l’emigrazione in
Messico, che inizia già negli anni Quaranta come migrazione interna, dalle zone rurali alle città,
causata dalle laceranti condizioni di povertà nelle campagne legate alla frammentazione
accentuata della proprietà terriera, alla caduta progressiva dei prezzi dei prodotto agropecuari, al
sovrasfruttamento delle risorse, ed infine al deterioramento dell’economia contadina basata sulla
monocoltura. Città del Messico, che più di tutte le altre città messicane ha assorbito emigranti
dalle varie zone rurali del Paese, attorno agli anni Ottanta del XX secolo ha saturato le
possibilità ricettive. La successiva destinazione è stata quindi la migrazione extra-nazionale,
verso i vicini Stati Uniti.
L’emigrazione degli uomini verso gli Stati Uniti, che si è incrementata nelle ultime due decadi
fino ad ampiezze straordinarie, è ormai un fenomeno massivo. Per quanto l’emigrazione sia
praticamente sempre illegale e sia difficile, quindi, quantificarla, approssimativamente il
numero di uomini emigrati da Oxcutzcab verso gli Stati Uniti (quasi sempre in particolare verso
San Francisco, California) è stato stimato sulle duemila persone. Si tratta di una emigrazione che
individua destinazioni ben precise, nelle quali quindi gli uomini ricostruiscono in dimensioni
ridotte il gruppo d’origine, compreso quello familiare, anche perché, per lo più, è una
emigrazione temporanea, anche di decenni, ma finalizzata al rientro nel luogo di origine. Il
ricongiungimento delle famiglie è quindi sempre in Messico e non negli Stati Uniti.
Tutto ciò ha creato sul piano sociale una femminilizzazione dell’agricoltura di sussistenza ed un
aumento senza precedenti per il Messico dell’incorporazione delle donne al lavoro salariato.
Fino a questo periodo, il lavoro della donna si era svolto quasi esclusivamente tra le mura
domestiche, differenziandosi tra la cura dei figli, l’igiene della casa e della famiglia, la
preparazione degli alimenti. Accanto a questi tre cardini, la donna occasionalmente aiutava nel
campo, vendeva i prodotti della terra, allevava animali domestici, raccoglieva e trasportava
legna, produceva artigianato, lavava per terzi, o preparava tortillas e altri cibi per la vendita,
assisteva con le cure la propria famiglia o per il vicinato. Se era necessario integrare l’economia
60
familiare con un lavoro remunerato, la donna poteva essere panettiera, partera, commessa,
specialista in preghiere, fabbricante di amache, addetta al mulino per il mais, cuoca in
cerimonie, modista, curandera, infermiera, maestra. Con la crisi dell’agricolutra e l’inizio
dell’emigrazione, la donna ha iniziato ad esplorare nuove opportunità economiche che
aiutassero la famiglia a far fronte alle necessità. Ma l’impatto non è stato meramente economico.
Di pari passo, è nata, infatti, una tipologia di relazione matrimoniale definibile come
“coniugalità a distanza”, un modello di vita, forse transitorio, che influenza anche le dimensioni
di tempo e spazio. Si assiste oggi all’appropriazione femminile di spazi fino a poco tempo fa
monopolizzati degli uomini, la femminilizzazione di compiti e occupazioni, lo spostamento
delle frontiere concettuali dei generi e la riorganizzazione del sistema uomo-donna anche nella
quotidianeità, a volte con elevati costi sociali.
Nell’arena familiare e domestica si giocano le relazioni di genere e generazionali e la coniugalità
senza corresidenza sostenuta nel tempo comporta la continua negozazione tra marito, moglie e
suocera dei processi decisionali relativi all’ambito domestico, alla cura dei figli, degli anziani, dei
beni materiali e simbolici del marito, tra cui il prestigio, l’onore, il buon nome e l’immagine
dell’assente. A carico dell’uomo, invece, la nuova coniugalità comporta il mantenimento e la
riproduzione del vincolo mediante l’impegno prolungato di fornire il sostegno economico,
dimensione primordiale della mascolinità in questo contesto, intimamente legata al
riconoscimento dell’autorità nella stessa figura.
In sintesi, l’emigrazione maschile produce una messa in discussione ed un riassesto delle
frontiere, dei limiti e dei divieti – materiali e simbolici – che connotano spazi significativi per la
distinzione di maschile e femminile. Le differenze tra privato e pubblico entrano in crisi e
l’omologazione tra spazio extradomestico, spazio esterno e spazio pubblico deve essere
ridefinita. Privato/pubblico, esterno/interno, aperto/chiuso, fuori/dentro cadono come
distinzioni tassative e predefinite e vengono ricontestualizzati.
La dimensione del tempo partecipa di questo processo. La nascita del lavoro salariato femminile
ed anche la femminilizzazione dell’agricoltura rendono visibile il lavoro invisibile svolto fino a
questo momento dalle donne. Questa invisibilità ne garantiva una disponibilità illimitata,
sempre a disposizione degli obblighi e delle responsabilità familiari. Il “tempo proprio”, fino ad
ora, era stato assente dalla vita di molte donne.
Rispetto alla tematica dell’essere sul campo devo riconoscere che la mia presenza lì è stata
agevolata dal calore e dalla disponibilità di tutte le persone che ho incontrato e con cui ho
parlato ad Oxkutzcab, che si sono messe in discussione nel corso delle interviste, mi hanno dato
fiducia e stima.
L’inserimento è avvenuto in un contesto nel quale c’è una facile riconoscibilità, date le
dimensioni della comunità e il relativo isolamento della stessa da flussi turistici o commerciali.
Questo fattore genera spesso delle aspettative inattese alle quali non si può rispondere, in quanto
ricercatori, ma alle quali a volte si può dare una spiegazione, si possono in qualche misura
controllare. Per molte titolari, il mio ruolo di donna adulta, “bianca”, proveniente da una
località esterna al contesto, istruita e che ha potuto pianificare la sua vita prescindendo dai ruoli
di moglie e madre, mi assimilava alle dottoresse o agli addetti del censimento socio-economico.
In generale, mi attribuivano un potere decisionale o un peso consultivo nell’ospedale, per
quanto da me sentissero sottilineare che conducevo uno studio autonomo dal governo
messicano.
61
Nella fase iniziale di molte interviste è stato necessario e doveroso spiegare, più o meno a lungo,
il senso ed il fine del colloquio. A volte la mia presentazione è stata fatta da terze persone,
dell’ospedale, che hanno dato una propria interpretazione della posizione dell’antropologo nel
contesto specifico, in base anche alla novità di una figura di questo tipo sul posto.
Spesso si è creata anche la difficoltà nel definire la provenienza geografica, in quanto lo stato
estero del quale si ha esperienza sono gli Stati Uniti. Ho cercato di spiegare la localizzione
dell’Italia, ma a volte mi sono adeguata alla collocazione in una lontananza imprecisa e
sicuramente non raggiungibile per le donne che me la proponevano, senza irriggidirmi su
specificità poco influenti.
Ho sottolineato spesso, invece, che non ero una laureata in medicina, perché questa specificità
influiva nelle aspettative create su di me e sul mio operato. Spesso, nella difficoltà di relazionarsi
con il termine “antropologo” che non aveva spessore nel vocabolario di molte intervistate, sono
stata assimilata ai docenti delle scuole per l’uso di penne e quaderni. In questo caso ho accettato
l’avvicinamento ad una figura professionale in cui c’è una forte prevalenza della parte teorica.
Alcuni infermieri si sono sentiti giudicati o esaminati dalla mia presenza alle lezioni ed è stato
necessario chiarire che la mia era una ricerca conoscitiva, non valutativa del loro operato. Ma,
nel corso delle interviste, a volte si è rovesciata la relazione ed è emerso l’interesse di alcune
infermiere a dialogare del proprio lavoro perchè sono poche o inesistenti le occasioni per fare
una valutazione del genere, una riflessione critica sui ruoli e le finalità dell’operare. In molte
interviste con medici e paramedici mi è stata rivolta una richiesta di interazione e di raffronto
con la situazione italiana, medica, sociale, assistenziale.
In conclusione, il mio posizionamento nel corso dell’incontro con le parteras, avvenuto in
ospedale, in occasione di una riunione mensile tra le levatrici formate dall’ospedale e l’assistente
sociale, è stato peculiare. Per quanto sia stata formalmente presentata dall’assistente sociale, la
vera “accettazione” è avvenuta nel momento in cui una anziana partera che avevo incontrato
l’anno precedente grazie ad una amica, che era sua paziente, si è ricordata di me e ha
socializzato questa conoscenza. Questa seconda “presentazione” ha generato la caduta della
diffidenza o del disagio che si era creato e ha innescato una accettazione da parte di tutto il
gruppo, concretizzatasi in baci, abbracci e “benedizioni”, auguri e la disponibilità a contattarle
telefonicamente.
In alcune interviste, specialmente con le titolari e con la partera, ho valutato importante partire
dal vissuto e condividere esperienze simili o opposte, rendendo l’intervista una relazione
dialogica, un confronto fra persone che si modificano reciprocamente.
Bibliografia
ALLUÉ XAVIER, Cultural competence in Medicine, in “AM. Rivista della società italiana di
Antropologia medica”, n. 11-12, pp. 243-254, Argo, ottobre 2001, Lecce.
ARANA MARCOS, Las fórmulas para la alimentación infantil, in La antropología médica en México,
a cura di CAMPOS NAVARRO ROBERTO, collana Antologías Universitarias, vol. II, Instituto MoraUniversidad Autónoma Metropolitana, 1992, México.
BARRERA BASSOLS DALIA-OEHMICHEN BAZÁN CRISTINA (a cura di), Migración y relaciones de género en
México, GIMTRAP-UNAM, 2000, México.
62
BARTOLI PAOLO, Antropologi, amas de casa e curanderos: appunti da una ricerca in corso in una
comunità nahua dello stato di Guerrero, Messico, «Quaderni di Thule», Atti del XXIII Convegno
Internazionale di Americanistica, Perugia, 4-5-6 maggio 2001, Centro Studi Americanistici
“Circolo Amerindiano”, Argo, 2002, Lecce.
CAMPOS NAVARRO ROBERTO, La calidad de vida en hospitales con atención a pueblos indígenas.
Actividades recientes en el programa Imss-Solidaridad, in Calidad de vida, salud y ambiente,
2000, México.
MENÉNDEZ EDUARDO L., Poder, estratificación y salud. Análisis de las condiciones sociales y
económicas de la enfermeded en Yucatán, CIESAS, Ediciones de la Casa Chata, 1981, México.
PIZZA GIANNI, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Carocci, 2005, Roma.
RAMÍREZ CARRILLO LUIS ALFONSO, Mujeres de Yucatán y Mérida, Análisis Cuantitativo, Universidad
Autónoma de Yucatán. Ayuntamiento de Mérida, 2001, Mérida.
WARMAN ARTURO, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, Fondo de Cultura Economica,
2003, México.
E’ l’antropologo a scegliere il proprio “campo”, o il “campo” il suo antropologo?
Giulia Pedone
Nel precedente contributo avevo suggerito di guardare al “campo” come ad uno spazio di
interazione dinamico, costruito attraverso un processo di relazioni sociali e negoziazioni tra gli
attori sociali che convergono su un territorio. La proposta era dunque quella di “recuperare
l’etnografo come vero attore sociale, immerso in una ragnatela costituita da relazioni e sensi, in
cui il campo di ciò che è osservato dipende dalle scelte intraprese a livelli multipli di fronte alle
aspettative ed alle costrizioni di tutti gli attori sociali presenti in quella data situazione
etnografica”. (Pacheco de Oliveira, 2005:317).
Considerando la situazione etnografica come un sistema di relazioni sociali, e di potere, vorrei
riflettere su quei fattori che contribuiscono alla costruzione, da parte dell’antropologo, del
proprio “campo”. Le scelte iniziali, concepite a partire dagli obiettivi personali ed animate dalle
aspirazioni maturate ancor prima di arrivare sul campo (inteso in questo caso come territorio
fisico, estraneo e spesso geograficamente distante), vengono a scontrarsi inevitabilmente con le
aspettative ed il ruolo attribuito all’antropologo dagli altri attori sociali che convergono sul quel
territorio. Comincia quindi una lunga, e mai conclusa, attività di interazione e negoziazione tra
“noi” e “gli altri” il cui obiettivo è quello di cercare un compromesso tra le nostre intenzioni e la
nostra volontà di azione in un determinato “luogo” (sociale e fisico) e la volontà altrui di
inserirci nel contesto locale, a partire dai propri interessi e dalle proprie interpretazioni.
“La territorialità comporta una discriminazione sociale tra “sé” e “gli altri” e al tempo stesso un
modo di contatto. Il territorio è frutto di una combinazione tra una componente spaziale e una
componente sociale. Esistono confini territoriali, ma anche confini sociali. I primi definiscono
lo spazio, i secondi chi lo abita. Si tratta di vedere infatti chi sono i soggetti della territorialità e i
detentori dell’esclusività a essa collegata”. (Moruzzi, 1983:17)
Destreggiarsi in questo “giuoco delle parti” non è sempre semplice; il significato che gli altri
attori sociali attribuiscono al lavoro dell’antropologo o alla sua stessa figura di ricercatore, e la
“parte” che vorrebbero quindi assegnargli, difficilmente corrisponde a quanto ci si era
63
prefigurati all’arrivo sul campo. In questo senso, come sostiene Renato Rosaldo, l’analisi sociale
“deve rendersi conto che i suoi oggetti di analisi sono anche soggetti che analizzano e
interrogano criticamente gli etnografi – i loro scritti, la loro etica e la loro politica.” (Rosaldo,
2001:61), e che “quello che era un semplice oggetto di ricerca diventa un soggetto che interpreta
non solo se stesso o la propria cultura, ma anche l’antropologo.” (2001:11)
Ciò è vero soprattutto nel caso del Brasile, in cui gli etnologi che si interessano alle comunità
indigene (in questo caso vige l’antica separazione tra antropologia e etnologia, che fa di me e dei
miei colleghi degli “etnologi”) sono generalmente identificati come coloro che lottano a fianco
degli indios per il riconoscimento dei loro diritti a livello nazionale ed internazionale. Difficile
sfuggire da questo ruolo “precostituito” affibbiato ad ogni antropologo, brasiliano o straniero,
voglia interessarsi alle comunità indigene. Quest’ultime, ormai scomparsa l’immagine della
società isolata, “scoperta” e descritta dall’antropologo, sono divenute bersaglio di ONG,
associazioni religiose, organizzazioni internazionali che si contendono “il campo” per mettere in
pratica progetti di sviluppo e programmi umanitari, dagli obiettivi non sempre trasparenti.
L’antropologo che si rechi presso le comunità indigene per svolgere un qualsiasi tipo di ricerca,
dovrà dunque prima confrontarsi con una lunga serie di entità ed attori sociali che da tempo
hanno consolidato la propria posizione di potere e di autorità (alle volte esclusiva) in relazione
alle comunità e all’accesso ad esse, ed essere abbastanza esperto nelle sue negoziazioni per non
venire escluso da quello che ormai sembra essere diventato un “patrimonio protetto”. Nel mio
caso, intendendo analizzare gli effetti che i progetti di cambiamento sociale ed economico
pianificato, messi in atto dalle ONG locali, stanno generando nelle comunità indigene
amazzoniche dell’Acre, questo tipo di negoziazione è abbastanza complessa, specialmente
quando si tratta di interagire con gli antropologi che lavorano nelle organizzazioni non
governative e che hanno fatto di quelle comunità le “loro” comunità indigene. Una volta
raggiunte le comunità, si dovrà poi definire nuovamente il proprio ruolo, cercando di
distinguersi agli occhi degli indigeni da “quegli” antropologi delle ONG ai quali si viene
irrimediabilmente associati.
L’abilità dell’antropologo/a si misurerà quindi nel muoversi all’interno di questa griglia di
significati a lui/lei attribuiti, nell’inserirsi in una rete di relazioni già segnate da rapporti di
potere e di autorità, in breve, nella costruzione del suo “campo”.
Tornando alla domanda di apertura, quindi, è “il campo” in un certo senso, a scegliere il suo
antropologo.
Bibliografia
− Moruzzi, L., 1983, La terra “padre”, ecologia e simbolismo nelle società di cacciaraccolta, Loescher Editore, Torino
− João Pacheco de Oliveira , 2005, Storia, Politica e Religione tra i Ticuna, Bulzoni Editore,
Roma
− Rosaldo, R., 2001, Cultura e Verità, Meltemi, Roma
64
Spazio sovrapposto: lo studio delle reti di relazione parentale in Toscana
Sara Testi
Durante il mio percorso di studio a dire il vero non mi è capitato così di frequente di assistere a
vere e proprie lezioni metodologiche approfondite e mirate alla spiegazione sul come si
costruisce il proprio campo di ricerca. Mi domando se questo accada anche in altri contesti
accademici. Ripercorrendo molto sommariamente l’iter universitario che in genere compie
l’aspirante antropologo si può riassumere dicendo che si inizia con la lenta acquisizione delle
capacità e degli strumenti per avviare i primi passi in direzione dell’osservazione partecipante e
più in generale della ricerca sul campo: tendenzialmente per farlo si procede riesaminando le
varie tappe che i “padri” della disciplina hanno percorso, focalizzandosi sulle migliorie che sono
riusciti ad apportare alla pratica antropologica; oppure si analizzano i diversi orientamenti delle
singole scuole che si sono succedute nel tempo o che convivono sincronicamente all’interno di
ambiti accademici diversi, e così via. Con il tempo le letture aumentano, lo sguardo si fa più
ampio e allo stesso tempo più mirato verso il campo d’interesse a cui tende ciascuno di noi e si fa
strada un proprio metodo di studio e di lavoro. E’ anche vero però che molti traguardi raggiunti
sono il frutto di una buona dose di autodidattica (quando non di veri e propri colpi di fortuna:
cerchi un articolo sull’arte africana e trovi proprio il saggio che fa per te sulla parentela
mezzadrile… proprio quello che avresti dovuto leggere per la tua tesi di laurea, ovviamente già
discussa). Probabilmente si potrebbero semplificare le cose se non si tentasse così raramente di
operare un’autoanalisi (e soprattutto un’autocritica) sul proprio operato, con il risultato che
l’impianto metodologico della nostra disciplina viene percepito a fatica e soprattutto viene
acquisito con delle tempistiche piuttosto lunghe. Questo accade forse anche perché ognuno ha il
proprio modo di rapportarsi con il suo oggetto di studio e raramente si può generalizzare
stilando un elenco di cosa un antropologo deve o non deve fare. Eppure molti di noi sentono il
bisogno di condividere e confrontare le proprie esperienze di ricerca che inevitabilmente sono
tanto esperienze di lavoro quanto di vita vissuta sulla propria pelle. Usciti dalla più o meno
recente discussione della tesi di laurea (la prima e forse unica esperienza di ricerca) sentiamo
l’impellenza del dialogo e, almeno per quanto mi riguarda, di scavare a fondo le più intime
criticità intellettuali per affrontarle e finalmente andare oltre. Vorrei poter descrivere cosa mi
ha spinto a intraprendere una via etnografica così intima come lo è inevitabilmente ogni ricerca
in un campo ed in un territorio che coincide con il luogo in cui l’antropologo è nato e vissuto e
che appartiene dunque allo “studiante” tanto quanto è parte integrante dello “studiato”. Nessuna
pretesa di elaborare enunciazioni teorico-metodologiche esaustive, piuttosto vorrei proporvi
due ordini di problematiche che emergono ogni volta che dobbiamo rapportarci da un lato con
l’antropologia, se vogliamo poco esotica e molto introspettiva, “del noi” e dall’altro con i nuovi
approcci agli studi sulla parentela.
Dunque procedo mettendomi in gioco “personalmente”, intimamente direi, un orientamento
che può essere giudicato estremamente semplicistico ma dal quale nessuno di noi può
prescindere: siamo umani tra umani e proprio per questo il nostro mestiere, che ci porta ad
esaminare proprio le infinite variazioni di questa relazione, si rivela essere una “questione
personale” qualsiasi sia il suo specifico oggetto di studio.
Inizio dal primo aspetto, vale a dire il significato che acquista la dicotomia “noi/loro” quando lo
spazio (fisico e culturale) in cui agiscono questi due termini del rapporto etnografico
corrisponde così intimamente.
65
Ho iniziato ad appassionarmi di genealogie, dinamiche di relazione familiare, generazioni e più
in generale al campo dell’antropologia della parentela all’ultimo anno di Università: la
preparazione dell’esame di etnografia mi mostrò un lato della “mia” porzione di mondo che
semplicemente non avevo mai focalizzato con occhio antropologico analitico e dunque con
l’abissale differenza che separa l’”osservare” dal semplice “vedere”. All’epoca stilai un ampio, a
tratti disorganico, grafico genealogico sul mio gruppo parentale: l’analisi oggettiva di quel metro
e mezzo di tondi e triangoli è stata la prova più difficile che avessi mai affrontato (e con la quale
tuttora mi trovo a dover fare i conti). Ebbene, questa sfida tra il mio “io-etnografo” ed il mio “ioin borghese” mi ha portato a fare dei luoghi nei quali sono nata e vissuta lo spazio preferenziale
in cui praticare la ricerca sul campo sia per la stesura della tesi di laurea che poi di dottorato. La
difficoltà sta proprio in quel concetto di spazio intorno al quale ruotano le nostre riflessioni,
inteso in questo caso sia come porzione di territorio sia come una rete di azioni e di relazioni
che costituiscono il cuore del mio campo di ricerca (le relazioni parentali appunto). Quando si è
immersi nella propria cultura si crede di conoscerla talmente bene da dare molto per scontato e
l’analisi oggettiva diviene ad un tratto un ostacolo pressoché insormontabile. Le dicotomie che
di solito vengono usate per identificare i due soggetti in relazione nelle dinamiche della ricerca
sul campo (ego/alter, interno/esterno, dentro/fuori, tanto per citarne alcune) rispecchiano una
suddivisione anche spaziale che viene inevitabilmente ad affievolirsi quando si fa antropologia
“a casa propria”. La sovrapposizione di spazi implica uno sforzo ulteriore in quello sdoppiamento
di ego a cui è necessariamente sottoposto l’antropologo quando osserva il suo oggetto di
indagine: le sfere concettuali e territoriali nelle quali sono immersi oggetti e soggetti di studio si
situano una sull’altra in molte delle loro parti, facendo cadere alcuni dei punti fermi sui quali di
solito ci aggrappiamo per la costruzione dei nostri campi di ricerca. Prima di tutto il mancato
spostamento da un luogo – casa - ad un altro – campo – provoca la perdita di quel senso di
distacco dalla propria condizione culturale che permette di avere una predisposizione di
maggiore apertura verso tutto ciò che di nuovo si presenterà al nostro cospetto. Quasi fosse un
rito di passaggio, il trasferimento aiuta ad indebolire i nostri preconcetti: la “non partenza”
diviene dunque una scelta estremamente complessa. Alcune vie che possono essere intraprese
per superare questo empasse possono prevedere una presa di distanza temporale come può
essere ad esempio lo studio di generazioni diverse dalla propria, la ricostruzione di network
parentali non contemporanei; oppure la selezione di interlocutori privilegiati (fanno parte di
questa categoria gli studi di genere, tanto per fare un esempio) e così via. In sostanza si tende
anche in questi casi a frapporre una distanza, magari non più spaziale ma operata su livelli
diversi, tra l’antropologo e gli “altri”. Possibile che sia così raro che invece si proceda con il fare
della propria condizione culturale il punto di forza sul quale puntare per una maggiore
comprensione dell’oggetto di analisi? La sovrapposizione spaziale non cade mai nella
coincidenza totale, a meno che io antropologa non decida di studiare me stessa (in questo caso
emergono problematiche di altra natura che esulano troppo da questa mia riflessione) e quindi
mi ripeto continuamente che, senza distrarci troppo problematizzando eccessivamente e
ossessivamente la difficoltà all’oggettivazione, dovremmo piuttosto concentrarci su ciò che già
possediamo ed impostare il lavoro a partire da noi stessi, dal nostro bagaglio culturale dal quale,
comunque, con possiamo prescindere.
Per questo cerco sempre di risalire alle cause dei fatti: un approccio che in qualche occasione si
è rivelato faticoso e forse un po’ troppo storicista ma che mi ha consentito più volte di
comprendere meglio alcune delle tendenze contemporanee di quegli attori sociali che di volta in
66
volta sono divenuti il mio oggetto di studio. Da qui il mio interesse per il periodo mezzadrile,
l’accanimento con cui mi piace immergermi negli archivi anagrafici, catastali, diocesani e
simili; e soprattutto è sempre da qui che è nata la volontà di rimanere a fare ricerca sul campo in
Toscana, quasi che fosse per me indispensabile conoscere meglio prima il mio mondo e poi
quello degli altri: lo considero uno stadio imprescindibile per il proseguimento del mio percorso
professionale, ne sento semplicemente la necessità. Non che non comprenda le motivazioni che
spingono molti colleghi a scegliere oggetti di studio più lontani (se non dal punto di vista
prettamente spaziale almeno da quello concettuale). Anzi, devo dire che mi sono ritrovata
spesso a chiedermi se non avessi dovuto ampliare un po’ di più i miei orizzonti senza focalizzare
solo o troppo su un singolo ambito di studi. Credo molto nell’approccio processuale ed
interdisciplinare di cui parlano studiosi come Moore (processual ethnography; 1987) e Marcus
(multi-sited ethnography; 1995): sto facendo i conti proprio in questo periodo con l’urgenza di
fare riferimento a lavori di studiosi di altre discipline come i sociologi che hanno scritto sulla
situazione delle politiche sociali in Italia o i demografi e gli statistici che si occupano delle
dinamiche che sottendono ai flussi di popolazione, o anche al lavoro di storici, politici e così
via…
Sempre da quell’esigenza di “basilarità” di cui ho parlato sopra credo che sia da ritrovare anche
la mia scelta di studiare la famiglia in contesto toscano: ecco che vengo dunque al secondo
aspetto che vorrei discutere. Proprio per il suo continuo movimento sia a livello di
comportamenti individuali o di gruppo che di interazione con le istituzioni, la famiglia rimane
al centro di diverse questioni sociali contribuendo, con la sua dinamicità, a definire i modi e i
sensi del mutamento sociale stesso (Saraceno, Naldini 2001). Ordine biologico e ordine sociale,
le due polarità intrinseche alla nozione stessa di parentela, hanno avuto fortune alterne nel
corso della storia degli studi e stanno subendo oggi una ridefinizione reciproca: attualmente
sembrano trovare un loro equilibrio nel concetto di relatedness (Carsten 2000), con il quale si
indica l’universo allargato di tutti quei “relati” legati da nessi ancora definibili parentali ma non
più necessariamente biologici. Il quadro generale che ne emerge è dunque un universo sociale
che per essere studiato ha bisogno di un approccio ampio, che tenga conto sia dei caratteri di
mutamento già conclusi che dei processi ancora in itinere e che sia in grado quindi di guardare
avanti e di far fronte all’analisi della contemporaneità senza temere di violare i canoni fissati
dall’antropologia classica, accettando così sfide interpretative mai percorse fino ad oggi. Gli
studi di network analysis (Schweitzer, White 1998) si rivelano un ottimo strumento per far
fronte alla necessità di dinamicità e complessità che lo studio delle attuali rappresentazioni
parentali comporta. Ho delimitato il mio campo di ricerca ad un’area fortemente caratterizzata
dal passato mezzadrile in modo da poter verificare fino a che punto la transizione demografica
ha investito queste zone e quali cambiamenti ha determinato nello strutturarsi delle famiglie
contemporanee, con particolare riferimento al conseguente mutamento dei rapporti
generazionali in termini di frequentazione, vicinanza abitativa, autodefinizione del proprio
ruolo all’interno della rete parentale e rapporti di dipendenza e solidarietà reciproca. Per questo
mi interessano molto gli studi che si occupano di processualità del sociale, in sostanza alla
tematica del mutamento che sia esso inteso come ri-costruzione o metamorfosi del soggetto, del
divenire della persona, oppure come spostamento da uno spazio all’altro. L’analisi si può
concentrare su singole famiglie, oppure su un reticolo di interrelazioni o, infine, su la vita di
singoli che attraversano più famiglie ed aggregati domestici. Nonostante in una prima fase abbia
tentato di definire i confini territoriali del mio campo ho dovuto ripensarli subito dopo: pur
67
lasciando come luogo di partenza l’area circoscritta che avevo scelto mi ritrovo adesso a seguire
le singole linee relazionali che dal centro si dipanano verso l’esterno. Lavorare sulle reti di
relazione parentale implica uno sguardo ampio sul territorio e soprattutto l’acquisizione della
consapevolezza di dover sempre mettere in discussione la staticità che talvolta viene attribuita
alle singole aree territoriali (vedi ad esempio gli studi sulle aree di alleanza matrimoniale
condotti in Toscana meridionale da Grilli e Solinas, 2002). Al contrario, il concetto stesso di
territorio è da intendersi come luogo all’interno del quale sono attive più forze che contrattano
il loro ruolo reciproco. Ho già spiegato come la stessa ricerca sul campo sia composta da una
diade dove da un lato sta il ricercatore, impegnato in un processo di delimitazione e di
attribuzione di significato a spazi, dall’altro sta uno spazio che si fa territorio in quanto investito
di significati da parte dei soggetti stessi che ne negoziano confini e contenuti. Anche in questa
diade la trasformazione è reciproca.
Bibliografia
− Carsten, J., (a cura di), 2000, Cultures of relatedness. New Approaches to the Study of
Kinship, Cambridge, Cambridge University Press.
− Grilli, S. e Solinas, P.G., 2002, Spazi di alleanza. Aree di matrimonialità nella Toscana
meridionale, Roma, CISU.
− Marcus, G.E., 1995, Ethnography in/of the world system : the emergence of multisited
ethnography, in Annual Review of Anthropology, 24: 95-177
− Moore, Sally Falk, 1987, Explaining the Present: Theoretical Dilemmas in Processual
Ethnography, in American Ethnologist, 14 (4): 727-736
− Naldini, M., Saraceno C., 2001, Sociologia della famiglia, Bologna, Il Mulino.
− Schweizer, T., White D.R., 1998, Kinship networks and exchange, Cambridge,
Cambridge University Press.
− Strathern, M.,1992, After nature. English kinship in the late twentieth century,
Cambridge, Cambridge University Press.
68