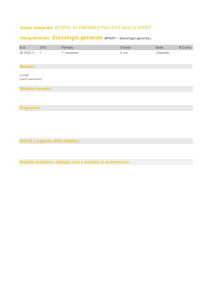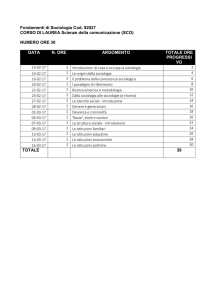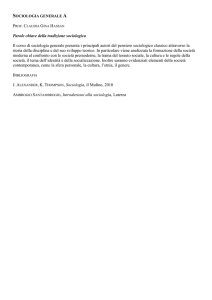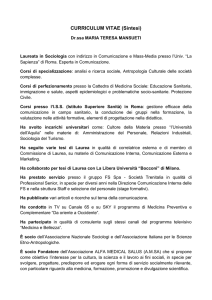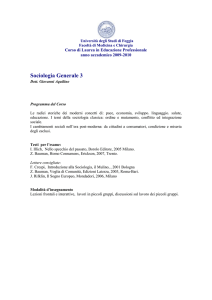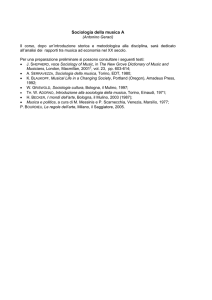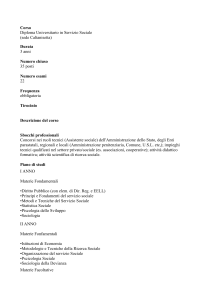Settembre 2006, Anno 3, Numero 5
Newsl ett er di S ociol ogia
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
Ricerca Sociale
R i c e r c a
3
S o c i a l e
L’intervista al professor Massimo Follis si inserisce nello spazio ormai consueto dedicato alle storie
intellettuali dei e delle docenti dell’Ateneo torinese. Massimo Follis è afferente ai corsi di studio in
Scienze dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro (laurea di 1° livello), e in Analisi e valutazione dei
Sistemi Complessi (specialistica). È titolare degli insegnamenti di Introduzione all’analisi dei reticoli
sociali e Sociologia del lavoro, nonché neo-coordinatore del Dottorato di ricerca in Ricerca Sociale
Comparata, presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino.
Intervista a Massimo Follis
di Marco Pozzan
Quarant'anni di professione. Come anticipato proponendole l’intervista, inizierei chiedendole di parlarci
della sua tesi.
Mi chiede della tesi, la mia storia però comincia prima. Mentre
l’attendevo ho ripensato al mio rapporto con la disciplina e mi
sono reso conto che non si tratta di una storia continua, ma
piuttosto caratterizzata da diverse svolte e ricominciamenti.
Alcuni colleghi mi dicono che in fondo è riconoscibile nel mio
lavoro un filo rosso. Io però non lo vedo chiaramente.
Percepisco piuttosto le discontinuità. La mia carriera è atipica
rispetto a quanto comunemente avviene. Sono stato infatti
cooptato precocemente dall’allora neonata Facoltà di Scienze
politiche alla ricerca di risorse e avendo sciolto a quel tempo
ogni dubbio sulla mia vocazione professionale, accettai subito.
Ho poi sostato a lungo prima nella posizione di Professore
incaricato, quindi associato, percorrendo diverse piste di
ricerca, cui successiva-mente non ho dato seguito. Questo
denota una certa dispersione nella mia carriera, una metrica
non ordinata. Credo sia significativo dirlo. Un assestamento è
avvenuto nella seconda metà degli anni ottanta.
Volendo individuare un punto d’inizio, io nasco alla sociologia
grazie al Professor Marletti, che negli anni sessanta aveva
creato presso il corso di laurea in Scienze politiche (all’insegna
della cattedra di Socio-logia del Professor Barbano) i Gruppi di
ricerca di sociologia. Cominciai assistendo ai seminari
promossi da Barbano e da Bobbio presso l'Istituto Gioele
Solari. Si trattava per lo più d'incontri con intellettuali non
accademici, spesso provenienti dal mondo della politica,
qualificati a confrontarsi con la sociologia (d’altra parte gli
accademici della nostra disciplina erano allora pochissimi).
Ricordo una splendida lezione di Vittorio Foa! Inoltre anche noi
eravamo sollecitati ad attivare dei seminari. Fu nel complesso
un’iniziativa davvero appassionante. Poi, poco alla volta,
spinto da una forte passione intellettuale, entrai a fare parte di
questa piccola comunità. Non siamo in molti ad essere
sopravvissuti a quell’esperienza. Nel gruppo originario, con
maggiore o minore coinvolgimento, erano presenti alcuni miei
coetanei, tra i quali il Professor Pichierri (ora a Scienze della
formazione), il Professor Almondo e il Professor Fischer.
Proprio il Professor Fischer ha ricordato questa esperienza durante l’intervista a noi rilasciata e pubblicata
nel numero precedente. Svolgevate dunque attività di
ricerca.
Sì, iniziai a fare ricerca prima di laurearmi. Eravamo "sul
mercato" per così dire. Si trattava per lo più di piccole
ricerche, ma talvolta anche pagate. Ricordo in particolare due
survey con questionario strutturato per il Piano regionale della
Valle d’Aosta. Certo, io ero un pulcino e il mio compito
prevalente era quello di effettuare le interviste. Ma già subito
dopo la laurea mi fu offerta l'opportunità di condurre insieme
al Professor Taglioli (quasi un tandem, il nostro, all’interno del
più vasto gruppo) una survey sugli operai contadini,
nell'ambito di un progetto diretto dal prof. Barbano. Era un
tema che avevamo scelto noi (Barbano era davvero molto
disponibile). C'interessava studiare il fenomeno dal punto di
vista dell’alternanza d'attività. Un tema curioso, se vuole; una
sorta di fiore all’occhiello, che pur rientrando nella tematica
più vasta del cambiamento sociale, era ai margini della
sociologia di allora, in cui dominavano gli studi sulla seconda
fase dell'industrializzazione che aveva assunto una dimensione
di massa, e richiamava l’attenzione sui problemi dall’immigrazione. Tuttavia, vi riconosco un rilievo analitico. Infatti, nel
paper che poi scrissi con Taglioli, confrontandomi con le analisi
dei processi di modernizzazione che parlavano di una progressiva specializzazione dei ruoli e trovandomi di fronte ad un
fenomeno che andava apparentemente contro tali considerazioni, mi domandavo se alla sua origine ci fossero unicamente
motivi di convenienza economica e non anche l'aspirazione ad
un lavoro autonomo, di cui il parallelo lavoro in fabbrica
riduceva l'incertezza di reddito. Mi ponevo, cioè, già delle
domande che nascevano all’interno della disciplina. Ci credevo
molto....tanto che quando, in quel periodo, mi fu offerta la
possibilità d’intraprendere la carriera diplomatica (a seguito di
uno stage molto selezionato presso tutte le sedi italiane a
Parigi, durante il quale mi occupai pure a fondo della mia tesi
di laurea), rifiutai piacendomi e riconoscendomi più nel mondo
della ricerca sociale.
Questo avvenne durante il periodo universitario?
Sì, nell’ultimo anno. Fu un impegno di circa tre mesi. Ricordo
che mi mantenevo malamente, si richiedevano infatti vestiti
inappuntabili e avevo qualche problema in questo. Ma,
insomma, mi fu comunque fatto intendere che avrebbero
avuto un occhio di favore nei miei confronti durante il
successivo concorso, avendo io soddisfatto le aspettative di chi
mi monitorava.
Compiuta la scelta per la sociologia mi rilassai. Fino a quel
momento non ero stato così convinto del mio percorso. Avevo
addirittura intrapreso il corso di Laurea in Scienze politiche
Settembre 2006, Anno 3, Numero 5
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
perché era quello che vincolava di meno. Fu in sostanza una
scelta per esclusione piuttosto che in positivo.
Il rapporto con le scienze sociali è dunque certamente
maturato in me grazie alla frequentazione dei Gruppi di
sociologia: un ambiente anche umano molto importante, fatto
di relazioni profonde. Fu un periodo bellissimo. Erano gli anni
sessanta, un periodo entusiasmante per chi, orientato come
noi a sinistra, credeva in un cambiamento della società in
meglio. Ricordo che eravamo stakanovisti, lavoravamo anche
a Natale. Lavoravo sempre! Lavoro regalato....era una forma
d'apprendistato. Avevamo una visione militante della ricerca,
la passione politica era indubbiamente un nostro elemento
qualificante. Insieme a Marletti mi spinsi a proporre al gruppo
dirigente della Federazione di Torino del Partito Comunista, al
quale ero allora iscritto, di fare una riflessione sociologica sulla
sua democrazia interna. Ci fu permesso e fu quindi organizzato un seminario, durante il quale raccontammo loro, con caute
e garbate argomentazioni e avanzando proposte, che il calo di
iscritti e di partecipazione alla vita del Partito era dovuto al
muro di gomma esistente tra la base e i vertici - di cui per
altro erano perfettamente consapevoli. Non intendevamo
fornire linee d’azione, né essere consiglieri del principe;
piuttosto cercavamo spazi, desideravamo dimostrare l’utilità
dei nostri lavori. Una posizione che ancora condivido. Mi
caratterizzava, cioè, una visione dal basso, unita all’interesse
per la democrazia diretta - aspetti poi ricorrenti, a partire dalla
mia tesi di laurea.
Tuttavia, la scelta della tesi, anch’essa importante, costituisce
un capitolo a parte.
Me ne parli.
Impiegai tre anni per preparare la tesi di laurea. È un episodio
a sé, una dimensione che suscita ancora ambiguità e
sofferenza nel mio ricordo personale, perché sono convinto
che avrei potuto trarne una monografia se fossi stato più
imprenditivo, a fronte del mancato sostegno del mio relatore e
della votazione di 108 che ottenni, invece del massimo dei
voti, come mi aspettavo. Tuttavia, ho sempre avuto un debito
di gratitudine per Bobbio, che come correlatore e in modo
inusuale (dimostrando anche profonda sensibilità umana) fece
un intervento per mia fortuna molto favorevole. In seguito, mi
propose anche di scrivere due voci (Consigli operai e Autogestione, che ora si possono considerare come archeologia
politica) per il Dizionario di politica da lui curato, così che misi
in parte a frutto il lavoro della tesi.
Però fu nel complesso un evento spiacevole, che mi ha reso
molto attento a questi passaggi nelle carriere dei giovani. Uno
squilibrio fra investimento e ricompensa può provocare delle
cicatrici che restano. In particolare, non avere un riconoscimento in un contesto così incerto come quello dell’attività
creativa può portare a pensare che ciò che si è prodotto non
ha valore, con conseguenze negative sia sul piano psicologico,
sia su quello pratico (se non si pubblica, non si è conosciuti).
Quale argomento affrontò nella sua tesi di laurea?
Dopo un’incertezza iniziale, discutendone con Barbano, decisi
Newsl ett er di S ociol ogia
4
per il tema dell’autogestione. All’epoca, la Repubblica
Jugoslava, che comprendeva tutto ciò che fu successivamente
smembrato, avendo rotto negli anni Cinquanta con il blocco
sovietico e pur mantenendo un regime a partito unico
d'ispirazione socialista, tentava di battere in ambito economico
una terza via, alternativa a quella capitalista e a quella a
pianificazione centralizzata. L’ideologia era quella dell’autogestione, appunto. Questa prospettiva ha illuso molti. Vi furono
tentativi nell’Algeria di Ben Bella, subito dopo l’indipendenza
dalla Francia, ed è poi noto il ruolo della Jugoslavia e dell’India
nel Movimento dei paesi non-allineati. Un pezzo di storia fallita
ma importante, che intrigava molto. Ebbene, io affondai in
questo. Volendo risalire alle origini di tale prospettiva,
m'immersi in un mare di letture sul socialismo in generale e su
quello utopista in particolare, che sfociarono in uno studio
sistematico di quei filoni del movimento operaio, che negli anni
della Rivoluzione d’ottobre, promossero sollevazioni in tutta
Europa all’insegna dell’autogoverno operaio, l’altra faccia
dell’autogestione.
Ma il pezzo forte della tesi era la descrizione del meccanismo
di funzionamento dell’autogestione. Un meccanismo complicatissimo, che aveva una base nell’economia (gli utili delle
imprese, pur essendo queste di proprietà pubblica, potevano
essere reinvestiti e gestiti direttamente dai lavoratori, che
avevano anche qualche diritto sulla nomina dei direttori) ed
una nella politica. Vi era cioè una continua tensione tra
decisioni centralistiche di piano e quelle autonome: l’idea era
di rilassare man mano le prime. Il problema della Jugoslavia,
noto allora e analogo alla situazione italiana oggi, era la
compresenza di regioni ricche al nord e molto povere al sud,
che godevano delle redistribuzioni di risorse provenienti dalla
tassazione, suscitando conflittualità. Non conoscendo il serbocroato, potei consultare la sola letteratura ufficiale in francese,
che taceva dei conflitti nazionali ed etnici, di cui siamo venuti
poi tutti a conoscenza. Compresi successivamente che il
tentativo messo in atto era di sanare i dissidi interni per via
economica, cioè riconoscendo le autonomie locali. Il mio fu per
certi aspetti un lavoro cieco, privo di un vero bandolo critico.
Si trattò quindi di un tentativo fallito.
Certamente, a fronte poi delle conseguenze a tutti note.
Tuttavia, era un argomento di forte interesse in Occidente,
una terza via verso lo sviluppo. Riassumendo schematicamente, l’idea, originariamente in Lenin e da lui poi contraddetta, che i mezzi del cambiamento devono essere adatti al livello
di sviluppo delle forze produttive, era coerente con l’allora
diffusa predilezione per l’autogestione, e sembrava riconoscere
uno spazio effettivo alla libertà individuale (la democrazia
diretta). Quest'aspetto si saldava con un altro mio interesse
sociologico, la possibilità di prendere decisioni come manifestazione attiva della libertà. Fu un periodo, infatti, in cui mi
occupai anche di scienza politica, conseguendo appena
laureato una borsa di studio presso il CoSPoS (Comitato per le
Scienze Politiche e Sociali in Italia).
La parte originale e che più mi appassionò della tesi era
vedere se e come potesse funzionare un sistema di gestione
Settembre 2006, Anno 3, Numero 5
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
basato su decisioni prive del presupposto del comando. Due
erano gli aspetti rilevanti: da una parte la necessità di
coniugare gli interessi particolari dei lavoratori coinvolti nella
direzione dell’impresa, inclini a spartirsi gli utili, con quello
generale del loro reinvestimento; dall’altra, l’intento di
realizzare processi gestionali condivisi, tali per cui ogni
lavoratore si trovasse a perseguire obiettivi e rispettare regole
che aveva contribuito a stabilire. Si tratta di un livello d'analisi
micro, per il quale la sociologia del tempo non forniva quasi
alcuno strumento (ricordo quanto cercai di spremere dalla
distinzione tra potere e autorità!), ma che qualifica il mio
rapporto con la disciplina. Da questo tentativo d'analisi sono
iniziati i miei interessi per il lavoro e l'aspirazione a far
coesistere l’impegno professionale nella disciplina con quello
politico, un elemento senza tener conto del quale si comprende poco la mia generazione in Italia. L’idea era quella di
condurre studi utili ad una parte politica affinché potesse
correggere gli errori e realizzare al meglio i propri obbiettivi.
Senza poi dimenticare che in famiglia ebbi esperienza diretta
del mondo dell’industria, in quanto mio padre era stato un
piccolo imprenditore.
Quanto durò la sua collaborazione presso il CoSPoS?
Poco, perché presto diventai assistente volontario in Sociologia
(chiamato proprio dal Professor Barbano), poi assistente
supplente (sostituendo il Professor Farneti che fu promosso di
grado) e quindi nel 1969, nell’appena nata Facoltà di Scienze
politiche, ebbi l’incarico in Sociologia del lavoro e da allora l’ho
sempre mantenuto.
Di cosa si è occupato da quel momento?
L'assunzione dell'insegnamento di questa materia riorientò di
necessità i miei interessi. Volendo dare qualche elemento di
contiguità, posso citare alcuni miei input ispiratori.
Un autore che influenzò diversi torinesi, orientandoli allo studio
del lavoro, fu Alain Touraine. Quest’autore francese è
diventato progressivamente una maitre-a-pensée, che ben
rappresenta una visione della sociologia che mi è pochissimo
congeniale. Ma la sua tesi di dottorato, una ricerca sull’evoluzione del lavoro operaio nelle officine Renault, rappresentò
una piccola Bibbia per diversi di noi, anche perché si
interfacciava molto bene con le considerazioni che Marx aveva
svolto nel Quarto capitolo del primo libro del “Capitale” (un
capitolo di sociologia del lavoro e dell’organizzazione vera e
propria). Allora questo si combinava, sul piano empirico, con il
progetto intellettuale, non solo mio, di fare una sociologia
marxista: di rendere seria e scientifica una sociologia basata
sul marxismo. Progetto che sul piano analitico-teorico traeva
alimento dalle argomentazioni di Althusser, in una prospettiva
strutturalista. Probabilmente, per certi versi era un pasticcio.
Si trattava di temi classici. Mi occupavo, cioè, di sociologia del
lavoro nel senso dell’organizzazione, di work, non di labour,
ovvero di mercato del lavoro. Di quest’ultimo, che ora è il mio
tema, iniziai ad interessarmi molto tardi. Allora l’attenzione
era rivolta ai modi di produzione ed alle loro transizioni (che io
studiavo da un punto di vista micro-analitico, senza successo
mancando gli strumenti nella sociologia di quel tempo), alla
qualificazione del lavoro e soprattutto di quello operaio, agli
Newsl ett er di S ociol ogia
5
effetti dell’automazione e dell’innovazione tecnologica, ai quali
man mano negli anni settanta si è affiancato il tema
dell’organizzazione a livello d’officina. Per alcuni aspetti (penso
cioè a Balibar, un collaboratore di Althusser), l’approccio strutturalista offriva delle risposte: per esempio con la distinzione
formale tra modo di produzione artigianale ed industriale. Oggi
non ne parlo più; sono temi ed autori che hanno fatto il loro
tempo non lasciando alcuna traccia, salvo la prospettiva
strutturalista che ritengo un mio filo rosso.
Devo tuttavia riconoscere che gli anni settanta sono stati un
periodo orribile per me, anche perché vivevo con sofferenza e
come una continua interferenza le richieste di prese di posizione politica da parte degli studenti. Mi sentii usato. Avrei
dovuto dimostrare maggiore autonomia, dire dei no più spesso, anche a quanti su un altro fronte mi richiedevano un voto
politico.
Come è uscito da questa impasse?
A parte piccole ricerche, ne sono uscito abbracciando due
prospettive. Un autore che verso la fine degli anni settanta mi
ha reintrodotto alla sociologia in modo vantaggioso e positivo
è stato Raymond Boudon (che considero uno dei miei maestri,
accanto a Sorensen e Goldthorpe). Per me un salvatore, gli
devo infatti grande riconoscenza. Della sua prospettiva
analitica strutturale, in particolare, recepii con forza (dando
una svolta importante al mio pensiero), l’individualismo
metodologico. Utile, congeniale e chiarificatore per i miei studi.
Mi dedicai ad una lettura approfondita del libro di Boudon
L'inégalité des chances. Fu il primo testo a presentare un
modello di simulazione e lo utilizzai anche per alcuni miei corsi
con il favore degli studenti. Lo ricordo con piacere.
L’altra gamba fu il rapporto con colleghi studiosi di economia
industriale. Con loro ho condotto alcune ricerche, che mi
hanno permesso di acquisire una buona reputazione. Precorrendo i tempi, avemmo infatti l’intuizione di studiare il settore
della componentistica per autoveicoli, allora chiamato
“indotto” (questo ha inoltre rappresentato un’estensione dei
miei interessi dal lavoro all’impresa), riconoscendone
l’importanza e prevedendo un rovesciamento del rapporto tra
produzione finale e componentistica, poi avveratosi. Ebbi
dunque delle soddisfazioni in quest’attività di ricerca. Ricordo
anche che un primo accenno di interesse per il labour risale al
1976, quando svolsi una ricerca empirica sul turn-over su un
campione di piccole imprese.
Per altro, a mio parere, le migliori intuizioni che ho avuto dal
punto di vista metodologico e tecnico non mi sono mai state
riconosciute. Nel 1980, ad esempio, con il Professor Enrietti
feci una rilevazione sulle imprese che producevano componenti. Avevamo degli explananda riguardanti il fatturato e, a
parte la piccola scoperta della rilevanza del mercato del
ricambio, ebbi l’intuizione di utilizzare le informazioni sulla
tecnologia dei prodotti per costruire delle proxy, ovvero variabili che diventavano dei vincoli tecnologici e di progettazione.
Feci anche ricorso ad un testimone privilegiato in Fiat,
l’ingegner Lanza, con cui ebbi uno scambio intellettuale entusiasmante. Alla definizione delle proxy seguirono poi delle
significative elaborazioni statistiche, che furono molto apprezzate dagli economisti, ma ignorate dai sociologi.
Settembre 2006, Anno 3, Numero 5
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
Ecco, io credo che a qualificare il sociologo sia spesso un’intelligenza metodologica o tecnica.
Siamo giunti ora agli ultimi vent’anni. Il periodo
precedente è stato caratterizzato professionalmente da
uno stretto rapporto con la politica e dallo studio, cosa
è accaduto successivamente?
Innanzitutto, ho abbandonato l’idea di combinare impegno
politico e professionale, contemporaneamente anche alla
parabola discendente del marxismo. È stato per me un
sollievo. Inoltre, durante gli anni settanta ho, in effetti, molto
studiato e poco prodotto. Cosa che non va, proprio nel periodo
tra i trenta e i quarant'anni. Probabilmente sarebbe stato
diverso se non fossi stato precocemente investito di un
insegnamento ed in un momento tanto turbolento.
Dalla seconda metà degli anni ottanta, impossessandomi
nuovamente del tema lavoro, ho dato realmente senso al mio
insegnamento, prima incentrato sull’eguaglianza di chances e
sulla mobilità sociale; temi non proprio pertinenti con la
sociologia del lavoro. Questo mio rapporto più pieno con la
disciplina è nato all’insegna di rinsaldare il mio impegno per
una sua rivalutazione scientifica – la parola scienza è scritta a
caratteri cubitali nella mia testa. È ciò in cui credo e per cui mi
spendo, in mancanza di meglio anche abbracciando la versione
più positivista esistente. Forse ho una visione pessimista, ma
credo che l’aspetto postmoderno stia condannando
all’irrilevanza ed alla chiacchiera la nostra disciplina.
Un intento originariamente presente a proposito del
progetto per una sociologia scientifica marxista, un
elemento di continuità con il passato. Immagino però
che siano cambiati i programmi dei suoi corsi...
Sì, prima è intervenuta una dimensione labour attraverso la
tematica della mobilità, mediata dalle riflessioni di Boudon. Ho
così importato un’ampia letteratura nordamericana sulle
carriere (dentro e fuori delle organizzazioni), che in quel paese
ha avuto molti riconoscimenti, ma che in Italia è rimasta
pressoché sconosciuta. Un altro contributo che ha alimentato
la mia didattica (sempre più orientata al labour) proviene da
testi di economia del lavoro, la cui frequentazione mi ha anche
permesso di rivisitare il lato work, dell’organizzazione: sebbene oggi sia più vicino al modello neoclassico, ho pesta to
anch’io l’acqua nel mortaio dell’approccio istituzionalista!
Attualmente, il mio corso di sociologia del lavoro ha un modulo
incentrato sulla mobilità nel mercato del lavoro e l’altro sulla
gestione del personale. Con coerenza ormai dagli anni novanta
sono conciliato con il mio insegnamento, che credo di svolgere
in modo utile, ma che tuttavia, ha pochissimi punti di contatto
con quanto avviene nelle altre università italiane.
Per quale motivo?
Poiché la sociologia è una disciplina poco istituzionalizzata.
Esistono molti paradigmi differenti, cosicché ognuno la
interpreta come crede. Cosa che io appunto contrasto. Penso,
al contrario, che dovrebbe essere più strutturata, rigorosa e
scientifica, con argomentazioni che si prestino alla falsificazione, definendo, ad esempio, precise soglie di accesso. Come in
ogni scienza, non è cioè possibile che tutti periodicamente sco-
Newsl ett er di S ociol ogia
6
prano un nuovo bandolo e la riscrivano interamente da capo. È
lecito piuttosto che ognuno coltivi il suo orto, fornendo così,
conseguentemente, un contributo relativamente limitato, sulla
base, però, di opzioni condivise.
In Italia, in particolare, il potenziale enorme che esisteva negli
anni sessanta è stato bruciato in modo crudele dalla mancanza
di un paradigma forte e dal narcisismo penoso di chi rilascia
interviste su qualunque argomento, svilendo in questo modo la
nostra professione e la disciplina. Tuttavia, di fronte alla complessità crescente della società contemporanea, il potenziale
resta e lo spazio per una scienza sociale rigorosa ed intelligente, che si proponga di offrire un reale valore aggiunto alla sua
conoscenza, non è certo diminuito. È necessario coltivarlo.
D’altra parte l’audience dei sociologi è crollata ovunque, ne da
una misura, ad esempio, il numero crescente di dipartimenti
chiusi negli Stati Uniti, come riportato nell’Introduzione
all’utilissimo testo di Goldthorpe, Sulla sociologia.
La stessa oscillazione nell’appellare la sociologia tra i
termini scienza e disciplina, sovente posti in contrapposizione, è una manifestazione di tale ambiguità.
Certo, ha ragione.
Quali sono i suoi interessi più recenti?
Sì, a seguito delle ricerche sulla componentistica sono stato
coinvolto in diversi progetti europei sulle politiche della
formazione continua in quell’ambito specifico, riconosciuto
come fondamentale per l’industria dell’auto e per la
competitività. Progetti stimolanti, interessanti e ricchi, che mi
hanno permesso di viaggiare molto e interagire con validi
studiosi stranieri. Inoltre, mi hanno in qualche modo
accreditato come esperto di formazione, da cui la mia
partecipazione nel corso degli anni ’90 a diversi progetti
finanziati dal Ministero del lavoro per la definizione di standard
formativi, a livello nazionale, di figure dell’industria, con
riferimento in particolare all’industria meccanica e al settore
auto. Questo ruolo d’esperto si è successivamente scontrato
con gli impegni conseguenti al mio più recente coinvolgimento
diretto nella gestione della Facoltà e ora dell’Ateneo. Ormai ho
un interesse puramente scientifico per la problematica della
formazione continua.
Come desidera concludere questa intervista?
Consiglio di essere coraggiosi e tenaci. Credo che il campo
della sociologia sia promettente e necessiti di essere vangato
con molta fatica, avendo un occhio di riguardo a ciò che
accade fuori dai nostri confini nazionali (al cui interno, come
detto, permane un ritardo). Sono anche convinto che lo spazio
per ricerche irrilevanti, ovvero i cui risultati non aggiungono
conoscenza chiara e usabile (e che tuttavia garantiscono ancora di ottenere riconoscimenti e fare carriere soddisfacenti), si
ridurrà sempre più. Esiste un mercato e di fronte alla mano
pubblica, che non può più permettersi di regalare denaro,
dobbiamo dimostrare la nostra utilità. Vedo due ambiti da
approfondire: quello della simulazione, un terreno d’elezione
per i sociologi desiderosi di produrre spiegazioni (oggi molto
praticato dagli economisti) e quello degli esperimenti.