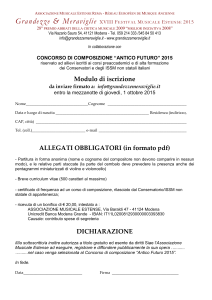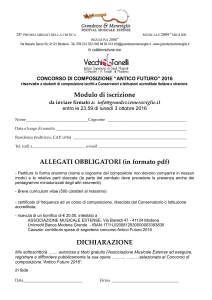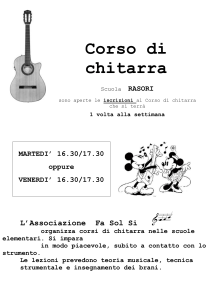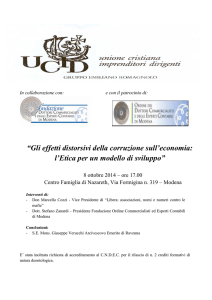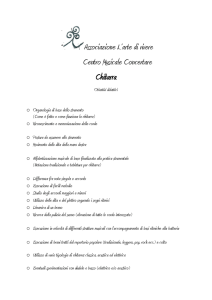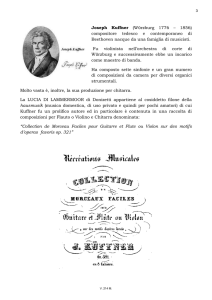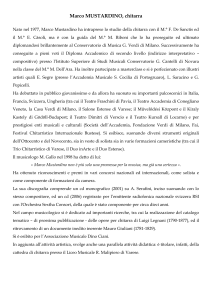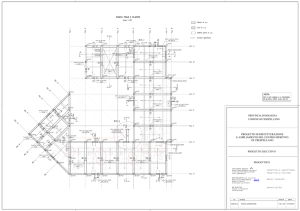MUSICA A CE ORTE
IN COLLEZIONE
D agli strume nti music ali
di Casa d’ Este
alle c olle zioni storic he
MUSICA A C
E ORTE
IN COLLEZIONE
D agli strumenti musicali
d i C a s a d ’Es t e
alle collezioni storiche
2
MUSICA A C
E ORTE
IN COLLEZIONE
D agli strumenti musicali
di Casa d’Este
alle collezioni storiche
Comune di Modena
Assessorato allo Sport
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per il Patrimonio Storico,
Artistico e Demoetnoantropologico
di Modena e Reggio Emilia
Sedi espositive
Palazzo Comunale di Modena
Galleria Estense
Centro Commerciale La Rotonda
Caffè Concerto Piazza Grande
20 giugno - 7 luglio 2002
A cura di
Lorenzo Frignani
Nunzia Lanzetta
Collaborazione all’organizzazione
Assessorato allo Sport
del Comune di Modena
Coordinamento
Maria Carafoli
Testi
Lorenzo Frignani
Nunzia Lanzetta
Patrizia Radicchi
4
Fotografia e Grafica dell’evento
Giorgio Giliberti
Enti prestatori
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e
Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia
Biblioteca Estense Universitaria di Modena
Lorenzo Frignani e collezionisti privati
Crediti fotografici
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e
Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia
Biblioteca Estense Universitaria di Modena
Ideazione Laboratorio Didattico presso il Centro
Commerciale La Rotonda
Nunzia Lanzetta
Si ringraziano
Accornero Giovanni
Balboni dr. Andrea
M° Bellei Marcello
Caffagni dr.Mirco
Caffè Concerto Piazza Grande
Calzolari Alessandra
Cavicchi dr.Gianni
Centro Commerciale La Rotonda
Comune di Pieve di Cento
Chiarelli Alessandra
M° Fanfoni Luca
Frignani Eugenio
Adalgisa Geremia
M° Grondona Stefano
Groppetti dr.Roberto
Intelisano Giovanni
Milano dr Ernesto
Parmiggiani Rolando
Parmiggiani Marina
Piccinini Anna Maria
M.se Rangoni Macchiavelli Claudio
M° Scrollavezza Renato
Trevisani dr. Filippo
5
La musica
che ci trasmette tante emozioni
e l'arte che la fa vivere diventano protagoniste di
questa mostra, Musica nelle mani, che ci fa conoscere gli artefici di un rapporto così speciale:
strumenti musicali e liutai che li hanno creati,
facendo della liuteria un'arte unica.
Per la nostra Amministrazione questo evento è
occasione, nell’ambito della tradizionale manifestazione Serate Estensi, di intrecciare ancora una
volta un proficuo connubio tra pubblico e privato,
strettamente connesso, nello specifico, a due
aspetti del collezionismo: quello aristocratico,
che ha radici profonde nella storia della città di
Modena e dei suoi Duchi, gli Este (rappresentato
in questa mostra da un piccolo, prezioso ed eterogeneo nucleo di strumenti musicali che sarà possibile ammirare presso la Galleria Estense di
Modena); e il collezionismo storico, praticato dai
tanti "amatori" di ieri e di oggi, che, con passione, ricercano strumenti pregiati non solo per la
raffinata qualità della tecnica artigianale che li ha
realizzati, ma anche per la sublime armonia di
suoni che sanno produrre.
Una passione spesso nota ed apprezzata solo tra
gli specialisti del settore, che con questo evento
va oltre gli “addetti ai lavori" presentando nella
prestigiosa ambientazione delle sale storiche del
Palazzo Comunale quegli strumenti musicali,
nucleo di collezioni che hanno radici antiche,
specialmente nella nostra regione che per tradizione può vantare un grande patrimonio musicale.
6
Per esplicito intento dei promotori, la chiave di
lettura di questo evento è sostanzialmente didattica, consapevoli che i molteplici aspetti del collezionismo musicale e della tipologia degli strumenti non potevano essere racchiusi in proposte
troppo specialistiche. Una mostra per tutti, dunque, che riserva una sorpresa nel ridefinire la
figura del Duca Francesco II, fino ad oggi avvolta
da un alone di opacità, e che alla luce di nuovi
documenti si configura come singolare figura di
mecenate e raffinato cultore delle arti e della
musica.
Un ulteriore aspetto di questa esposizione, che va
segnalato, è la sua continuazione “oltre la
mostra”, dilatandosi all’interno del “Caffè
Concerto” in Piazza Grande e del Centro
Commerciale “La Rotonda” (dove saranno attivi
due laboratori didattici per i più piccoli), proiettando così un evento culturale nei luoghi della
nostra quotidianità.
Agli organizzatori, ai collezionisti che hanno
generosamente messo a disposizione pezzi pregiati delle loro raccolte, agli enti pubblici e ai
privati che hanno collaborato, a tutti coloro che
hanno reso possibile questa importante esposizione, va il mio sentito ringraziamento.
Giuliano Barbolini
Sindaco di Modena
7
M usica a corte
T
estimonianza preziosa della passione
musicale, che in tempi e modi diversi ha animato
il collezionismo e mecenatismo dei Duchi d'
Este, è un piccolo ma pregevolissimo nucleo di
strumenti musicali, oggi nelle raccolte della
Galleria Estense. Si tratta di una collezione che
8
se pur eterogenea, sia per periodo di esecuzione
che per stile e materia dei manufatti, riesce a tradurre il gusto collezionistico di una casata, quella
degli estensi, dagli splendori del rinascimento
ferrarese allo sfarzoso ‘600 barocco.
Nicolò Dell’Abate
Modena 1512 - Fontainebleau
1571
Allegoria della musica
Affresco trasportato
Galleria Estense Modena
9
La musica a Ferrara
con il duca Alfonso II
N
Il Lauro Secco...
Madrigali a cinque voci...
Ferrara, 1582
Biblioteca Estense
Universitaria, Modena
10
el Rinascimento, a
Ferrara i Duchi d' Este
fecero della loro corte un
innovativo centro di cultura e di sperimentazione
stilistica al pari di grandi
casate come quella dei
Gonzaga a Mantova e dei
Medici a Firenze. In questo contesto la musica
ebbe un posto di rilievo,
come arte tra le arti, presente quotidianamente nel
cerimoniale di corte, con
un ampio repertorio sia
per la musica da cappella,
nelle funzioni religiose,
sia per la musica d'intrattenimento: musica da
ballo, musica per i banchetti, musica per i tornei.
Alfonso II, ultimo duca estense a Ferrara, manifestando un'intensa volontà di grandezza, perpetuò uno stile di vita grandioso e un ambizioso
programma culturale atto ad affermare il prestigio di Casa d'Este. In tale contesto la vita musicale a corte si arricchì ulteriormente, nonostante
Ferrara, come tanti altri centri italiani, nella
seconda metà del cinquecento attraversasse una
profonda crisi culturale oltre che economica.
Nell'ambizioso programma culturale del Duca
rientrava la creazione di un concerto di voci femminili. L’idea di un simile repertorio musicale era
venuta nel 1568 in seguito alla visita di Stato
compiuta a Modena da Alfonso II d' Este con la
seconda moglie Barbara d'Austria, ove i coniugi
avevano assistito ad un'esibizione musicale di
Tarquinia Molza, dama di grande prestigio culturale, poetessa e musicista il cui canto si associava
alla maestria nel suonare il cembalo, il liuto e la
viola da gamba.
La pratica del canto femminile in questi anni era
già in voga a Ferrara, con le stesse sorelle del
duca, Leonora e Lucrezia che si dilettavano in
canto, e con i concerti al castello delle sorelle
Lucrezia e Isabella Bendidio, abili cantrici; ma
solo in seguito alle nozze di Alfonso con
Margherita Gonzaga, avvenute nel 1579, si delineò la situazione ottimale per la realizzazione di
quel concerto di dame che avrebbe dato prestigio,
invidia e fama al ducato estense, suscitando un
sempre più crescente ed esclusivo interesse del
Duca per la musica
In seguito a questo matrimonio si strinsero, infatti, i rapporti con la corte dei Gonzaga a Mantova,
qui il Duca ebbe occasione di assistere al canto di
Laura Peperara, restando profondamente ammirato dalle doti musicali e strumentali della dama,
tanto da chiedere a Guglielmo Gonzaga di avere
Laura a Ferrara come dama di Margherita.
Laura era stata educata nell'ambiente di corte,
poiché figlia di Vincenzo Peperara precettore dei
principi Gonzaga; qui era
divenuta allieva di Jaques de
Wert, maestro della cappella
di corte, acquisendo un'eccellente formazione musicale che
affiancava alla pratica del
canto lo studio dell'arpa, di cui
era gran virtuosa..
Arrivata alla corte ferrarese
nel maggio del 1580, Laura
iniziò subito ad esercitarsi ed
esibirsi al fianco di Anna
Guarini, figlia del poeta
Battista Guarini. Anche Anna
possedeva ottime qualità canore e un eccellente pratica strumentale, in particolare del
liuto. Per completare il trio, e
realizzare il progetto di quel
concerto femminile, tanto
desiderato dal Duca, alle due dame venne in
seguito affiancata la contessa Livia d'Arco.
L'ingresso di Livia nel concerto avvenne nel
1582, ben due anni dopo l'inizio dell' attività
musicale delle altre due dame e fu ritardato dalla
necessità di approfondire lo studio della viola,
sotto la guida di Lazzaro Luzzaschi, organista e
direttore della musica da camera di Alfonso II.
L' eccezionalità del concerto delle dame, denominato nell' ambito della stessa corte Concerto delle
dame Principalissime, e il successo della musica
secreta - così chiamata a corte - era legato sia al
ricercato repertorio musicale creato appositamente dal Luzzaschi spesso in collaborazione
con il poeta Giambattista Guarini, sia alla preparazione artistica delle musiciste che raffinarono
le loro competenze unite a doti canore naturali,
con puntuali e quotidiane esercitazioni sotto la
guida dello stesso Luzzaschi, di Ippolito Fiorini,
liutista e maestro di cappella, di Jaques Wert e,
per un periodo, con la preziosa partecipazione di
Tarquinia Molza, chiamata a corte nel 1583 ove
rimase fino al 1589.
L' Arpa di Laura
I
Liutaio romano (Cerchia di
Govan
Battista
Giacometti),
Giulio Marescotti, Orazio
Lamberti, 1581 - 1591
Arpa estense
Legno decorato
l clima artistico musicale, l' ammirazio
ne verso la musica secreta e le sue dame, spinsero
il Duca a commissionare strumenti nuovi, tra cui
un arpa, un liuto e una viola.
Alfonso II volle creare intorno al concerto una
splendida cornice visiva, facendo decorare e
miniare gli strumenti e racchiudere i libri di
musica in raffinatissime legature, quegli stessi
libri che spesso il duca in persona offriva in
visione ai colti ospiti che assistevano al concerto.
L’arpa fu eseguita a Roma, attraverso l'ambasciatore ducale Giulio Masetti, presumibilmente in
una bottega della cerchia di Giovanni Battista
Giacometti Si trattava di un arpa moderna in
legno d' acero e di pero verniciato, composta da
una doppia fila di 58 corde.
La decorazione dell' arpa, attuata tra il 1587 e il
1589, fu affidata al pittore ferrarese Giulio
Marescotti, mentre il disegno dei fregi superiori fu
eseguito da Giuseppe Mazzuoli detto il Bastarolo
che provvide anche a decorare “alla damaschina”
la viola e il liuto destinate a Livia e Anna.
L’esecuzione del fregio fu poi realizzata da
Orazio Lamberti, fiammingo di Aarsele , mentre
la doratura degli
stessi fu
attuata da
Giovan
Battista
Rosselli.
La ricca decorazione
dell’
arpa rimanda al
genere delle grottesche della prima
metà del’500, con
una decorazione
ricca di
motivi
miniaturizzati, tipica
dei motivi propri
delle legature, che
crea nei risultati uno
strumento elegantissimo, la cui decorazione
con grande varietà cromatica e di stili, riassume
e sintetizza il gusto artistico e l’ influenza della cultura per tanti aspetti cosmopolita della Ferrara della
seconda metà del XVI secolo.
Sulla cassa sonora, che si dilata verso il retro in una composizione ad arabesco di derivazione
orientale, dall’alto verso il basso,
sono inserite in cornici alternativamente monocrome e policrome - su
fondo oro, giallo, verde, rosso - dodici figurette, identificabili, sia per i
simboli che le contraddistinguono,
sia per le iscrizioni poste al di sotto
delle singole cornici, con le divinità
che presiedono all’ ispirazione artistica.
Al di fuori delle cornici, come sul davanti dello strumento, una miriade di raffigurazioni naturalistiche con ricche decorazioni floreali e faunistiche, rimandano ad un
ricco erbario.
11
L’ arpa e le sue dame scomparvero dalla scena
con la morte del Duca Alfonso II. Stessa sorte
subì parte della ricca collezione estense, compresi molti strumenti musicali che andarono
dispersi o distrutti dal degrado.
Trasferita a Modena nel 1601, l’arpa di Laura
- per lo scarso interesse e le difficoltà del
momento - passò da un magazzino all’ altro
fino ad essere dimenticata. Grazie a Luigi
Francesco Valdrighi e ad Adolfo Venturi,
nella seconda metà dell’ ‘800 questo strumento preziosissimo che, solo per una fortuita
vicenda è arrivato intatto ai giorni nostri,
venne sottratto all’oblio.
La musica alla corte di
Modena
Domenico Galli
notizie dal 1687 al 1691
Violoncello
(particolare)
Legno intagliato
Galleria Estense, Modena
12
Alla
morte di
Alfonso II d’Este, in
assenza di figli,
suo successore,
designato per
testamento, fu
il
cugino
C e s a r e
d’Este, ma
P a p a
Clemente
VIII non
riconobbe tale
Domenico Galli
notizie dal 1687 al 1691
Violino
Dedica a Francesco II D’Este
Legno intagliato
Galleria Estense, Modena
diritto e il dominio di Ferrara, in seguito alla
Convenzione Faentina del 12 gennaio 1598,
venne incorporato allo Stato della Chiesa.
Il 28 gennaio 1598 Cesare fu quindi costretto a
lasciare Ferrara per trasferire la Capitale a
Modena. che da piccola città di provincia dello
stato estense si innalzò a Capitale.
Per il Duca nel vecchio castello furono anni difficili, in cui risultò arduo il tentativo di recuperare almeno una parte delle ricche collezione ferraresi, sottoposte all’ inarrestabile depredazione da
parte dei cardinali papali, Pietro Aldobrandini e
Scipione Borghese, con la conseguente dispersione di tanti pezzi pregiati tra cui non pochi
strumenti musicali.
L’ impegno di Cesare d’Este di edificare e organizzare sul piano culturale la nuova corte investì
anche la vita musicale, con la riqualificazione
della cappella musicale estense, attuata soprattutto grazie all’ impegno di Orazio Vecchi.
Nunzia Lanzetta
Francesco II d’Este ed il collezionismo
artistico e musicale estense
L
’alone di opacità che ancora circonda
il duca Francesco II d’Este è da limitare, forse,
solo all’uomo politico e di governo, ma non
certo, alla luce di nuovi documenti, alla sua singolare figura di mecenate e di raffinato cultore
della musica e delle arti. Ad una storiografia
parca nell’attribuire doti di capacità a un duca
ritenuto succube del parente prossimo Cesare
Ignazio, e piuttosto orientata al riconoscimento di
una negletta intraprendenza, ha fatto sì da contrappeso l’individuazione di interessi musicali e
artistici, ma ciò è stato visto più come habitus
esteriore ed effimero che come segno evidente di
un più ampio progetto culturale.
Eppure numerose sono le ‘prove’ in grado di
riconoscere gli originali gusti musicali del duca,
e la sola raccolta di manoscritti di Alessandro
Stradella, offerta dopo la morte del musicista allo
stesso Francesco II e oggi appartenente alla ricca
collezione musicale della Biblioteca Estense, è di
per sé un dato assai significativo. Molte altre
testimonianze potrebbero essere citate, per le
quali si rimanda ai diversi studi di carattere tematico eterogeneo sull’iconografia musicale, sul
teatro, sull’oratorio, sull’opera, sul costume, sul
patrimonio artistico generale, che già hanno cercato di offrire un’immagine della corte nel breve
periodo di governo di Francesco II d’Este.
Tali contributi, pur delineando una più chiara
fisionomia del duca-mecenate, non hanno ancora
inciso adeguatamente sul giudizio della critica
storica, restia a riconoscere nella promozione
della cultura e delle arti operata da Francesco II
uno degli strumenti prediletti ai fini della realizzazione di quell’ideale progetto di assolutismo
monarchico facente parte delle aspirazioni o dei
programmi dei regnanti del tempo.
La recente inventariazione degli atti amministrativi della “borsa segreta” estense, da parte dell’Archivio di Stato di Modena, viene in aiuto per fare
chiarezza sui programmi culturali di Francesco
II, sui suoi poliedrici interessi e sui suoi finora
Domenico Galli
Sonate, (particolare)
Biblioteca Estense
Universitaria, Modena
13
ignorati meriti, svelando una lucente icona che
non è altro che la proiezione, l’emblema e la celebrazione di un ambiente colto e raffinato. La
visione d’insieme, che scaturisce da tale prezioso
materiale, permette di recuperare e giustamente
valorizzare la figura di Francesco d’Este, nel
contesto storico di fine Seicento.2
I nuovi documenti offrono una messe di informazioni sorprendenti riguardanti il nome e il numero degli artisti stipendiati e occasionali, dei comici, dei musicisti, dei costruttori di strumenti
musicali, dei pittori, degli scultori, degli indoratori e intarsiatori, dei copisti, dei gioiellieri, dei
ricamatori e sarti, dei fornitori di libri e stampe.
Ciò consente di colmare le lacune del ‘già noto’ e
permette, attraverso la raccolta e comparazione
dei dati, la ricostruzione puntuale della storia di
una corte nei suoi molteplici aspetti.
Nella loro peculiarità le fonti ritrovate consentono anche di valutare la
ricchezza dei mercati del
tempo, la qualità dei prodotti, il valore assegnato ai
prestatori d’opera e ai loro
servigi, di ricavare le provenienze geografiche degli
artisti e la collocazione temporale della loro permanenza
in territorio modenese, gli eventuali spostamenti in altri luoghi
degli artisti salariati e in alcuni
casi
i
dati
anagrafici.
Diversamente da quanto generalmente accade, questi
atti non limitano l’informazione al solo sintetico
compenso, già di per sé
importante e tale da suggerire analisi critiche
ma, fornendo elementi
precisi sulla ragione
dell’emolumento, offrono anche la possibilità
di ridisegnare l’ambiente
dall’interno e nei suoi rapporti esterni.
14
Ripercorrendo le vicende di un luogo e degli
uomini che in esso hanno operato possono, così,
essere avviate indagini più ampie di carattere
economico, artistico, sociale, umano.
Il quadro che emerge con evidenza è quello di
una città estremamente vivace ed attiva, aperta e
correlata ad altre realtà, disposta al prestito di
manodopera artistica e al reclutamento sul mercato italiano ed europeo delle maestranze più
disparate, grazie ai rapporti dinastici, ai contatti
diplomatici e al regime stanziale dei suoi funzionari-residenti. E’ proprio la varietà inimmaginabile di informazioni a favorire una visione, straordinaria e affascinante.
Attraverso le annotazioni relative alla ‘libraria’ si
coglie l’aspetto del collezionismo letterario coltivato dal duca. Oltre le notizie sugli acquisti e
dunque sulla quantità e qualità del materiale
bibliografico, si ricava la fonte di approvigionamento tanto di manoscritti, quanto di stampe,
carte geografiche, disegni, gazzette, almanacchi e
lunari, provenienti in prevalenza dalle piazze
veneziane e del nord Europa (principalmente
Amsterdam, Lione, Londra e Anversa). Non di
rado vengono indicati sia i nomi degli stampatori
sia i titoli delle opere acquisite; ciò consente, ad
oggi, riscontri sul patrimonio bibliografico tuttora posseduto e sulla sua storia. Allo stesso modo
il territorio parigino appare invece una delle più
attraenti piazze per comperare lussuosi gioielli
(“una boveta da ritratto arricchita di diamanti”,
provveduta a Parigi, costò nel 1684 lire 7.514.17)
e abiti ricamati “d’oro, et argento”, rifiniti di bottoni dipinti o di diamanti.
Il dinamismo interno della corte può essere ricostruito attraverso il calendario delle feste, degli
intrattenimenti ordinari e straordinari, oppure
tramite le musiche composte o copiate (delle
quali in alcuni casi viene fornito oltre il titolo,
anche il numero dei fogli acquistati e ricopiati, il
nome del copista, le parti strumentali), i ‘donativi’ elargiti ai musicisti, ai cantanti, ai comici. Se
a ciò si aggiungono ulteriori indicazioni provenienti dai resoconti dei funzionari e dagli ‘avvisi’3 si conosce anche il tessuto sociale cittadino e
si recepisce, attraverso l’immediatezza
Giovan Battista Cassarini
Sorgniano, 1643-Carrara, 1700
Violino (retro)
Marmo bianco di Carrara
Galleria Estense, Modena
dell’espressione e il taglio cronachistico delle
recensioni, l’incidenza e il riflesso determinato
dalla corte sulla vita e sul costume urbano.
L’attenzione rivolta invece dal Signore alla immagine personale, con evidenti scopi dispettacolarità pubblica, emerge anche dalle annotazioni
relative al corredo ‘privato’per sè e i suoi famigliari (perle, anelli, smeraldi e rubini, collane,
pendenti, “punte da busto di diamanti”, “orologi
gioiellati”, camei, lapislazzuli), mentre nel campo
degli arredi del Palazzo immenso è l’interesse per
le opere d’arte: quadri, arazzi e drapperie, mobili,
tavolini di marmo, decori e pitture, statue di
“busso” (legno di bosso) e di marmo affidate agli
scalpelli dei carraresi Francesco e Andrea Baratta,
Giovanni Lazzoni, del comasco Tommaso
Loraghi4e di Bernardo Falcone.
E’soprattutto il gusto spiccato per gli oggetti
artistici cosiddetti ‘minori’ a stupire; negli elenchi risultano maioliche pregiate, tra le quali non
può non sorprendere la presenza, negli anni 1681
e 1688, di due catini e un bacile di “Rafael d’Urbino”, argenti riccamente lavorati (bacili, vascelli, “galere armate”, fruttiere, panieri e tabacchiere, coltelli indiani e alla turchesca), scatole
d’agata, vasi d’alabastro, scrigni dorati, brocche
e scatolini, medaglie d’oro ed orologi, diaspri di
Boemia e pietre dure, “cristalli di monte”, cornici
e piedistalli, lavori d’intaglio. Non mancano
curiosità (lumache orientali), “inventioni”,
“instromenti matematici”, “carte di globi”, un
cannocchiale astronomico, mappamondi: lussuosi ornamenti che, nell’appagamento di un gusto
estremamente raffinato, indubbiamente conferivano prestigio e potere e consentono, ora come
allora, la percezione delle reali risorse economiche della corte (oggi verificabili con esattezza
attraverso il computo delle entrate e delle uscite).
Con il nome degli artefici di tali opere viene alla
luce un mondo sommerso che, relegato per lungo
tempo in un rango inferiore dell’arte, è invece
testimonianza di una cultura della manualità in
grado di creare preziosi e rarissimi manufatti.
Sorprendente è il numero degli artisti menzionati
e delle loro qualifiche: intarsiatori (Federico
Piazzalonga, Lorenzo Hail, Marcantonio
Mazarino o Mazzarini, Torri, Matteo Coppini),
intagliatori, ebanisti, indoratori, miniatori, ricamatori, incisori, fabbricanti di vetri e cristalli
(Francesco Verrio ed Enrico Vidman), gioiellieri
(in prevalenza francesi: Denis, Henri Gascar,
anche pittore, Palliot, “Maffeo”), argentieri (Carlo
Antonio Canoppi o Canovi e Girolamo Avosani),
ma anche più noti o pregevoli pittori (Pellegrino
Ascani, Domenico Bettini, Francesco Guienotti o
Guyenot, Baldassarre Bianchi, Bartolomeo
Schedoni, Bresciani5, Alfonso Gioia) e scultori.
Di tali artisti si conosce il luogo di provenienza e,
talvolta, anche una breve descrizione dell’oggetto elaborato; ciò ovviamente consente raffronti e
forse può favorire attribuzioni incerte.
Nella molteplicità degli aspetti relativi alla musica e al teatro6, si intende, in questa sede, segnalare il gusto per il collezionismo strumentale,
individuabile nell’elevato numero di commissioni (spinette di Giuliano Giovannini, cembali di
Sebastiano Ossa, organi, chitarre, un violone “da
Cremona”, timpani, un non meglio specificato
“instromento dato”) tra le quali figurano alcune
rarità, tuttora presenti presso la Galleria Estense.
Si fa riferimento in particolare agli strumenti in
marmo provenienti dalla città di Carrara, riconosciuta come principale luogo di rifornimento di
Domenico Galli
Sonate, (capilettera)
Biblioteca Estense
Universitaria, Modena
14
materiale di qualità e sede di pregiata lavorazione
scultorea. I contatti tra le due corti appenniniche,
favoriti da evidenti ragioni di vicinanza geografica, erano stati rafforzati nel tempo dalle parentele
dinastiche7, pur non essendo da escludere, anche
per questi luoghi, l’aspetto della ‘mobilità’ cui
andavano soggetti gli artisti.
Nel corso del Seicento aumentarono sensibilmente le richieste della corte estense ai signori di
Massa Carrara per il prestito di scultori, da
impiegarsi soprattutto negli interventi alle fabbriche di Sassuolo o per il Palazzo Ducale, per
“balaustri”, bassorilievi e cornici, per tavolini di
mischio, brocche, statue e altari. Nel 1646 Carlo
I Cybo aveva già concesso a Francesco I d’Este
Giuseppe Guidi8 per le fabbriche di Sassuolo, nel
1662 Giovanni Lazzoni veniva reclamato dalla
Duchessa Laura Martinozzi per la costruzione di
Angelo Maria Eschini
Antiporta incisa in
Giuseppe Colombi
La Lira Armonica...
Bologna 1673
Biblioteca Estense
Universitaria, Modena
16
una statua per le esequie del Duca (e a Modena
lo scultore risulta risiedere ancora negli anni
1667-69 e 1682)9, mentre il carrarese Andrea
Baratta lavora per la corte estense tra il 1685 e il
1694 fornendo, tra gli altri lavori, un busto di
Francesco II, statue, tavolini di marmo bianco e
“di marmo coloriti”10.
Non meno interessante lo scambio di musica e
musicisti; ad esempio l’agostiniano massese
Agostino Guidoni, organista e maestro di cappella nella Chiesa di S. Andrea di Carrara dal 1665,
prestò i suoi servigi al Duca Francesco I, ad Alfonso
IV e, nel 1677 e nel 1689, a Francesco II11.
Gli strumenti musicali in marmo rientrano a
pieno titolo nella amichevole dinamica di scambio tra le due corti e, in quanto ‘oggetti’ senza
dubbio particolari, furono offerti ad una personalità disposta ad accogliere con entusiasmo ciò che
apparteneva all’area della sperimentazione e
dell’eccezionalità ma, nel contempo, anche alle
categorie della raffinatezza artistica assoluta e del
collezionismo più esclusivo.
Il Duca Francesco II ricevette la chitarra di
Michele Antonio Grandi nel 1686, non sappiamo
se acquistata o regalata dalla famiglia Cybo di
Massa Carrara. Si ritiene che a favorire l’arrivo a
Modena degli strumenti in marmo sia stata anche
la permanenza a Massa Carrara del chitarrista e
tiorbista carpigiano Pietro Bertacchini, già secondo soprano nella cappella ducale di Modena, poi
al servizio dei Cybo negli anni 1685-86 (sopraggiunto dalla vicina Lucca, dove aveva ricoperto
l’incarico di maestro della cappella palatina)12;
ma le abilità di Grandi avrebbero già potuto essere note a corte se si presta fede alle affermazioni
del figlio Giacomo, che riferisce di “diversi lavorieri” del padre svolti al tempo del duca Francesco
I13.
Furono, comunque, soprattutto lo stupore e la
meraviglia suscitati dalla chitarra14 del carrarese
a determinare all’artefice ulteriori commissioni,
certamente un clavicembalo e, forse, anche quattro flauti e una cornetta, consegnati al Duca nel
novembre dell’anno successivo. In realtà i documenti archivistici registrano l’arrivo a Modena
solo di un clavicembalo e di un “ornamento di
acqua benedetta”, riportandone i relativi compensi e gli oneri per il trasporto riconosciuti al mulattiere ducale, inviato appositamente per il carico a
Carrara; nessuna testimonianza archivistica resta
invece degli altri oggetti. La puntualità con cui i
registri e le bollette di pagamento annotano i
movimenti di denaro escluderebbero la consegna
di tali strumenti di più piccolo taglio, ma si può
supporre che flauti e cornetti fossero inclusi nel
trasporto del cembalo (avvenuto probabilmente
per la via del Cerreto), uno strumento che, per le
sue grandi dimensioni, deve aver posto non pochi
problemi, finendo con il far trascurare dal computo, forse, altro materiale. Si può invece confermare che, nel 1687, Michele Antonio era accompagnato a Modena dal giovane figlio Giacomo
(nato a Carrara nel 1677)15, insieme al quale
soggiornò ‘a dozena’, cioè a pensione, a spese
della camera ducale, per un mese e quattordici
giorni16.
Di Michele Antonio Grandi si conoscevano, fino
ad oggi, solo i dati anagrafici essenziali, ma i
documenti emersi offrono molte informazioni
sul suo conto e sulla sua famiglia.
Il capotistipite del ramo carrarese della famiglia
Grandi è Matteo, originario di Bologna, stanziatosi a Carrara nel secondo ‘500. Da Matteo nacque Michele Antonio, padre di Francesco Maria
e, dall’unione di quest’ultimo con Giovanna
Fucigna, il futuro scultore. Venuto alla luce, nella
casa paterna situata nella frazione di Grazzano il
2 dicembre 1635, Michele Antonio fu battezzato
il giorno stesso nella chiesa di S. Andrea, dove
poi fu sepolto il 15 settembre 170717.
Vissuto in una famiglia di scultori e commercianti di pietra grezza, c’è da pensare che Grandi
abbia imparato l’arte dell’intaglio nella bottega
del padre o comunque in Carrara, prima di perfezionarsi sotto la probabile guida del Bernini a
Roma. Se ciò è ipotizzabile dalla raccomandazione, caldeggiata dal cardinale Alderano Cybo al
cavaliere Gian Lorenzo nell’ottobre 1659, un atto
notarile del febbraio successivo, attestante il suo
ritorno a Carrara per lavori ad un altare della
Chiesa di S. Andrea, può essere interpretato come
un’ulteriore prova dell’accoglimento del carrare-
se nella cerchia berniniana18. Questa notizia
rende più verosimile, tra l’altro, quanto affermato
da Giovanni Tiraboschi, relativamente ad un
impiego di Grandi presso “una cappella del
Gesù” a Roma; proprio in quegli anni Bernini fu
impegnato con la sua bottega nella chiesa del
noviziato dei Gesuiti, Sant’Andrea al Quirinale
Si può ancora documentare con certezza un rapporto duraturo con il cardinale Alderano Cybo,
per il quale Grandi (a meno che non si tratti del
padre) dapprima scolpì la cornice in marmo bianco e mischio per il bassorilievo dell’abside della
cattedrale di Jesi (a. 1663), per rivestire poi un
ruolo di consigliere e soprintendente sia per i
lavori di costruzione della Cappella Cybo presso
la Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma
(negli anni tra il 1683 e il 1687)19, sia per le
opere agli altari del transetto del Duomo di S.
Giovanni Battista Vitali
Artificii Musicali...
(frontespizio)
Modena, 1689
Biblioteca Estense
Universitaria, Modena
17
Pietro a Massa (a. 1687)20. Di una successiva
tarda commissione di “un’arma”, cioè uno
stemma, da parte del prelato (a. 1697) poco è
dato ancora di sapere21.
Se Michele Antonio Grandi è, ad oggi, “l’intagliatore” più ‘noto’ di strumenti musicali (a lui è
anche attribuito il salterio della collezione medicea conservata presso la Galleria dell’Accademia
di Firenze, Collezione del Conservatorio
Cherubini)22, c’è da pensare che la città di
Carrara coltivasse ars sculptorea in un settore, a
dir poco esclusivo, soprattutto in considerazione
dell’esistenza di un altro strumento, un violino in
marmo, di inconfutabile creazione ad opera del
carrarese Giovanni Battista Cassarini, conservato
nella stessa Galleria Estense.
Altre testimonianze bibliografiche, nel confermare la sopravvivenza di questa tradizione a Carrara
fino alla metà dell’800, inducono a pensare ad
una vera e propria scuola di cui purtroppo si è
perduta ogni traccia persino a livello di memoria
storica. Andrea Fortini (sec. XVIII), detto
Domenico, “intagliatore di strumenti a fiato”
(flauti, clarini e ottavini), fu probabilmente l’ultimo rappresentante di più generazioni
di carraresi, specialisti in un’arte che
richiedeva rara maestria23.
Pochi sono i dati relativi a Giovanni
Battista Cassarini e, al fine dell’identificazione della famiglia, fondamentale è
la firma leggibile sul fondo dello strumento. Il cognome registrato, contenente un’ evidente abbreviazione (“Casrini),
confuta precedenti interpretazioni e attribuzioni (finora Casarini) e rende giustizia a questo raffinato artista, del quale
nulla avremmo potuto altrimenti conoscere, in quanto gli storici menzionano
esclusivamente il nome di Sante scultore
(forse un fratello) e dell’ornatista Bartolomeo
(1686-1773), ignorando Giovanni
Battista.
La
consultazione
degli atti nota-
18
La chitarra di Michele Antonio Grandi
rili, di battesimo, morte, matrimoni, ha consentito, se non altro, di precisare i dati anagrafici, di
avanzare qualche notizia sulla famiglia e di individuare rapporti di conoscenza tra le famiglie
Grandi e Cassarini.
Giovanni Battista Cassarini nacque, probabilmente a Sorgnano, una piccola località presso
Carrara, il 22 maggio 1643 (morì a Carrara il 13
aprile 1700), figlio di Bartolomeo (a sua volta
figlio di Santino) e di Virginia Conti (figlia del
musicista spoletino Simone Conti). Del suo
matrimonio con Francesca Zambelli si conoscono le figlie Caterina e Virginia24.
L’elevato numero delle famiglie Cassarini a
Carrara, nel corso del Seicento, non ha certo agevolato l’esatta ricostruzione genealogica, ancora
in fase di studio. E’ comunque evidente il coinvolgimento del casato nell’arte della lavorazione
del marmo e del legno, di cui sono testimonianze
tangibili la qualità e il colore del decoro del violino25. La presenza poi nell’asse materno di un
musicista, l’organista e maestro di cappella
Simone Conti26, al servizio della Chiesa di S.
Andrea, rende ancor più verosimile l’esercizio
professionale in un ambito ‘scultoreomusicale’.
Qualche testimonianza supporta nell’affermazione di rapporti di conoscenza tra
le famiglie Grandi e Cassarini; i documenti notarili27 confermano reciproche
presenze in occasione di vendite e atti
testimoniali rendendo così verosimili
anche contatti professionali tra i due
scultori.
Patrizia Radicchi.
Michele Antonio Grandi
Grazzano (Carrara) 16351707
Chitarra (particolare)
Marmo bianco con intarsi
in marmo nero
Galleria Estense, Modena
L
a chitarra, realizzata interamente in
marmo bianco, presenta ricchi motivi ad intaglio,
con riempimenti in pasta di marmo nera. Fregi
floreali e vegetali a foglia d’acanto decorano lo
strumento tanto sulla tavola armonica quanto
sulle fasce e, parzialmente, sul cavigliere a paletta, caratterizzato da forma ondulata sui lati esterni
e sul margine superiore. Lo strumento si compone
di due pezzi: una lastra di marmo per la tavola
armonica e il manico, una base concava per la
cassa armonica e il fondo.
I fregi della tastiera propongono nove piccoli
boccioli, formati da tre elementi di cui un calice
centrale più grande e due petali laterali più piccoli -presenti anche sulla tavola armonica- con
dimensioni progressivamente ridotte dall’alto
verso il basso, in corrispondenza del diverso spazio che intercorre tra un tasto e l’altro. La sezione
tra il capotasto e il primo tasto e la porzione sottostante all’ultimo tasto mostrano invece differenti piccoli motivi a foglia. I tasti –in numero di
dieci-, costituiti da barrette di metallo scuro con
piccola scanalatura centrale (forse ottone brunito)
sono in rilievo e risultano inseriti nel marmo
mentre il capotasto è in marmo bianco e in altorilievo con piccole incisioni longitudinali colorate di nero corrispondenti ai cinque ordini di
corde doppie.
Sulla paletta si trovano cinque ordini di piroli o
caviglie, la cui forma -allargata nella testa con
parte terminale a sfera- si appoggia su una base
circolare che si inserisce nel cavigliere. Il retro
della paletta è completamente in marmo bianco.
Lo spessore del manico, di forma arrotondata,
aumenta gradualmente fino al tacco, decorato
anch’esso con motivo a foglia, mentre la superficie risulta interamente suddivisa in undici piccoli
spazi rettangolari leggermente svasati in basso,
alternati nei colori bianco e nero, le cui differenti
dimensioni sono determinate dalle diverse misure
delle sezioni dei tasti.
La tavola armonica, dal punto di vista decorativo
è articolata in tre sezioni, ciascuna delle quali
presenta caratteristiche proprie. La parte superiore mostra un calice centrale vegetale (rovesciato
verso il basso) che si dirama in due volute a foglia
d’acanto dalle quali fuoriescono quattro boccioli
Michele Antonio Grandi
Grazzano (Carrara) 16351707
Chitarra
Marmo bianco con intarsi
in marmo nero
Galleria Estense, Modena
19
(fior di loto), simmetricamente protesi verso l’alto e discendenti verso la rosetta. Due boccioli
compaiono anche in mezzo ai tralci.
Il fregio inferiore, al di sotto della rosetta, ripropone –a specchio- gli stessi motivi delle volute
superiori che si dipartono però da un nodo centrale-, con dimensioni più ampie e con arricchimenti nel disegno interno; compaiono anche gli stessi
boccioli, due dei quali allungati verso l‘alto, altri
due più piccoli verso i bordi e due minuscoli
rivolti all’interno. In basso i tralci terminano con
due corolle con lo stesso numero di petali disposti
a ruota. Motivi di fiore aperto con pistillo, orientati verso i bordi, si trovano sotto la cordiera e
completano in modo armonico la composizione
decorativa.
Disegni geometrici costituiti da otto elementi
biforcati, si trovano disposti a raggiera all’interno
della rosetta, circondata da una doppia cornice
che, internamente, presenta piccoli cerchi in pasta
nera inseriti in cerchi bianchi di maggiori dimensioni contornati, a loro volta, da doppia filettatura
nera; esternamente la rosetta si articola in fregi a
forma di gigli, alternati nelle dimensioni, con
terminali a piccole sfere.
Il ponticello, posto a separazione del grande e
ricco fregio a volute dal motivo a petali di chiusura, fuoriesce in altorilievo dalla tavola armonica degradando bilateralmente fino a fondersi col
disegno della tavola stessa; presenta doppie incisioni longitudinali da riferirsi ai cinque cori, dei
quali segni visibili appaiono anche sul bordo
esterno inferiore. In corrispondenza di tali piccole
incisioni si trovano, nel bordo bianco superiore
che incornicia la fascia, cinque ordini di fori
Domenico Galli
Sonate, (frontespizio)
Biblioteca Estense
Universitaria, Modena
20
doppi sotto i quali si evidenziano un piccolo tassello rettangolare di marmo bianco e due semicerchi in rilievo, entrambi forati.
Intorno alla tavola armonica si trova una filettatura nera, inserita in mezzo all’orlo bianco che
corre tutt’intorno allo strumento; il bordo, lievemente sporgente e poco arrotondato, ha uno spessore lievemente variabile.
La fascia presenta otto doppie volute concatenate
che ripropongono i disegni della parte inferiore
della tavola armonica, con direzione di apertura
verso l’alto. Superiormente ed inferiormente corre
una filettatura nera inserita nel mezzo del bordi
bianchi; nella parte inferiore del bordo compaiono piccoli tagli longitudinali colorati di nero.
Lo strumento, restaurato nel 1995 presenta alcune
venature sulla tavola armonica, dovute a piccole
lesioni, opportunamente incollate e stuccate.
Alcuni piroli, perduti, sono stati sostituiti da
materiale nuovo, mentre le corde non sono state
ripristinate. Una macchia di colore giallo si trova
nella parte superiore del fregio centrale.
Il violino di Giovanni Battista Cassarini
I
l violino è realizzato in marmo bianco
statuario con delicatissimi intagli di pasta di
marmo lavorata nei colori rosso e giallo Siena.
Sulla tavola armonica, di forma arrotondata nella
parte superiore e priva di due spigoli (“punte”)
rispetto agli attuali strumenti, si appoggiano la
cordiera, il ponticello e la tastiera, quest’ultima in
sospensione sopra il piano.
La cassa mostra decori tanto sulla tavola armonica quanto sul fondo e sulle fasce. Sulla tavola,
sopra il ponticello, si apre - su un nodo di colore
rosso chiaro doppiamente filettato e chiuso da
sottili nastri incrociati -, un disegno a ventaglio di
colore rosso con volute vegetali, viticci e terminali di piccoli fiori con quattro petali aperti; nella
parte inferiore, sotto il ponticello, il decoro vegetale si struttura intorno a due piccoli fori armonici
laterali e risulta più spesso di quello soprastante.
La tavola armonica risulta lievemente rialzata
intorno alla filettatura nera che corre intorno a
tutto lo strumento ed è contornata da un piccolo
bordo sporgente. Il fondo, come la tavola, è lievemente bombato e il bordo simmetricamente spor-
Giovan Battista Cassarini
Sorgniano (Carrara ),
1643-Carrara, 1700
Violino
Marmo bianco di Carrara
Galleria Estense, Modena
gente rispetto al piano superiore. Tra i fregi del
fondo della cassa, quello superiore è sviluppato in
egual misura nel senso della larghezza e della
lunghezza, mentre quello inferiore è meno esteso
nel senso dell’altezza. Entrambi, di colore rosso,
incorniciano un grande giglio, di tipo francese,
della stessa tinta
Nel manico il capotasto è lievemente sporgente e
di colore nettamente più bianco rispetto al colore
generale dello strumento
La voluta del riccio completa il cavigliere e presenta due ben modellate scannellature che separano i nastrini; le parti laterali del riccio chiudono
con due piccole nocette. I quattro piroli o bischeri, sui quali si avvolgono le estremità delle corde,
sono infissi sul cavigliere e ripropongono la stessa forma dei piroli della chitarra.
La tastiera presenta, dal basso verso l’alto, un
piccolo disegno geometrico di forma romboidale
che schiude un cuore con parte terminale interna
conclusa da una piccola croce. Al di sopra, la
tastiera ha una decorazione ripartita in quattro
sezioni, divise tra loro da barrette orizzontali, di
colore giallo, equidistanti l’una dall’altra; tra i
piccoli spazi barrette di colore alternato (giallo
Siena e rosso) si inseriscono nella serie di minuscoli cerchi ordinati a gruppi di due e tre, riempiti di pasta nera. Sul retro del manico si trovano
due figure geometriche modulate sulla forma e
sulle dimensioni del manico e allungate verso il
covino o tallone; di colore chiaro, ciascuna figura
-attraversata da nove piccole tacche-, risulta
orientata nella parte terminale in direzione convergente.
Il ponticello poggia su due piccoli fori; lateralmente ad esso si trovano i due intagli a forma di
effe privi di taglietti trasversali.
Nella parte alta della cordiera, sotto un sottile
rilievo, si trovano quattro fori di aggancio per le
relative corde. In basso, una piccola fessura ha la
funzione di legare la cordiera al bottone sottostante, tramite una corda di sostegno (originariamente forse un budello).
La fascia, incollata alla tavola armonica e al
fondo, presenta losanghe sviluppate nel senso
della larghezza, in pasta nera.
All’interno, sul fondo, risulta incisa la seguente iscrizione: “D.O.M/Jo. Baptista Casrini/Carrara 1687”
La maggiore pesantezza dello strumento nella
21
parte alta fa ipotizzare l’utilizzo di un diverso
spessore del marmo tra la sezione superiore e
quella inferiore. Si segnala, nella parte interna, la
presenza della catena in legno.
Restaurato nel 1995, lo strumento
è in ottimo stato di conservazione;
ricostruiti solo una porzione del
ponticello e, probabilmente, due piroli.
Il flauto dolce
(attribuito a Michele Antonio Grandi)
I
l flauto dolce in marmo conchigliare
lumachella, ha una lunghezza di cm. 34 e un tubo
a forma conica nella parte terminale. Sotto l’imboccatura a becco si trovano il labio e 6 fori, più
un foro laterale per il mignolo, sottostante al
primo foro e lievemente spostato rispetto ad esso.
E’ presente il foro posteriore.
Restaurato nel 1995, lo strumento presenta evidenti segni di rottura in tre pezzi, uno tra il primo
e il secondo foro, e l’altro all’altezza del quarto
foro; tali lesioni non intaccano comunque la particolare bellezza determinata, oltre che dalle proporzioni e dalla cura di lavorazione, dalla rara
qualità di marmo, di per sé già decorativo.
E’ probabile che lo strumento sia opera di Michele
Antonio Grandi e facesse parte della serie di strumenti sopraggiunti a Modena nel 1687, su commissione di Francesco II.
Questi strumenti, entrati a far parte della Galleria
Estense negli anni 1686-7, compaiono negli
inventari del 175128. Da tali documenti risulta la
presenza di due flauti, “uno più grande dell’altro
di marmo venato di bianco e rosso; ed il più piccolo tutto rosso”, mentre relativamente alla chitarra si ricava anche l’esistenza della custodia
(“sua cassa e serratura”), oggi scomparsa. Un
errore di valutazione appare nell’individuazione
del materiale definito “d’alabastro”, comprensibile se si considera la trasparenza, l’omogeneità e il
candore del marmo utilizzato per il violino e la
chitarra.
Secondo la testimonianza di Luigi Francesco
Valdrighi gli strumenti sarebbero stati riconsegnati a Francesco V nel 1868, in quanto “provati
di essere di proprietà privata”29. La conferma
dell’esattezza della notizia si ricava dalla loro
22
presenza nel catalogo del Museo degli strumenti
musicali di Vienna, pubblicato nel 192030. Di lì a
poco (23 giugno 1923) gli strumenti in marmo
tornarono alla Galleria Estense, insieme ad altri
beni restituiti dall’Austria-Ungheria. Ciò si
evince dalla lettera di riconsegna
da parte del Ministero
d e l l a
P u b b l i c a
Istruzione
(Direzione
Generale per le Antichità e le Belle
Arti), rappresentato dall’allora Regio Ispettore
della Pinacoteca di Brera di Milano, Dott. Mario
Solmi, conservata presso la Soprintendenza di
Modena. Dalla ricevuta risultano la chitarra, il
violino e “un piffero di marmo macchiato con
relativi sostegni”31.
E’ evidente che, nell’ultimo caso, al di là della
definizione utilizzata, si alluda chiaramente al
flauto dolce in marmo di lumachella. Manca invece l’altro flauto, forse il più piccolo, presente
negli inventari del 1751.
NOTE
1 Per informazioni su questi studi si rimanda alla bibliografia generale; nel presente articolo si forniscono esclusivamente, in forma
succinta, le fonti archivistiche.
2 Archivio di Stato di Modena (d’ora in poi ASMo), Camera Ducale,
Borsa segreta, bb. 273, 284, 286-9, 293, 297, 298. Su questo materiale è in preparazione uno studio approfondito, relativo all’arte e
alla musica, nel periodo di governo di Francesco II.
3 ASMo, Avvisi e Notizie dall’Estero, bb. 63-5.
4 ASMo, Cancelleria estense, Referendari, Consiglieri, Cancellieri e
Segretari, b. 52b, Lettere di Giuseppe Busseti; Archivio per materia,
Scultori, b. 17/1; Cose d’arte, Miscellanea, b. 19/1; Carteggio
Principi Esteri, b. 1507/C.
5 Di costui, il 10 settembre 1688, furono acquistati “due quadri di
battaglie”.
6 Anche su questo argomento è in corso una ricerca sistematica.
7 Le attestazioni di amicizia erano sensibilmente aumentate a seguito dell’unione di Alderano I Cybo con Marfisa d’Este e, nel primo
Seicento, dopo i due matrimoni tra i Cybo e i Pico della Mirandola.
8 ASMo, Carteggio Principi Esteri, b. 1208/3.
9 Archivio di Stato di Massa (d’ora in poi ASMs), Cybo Malaspina
(salvo diversa indicazione), Lettere ad Alberico II Cybo Malaspina,
b. 328, n. 231; b. 329, n. 38; b. 331, n. 127; b. 332, n. 31; ASMo,
Carteggio Principi Esteri, bb. 1209/4, 1507/C.
10 ASMs, Lettere a Carlo II Principe di Carrara, b. 463, n. 67;
Arch. Card. Alderano, b. 23, p. 181; b. 24, p. 99.
11 ASMs, Notarile Carrara, (d’ora in poi si omette) Lombardelli
Angelo, b. 100, fasc. 1665-75, p. 548; ASMo, Carteggio Principi
Esteri, bb. 1208/3, 1212/7.
Anonimo
sec. XVII
(Michele Antonio Grandi ?)
Flauto dolce
Marmo di lumachella
Galleria Estense, Modena
12 Bertacchini viene richiesto dai Cybo anche nell’aprile 1687;
ASMo, Carteggio Principi Esteri, b. 1212/7.
13 ASMo, Archivio per materia, Scultori, b. 17/1. Potrebbe però
anche trattarsi di un errore di scrittura e alludere invece a Francesco
II.
14 Teoricamente è da suffragare quanto affermato da Bertacchini
nella sua autobiografia -oggi purtroppo perduta-, relativamente
all’impatto prodotto dal suono del marmo in ambiente modenese
quando egli vi fece ritorno nel 1686. Pur mancando la chitarra del
foro centrale, utile per far vibrare la cassa armonica, non si esclude
la produzione di suono, in considerazione del fatto che la cassa è in
un pezzo unico di marmo, scavato al suo interno.
15 Archivio del Duomo di Carrara (d’ora in poi ADC), Battesimi,
VIII, p. 29.
16 ASMo, Archivio per materia, Scultori, b. 17/1; Carteggio Principi
Esteri, b. 1208/3, 1217/7, 1209/4. Non si può invece documentare la
presenza di Grandi nell’anno precedente, riportata da Bertacchini e
ripetuta dagli storici successivi. Per la chitarra e “l’ornamento di
acqua benedetta” Grandi ricevette, non sappiamo se un compenso o
un donativo, rispettivamente doppie 25 per un valore di lire 825,
mentre per il clavicembalo doppie 80, cioé lire 2640.
17 ADC, Battesimi, IV, V, VI, VII, VIII; Matrimoni, I, Morti I-II,
III.
18 Bibliothèque Nationale de France, Ms Italien 2082, f. 68-69v, cit.
in Fabrizio Federici, “Qual redivivo Augusto”. Il cardinale Alderano
Cybo (1613-1700) mecenate e collezionista; tesi di laurea dell’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento
di Storia delle Arti, relatore Prof. Antonio Pinelli, anno accademico
2000/2001, pp. 18-19. ASMs, Lombardelli Angelo, b. 99, fasc.
1660-61, 1 agosto 1660; Lombardelli Angelo, b. 104, Indice 1637,
1662 e 1669.
19 ASMs, Carteggio di Veronica Cybo Salviati, b. 476, n. 174; Arch.
Card. Alderano, b. 6, e p. 437; b. 24, p. 99.
20 ASMs, Arch. Card. Alderano, b. 24, p. 99.
21 ASMs, Archivio Card. Alderano, b. 29, pp. 849, 851, 981 e col 185.
22 Franca Falletti, Renato Meucci, Gabriele Rossi Rognoni (a cura
di), La musica e i suoi strumenti. La collezione Granducale del
Conservatorio Cherubini, Ministero per i Beni e le Attività Culturali-
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, Pistoia e
Prato,Firenze, Giunti 2001.
23 ASMs, Archivio privato Canonico P. Andrei, Miscellanea storica,
b. 7, fasc. 59, p. 88.
24 ADC, Battesimi, VI, p. 116; Battesimi, VII, p. 92; Battesimi, VIII,
p. 4; Morti, III/A, p. 125; Morti, III/B, p. 3.
25 ASMs, Agostini Paolo, b. 95, Rubrica, 1 aprile 1620; Schiffini
Gio. Battista, b. 133, fasc. 1691-2, pp. 97-99.
26 Rimando, per costui, al mio articolo Alberico Cybo Malaspina e
la musica nello Stato di Massa Carrara:1553-1623, <<Studi
Musicali>>, XXX, 2001, n. 2, pp. 348-9.
27 ASMS Ghirlanda Leandro, b. 115 (1673-77), fasc. 1673-74, pp.
4-6; Lombardelli Angelo, b. 98. (fasc.1651-54), pp. 110-14.
28 ASMo Camera Ducale, Cassa segreta, n. 24108, Inventario generale dei dissegni, medaglie e altro, cit. in Ducal Galleria Estense.
Dissegni, Medaglie e altro. Gli inventari del 1669 e del 1751 a cura
di Jadranka Bentini e Patrizia Curti,<<Materiali per la Storia di
Modena Medievale e Moderna>>, pp. 103, IX, Panini, Modena
1999. Ringrazio il Prof. Renato Meucci per i consigli e i suggerimenti offerti per la compilazione delle schede e per la segnalazione
dell’esistenza di questi strumenti.
29 Luigi Francesco Valdrighi, Nomocheliurgografia antica e moderna, ossia elenco di fabbricatori di strumenti armonici con note
esplicative e documenti estratti dall’Archivio di Stato di Modena,
<<Memoria della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di
Modena>>, Modena, Soc. Tipografica, serie 2^, vol. II, 1884, p. 160
, rist. Bologna, Forni, 1967.
30 Julius Schlosser , Die Sammlung alter Musikinstrumente, Wien,
Schroll. 1920, pp. 59, 67, 77.
31 Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e
Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emolia, Atti della
della direzione, prot. n. 1032
Patrizia Radicchi.
Domenico Galli
Sonate, (capilettere)
Biblioteca Estense
Universitaria Modena
23
D ue preziosi intagli:
il violoncello e il violino di Domenico Galli
Per
il duca Francesco II, la
cui passione per la musica e la letteratura superava i doveri di governo,
furono realizzati dal parmense
Domenico Galli , intagliatore, decoratore, calligrafo e musicista due
strumenti, pregevoli esempi dell'arte
dell' intaglio.
Si tratta di un violino e violoncello definiti muti, poiché il ricco intaglio trafora la
cassa sonora, mostrando chiaramente che
simili preziosi manufatti sono stati commissionati più per accrescere il gusto collezionistico del principe che per rispondere
a reali esigenze di qualità strumentale.
Il violino realizzato nel
1687 presenta, in un piccolo
medaglione in cima alla
tastiera, una iscrizione ove
vi è la dedica dell' artista al
duca: ”SER..MA ALT.ZA/
La mia dolcezza animata dal
commando augusto di V.A.S.
ardisce sperare benigno gradimento di quest’ opra che
figlia de di lei serenissimi co
tante bocche quanti sfori mostra,
ambisce pubblicare all’ universo / Parma il di P.o
Sett. bre 1687/di V.A.S./
Um.o Div.oet ob.oS.o/
Dom.o Galli”.
Anche il violoncello presenta analoga dedica, e
fu offerto dall’artista al
Duca l’ 8 settembre 1691
corredato da una rassegna di dodici sonate composte appositamente per
Francesco II d'Este.
24
Domenico Galli
notizie dal 1687 al 1691
Violoncello
Legno intagliato
Galleria Estense, Modena
Lo strumento è impreziosito da un ricchissimo
intaglio in una profusione di idee decorative e
motivi allegorici che culminano nel fregio
superiore ove è raffigurato un drago svolazzante. Nella cassa, sul retro, il prezioso intaglio si snoda in una serie di raffigurazioni
allegoriche con Orfeo che suona la lira e
nella parte bassa Ercole che abbatte l’ Idra ,
Pallade, il leone e la Perfidia. Queste allegorie secondo Luigi Francesco Valdrighi1 erano
riferibili alle vicende politiche occorse alla
sorella del Duca Francesco II, Maria Beatrice
d' Este, la quale andò sposa a Giacomo Stuart,
diventando regina d' Inghilterra. Nel 1688 i
cattolici Stuart furono però spodestati, insieme al loro figlioletto Giacomo Stuart III,
erede al trono cattolico d’Inghilterra, dal protestante Guglielmo d'Orange.
Il ricco intreccio di intagli rimanda ad una
rappresentazione, quasi soffocante, di ornati,
puttini, fiori, frutti, ricci, armi, medaglioni,
espressione tipica del gusto barocco, forse
esageratamente ripetuto nell’ intaglio ma efficace nella composizione.
La viola contralto di
Girolamo e Antonio Amati
ecentissima la collocazione, a pieno
titolo, nel percorso espositivo della Galleria
Estense di un pregevolissima viola, esempio
della liuteria cremonese dei primi decenni
del ‘600.
La viola, di taglia piccola (la cassa misura 406
mm di lunghezza, il che la rende per dimensioni estremamente rara) fu eseguita dai fratelli Girolamo e Antonio Amati.
Dall’ etichetta all’interno della cassa armonica si desume che sia stata realizzata nel 1620.
L' attribuzione alla bottega Amati2 confermata dal modello della cassa, del riccio e delle
"FF" insieme alla proporzione della forma, gli
spessori e la bombatura della tavola e del
fondo, non lasciano dubbi circa l'originalità;
al contrario non sono originali la cordiera e la
R
Domenico Galli
notizie dal 1687 al 1691
Violino
Legno intagliato
Galleria Estense, Modena
25
L a musica nelle mani
tastiera , comunque sostituiti in un intervento
di restauro antico .
L'’assenza di documenti d’ archivio e di
riscontro negli inventari estensi non consente,
allo stato attuale, di risalire al committente ne’
a quando e come sia arrivata nelle collezioni
ducali. Da un altro cartellino a corredo dello
strumento si desume che sia stata restaurata a
Mainz nel 1795. Sottoposta nel 1914 ad intervento di restauro dal liutaio modenese Pietro
Messori, la viola si presenta oggi in ottimo
stato di conservazione.
Nelle collezioni della Galleria Estense si conserva un altro strumento attribuito alla Bottega
Amati: si tratta di un violoncello attribuito a
Nicola Amati da un etichetta posta all' interno
della cassa <Nicolaus Amatius Cremonien
Hiero/Nimi filii Antoni Nepos fecit
Ao.1676>.
Una recente indagine fa ritenere che lo strumento sia una copia riferibile a Scuola Tedesca
dell' '800, nello stile dei violoncelli di Nicola
Amati, ove anche l'etichetta è "una copia".
NOTE
1 L.F. Valdrighi. Di un’arpa un violino e un violoncello che si
conservano nell' odierno Museo Artistico Estense. Nel testo
Valdrighi descrive sul retro del violino il ricco intaglio allegorico riferibile a Maria Beatrice Stuart e alle sorti della sua
famiglia,. E' questo un errore che ha generato tra gli storici
confusione, poiche il violino è stato eseguito nel 1687, un anno
prima della cacciata degli Stuart.
( 1688) In realtà le allegorie: Ercole, Pallade, Orfeo, il leone
ecc, non sono sul retro del violino ma sono sul retro del
Violoncello, costruito tre anni dopo(1691) la cacciata degli
Stuart.
2 La viola Amati è stata oggetto di studio da parte del liutaio
Carlo Chiesa di Milano, la cui relazione tecnica sul manufatto
è stata utilissima per la redazione di questa scheda
Nunzia Lanzetta
Antonio e Girolamo Amati
Primi decenni del sec. XVII
Viola contralto
Galleria Estense, Modena
26
Fabbricatore Gennaro
chitarra (particolare)
Napoli – 1822
L
a “musica nelle mani” è un’affermazione coniata per puntualizzare il fulcro intorno
al quale ruota la capacità di creare e di usare
uno strumento musicale, l’utensile più bello
e più straordinario che “ l’homo faber “
abbia saputo costruire, ricavando da una
materia inerte (sia questo legno, metallo,
osso), il modo di generare il suono e le
meraviglie che dal suono o dai suoni,
opportunamente organizzati dalla mente
umana, si possono generare.
Con le mani il liutaio, il cembalaro o il
costruttore di strumenti a fiato, generano lo
strumento musicale ed il musicista, con l’interazione delle mani su di esso, genera il
suono,”fiore” di quella creazione, che emana il
suo “profumo”, in musica.
Questa successione di eventi è altresì la summa
di tecnica, logica, ispirazione, istinto, intuizione,
ovvero l’uomo nella sua essenza creativa.
Ecco perché gli strumenti musicali possono
essere considerati una delle testimonianze più
complete della storia dell’artigianato creativo, poiché raccontano il lavoro dell’uomo nel corso dei secoli, le sue invenzioni e tecnologie, i meccanismi, i
congegni e le alchimie che l’Antico
ha dovuto da sempre escogitare per
“trasferire sulla terra”, “le armonie
delle sfere celesti” (Severino
Boezio,V° sec.).
Un oggetto progettato per fare
musica, è un oggetto d’arte, per
sua natura fragile e delicato, con
una struttura calcolata, in ogni
tempo, al limite delle possibilità
costruttive e proprio per questa
ragione esso è particolarmente soggetto al degrado, alla perdita delle
sue qualità intrinseche ed è inoltre
esposto a tentazioni di recuperi funzionali
indiscriminati, che hanno purtroppo già com-
27
promesso in passato molti documenti ed esemplari unici.
C
ome oggetto d’arte , lo strumento musicale si è sempre identificato
come qualcosa di esclusivo, a volte
di unico, quindi una rappresentazione di preziosità che ha sempre appassionato nobili ed aristocratici delle
varie epoche, eleggendolo a simbolo
di una ricchezza non solo oggettiva.
Lo strumento musicale ha accompagnato l’uomo nei suoi riti tribali,
nelle sue battaglie di conquista, nei
suoi lutti, nei suoi momenti di vita
sociale, nei momenti di riflessione e
di ispirazione, nei suoi pellegrinaggi.
C
ome oggetto storico, ha ricevuto
un contributo fondamentale dalla
cultura Islamica, che ha completamente condizionato e trasformato la
nostra cultura.
Basti pensare che fino all’avvento
dell’Islam, non si conosceva il
“suono continuo” su uno strumento
a corda.
Gli Islamici ci hanno portato lo strumento ad
arco con il “rebàb” (diverrà la medioevale
“ribeca”) ed i “kemànge” a braccio e a gamba.
Il liuto con la cassa piccola ed il manico lungo
era già noto agli Egiziani, ma gli Arabi hanno
introdotto lo ”el-ud “, < il legno> (perché aveva
la tavola armonica in legno e non in pelle), che si
trasformò nelle varie accezioni di “Lute”, “Laute”
e da noi “Liuto”, con la grande cassa ovoidale, il
fondo bombato a strisce, il manico corto e largo
ed il cavigliere a spatola ripiegato.
Il liuto sarà il protagonista di tutta la nostra cultura del Rinascimento, tenterà di sopravvivere
all’avvento delle più comode “tastiere” con gli
arciliuti, le tiorbe e i chitarroni, ma infine rimarrà
solo un importante testimone di una grande civiltà musicale.
J.W. Oberlennder
flauto diritto contralto
in avorio
Norimberga
Callezione privata
28
E pensare che nel 1507, in assoluto, fu proprio
musica liutistica, la prima musica “strumentale”
stampata.
La moda del liuto, seguita a breve termine da
quella della chitarra, si diffuse per tutta l’Europa.
Lo strumento aveva i requisiti per essere ben
accetto ovunque: a corte, in chiesa, nella strada.
E’ infatti uno strumento polifonico, che permette
di assecondare il gusto musicale più colto; è
facilmente trasportabile e ciò lo rende idoneo a
svariate occasioni di musica d’insieme.
Ha una sua intrinseca nobiltà timbrica, tanto da
venir definito come “il divin Liutto, Rè di tutti li
strumenti”.
La moda del liuto creò un notevole
mercato di strumenti, corde e accessori vari.
Si pensi, ad esempio, che secondo le
scritture contabili del Porto di
Londra, tra il 1567 ed il 1568, nel
corso di dieci mesi, vennero importati 86 liuti (di cui 12 da Anversa, 14
da Colonia e 24 da Venezia) e 13.848
corde di budello.
Nella stessa epoca, acquistare un
liuto, per esempio a Bologna, città
con un’elevata concentrazione di
liutai, equivaleva oggi ad acquistare
un mini-appartamento.
Ora, poteva accadere che uno strumento appartenente ad una famiglia,
acquistasse un particolare favore del
pubblico e sviluppasse, col tempo,
una sua letteratura autonoma, che
non era più riconducibile a quella
della famiglia originaria.
Così è accaduto al violino, illuminante prova dell’intelligenza umana;
da una sterminata famiglia di viole
(da gamba, da braccio, d’amore,
pompose e via dicendo) e dalle lire
da braccio
(che denunciano la loro origine
Islamica dal cavigliere con i piroli frontali),
Cerino Lorenzo
flauto traverso in avorio
fine XVIII sec.
Torino
Callezione privata
anche i liutai contribuirono, con lenta ed
implacabile tenacia, a condensare in quattro
strumenti ad arco (violino, viola, violoncello e contrabbasso, corrispondenti alle
voci di soprano, tenore, baritono e
basso), tutte le proprietà delle famiglie originarie, riducendone anche
l’incordatura a quattro corde semplici.
E’ accaduto altrettanto
per lo strumento più
piccolo
della famiglia
del
liuto, quello
che già alla
fine
del
Seicento
veniva chiamato “mandolino”.
Nel
secolo
XVIII° si hanno
diversi modelli
di mandolini,
ognuno dei quali
era espressione
di
letteratura
musicale piuttosto sviluppata.
Nella classificaz i o n e
Ottocentesca si
avevano così il
mandolino lombardo, il napoletano, il
genovese, il bresciano, il fiorentino, il padovano, il
senese, il romano, il
siciliano.
Dal mandolino, inoltre, si sviluppò
un’intera famiglia di
cordofoni a pizzico che comprendeva il modello
soprano, il tenore ed il basso.
Riguardo alla chitarra, attorno al XVI° secolo, si ha
una prima diffusione di un modello di strumento a
quattro ordini di corde (es.Belchior Dias ),assai
apprezzato in Spagna, Francia ed Italia.
Con l’aggiunta di un quinto ordine di corde
(“ordine” sta per corda doppia), lo strumento si
afferma in tutta Europa, con forme e dimensioni
diverse, creando delle vere scuole nazionali.
Parallelamente si consolida la fama di alcuni
liutai, i cui strumenti già all’epoca erano ricercati e collezionati: ricordiamo i Sellas di Venezia,
attivi già nella prima metà del Seicento.
I Voboam a Parigi, che produssero strumenti
intarsiati e riccamente decorati di gran pregio,
come pure J.Tielke, di Amburgo, famoso anch’egli
per gli intarsi.
In Italia Antonio Stradivari portò il proprio personale contributo alla costruzione della chitarra
ed in seguito Luigi Marconcini, della corte di
Ferrara (allievo di Omobono Stradivari, figlio
del sommo Antonio) ed il figlio Giuseppe
Marconcini, allievo di Lorenzo Storioni.
Menzionato nell’anno 1816, nel Carteggio del
Conte Cozio di Salabue, come abile aggiustatore
attivo in Ferrara, G. Marconcini fu inoltre buon
violinista e amico di Nicolò Paganini.
Mentre a Napoli, alla Corte della Regina
Margherita, GiovanBattista e Gennaro
Fabbricatore furono fra i più famosi costruttori di
chitarre.
Ignoto alla nostra cultura il “salterio”, derivato
dall’arabo “qànùn” (medioevale:canone).
Quando si applicherà una tastiera al salterio,
nasceranno la spinetta, il clavicembalo e, alla
fine, anche il pianoforte, che non è altro che un
grande salterio non più a pizzico, ma a percussione.
Questi sono solo alcuni accenni storici al fascino
di esercitarsi nella “raccolta” di violini, chitarre,
flauti, arpe, cembali, e strumenti musicali in
genere, fino a creare la “collezione storica”, ricca
di suggerimenti per coloro che cercano il fascino
dell’antico e godono dell’esperienza profonda di
G. Gelso (?)
fece in palazzo
Zambeccari
Bologna – 1806
29
essere nel mezzo delle conoscenze insite nelle
forme degli oggetti che la compongono.
Ma una raccolta pone la necessità di una catalogazione; ed è antica la preoccupazione di catalogare gli strumenti musicali nei loro vari
generi.
I cinesi, ai quali si è spesso
avuta l’abitudine di far risalire
antiche invenzioni o antiche
soluzioni, hanno proposto delle
classificazioni pittoresche come
i loro manufatti, secondo la
materia, i punti cardinali, le stagioni dell’anno, gli elementi
(terra-aria-acqua-fuoco).
Per esempio i tamburi, se matericamente fanno parte della pelle
(membrana percossa), rappresentarono il Nord, l’inverno,
l’Acqua e via dicendo.
Il mondo Greco e Romano,
invece, impostò una classificazione che perdurò nel Medioevo
e, naturalmente, andiamo già sul
concreto: si stabilirono le tre
grandi classi degli strumenti a
percussione (senza distinguere
gli idiofoni dai membranofoni),
degli strumenti a fiato e degli
strumenti a corda.
I primi furono chiamati dai
Greci “kroustikon”, dai Romani
“pulsatile” e dai Medioevali
“percussionalia”.
Gli strumenti a fiato per i Greci
erano “pneumatikon”, per i
Romani “inflatile” e per i
Medioevali “inflatilia”.
Gli strumenti a corda “enchordo” (Greci), “tensile” (Romani), “tensibilia” (Medievali).
Ma dobbiamo arrivare alla fine del 1700 per rag-
30
giungere una chiara e unanime classificazione
tipologica delle famiglie di strumenti, con la
nascita dell’orchestra classica, per la quale operarono tre fra i maggiori compositori di tutti i tempi: F.J.Haydn,
W.A. Mozart e L.V. Beethoven.
A quell’epoca, il clavicembalo e la
sua famiglia di strumenti derivati,
stava perdendo popolarità rispetto
al nuovo pianoforte, gli strumenti
a fiato venivano perfezionati con
valvole e chiavi, la famiglia del
violino veniva modificata secondo
una nuova geometria e suonata coi
nuovi archi modificati da Tourte
(Francia), la famiglia dei liuti
lasciava sempre più spazio alle
chitarre.
A poco a poco, i legni e gli ottoni
si diversificarono, acquistando una
maggiore importanza, fino ad
assumere una propria autonomia,
al punto di divenire essi stessi
concertanti (migliorie tecniche ed
il conseguente ampliamento delle
potenzialità espressive di questi
strumenti musicali, fecero assumere loro ruoli di primo piano
nelle produzioni musicali dei
musicisti del tempo, sia con la
funzione di solisti che come formazioni di gruppo. Mozart e
Haydn, in particolare, composero
opere nelle quali il ruolo dei
“legni” e degli “ottoni” era di
primo piano).
L’esposizione dei “quadri sonori”
divenne così sempre più ricca di
sfumature timbriche e colori d’espressione e fu
rivolta ad un pubblico sempre più vasto.
Quest’ultimo fattore, in molti casi, condizionò lo
stile costruttivo degli strumenti musicali verso
COLLEZIONe
Lorenzo Frignani
e
C ollezioni Private
Anonimo
liuto (particolare)
probabilmente Napoli
XVIII sec.
31
chitarra
MARCONCINI GIUSEPPE
Ferrara - 1805
32
chitarra
MARCONCINI GIUSEPPE
Ferrara - 1824
33
chitarra
MARCONCINI GIUSEPPE
Ferrara - 1800
Callezione privata
34
chitarra
FABBRICATORE GENNARO
Napoli - 1801
Callezione privata
35
chitarra
FABBRICATORE GENNARO
Napoli - 1820
36
chitarra
FABBRICATORE GENNARO
Napoli – 1822
Chitarra di pregevolissima fattura,
probabilmente destinata ad una
persona molto importante della nobiltà
dell’epoca.
Strumenti di questo livello nascevano
spesso come pezzi unici
37
chitarra
FABBRICATORE GENNARO
Napoli – 1830
Splendido esempio dove si manifestano già influenze “viennesi”
(nella meccanica) e “francesi”
(nella decorazione floreale della
tavola armonica e nel modello del
ponticello
Callezione privata
38
chitarra
GIOVAN BATTISTA FABBRICATORE
Napoli – 1799
Uno dei primi esempi di chitarra a 6 corde
semplici
39
chitarra
DE GRADO GAETANO
Napoli – 1807
Raffinatissimo strumento di
questo autore del quale si
hanno pochissime informazioni
biografiche
40
chitarra
RIVOLTA GIACOMO
Milano – 1807
Di questo importante autore
milanese ne parla il Conte
Cozio di Salabue nel suo
“Carteggio” per la qualità
delle sue vernici.
Uno strumento analogo è conservato nella collezione di
strumenti storici del Castello
Sforzesco di Milano
41
chitarra
GUARMANDI FILIPPO
Bologna – 1803
Callezione privata
42
chitarra
ERTL JOHANN
Vienna – 1817
43
chitarra
ZUCCONI GIACOMO
Bologna – 1811
Importantissimo autore
bolognese di cui si conoscono
pochissimi strumenti
44
chitarra
DA GENNARO
Napoli - 1822
Raffinatissimo autore di cui mancano
notizie biografiche
45
chitarra
STAUFER GEORG
prima metà XIX sec.
Il più importante autore viennese
del primo ottocento.
Particolarità delle sue chitarre
era la possibilità di regolare
il manico con un sistema “basculante” agendo su di una vite che
fissava il manico stesso alla
cassa armonica
46
chitarra
LACOTE RENE’
Parigi – prima metà dell’ottocento
Callezione privata
47
chitarra
etichetta PONS
Londra – inizio XIX sec.
48
chitarra
ROMANO MARENGO-RINALDI
Torino - metà XIX sec.
Strumento costruito su modello e nello stile
dei“Guadagnini”.
49
chitarra
PANORMO LOUIS
Londra – 1849
Callezione privata
50
liuto
Anonimo
probabilmente Napoli
XVIII sec.
51
mandolino
SMORSONE GIOVANNI
Roma – 1721
Callezione privata
52
mandolino
MOLINARI GIUSEPPE
Venezia - metà XVIII sec.
Callezione privata
mandolino
PRESBLER GIUSEPPE
Milano - 1793
Callezione privata
mandolino
ANONIMO
metà XVIII° sec.
Callezione privata
53
mandolino
GIOVAN BATTISTA FABBRICATORE
Napoli – 1781
Callezione privata
54
mandolino
VINACCIA GIOVANNI
Napoli – metà XVIII sec.
Callezione privata
Pochette di mandolino
Napoli – metà XIX sec.
mandolino
ALBERTINI E FIGLI
Milano – XIX° sec.
55
salterio
Anonimo
metà XVIII sec.
Callezione privata
salterio
Anonimo
probabile Venezia metà
XVIII sec.
Callezione privata
56
57
violino
GOBETTI FRANCESCO
Venezia – 1713
Callezione privata
58
violino
CAPPA GOFFREDO
Saluzzo – c.1700
59
Armonium portativo
Dupuy
Parigi – metà XIX sec.
60
fortepiano
Anonimo
(probabilmente austriaco)
inizio XIX sec.
Callezione privata
61
Bibliografia generale
- G. Tiraboschi, Biblioteca Modenese o Notizie della
vita degli scrittori natii degli Stati del Serenissimo di
Modena (…), Modena, Società Tipografica, 1786, vol.
VI, pp. 432-3.
- G. Campori, Memorie biografiche degli scultori,
architetti, pittori, ec. della Provincia di Massa,
Modena, Carlo Vincenzi, 1873.
- L. F. Valdrighi, Pietro Bertacchini e altri musicisti
del secolo XVII, <<Musurgiana>>, n. 6, Modena, G.
T. Vincenzi, 1881.
- A. Venturi, La Regia Galleria Estense, Modena,
1882, pp. 109-111.
- L.F. Valdrighi,Cappelle, concerti e musiche di casa
d' Este, in Atti e memorie della RR.Deputazione di
Storia Patria per le provincie modenesi e parmensi ,
s.III, vol II, 1883
- J.Schlosser, Die Sammlung alter Musikinstrumente,
Wien, Schroll. 1920, pp. 59, 67, 77.
- M.G. Scimeca, L’arpa nella storia, Bari, 1938, pp.
82-83.
- L. Cervelli (catalogo a cura di), Mostra di antichi strumenti musicali, Modena, Teatro Comunale, 1963-64.
- L. Chiappini, Gli Estensi, dall' Oglio, 1967.
- L.F. Valdrighi, Nomocheliurgografia antica e
moderna, ossia elenco di fabbricatori di strumenti
armonici con note esplicative e documenti estratti
dall’Archivio di Stato di Modena, <<Memoria della
R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di
Modena>>, Modena, Soc. Tipografica, serie 2°, vol.
II, 1884, p. 160, rist. Bologna, Forni, 1967.
- G. Targioni Tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi fatti
in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa, vol.
XII, Firenze, 1779; Bologna, rist. anastatica, Forni,
1972, pp. 132-4.
- G. Tintori, Gli strumenti musicali, Torino, ed.
UTET, 2 volume, 1973, pag. 1143
- J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano, 1974, pp. 101 e 246.
- E. Durante. A.Martellotti, Cronostoria del
Concerto. Delle dame Principalissime di Margherita
Gonzaga d' Este. Firenze, 1979.
- Evans Tom e Mary - Anne, Le grand livre de la
Guitare de la Renaissanceau Rock, Paris, ed Albin
Michel, 1979, pag. 354
- Turnbull Harveey, La chitarra dal rinascimento ai
giorni nostri, Milano, ed.Curci, 1982, pag.149.
62
- Alessandro Stradella e Modena, Musica, Documenti
e Immagini, Catalogo della Mostra, Modena, 1983.
- Alessandro Stradella e Modena, Atti del Convegno
Internazionale di Studi, Modena 15-17 dicembre
1983, Modena, COPTIP, 1985.
- Vannes Renè, Dictionnaire Universel des Luthiers,
Bruxelles, Les Amis de la Musique, 2° volume, 1986.
- E. Landi, Le collezioni Estensi - Gli strumenti
musicali in La Galleria Estense di Modena, guida
illustrata, Modena, 1987, pp. 186-189.
- S. Toffolo, Antichi Strumenti Veneziani, Venezia, ed
Arsenale, 1987, pag.231.
- A. Martellotti, E. Durante, E. Landi, S. Renzi, Arpa
Estense, Dossier 2, a cura della Soprintendenza per i
Beni Artistici e Storici di Modena e Reggio Emilia,
Modena ,1988
- La collezione di strumenti musicali del teatro del
Museo Teatrale alla Scala, Silvana Editoriale, 1991,
pag.159
- Free Ensemble, Il Salotto Musicale, Sala Bolognese
(Bologna), ed.A.Forni, 1992,pag. 294
- Roger Bragard, Ferdinand J De Hen, Gli strumenti
musicali, Bramante, Milano 1994
- M. Lucchi, Gli strumenti musicali, I beni musicali,
Atlante dei Beni Culturali dell’Emilia Romagna,
Bologna, 1996, pp. 152-182.
- G. Antonioni, Dizionario dei costruttori di strumenti
a pizzico in Italia dal XV al XX sec. ,Cremona , ed
Turris, 1996, pag. 199.
- L. Amorth, Modena Capitale, ristampa, ed. Artioli,
Modena, 1997.
- L. Frignani, Chitarre e Mandolini - Piccola collezione di strumenti italiani dell' '800 e del '900,
Comune di Pieve di Cento, ed. Mucchi, Modena,
1998, pag, 95
- Howard Schott and Anthony Baines, Catalogue of
Musical Intruments in the Victoria and Albert
Museum, V&A publications, London 1998, pag. 224
- L. Frignani, L' estetique du son, Suisse, Philip
Morris Europe S.A., 2001, pag.64
- N. Lanzetta, Gli strumenti del Duca in Grandezza &
Meraviglia, Festival Musicale Estense
ed. PubliPaolini, Mantova 2001
7
9
13
19
20
21
24
25
27
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 62
64
Presentazione
Musica a corte, di Nunzia Lanzetta
Francesco II d’Este ed il collezionismo artistico e musicale estense, di Patrizia Radicchi
La chitarra di Michele Antonio Grandi, di Patrizia Radicchi
Il violino di Giovanni Battista Cassarini,, di Patrizia Radicchi
Il flauto dolce (attribuito a Michele Antonio Grandi),di Patrizia Radicchi
Due preziosi intagli: il violoncello e il violino di Domenico Galli, di Nunzia Lanzetta
La viola contralto di Girolamo e Antonio Amati, di Nunzia Lanzetta
La musica nelle mani, di Lorenzo Frignani
Collezione Lorenzo Frignani e Collezioni private
Chitarra MARCONCINI GIUSEPPE Ferrara - 1805
Chitarra MARCONCINI GIUSEPPE Ferrara - 1824
Chitarra MARCONCINI GIUSEPPE Ferrara - 1800
Chitarra FABBRICATORE GENNARO Napoli - 1801
Chitarra FABBRICATORE GENNARO Napoli - 1820
Chitarra FABBRICATORE GENNARO Napoli – 1822
Chitarra FABBRICATORE GENNARO Napoli – 1830
Chitarra GIOVAN BATTISTA FABBRICATORE Napoli – 1799
Chitarra DE GRADO GAETANO Napoli – 1807
Chitarra RIVOLTA GIACOMO Milano – 1807
Chitarra GUARMANDI FILIPPO Bologna – 1803
Chitarra ERTL JOHANN Vienna – 1817
Chitarra ZUCCONI GIACOMO Bologna – 1811
Chitarra DA GENNARO Napoli - 1822
Chitarra STAUFER GEORG prima metà XIX sec.
Chitarra LACOTE RENE’ Parigi – prima metà dell’ottocento
Chitarra etichetta PONS Londra – inizio XIX sec.
Chitarra ROMANO MARENGO-RINALDI Torino – metà XIX sec.
Chitarra PANORMO LOUIS Londra – 1849
Liuto Anonimo probabilmente Napoli XVIII sec.
Mandolino SMORSONE GIOVANNI Roma – 1721
Mandolino MOLINARI GIUSEPPE Venezia - metà XVIII sec.
Mandolino PRESBLER GIUSEPPE Milano - 1793
Mandolino ANONIMO metà XVIII sec.
Mandolino GIOVAN BATTISTA FABBRICATORE Napoli – 1781
Mandolino VINACCIA GIOVANNI Napoli – metà XVIII sec.
Pochette di mandolino Napoli – metà XIX sec.
Mandolino ALBERTINI E FIGLI Milano – XIX° sec.
Salterio Anonimo metà XVIII sec.
Salterio Anonimo probabile Venezia metà XVIII sec.
Siolino GOBETTI FRANCESCO Venezia – 1713
Violino CAPPA GOFFREDO Saluzzo – c.1700
Armonium portativo Parigi – metà XIX sec.
Fortepiano Anonimo (probabilmente austriaco) inizio XIX sec.
Fortepiano Anonimo (probabilmente bolognese) fine XVIII sec.
Bibliografia
Indice
63