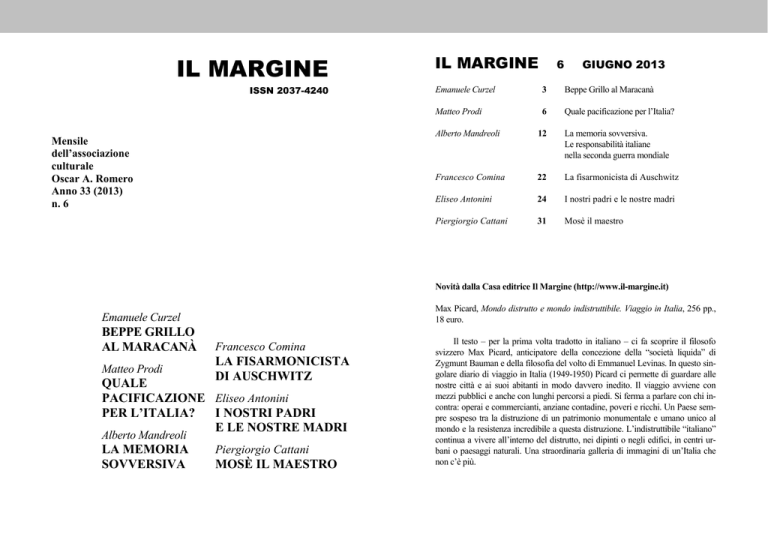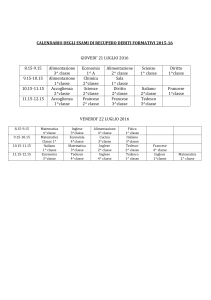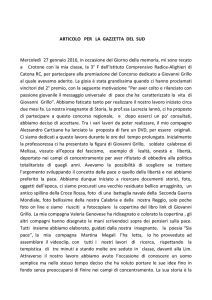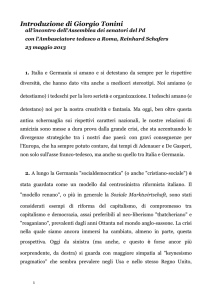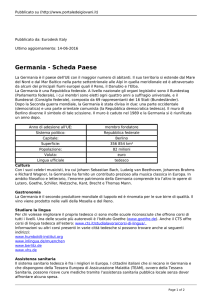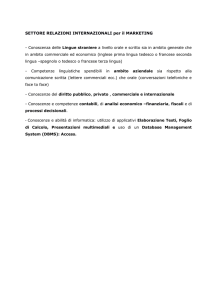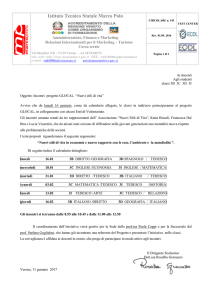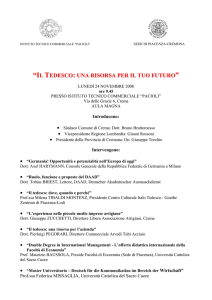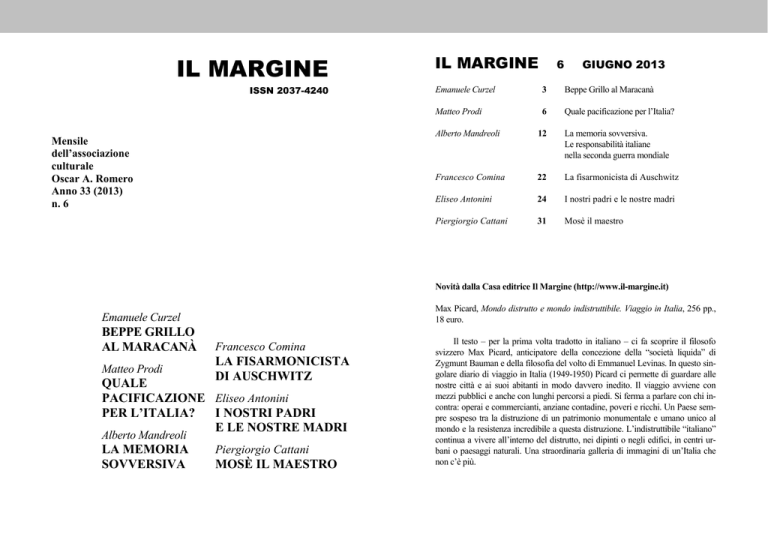
IL MARGINE
ISSN 2037-4240
Mensile
dell’associazione
culturale
Oscar A. Romero
Anno 33 (2013)
n. 6
IL MARGINE
6
GIUGNO 2013
Emanuele Curzel
3
Beppe Grillo al Maracanà
Matteo Prodi
6
Quale pacificazione per l’Italia?
Alberto Mandreoli
12
La memoria sovversiva.
Le responsabilità italiane
nella seconda guerra mondiale
Francesco Comina
22
La fisarmonicista di Auschwitz
Eliseo Antonini
24
I nostri padri e le nostre madri
Piergiorgio Cattani
31
Mosè il maestro
Novità dalla Casa editrice Il Margine (http://www.il-margine.it)
Max Picard, Mondo distrutto e mondo indistruttibile. Viaggio in Italia, 256 pp.,
18 euro.
Emanuele Curzel
BEPPE GRILLO
AL MARACANÀ
Matteo Prodi
Francesco Comina
LA FISARMONICISTA
DI AUSCHWITZ
QUALE
PACIFICAZIONE Eliseo Antonini
I NOSTRI PADRI
PER L’ITALIA?
E LE NOSTRE MADRI
Alberto Mandreoli
LA MEMORIA
SOVVERSIVA
Piergiorgio Cattani
MOSÈ IL MAESTRO
Il testo – per la prima volta tradotto in italiano – ci fa scoprire il filosofo
svizzero Max Picard, anticipatore della concezione della “società liquida” di
Zygmunt Bauman e della filosofia del volto di Emmanuel Levinas. In questo singolare diario di viaggio in Italia (1949-1950) Picard ci permette di guardare alle
nostre città e ai suoi abitanti in modo davvero inedito. Il viaggio avviene con
mezzi pubblici e anche con lunghi percorsi a piedi. Si ferma a parlare con chi incontra: operai e commercianti, anziane contadine, poveri e ricchi. Un Paese sempre sospeso tra la distruzione di un patrimonio monumentale e umano unico al
mondo e la resistenza incredibile a questa distruzione. L’indistruttibile “italiano”
continua a vivere all’interno del distrutto, nei dipinti o negli edifici, in centri urbani o paesaggi naturali. Una straordinaria galleria di immagini di un’Italia che
non c’è più.
Il Margine 33 (2013), n. 6
Te lo do io il Brasile
Beppe Grillo al Maracanà
EMANUELE CURZEL
S
crivere oggi, qualche giorno dopo le elezioni amministrative, sul movimento guidato da Beppe Grillo può sembrare beffardo. È infatti fin
troppo facile fare ironia su un “qualcosa” che ha perso – a seconda dei casi – la metà, tre quarti, quattro quinti dei consensi raccolti solo tre mesi
prima, fino a giungere a percentuali paragonabili a quelle di una qualunque
UDC (per di più, nell’unica città di medie dimensioni in cui è andato al ballottaggio, cioè Ragusa, con un pauroso squilibrio tra voto al candidato sindaco, il 15%, e voto alla lista, il 10%: come a dire che Federico Piccitto
gode di un gradimento superiore a quello di Beppe Grillo). È d’altronde
inevitabile che il crollo di una lista che a febbraio aveva raccolto un quarto
dei consensi, e che ambiva a fare ben di più, susciti commenti che vanno dal
“ben gli sta” al “ve l’avevo detto”.
Questo corsivo ha però un’intenzione almeno parzialmente diversa:
vorrei infatti, astraendomi dall’attualità più stretta, fare qualche domanda e
tentare un risposta in chiave “storica”, prendendo spunto da una constatazione dello stesso Grillo. Il 12 giugno, in uno dei post inviati dal suo bunker
elettronico, rivolgendosi a coloro che a febbraio avevano votato per 5Stelle
egli ha scritto: «con il vostro voto avete cambiato la Storia del Paese» (le
maiuscole nell’originale). Lo dico non con ironia ma con rammarico: è vero, l’ha cambiata; e hanno contribuito a cambiarla anche le decisioni prese
dal MoVimento nelle settimane successive. Un giorno dovremo pur chiederci: come mai gli italiani, al termine del ventennio berlusconiano, si divisero
al punto da rendere impossibile la costituzione di una maggioranza parlamentare omogenea? come fu possibile che, raccogliendo poco più di un
quinto dei voti (il PdL è giunto al 21,6%), Silvio Berlusconi poté tornare a
tenere in scacco il Paese? come fu possibile impedire a Romano Prodi di
diventare presidente della Repubblica?
So che a queste domande si potrebbero dare moltissime risposte, e che
molte risposte conterrebbero una parte di verità. Da parte mia vorrei aggiungerne una. La trovate qui: http://www.youtube.com/watch?v=c_LZQRyjTg. E se avete visto il filmato, ora potete anche girare pagina.
3
Il filmato che avete visto è tratto da una delle trasmissioni televisive
più fortunate di Beppe Grillo, Te lo do io il Brasile, andata in onda in prima
serata su Rai1, tra il marzo e l’aprile 1984, con la regia di Enzo Trapani
(presidente del consiglio Bettino Craxi, ministro delle poste e telecomunicazioni Antonio Gava). Si trattava del seguito ideale all’altra parimenti fortunata trasmissione Te la do io l’America (1981), che aveva dato al comico
genovese la notorietà. Era un mix di interventi e sketch in studio alternati a
filmati che parlavano ironicamente della realtà brasiliana (e delle “avventure” di Grillo stesso in Brasile). Una trasmissione divertente, anche se i
ritmi non erano probabilmente quelli odierni.
Come avrete visto, nel filmato Grillo si trova in una situazione surreale. È al Maracanà, il più grande stadio del
mondo, sul campo di gioco, con
maglietta, pantaloncini e scarpette regolamentari. Sul tabellone compaiono i nomi delle
due squadre pronte a sfidarsi:
Grillo e il Resto do Mundo. Ma
sul prato c’è solo lui. Che corre, dribbla, tira, mima un fallo
subito, se la prende con l’inesistente arbitro, entra a gamba tesa, ostenta
innocenza, segna, segna ancora, gioisce, infine vince. Sette a zero. Una scenetta spiritosa che strappa risate e applausi.
L’uomo e il personaggio
Nella vicenda politica grillina c’è una questione che mi lascia sottilmente inquieto. Nel mondo dello spettacolo, e a maggior ragione tra i comici, è frequente – vorrei dire obbligatoria – la distinzione tra l’uomo e il personaggio. Charlie Chaplin non è Charlot, Paolo Villaggio non è Ugo Fantozzi, Rowan Aktinson non è Mr. Bean. Ci possono essere maggiori o minori
“somiglianze”, ma la convergenza darebbe esiti grotteschi e persino pericolosi. E così penso, e continuo a pensare, che il Beppe Grillo che gioisce per
4
Il Margine 33 (2013), n. 6
la vittoria per sette a zero sul Resto del Mondo sia un personaggio; che
l’uomo sappia che si tratta solo di una scenetta comica, non della realtà, e
di non aver vinto alcunché. E così a lungo avevo pensato che il Grillo del
“Vaffa day”, capace di catalizzare le energie delle piazze (e poi anche delle
urne) non fosse esattamente il Giuseppe Grillo della realtà. Che la sua enfasi retorica, la sua violenza verbale, i suoi paradossi e le sue incongruenze
fossero solo espedienti per destare l’attenzione, non un programma di governo. A lungo ho atteso che il ghigno potesse allargarsi in un sorriso: vi ho
preso in giro, lo so benissimo che non ho sconfitto nessun Resto do Mundo.
L’ho fatto per attirare la vostra attenzione, per darvi un momento di allegria o di consapevolezza, per provocarvi o per farvi pensare, ma so che la
dimensione politica è una cosa un po’ diversa: e quello non è il mio mestiere. Com’è noto questo modo di leggere la vicenda grillina è ormai sempre
meno sostenibile.
Ci piace vincere facile
E allora mi è tornata in mente la scena in cui Grillo fa quello che tutti
noi (tutti noi maschi, per lo meno) vogliamo da una vita, e mai potremo fare
(forse). Stravincere al Maracanà, segnando sette reti. Un sogno sfrenato, al
limite di ogni immaginazione. Grillo lo ha sognato. E a questo punto posso
anche pensare: ha creduto che fosse vero.
Riprendiamo le domande di partenza. Come fu possibile? Perché così
tante persone diedero tanta forza al (movimento del) comico genovese Giuseppe Grillo, negando credito a proposte ben più sensate e strutturate? E
come fu possibile che egli, forte di tanto consenso, abbia continuato a negare e a negarsi la possibilità di agire, di incidere davvero nella realtà?
Il fatto è che nei sogni sfrenati non ci sono vie di mezzo. Sono seducenti
proprio per questo: non hanno limiti, e pretendono di non averne. In un
Paese privo di futuro e di prospettive ci rifugiamo in essi. Li votiamo. E
quando siamo in un (bel) sogno non accettiamo di fermarci a metà. Pensiamo che sia necessario, obbligatorio, che non esista altro, che non ci possano e non ci debbano essere interruzioni e compromessi.
In queste settimane, in questi mesi, la realtà sta tornando – nel bene e
nel male – a bussare alla porta. Non è un auspicio, non è una speranza, è un
dato di fatto, alla faccia di chi ha pensato e pensa di potersi rifugiare nel
proprio personale sogno del Maracanà. Te la do io l’Italia.
5
Quale pacificazione
per l’Italia?
MATTEO PRODI
L
e ultime elezioni hanno lasciato il nostro Paese in una situazione difficilissima, in cui è davvero arduo sperare in una stabile governabilità.
Ininterrottamente il Pdl e il suo leader Silvio Berlusconi hanno mostrato una
quasi assoluta disponibilità a formare un governo di larghe intese, manifestando un inedito desiderio di pacificazione nazionale. Affermano che è ora
che la politica volti pagina, che si esca dall’odio antiberlusconiano per occuparsi del bene delle persone, in particolare di quelle che sono più toccate
dalla crisi, dalla perdita del lavoro, dalla povertà.
Non vi è dubbio che l’Italia abbia bisogno di pacificazione1; vi è, invece, qualche dubbio sulla limpidezza di queste affermazioni da parte del centro-destra, in particolare per il fatto che contengono il non troppo velato desiderio dell’ex premier di svolgere un fantasioso ruolo di padre della patria,
gestendo in prima persona le riforme istituzionali, aspirando a diventare senatore a vita o addirittura a essere eletto presidente della Repubblica.
In realtà, ciò che lascia maggiormente stupiti è il fatto che tutto questo
provenga dalla persona che ha deliberatamente inserito nella competizione
politica italiana un odio, in particolare un odio anticomunista, che non ha
spiegazioni né nella storia attuale dell’Italia né nella proposta politica di coloro che, a torto o a ragione, sono considerati come gli eredi del PCI. Difficile, infatti, contraddire la tesi secondo cui una parte non irrilevante dei successi elettorali di Berlusconi derivano dal suo continuo sventolare la possibilità che l’Italia sia governata da ipotetici seguaci di Marx.
Non è questo il luogo per ri-analizzare il ruolo del PCI nel nostro secondo dopoguerra. Può essere storicamente dimostrabile il pericolo che
1
6
Il punto in questione è già stato affrontato in varie occasioni; cfr., ad esempio, S. Tanzarella, La purificazione della memoria, Bologna, EDB, 2001.
l’Italia finisse nell’orbita di influenza (potremmo dire sudditanza)
dell’URSS; può essere messo in evidenza anche il fatto che i comunisti abbiano scelto, a quel punto, di dedicarsi maggiormente alle amministrazioni
locali, costruendo una rete rilevante di potere anche con il mondo degli affari, soprattutto attraverso le cooperative rosse. Può essere, quindi, affermato
che il nostro paese avesse come un bilanciamento di poteri che ruotava attorno all’asse DC-PCI. È stato, in ogni caso, chiaro che quella sinistra in Italia non poteva governare: moltissimi veti lo impedivano; e anche qui gli storici ci diranno quanto abbiano contato i veti degli USA e del Vaticano.
Mettere in fila i nomi di Dossetti, di Moro e di Romano Prodi ci mostra
come l’alleanza delle forze realmente popolari (quelle, cioè, per vocazione
chiamate a curare gli interessi del popolo) non fosse possibile; e quando è
stata possibile è stata spazzata via da movimenti sotterranei, ancora difficili
da decifrare.
Rimane il fatto che, quando nel 1996 l’Ulivo si presentò alle elezioni,
una parte non irrilevante dell’entusiasmo dei suoi sostenitori era data dal fatto che famiglie, amici, cittadini che si erano sempre sentiti dalla stessa parte
della barricata potevano votare lo stesso simbolo, lo stesso leader, perché
molte contrapposizioni ideologiche erano cadute.
Rimane il fatto che nel 2013 persone ancora dichiarano di non poter votare PD, a causa di colpe, delitti compiuti da individui che si richiamavano
all’ideologia comunista.
Rimane il fatto che il crollo della prima repubblica ha travolto tutti i
partiti tradizionali, ma ha appena sfiorato il PCI, che ha semplicemente operato qualche ritocco estetico cambiando ripetutamente nome e simbolo.
No, l’Italia non è un paese riconciliato, pacificato; ma non riuscirà certo a pacificarlo l’uomo che ha deliberatamente portato al conflitto permanente la competizione politica, la competizione democratica, contando su un
controllo intollerabile dei mass media. L’Italia ha bisogno di ritrovare le sue
radici, a partire da quella Costituzione, nata dal desiderio delle varie forze
politiche di costruire davvero una nuova umanità, ma che proprio dalla
mancata riconciliazione nazionale è stata bloccata2.
2
Interessanti, a tale proposito, gli studi di Claudio Pavone; cfr., ad esempio, Una guerra
civile. Saggio storico sulla moralità della resistenza, Torino, Bollati Boringhieri,
1991.
7
Un episodio della storia della Chiesa di Bologna
Il problema è molto profondo. Una rapida scorsa a un episodio della
storia della chiesa di Bologna può aiutare a capire.
Nel settembre del 1944, sulle colline dell’Appennino bolognese le SS
tedesche hanno compiuto una delle stragi più terribili della guerra combattuta in Italia. La storia civile la chiama la strage di Marzabotto; la storia ecclesiale la chiama l’eccidio di Monte Sole. Che significato hanno questi due
nomi? E che problemi storiografici sottintendono?
Come si può ben capire la vicenda è molto complessa. Le domande sono così riassumibili: chi ne è stato la causa diretta e indiretta? Quale ruolo
hanno avuto i partigiani? A chi andava attribuita la responsabilità di quel
martirio? Chi poteva sperare di ricavarne il maggior vantaggio?3
Subito dopo la guerra il mondo legato alla resistenza si appropriò (spero di non essere troppo crudo) di quei morti; e siccome le vicende di
quell’eccidio erano particolarmente legate alle comunità cristiane di Monte
Sole e ai suoi preti, di fatto fu “ricollocata”, geograficamente, come avvenuta a Marzabotto, il comune più grande a valle dei fatti, lungo il fiume Reno4.
Solo nel 1983, con il vescovo Manfredini5, la chiesa di Bologna risalì a
Monte Sole, recuperando la memoria anche ecclesiale di quei fatti; da allora
ogni anno fino al 2004, si è celebrato un pellegrinaggio diocesano; dopo po-
3
Il dibattito è sterminato. Riporto solo un pensiero dal quarto di copertina del libro Giampaolo Pansa, La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti (Rizzoli, Milano, 2012) per
un’istantanea sulla percezione attuale della situazione: il libro «descrive il lato oscuro
degli anni tra il 1943 e il 1945. Ho voluto narrarlo sfidando quanti strilleranno che il
virus del revisionismo mi ha dato alla testa. Eppure che i partigiani e i fascisti si assomigliassero era una certezza già presente nei racconti di chi aveva vissuto da spettatore inerme un massacro mai visto in casa nostra».
4
Sarebbe molto interessante ripercorrere anche le intenzioni di fondo con cui si ricordava
a livello civile quell’eccidio; sicuramente si iniziò a celebrarlo come fatto eroico della
resistenza; poi, in particolare il PCI negli anni Ottanta, si sbilanciò sul tema della pace, senza mai avviare un processo storicamente fondato di analisi delle diverse responsabilità.
5
Con queste parole l’arcivescovo dava l’annuncio dell’evento: «il nostro pellegrinaggio
vuole essere prima di tutto, un invito alla conversione, una decisa proposta di fede e
di speranza… tutti dobbiamo fare memoria viva, sentirci convertiti e responsabilizzati».
8
co, la custodia orante di quei luoghi fu affidata, dal cardinal Giacomo Biffi6,
alla comunità di don Giuseppe Dossetti.
Non intendo dare valutazioni; desidero mostrare una tensione quasi insanabile, costruita attorno a centinaia di morti, quasi tutti donne e bambini.
Occorre evidenziare, però, come il livello della contrapposizione non si
sia smorzato neppure ai nostri giorni e neppure all’interno della compagine
ecclesiale. Mi riferisco alle valutazioni che a più riprese ha offerto ai suoi
lettori il cardinal Biffi, ora arcivescovo emerito della chiesa petroniana.7 Si
accusa Dossetti di aver svolto la sua riflessione8 sulla natura dei fatti di
Monte Sole dimenticando di fatto metà degli avvenimenti tragici della storia
contemporanea: «le stragi direttamente o indirettamente provocate dal comunismo bolscevico non sono state ritenute utili a supportare l’ideologia
ispiratrice di questa Introduzione. Questo è significativo ed è grave. In effetti, Dossetti qui si rivela allergico alle ricerche storiche obiettive, quando non
servono ad aiutare le sue premesse ideologiche»9.
Ancora: non desidero esprimere giudizi; probabilmente il pensiero di
Biffi è più che corretto, ma anch’esso parziale, visto che si dimentica, ad
esempio, di ricordare tutto quello che è avvenuto in Vietnam, guerra non
certamente voluta dai bolscevichi. Guerra che, indirettamente certo, ha causato la rimozione del cardinal Lercaro e la conseguente perdita, progressiva
ma totale, della spinta conciliare che la diocesi bolognese aveva ricevuto. Si
può ipotizzare che quella pagina della storia non fosse funzionale al ragionamento di Biffi. Ma il suo ragionamento procede:
«non posso inoltre nascondere a questo punto un motivo di meraviglia, né differire
più oltre un interrogativo che mi sembra inevitabile. Col 1944 (e nemmeno col 25
aprile 1945) non si è finito di uccidere nella nostra terra. Particolarmente nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia – dove Dossetti ha vissuto l’intera ‘av6
Se Manfredini aveva posto l’accento sulla necessità di vivere il pellegrinaggio a Monte
Sole come occasione per convertirsi, Biffi puntò maggiormente su altri temi: il perdono che i cristiani devono offrire ai loro nemici; condannare contemporaneamente
tutte le ideologie antiumane e anticristiane del XX secolo; sottolineare in modo diverso le responsabilità dei partigiani, tanto da far emergere la strage di Monte Sole come
una strage anche a responsabilità comunista.
7
L’ultima pubblicazione è G. Biffi, Don Giuseppe Dossetti. Nell’occasione di un centenario, Cantagalli, Siena, 2012.
8
Mi riferisco all’Introduzione che Dossetti ha scritto per il volume di Luciano Gherardi
Le Querce di Monte Sole.
9
Biffi, Don Giuseppe Dossetti, p. 30.
9
ventura’ di uomo, di cristiano politicamente impegnato, di religioso – le stragi sono
continuate, ad opera solitamente di uomini che si ispiravano al mito del comunismo
e vagheggiavano l’instaurazione anche in Italia, di una società conforme al modello
sovietico. Come mai non se ne fa alcuna parola in questa accurata rassegna delle
violenze e degli eccidi?»10.
La stesso risentito desiderio di ricordare solo o, almeno, principalmente, le vittime della violenza comunista è stata espressa molte volte negli ultimi anni, anche a livello liturgico, nella chiesa ora guidata dal cardinal Carlo Caffarra.
Ossessivamente ripeto: non è questione di giudicare; si tratta di evidenziare che anche dentro la Chiesa, la famiglia dei riconciliati, di coloro per i
quali Gesù ha offerto la propria vita sulla croce, esistono in Italia situazioni
dove la riconciliazione, proprio dentro al problema del comunismo, ormai
evaporato anche in Cina, sembra lontanissima.
Di questo abbiamo bisogno
Quale potrebbe e dovrebbe essere, invece, l’orizzonte dell’umanità e
della chiesa, tenendo conto dell’abissale crisi in cui stiamo vivendo?
La radice di tutti mali dell’oggi, mi sembra, è l’incapacità e il rifiuto di
occuparci dell’altro, degli altri. L’orizzonte, quindi, dovrebbe essere la fraternità universale, il desiderio reale e concreto di costruire di tutti gli uomini
una sola famiglia. È, come molte volte ricordato, il desiderio di fondo della
Gaudium et Spes.
In vista di questo, laddove si sono verificati conflitti che hanno contrapposto così violentemente persone di un medesimo Paese, occorre proporre processi di riconciliazione capaci davvero di sanare tutte le ferite, di
costruire basi non per dimenticare ma per perdonare e re-iniziare una vita
quotidiana capace di una vera pace11.
10
11
Biffi, Don Giuseppe Dossetti, p. 32.
In Italia la riconciliazione ha avuto la massima spinta nell’Assemblea Costituente, partendo dal personalismo cristiano. Si tratta di un luminoso esempio di “inculturazione
della fede” compiuto da personalità profondamente credenti come Dossetti, Lazzati e
La Pira, capaci di coinvolgere tanti laici e marxisti.
10
Il Margine 33 (2013), n. 6
Sarebbe interessantissimo guardare nel mondo a tanti processi di riconciliazione che hanno avuto successo, ma non è questa l’occasione più opportuna ci basterà fare un piccolo e insufficiente elenco:
- il Sudafrica: il vescovo anglicano Desmond Tutu e Nelson Mandela
hanno sostenuto il processo Verità e Riconciliazione, capace di porre solide
basi per una pacificazione nazionale.
- l’Albania: il Kanun è un codice civile medievale che impone la vendetta se, a causa di un omicidio, si è perso l’onore. Anche volontari italiani
si stanno impegnando, condividendo la vita delle persone, che per paura vivono segregate in casa, affinché si instaurino percorsi di riconciliazione tra
le parti.
- il Vietnam: spesso si dimentica che la guerra in Vietnam è stata una
guerra civile, molto particolare certamente, ma che ha visto su sponde opposte del conflitto persone appartenenti alla stessa nazione. La revisione della
Costituzione, le aperture democratiche che potrebbero essere codificate,
possono dare slancio ad un processo di riunione non solo geopolitica del
Vietnam.
La Chiesa è chiamata a compiere tre cose decisive:
- discernere i segni dei tempi riguardanti la riconciliazione e saper indicarli agli uomini di buona volontà.
- essere fattivamente un laboratorio di riconciliazione, anche imparando
dal mondo prassi concrete.
- esercitare solo il potere del servizio e della carità, per costruire e anticipare il Regno dei cieli.
Di questo nel mondo e in Italia abbiamo bisogno; di parole e di proclami dettati dall’interesse individuale non sappiamo più cosa farcene.
La memoria sovversiva
Le responsabilità italiane
nella seconda guerra mondiale
ALBERTO MANDREOLI
«Si ammazza troppo poco» (generale Mario Robotti, comandante
del XI Corpo d’Armata, agosto 1942).
«Non dente per dente, ma testa per dente!» (generale Mario
Roatta, comandante della 2ª Armata, marzo 1942).
si riflette su ciò che la seconda guerra mondiale ha rappresentato
Quando
per la storia d’Europa e per l’intera umanità, il pensiero va naturalmente e, si direbbe quasi in modo istintivo, alle orrende atrocità commesse dalle
truppe tedesche nei paesi d’occupazione e dai reparti delle SS nei campi di
sterminio. Come sancito dal processo di Norimberga, che si svolse nel palazzo di giustizia dell’omonima città dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre
1946, il nazionalsocialismo nei suoi principali esponenti fu riconosciuto dal
Tribunale militare internazionale (IMT) come l’unico responsabile per i
crimini di guerra commessi contro l’umanità e contro la pace. Di per sé, il
processo di Norimberga fu l’esito non solo giudiziario ma anche politico del
disegno dell’United Nations War Crimes Commission – istituita nel 1942
con l’adesione di diciotto nazioni alleate – di portare alla sbarra i più influenti e decisivi uomini dell’Asse Roma-Berlino, ritenuti i maggiori responsabili della guerra d’aggressione.
Se da un lato questo processo significò un passo in avanti nella storia
giuridica europea – un vero e proprio antesignano della Corte Penale internazionale – dall’altro esso, insieme ad altri processi “mancati” perché depotenziati nella loro capacità normativa1, non fu privo di lacune e reticenze
motivate da ragioni politiche e da interessi particolari. Secondo una rigida
forma di selettività giudiziaria, la Germania nazista venne riconosciuta come
1
11
Il processo intentato a Venezia contro il feldmaresciallo Albert Kesserling potrebbe costituire un valido esempio della dinamica descritta. Si veda il capitolo “Intorno al processo Kesserling” di M. Battini, Peccati di memoria, la mancata Norimberga italiana, Roma, Laterza, 2003.
12
l’unica responsabile per i crimini commessi contro la pace, escludendo indirettamente ma di fatto gli altri Paesi da qualsiasi coinvolgimento nei misfatti
attuati durante la seconda guerra mondiale, al fine di evitare l’insorgenza di
dibattimenti intorno agli accertati crimini attuati dagli Alleati: così le bombe
atomiche sulle città nipponiche di Nagasaki e di Hiroshima, i bombardamenti degli Alleati sulle città europee, in particolare su quelle tedesche, caddero
una volta per tutte nell’oblio giudiziario.
Ed è in questo contesto, segnato oramai dalla guerra fredda e dalle contrapposizioni ideologiche, che si inserisce la condotta mantenuta dall’Italia
durante il secondo conflitto mondiale e la relativa auto rappresentazione che
essa volle fare di se stessa. Da alleato fidato e ossequioso di Adolf Hitler e
del III Reich, l’Italia passò nel ruolo di “cobelligerante” a fianco degli Alleati dopo l’8 settembre 1943: data che segnò l’armistizio con le forze angloamericane e inizio della guerra fratricida che vide la Repubblica Sociale
Italiana, fondata da Mussolini, contrapporsi ai primi gruppi della Resistenza,
composti da antifascisti convinti, da renitenti alla leva e da giovani che desideravano liberare l’Italia dall’occupante tedesco.
Salvo alcuni processi celebrati nell’immediato dopoguerra contro alcuni responsabili dell’occupazione ‘terroristica’ tedesca in Italia – Eberhard
Mackensen, Kurt Mältzer, Max Simon, Albert Kesserling, Herbert Kappler,
Walter Reder2 – già serpeggiava a livello internazionale e nella politica italiana il tentativo di insabbiare una volta per tutte queste dolorose vicende, i
cui fascicoli furono letteralmente archiviati a Palazzo Cesi (Roma)
nell’“armadio della vergogna”3. Questo avveniva nonostante l’opinione
pubblica italiana non avesse dimenticato e chiedesse ancora giustizia. I motivi di questa incontrovertibile dicotomia – richiesta di giustizia da parte dei
parenti delle vittime e, a livello ufficiale, tentativo di dimenticare il passato
insanguinato – devono essere ricondotti direttamente alle responsabilità italiane e fasciste nel secondo conflitto mondiale.
Rimossi dalla memoria nazionale italiana perché ritenuti scomodi sia
da un punto di vista di politica interna sia in una prospettiva internazionale
furono le tristi vicende che videro protagonisti non solo le milizie fasciste
ma anche lo Stato Maggiore italiano e reparti dell’esercito regio impiegati
nelle campagne militari svolte nei Balcani, in Albania, in Grecia e nelle colonie africane. Repressioni contro interi villaggi, fucilazioni sommarie di
civili, devastazioni di case, misure repressive contro civili, campi di concentramento per sloveni e croati non furono patrimonio unico ed esclusivo del
“cattivo tedesco” su cui si intendeva far ricadere la “colpa” ma vennero pienamente condivise dallo Stato Maggiore italiano e dal regime fascista.4 Tuttavia, il tentativo di attribuire le gravi responsabilità del conflitto unicamente
alla Germania nazionalsocialista era già presente nell’Italia del 1945 e presentava il risvolto non secondario e, si potrebbe affermare, opportunistico di
assolvere la classe dirigente italiana e la monarchia sabauda riducendo la
fenomenologia del fascismo a una “triste parentesi” della storia italiana5.
Normalizzare l’esperienza totalitaria era divenuta, per gli uomini della
politica, la parola d’ordine per ristabilire una parvenza di pace e riconciliazione nel Paese dilaniato dalla guerra civile. Prova di questo orientamento,
non dichiarato apertamente ma operante nella società civile, è la nota comparsa sui giornali del 27 ottobre 1945 che porta la firma di Benedetto Croce;
in essa si invita a raccogliere prove documentarie che testimonino le atrocità
commesse dall’occupante tedesco in Italia per «serbare esatto ricordo di un
tratto di storia» e fornire la possibilità al popolo germanico di riflettere sul
proprio operato:
«L’opportunità di questa pubblicazione è triplice: 1) serbare esatto ricordo di un
tratto della storia della nostra Italia, della quale, col passare del tempo, si disperderebbero e in gran parte si prederebbero testimonianze e documenti … ; 2) mettere
sotto gli occhi del mondo con quanti dolori atroci, con quanti grandi danni spaventosi e irreparabili, l’Italia abbia pagato la pena della stoltezza fascista, alla quale
2
Walter Reder, maggiore delle Waffen-SS e comandante del battaglione esplorante della
16ª divisione Reichsführer, fu uno dei maggiori responsabili del massacro di civili a
Monte Sole tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944; l’Obersturmbannführer Herbert
Kappler, i generali von Mackensen e Mältzer, rispettivamente comandante della XIV
armata dell’esercito regolare e comandante della piazza di Roma, furono processati
per l’eccidio di 335 individui maschi presso le Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944
(Roma). Max Simon fu generale delle SS ed anche lui insieme a Reder fu coinvolto
nel sistematico annientamento delle comunità che vivevano attorno a Marzabotto
(Bologna); e infine il feldmaresciallo Kesserling, comandante della Wehrmacht in Italia.
3
Si veda il testo di F. Giustolisi, L’armadio della vergogna, Roma, Nutrimenti, 2004.
13
4
Si segnalano D. Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione
dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), Torino, Bollati Boringhieri, 2003; E. Gobetti, Il mito dell’occupazione allegra. Italiani in Jugoslavia (1941-1943), in Memoria
e rimozione. I crimini di guerra del Giappone e dell’Italia, a cura di G. Contini, F. Focardi, e M. Petricioli, Roma, Viella, 2010, p. 164.
5
Di recente pubblicazione F. Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione
delle colpe della seconda guerra mondiale, Roma - Bari, Laterza, 2013.
14
soggiacque; 3) fornire al popolo tedesco, che ha in gran parte ignorato la qualità e
l’estensione di quegli orrori, uno specchio in cui guardarsi»6.
da me, mi investiva in pieno producendomi le trecentocinquanta ferite da schegge
che mi offesero il lato destro dalla spalla al tallone. Il colpo mi abbatté a terra. Ma
subito cercai di rialzarmi. Il generale Gariboldi e il federale Cortese mi raccolsero e
trasportarono nella prima autovettura. Nello stesso momento nel quale ci mettemmo
in moto, un’altra bomba fu lanciata, senza che ci colpisse: all’uscita del cancello del
parco, un’altra ancora; e appena fuori fummo investiti da una raffica di mitragliatrice. Nulla era stato trascurato; una preparazione da fare invidia ai più raffinati terroristi»8.
Il buon italiano in Etiopia
Il mito del “bono italiano”, stereotipo mentale e culturale inseritosi nella coscienza collettiva italiana, fu avversato e caldeggiato nello stesso tempo
dal fascismo, abituato per sua natura a una intenzionale ambiguità. Se da un
lato si privilegiava l’immagine dell’italiano forte, coraggioso, sicuro di sé,
dall’altro – soprattutto nella missione civilizzatrice operata nelle colonie
d’Africa – si voleva che l’uomo italico fosse dotato delle qualità della bontà,
della generosità e di un’umanità di fondo, “costretto” ad andare in guerra e
persino a uccidere per il bene della Patria e della propria famiglia.7
Si consideri come sia stato messo nel dimenticatoio della memoria
l’eccidio del monastero di Debrà Libanòs, località situata a nord-ovest della
capitale dell’Etiopia, Addìs Abeba, compiuto il 19 maggio 1937 dalle truppe
guidate dal generale Rodolfo Graziani (che in quella guerra, condotta insieme al maresciallo Pietro Badoglio, fece uso di gas espressamente vietati dalle convenzioni internazionali). Furono uccisi in quella drammatica circostanza 297 monaci, 129 diaconi e 23 laici, ritenuti falsamente i responsabili
dell’attentato che egli aveva subìto il 19 febbraio dello stesso anno ad Addis
Abeba nel palazzo imperiale. Vennero denominati «assassini, briganti e monaci avversi».
«La prima bomba, lanciata sul davanti, ebbe troppo alto percorso e cadde sulla pensilina. Mi balenò in mente che si trattasse di fochi di fantasia che dovessero accompagnare la cerimonia; e dentro di me biasimavo l’ufficio politico per non avermene
data notizia. La seconda bomba, anch’essa troppo alta, colpì lo spigolo della pensilina sollevando del polverio. Ritenendo che i fuochi d’artificio fossero fatti dall’alto
della terrazza e non avendo ancora l’impressione di che si trattasse, discesi d’impeto
le scale che dividevano dal piazzale e mi volsi in su per rendermi conto di ciò che
avveniva. Mi offersi così, bersaglio isolato e ravvicinato, al gruppo degli attentatori.
Fu questo il momento nel quale una terza bomba, caduta a una trentina di centimetri
6
Citato in Battini, Peccati di memoria, pp. 91-92.
Si ricordi che il programma di eliminazione del popolo etiope fu perseguito dallo
Stato maggiore italiano, in particolare dal maresciallo Pietro Badoglio e dal generale Rodolfo Graziani, attraverso l’utilizzo di gas. Si consulti A. Del Boca, I gas di Mussolini. Il
fascismo e la guerra di Etiopia, Roma, Ed. Riuniti, 2007.
7
15
Il telegramma, asciutto e sintetico, inviato a Roma dallo stesso Graziani
riguardo alla rappresaglia diceva:
«oggi alle 13 in punto il generale Maletti ha destinato al plotone di esecuzione 297
monaci, incluso il vice-priore, e 23 laici sospetti di connivenza. Sono stati risparmiati i giovani diaconi, i maestri e altro personale d’ordine, che verranno tradotti e
trattenuti nelle chiese di Debrà Berhàn. Il convento è stato di conseguenza chiuso
definitivamente»9.
Il momento culminate della strage di Debrà Libanòs è stato così ricostruita dagli storici:
«Le vittime furono spinte giù dal camion e furono rapidamente fatte allineare, con il
viso a nord e la schiena volta verso gli ascari (soldati etiopici a servizio degli italiani). Furono quindi costrette a sedersi in fila lungo l’argine meridionale del fiume,
che in quel periodo dell’anno era quasi completamente in secca. Gli ascari presero
quindi un lungo telone, preparato appositamente per l’occasione, e lo stesero sui
prigionieri come una stretta tenda formando un cappuccio sopra la testa di ognuno
di loro»10
8
A. Del Boca, Italiani, brava gente?, Vicenza, Neri Pozza, 2005. Si segnala anche D.
Bidussa, Il mito del bravo italiano, Milano, Il Saggiatore, 1994. Rodolfo Graziani, generale italiano, nato a Filettino nel 1882 e morto a Roma nel 1955. Nella sua carriera militare ricoprì diverse cariche: generale di corpo d’armata dal 1932, governatore della Somalia
nel 1935, dal ’36 al ’37 vicerè d’Etiopia, nel 1939 capo di Stato Maggiore dell’esercito.
Dopo l’8 settembre divenne ministro della Difesa nella RSI. Consegnatosi agli Alleati nel
’45, venne processato per collaborazionismo nel ’48 ma nel 1950 ottenne la scarcerazione
per amnistia (www. treccani.it).
9
Telegramma di R. Graziani (21 maggio 1937, n. 23260) citato in A. Del Boca, Italiani, brava gente?, Vicenza, Neri Pozza, 2005, pp. 219-220.
10
I.L. Campell, D. Gabre-Tsadik, La repressione fascista in Etiopia. La ricostruzione del
massacro di Debrà Libanòs, in “Studi Piacentini”, n. 21 (1997), p. 100.
16
validi, di qualsiasi età, e le donne, trovati in zona dove si è svolto o si svolge il
combattimento, e non abitanti nella zona stessa, saranno arrestati per le indagini e
successivo deferimento ai tribunali, o internamento. Lo stesso avverrà per gli imputati o sospetti di favoreggiamento ai ribelli, siano essi abitanti, o meno, della zona di
cui trattasi»13.
Il buon italiano in Jugoslavia
Tra i maggiori responsabili della guerra intentata dall’Italia fascista alla
Jugoslavia, all’Albania e alla Grecia si devono citare Francesco Jacomoni,
luogotenente d’Italia in Albania dal 1939 al 1943; il governatore militare del
Montenegro Alessandro Pirzio Biroli; Giuseppe Bastianini e Francesco
Giunta, governatori della Dalmazia; Vittorio Ambrosio, capo di Stato Maggiore dell’esercito11. Ma spicca tristemente soprattutto il nome del generale
d’armata Mario Roatta12. Pochi conoscono la circolare denominata “3C”
emanata il 1° marzo 1942 da Roatta, allora comandante della 2ª Armata operante nella provincia di Lubiana: un insieme organico di norme comportamentali per l’esercito italiano impegnato nei Balcani contro la guerriglia e il
sabotaggio attuati dalle bande partigiane. Essa non si presenta dissimile dalle norme di condotta adottate dalla Wehrmacht (l’esercito regolare tedesco)
contro i movimenti partigiani sviluppatisi nell’Europa orientale ed occidentale e contro gli stessi i civili, accusati di sostenere i “ribelli” (banditen).
Emblematici nell’orientamento repressivo alcuni tratti della circolare 3C:
«Questo importa: mentalità di guerra; ripudio delle qualità negative compendiate
nella frase “bono italiano”; “grinta dura” … Le operazioni contro i ribelli sono vere
e proprie operazioni belliche … nelle località in situazione anormale si procederà ad
internare le famiglie da cui siano o diventino mancanti, senza chiaro e giustificato
motivo, maschi validi di età compresa fra i 16 e i 60 anni … si procederà a designare, fra le la parte sospetta della popolazione, degli ostaggi, che verranno tratti e
mantenuti in arresto. Costoro risponderanno colla loro vita di aggressioni proditorie
ai militari … si stabilirà che gli abitanti di case prossime al punto in cui vengono attuati sabotaggi … siano considerati corresponsabili dei sabotaggi stessi. … I maschi
11
Ambrosio ottenne questa carica nel 1942; dal febbraio al novembre 1943 divenne capo
di Stato Maggiore generale.
12
Nato a Modena il 2 febbraio 1887 e morto a Roma il 7 gennaio 1968, è stato generale e
agente segreto italiano. Ufficiale di fanteria nella Grande Guerra, fu promosso colonnello dell’esercito nel 1930. Dopo essere stato al comando dell’84° reggimento Venezia, nel 1934 divenne capo del Servizio Informazioni Militari (SIM) sino all’agosto
1939. Comandante del Corpo Truppe Volontarie, partecipò alla guerra civile spagnola
per sostenere i nazionalisti di Francisco Franco. Nel 1940 fu nominato sottocapo dello
stato maggiore. Capo di stato maggiore dal marzo 1941 al gennaio 1942. Il 18 marzo
1942 diventò comandante della 2ª Armata in Croazia. Arrestato il 16 novembre 1944,
Roatta – in qualità di capo del SIM – venne processato dal governo italiano per aver
partecipato a crimini fascisti. Le deportazioni, le vessazioni e le fucilazioni subite dal
popolo sloveno rimasero impunite.
17
Le accuse della commissione d’inchiesta jugoslava parlano chiaro in
merito alle responsabilità del comandante d’armata Mario Roatta: deportazione e sterminio del popolo sloveno, internamento di 35.000 persone, fucilazione nella provincia di Lubiana di 1.000 ostaggi, aver ucciso 8.000 individui, aver dato alle fiamme circa 3.000 case e aver distrutto 800 villaggi,
morte per fame di 4.500 individui nel campo di concentramento di Arbe.
I campi di concentramento del buon italiano
L’opinione pubblica non solo sa poco della presenza di campi di internamento nell’area della Sirtide14 - a El-Agheila, Marsa el-Brega e Agedabia
– e destinati ai resistenti libici; ma poco si sa anche dell’esistenza di campi
di concentramento italiani dislocati lungo la nostra penisola e finalizzati ai
prigionieri di guerra e alle popolazioni slave. Si tratta di Colfiorito (Umbria), Renicci (Toscana), Cairo Montenotte (Liguria), Chiesanuova e Monigo (Veneto), Gonars-Visco-Cighino (Friuli Venezia Giulia). Per gli internati
ex-jugoslavi, tra il 1941 e il 1942, furono allestiti anche campi di internamento a Casoli, Corropoli, Lanciano, Notaresco, Sassoferrato.
Nei primi anni della guerra sorsero nell’area jugoslava quattro strutture
riservate ai civili rastrellati nelle azioni contro le bande partigiane: ad Arbe
(isola di Rab, golfo del Quarnaro), a Melada (Melat), presso l’isola di Mamula (Lastavica) e vicino a Prevlaka. Il primo arrivo di prigionieri nel già
citato campo di Arbe, costruito nel giugno 1942 e composto da un migliaio
di tende e da baracche di legno o muratura, risale al 28 giugno 1942: si trattava di 198 sloveni. Va da sé che le condizioni igienico-sanitarie, la scarsità
di cibo, il sovraffollamento e le punizioni inflitte agli “indisciplinati”, ordi-
13
Documento n. 1 Comando 2ª armata – stato maggiore Circolare 3C, 1° marzo 1942-XX
contenuto nell’appendice di G. Oliva, Si ammazza troppo poco. I crimini di guerra
italiani 1940-43, Milano, Mondadori, 2007.
14
Si calcola che durante il “genocidio libico” l’esercito italiano abbia sterminato più di
40.000 libici.
18
nate dal comandante di Arbe, il tenente colonnello dei carabinieri Cuiuli15,
recavano inutili sofferenze e, nella maggior parte dei casi, la morte degli internati, il cui numero raggiunse in pochi mesi le 7.541 unità. Erano per lo
più sloveni; vi era poi un considerevole numero di croati e 2.761 ebrei stabilitisi temporaneamente in Croazia. Alla data dell’8 settembre 1943 il numero
dei deceduti ammontava, secondo le stime ufficiali, a 1.435; si calcola che
morì il 20% degli internati.
«Arrivai ad Arbe il 6 agosto 1942 con tutta la famiglia composta dal nonno ottantasettenne, da mio padre e da mio fratello, rispettivamente di 54 e 27 anni, mia cognata di 21 ed io che ne avevo 7. … Sono nato a Stari Kot, un villaggio che comprendeva appena 36 case … Tre compaesani furono fucilati come ostaggi, mentre il resto della popolazione del luogo venne completamente deportata ad Arbe … Nel
campo di Arbe, l’11 novembre, morì mio nonno e il 27 gennaio mio padre; complessivamente nell’isola persero la vita 17 miei compaesani, mentre altri 21 sarebbero morti successivamente».
«Durante i temporali, più di una volta la pioggia intasò le latrine che riversavano
così il liquame tra le tende. Nella notte del 29 ottobre 1942, il campo fu colpito da
un violento nubifragio che spazzò via più di 400 tende e causò l’annegamento di
cinque bambini. Quanto alle razioni alimentari, esse erano minime e pessime, molto
al di sotto di quelle già precarie previste per gli internati dal Regio esercito. … Grave fu la situazione delle gestanti che, non di rado, diedero alla luce creature già morte»16.
Il buon italiano in Grecia
La stessa matrice criminosa operante sulle coste africane e in terra jugoslava si manifestò anche in Grecia. Attaccato dall’esercito di Mussolini
nell’ottobre 1940, l’esercito ellenico riuscì a contrattaccare arrestando le
truppe italiane, ma nell’aprile 1941 la Grecia capitolò a causa dell’invasione
tedesca. Nell’estate la situazione economica e sociale precipitò: le ripetute
“confische” da parte dell’esercito italiano – in realtà esse erano indiscriminate requisizioni di cibo e soprattutto di grano – portarono la popolazione
alla fame e alla nascita del risentimento contro il soldato italiano, percepito
15
All’indomani dell’8 settembre 1943 il tenente colonnello Cuiuli venne processato e
condannato a morte dalla brigata partigiana “Rab” guidata da Franc Potocnik, ex ufficiale della marina jugoslava.
16
G. Oliva, Si ammazza troppo poco, p. 132.
19
fino a quel momento come un occupante più intento a ‘fraternizzare’ con le
donne locali che a esercitare l’arte della guerra.
Nella notte del 17 febbraio 1943 la 24ª divisione fanteria Pinerolo, su
ordine del generale Cesare Benelli, uccise 150 civili a Domenikon17, un piccolo villaggio della Tessaglia. La dinamica della rappresaglia avvenuta nel
pomeriggio del 16 a causa della precedente uccisione di 9 soldati italiani avvenuta nelle vicinanze del villaggio per opera di partigiani greci è tristemente conosciuta: accerchiamento del villaggio, rastrellamento della popolazione, paese dato alle fiamme attraverso l’aviazione italiana, selezione tra uomini e donne ed infine l’esecuzione dei maschi.
Secondo le ricerche documentarie condotte da Lidia Santarelli, docente
al Centre of European and Mediterranean Studies della New York University, altri massacri di civili – a Tsaritsani, a Domokos, a Farsala e a Oxinià –
seguirono quello avvenuto a Domenikon, secondo la circolare emanata dal
generale Carlo Geloso18 per contrastare l’azione dei ribelli. Il punto cardine
della circolare, emessa il 3 febbraio 1943, ruotava attorno proprio al principio della «responsabilità collettiva»: la popolazione civile, in quanto sosteneva le bande di irregolari, poteva essere considerata colpevole e punibile
quanto i partigiani. Di qui lo scatenamento della «guerra ai civili»19. Il generale Benelli, che intendeva dare un’onorificenza al tenente colonnello De
Paola che aveva condotto le operazioni di terra, definì i fatti di Domenikon:
«una salutare lezione impartita alle popolazioni della zona». L’immagine
bonaria che il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores (1991) intende fornire del soldato italiano risulta molto lontana dalla realtà storica.
17
18
19
Il massacro di Domenikon è stato ricostruito in un documentario intitolato La guerra
sporca di Mussolini, diretto da Giovanni Donfrancesco e prodotto dalla GA&A Productions di Roma e dalla televisione greca Er.
Comandante delle forze d’occupazione in Grecia dal settembre 1941 all’aprile 1943.
Particolare la situazione che portò alla rimozione al comando del gen. Geloso. Costui
si rifiutò di eseguire gli ordini imposti dal generale tedesco Löhr, comandante del
gruppo armate est tedesco: arresto degli ufficiali greci e consegna della popolazione
di religione ebraica residente nella zona occupata dalle forze italiane.
La tattica appena descritta presenta similarità con la strategia di antiguerriglia attuata
con spietata ferocia dalle truppe germaniche in numerose aree d’occupazione e in particolare in Italia nella zona di Monte Sole dal 29 settembre al 5 ottobre 1944. Essa fu
denominata con l’espressione “prosciugare il mare”: «Come il pesce si muove nel
mare così il guerrigliero svolge la propria attività nascosto tra la popolazione». Cfr.
A. Mandreoli, Chi resta saldo. Memoria e responsabilità. Monte Sole 1944, Bologna,
Epika, 2012, p. 114.
20
Il Margine 33 (2013), n. 6
Nessuno ha pagato
Per una nazione stremata dalla guerra e sorta dalle ceneri della dittatura
fascista, cui essa aveva dato per vent’anni il proprio quasi generale assenso,
richiedere di processare in Italia i graduati tedeschi responsabili degli eccidi
compiuti dal 1943 al 1945 sul suolo italiano sarebbe valso come riconoscere
i misfatti attuati dall’esercito e dalle milizie fasciste in Albania, in Grecia e
in Jugoslavia. Se l’Italia avesse concesso agli Stati richiedenti – Grecia, Albania e Jugoslavia – l’estradizione dei vertici militari italiani che avevano
ordinato fucilazioni e la distruzione di interi villaggi di contadini, ciò avrebbe significato per la classe dirigente, per lo Stato maggiore italiano e per la
stessa monarchia ammettere le colpe commesse con l’inevitabile conseguenza di screditare dinanzi alle nazioni straniere l’immagine dello Stato
appena formato e di minare le incerte ed ambigue basi della democrazia italiana, che stentava a fare i conti con il proprio passato insanguinato. La parziale e piuttosto blanda epurazione dei fascisti dagli apparati dello Stato, avviata da Ivanoe Bonomi nel 1944, e la stessa “amnistia Togliatti”20, provvedimento percepito dai gruppi di partigiani e dai perseguitati politici antifascisti come un autentico “colpo di spugna” che portò alla scarcerazione di
numerosi fascisti, sono sfaccettature della medesima realpolitik: compromesso con il passato “sporco” e pacificazione nazionale nel nome della
“continuità dello Stato” tra il fascismo e la Repubblica21.
La mancata “Norimberga italiana” – composta da un lato dall’assenza
di unico processo contro i graduati tedeschi e dall’altro dalla reale impunibilità delle più alte gerarchie dell’esercito italiano e del regime fascista – fu
quindi funzionale alla politica contingente dell’immediato dopoguerra. Per
evitare un vero e proprio effetto boomerang nei confronti della propria nazione, l’Italia ufficiale rappresentata dal governo De Gasperi scelse – anche
se la decisione fu condizionata dagli Alleati, che premevano per mantenere
l’Italia sotto la propria influenza – la politica piuttosto che la giustizia.
20
Il provvedimento di condono delle pene per reati comuni e politici, tra cui si annovera
quello di collaborazionismo con il nemico, commessi sul suolo italiano dall’8 settembre 1943 sino al 30 giugno 1945, fu proposto dal ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti il 22 giugno 1946. L’amnistia si prefissò lo scopo fu ottenere quanto prima la pacificazione della società italiana, ferita e frammentata al proprio interno da
lotte fratricide, per dedicarsi alla ricostruzione. M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti, 22
21
G. Crainz, L’Italia repubblicana, Firenze, Giunti, 2000, p. 14.
giugno 1946 colpo di spugna sui crimini fascisti, Milano, Mondadori, 2006.
21
La fisarmonicista di Auschwitz
FRANCESCO COMINA
I
l primo treno di prigionieri arrivò nel campo il 14 giugno del 1940.
L’inferno di Auschwitz apriva il suo cancello a 740 polacchi, prime
vittime del terrore nazionalsocialista. Poi ne arrivarono a migliaia (ebrei,
zingari, omosessuali, handicappati, bambini) stipati nei vagoni merce. Si
arrivò fino a ventimila detenuti nel 1942, ma la media giornaliera oscillava
fra i tredicimila e i quindicimila. Alla fine si contarono oltre un milione di
vittime.
Auschwitz spaventa. Auschwitz commuove. L’orrore ha rivelato la
parte più brutale dell’animo umano, quella più sconvolgente, per nulla
banale. Organizzata, orchestrata, scientificamente manipolata. Il male
metafisico ha posto perfino il problema di Dio. Dov’era? Come ha potuto
tollerare l’intollerabile? Come ha fatto a chiudere gli occhi davanti allo
sterminio degli innocenti? Elie Wiesel ha cercato di rispondere nella
maniera più semplice, raccontando l’episodio dei tre uomini appesi alla
fune, due adulti e un bambino che si dimenava per non morire. «Dov’è Dio?
Dov’è? continuava a ripetere l’uomo dietro di me. E una voce mi saliva dal
di dentro: Dov’è Dio? Eccolo lì, appeso a quella fune».
E poi c’era la musica. La follia genocidaria ha pensato anche a quello.
Come è possibile mescolare il paté dello sterminio, per dirla con Montale,
senza ascoltare le grida dei moribondi? Ci saranno, fra le migliaia di
prigionieri, dei musicisti in grado di allietare il lavoro macabro delle
esecuzioni di massa?
Berlino in questi giorni ha ricordato il primo trasporto di deportati a
Auschwitz attraverso i ricordi dell’orchestra femminile. Esther Bejarano, 89
anni, era la fisarmonicista del campo. È l’unica sopravvissuta di quel gruppo
di musicisti che arrivò fino a quaranta elementi. Al Friedensfestival in
Alexanderplatz la Bejerano ha raccontato la sua storia cantando le canzoni
di pace insieme al figlio in un concerto rap durato oltre due ore. E nella
Gedächtniskirche la sua voce ha commosso il pubblico che ha partecipato al
22
Il Margine 33 (2013), n. 6
concerto delle due orchestre femminili di Auschwitz e di Berlino, unite
insieme nel ricordo e nella riproposizione dei pezzi che venivano suonati nel
campo. La fisarmonicista di Auschwitz ha raccontato:
«Ci costringevano a suonare senza sosta. A volte nella cappella, ma spesso in giro
per il campo. I momenti più strazianti li abbiamo vissuti sul binario dei treni
destinati alle camere a gas. Suonavamo con le lacrime che scendevano dalle guance.
Noi sapevamo la fine che attendeva quei carichi di condannati. Loro no, pensavano
fra sé: “Se ci accolgono con questa bella musica, forse non dev’essere poi un posto
così terribile”».
Il direttore, Stefan Heucke, ha scelto i brani che l’orchestra femminile –
fondata e diretta da Alma Rosé, violinista di origine ebraica nipote di Gustav
Mahler morta ad Auschwitz il 4 aprile del 1944 – doveva eseguire su ordine
delle SS. E così sappiamo che l’angelo della morte, Josef Mengele amava le
note dolci di Schumann e del suo Die Träumerei. Chiedeva di ascoltarla
innumerevoli volte, fino all’ossessione. E che ai concerti della domenica,
quando l’orchestra veniva fatta girare nelle varie zone del campo, non
poteva mancare Johann Strauß con An der schönen blauen Donau. Nella
cappella del campo veniva richiesto varie volte il pezzo tratto da Madama
Butterfly, Un bel dì vedremo. Ma la musica d’accompagnamento per i
condannati alle camere a gas era la Leichte Kavallerie di Franz Suppé.
Nel giorno del ricordo di quel primo transito di deportati ad Auschwitz,
la città di Berlino ha anche dedicato a quell’evento una scultura nella
Wittenbergplatz con una cerimonia a cui hanno preso parte cinque
sopravvissuti. Una grande lettera B, come la lettera del “Block”, il blocco
dove venivano rinchiusi i prigionieri, ora campeggia in uno degli snodi più
battuti della Berlino ovest, a due passi dalla Ku’damm. Una lettera B come
richiamo di quella B faticosa ed estenuante che ricorda la scritta del
cancello: ArBeit macht frei.
«A distanza di così tanti anni ho ancora paura – ha affermato la Bejarano – si, ho
ancora tanta paura. Ho paura che i nazisti ritornino. A volte mi sveglio di soprassalto
con questo incubo che non mi abbandona. Per questo faccio ancora la mia battaglia
affinché ciò non avvenga. Per questo testimonio la storia dell’orchestra di
Auschwitz. Per questo canto le canzoni di pace. Non posso fare altro. Vivere per far
trionfare la pace e la riconciliazione. Per paura che tutto possa tornare. Vi chiedo, vi
supplico, vi esorto: non dimenticate!».
23
I nostri padri
e le nostre madri
ELISEO ANTONINI
L
a generazione che ha attivamente vissuto la seconda guerra mondiale se
ne sta andando. In Germania, tra il febbraio e l’aprile di quest’anno, sono state molte le celebrazioni ufficiali a ricordo di quel drammatico periodo
storico. Sono trascorsi 67 anni dalla fine della guerra e 70 anni dalla morte
dei fratelli Hans e Sophie Scholl e degli altri componenti del gruppo di resistenza della Rosa Bianca tedesca a Monaco di Baviera. Si tratta quasi della
durata di una vita umana. Non per molto tempo ancora si avrà la possibilità
che entrino in dialogo coloro che hanno preso parte alla guerra e i loro figli,
nipoti e pronipoti.
A marzo il secondo canale della televisione pubblica tedesca (ZDF) ha
trasmesso un film in tre parti. Un invito a intensificare il dialogo. C’è dialogo tra le generazioni nella Germania del 2013? Sentendo alcune interviste e
racconti in trasmissioni televisive di approfondimento non pare; la nipote
quindicenne il cui nonno era sul fronte russo non gli ha mai posto tante domande, e nemmeno il figlio cinquantenne.
Il segretario del partito socialdemocratico tedesco Sigmar Gabriel, in
un dibattito televisivo sui padri e sulle madri del periodo nazista, ha raccontato la sua storia personale. Il padre era un convinto nazista. Tra loro il dialogo su quei tempi era praticamente assente: le posizioni sono sempre state
distanti e non conciliabili. Suo padre accusava il figlio sedicenne, che aveva
scoperto le letture “compromettenti” sulla scrivania del padre e cercava un
dialogo: «tu sei figlio della propaganda americana». «Per mio padre, ammettere di essere stato dalla parte sbagliata voleva dire rinnegare anche se stesso, il suo mondo, in modo tragico e radicale. Questo per mio padre non è
stato possibile, non ha avuto la forza per farlo. Un normale dialogo non era
quindi pensabile, non lo è mai stato».
24
lo Hans, così come Christoph Probst, tre volte padre di famiglia, così come più tardi
gli altri membri della Rosa Bianca, Alexander Schmorell e Willi Graf, il loro professore Kurt Huber e due anni più tardi, nel gennaio del 1945, Hans Leipelt. Sono
stati uccisi, perché hanno guardato a quanto accadeva, si sono indignati e hanno agito, perché hanno definito “criminali” i criminali, “assassinio” l’assassinio e la viltà,
“viltà”. Essi hanno reso palese l’ingiustizia con la loro azione decisa. Essi hanno voluto anche mobilitare le altre persone, far vedere loro quanto stava accadendo e
uscire così dal silenzio».
Il presidente tedesco Gauck ricorda e celebra la Rosa Bianca tedesca
Che cosa è rimasto della vicenda umana e “politica” della Rosa Bianca? Mi pare che un elemento lo si possa oggi ritrovare nelle parole di Joachim Gauck, il presidente della Repubblica federale di Germania che il 30
gennaio 2013, nella gremita aula magna della Ludwig-Maximilians
(l’Università di Monaco di Baviera), ha tenuto un discorso in ricordo della
presa del potere di Hitler e anche del 70° dalla morte (22 febbraio 1943) dei
membri del movimento di resistenza Weiße Rose. Egli, citando l’articolo 20,
comma 4 della Costituzione tedesca, ha detto: «Contro ciascuno che intraprende azioni» per sopprimere la libera e democratica comune convivenza,
«tutti i tedeschi hanno il diritto alla resistenza»1.
Questo articolo è entrato nella Costituzione tedesca alcuni anni dopo la
fine della seconda guerra mondiale anche grazie, vogliamo pensare, alla Rosa Bianca tedesca, oltre a tutti gli altri gruppi di resistenza. Il presidente tedesco Gauck ha poi citato anche il grande lavoro che fece Fritz Bauer (19031968), un alto magistrato dell’Assia, la cui famiglia ebrea fu costretta a fuggire dalla Germania per poi farvi ritorno finita la guerra.
«Egli – prosegue il Presidente – è stato il protagonista che ha istruito i cosiddetti
“processi di Auschwitz” che negli anni Sessanta nella Germania dell’Ovest hanno
contribuito a iniziare un ampio e pubblico dibattito sul tema dell’Olocausto. Egli fu
anche colui che nel 1952 ottenne per la prima volta che un Tribunale militare
dell’ovest dichiarasse il gruppo di resistenza 20 luglio 1944 servitori “del Bene della
Germania” e non “traditori della Patria”! Il dibattito sul diritto di ogni cittadino tedesco alla resistenza contro lo Stato tiranno si è concluso solo nel 1968 con l’attuale
formulazione».
Il Presidente ha proseguito ricordando ancora gli studenti resistenti della Rosa Bianca tedesca:
«“Qualcuno deve pur a un certo punto iniziare”: così disse Sophie Scholl il 22 febbraio 1943 guardando in faccia Roland Freisler, il temuto presidente del “Tribunale
del Popolo”, il quale nello stesso giorno la condannò a morte. Così come suo fratel-
1
A Monaco di Baviera, ma anche a Ulm e in altre città tedesche, sia la
Chiesa protestante sia la Chiesa cattolica hanno promosso molte iniziative in
ricordo degli studenti di Monaco: messe, letture delle loro lettere, appunti
del diario e dei volantini; molte le rappresentazioni teatrali e i concerti.
Il racconto del nazismo alla televisione tedesca
È assai frequente vedere in televisione in prima serata filmati, documentari e dibattiti dedicati al tragico periodo della Germania nazista. Ultimo
in ordine di tempo il lungo film trasmesso dal secondo canale della televisione pubblica tedesca dal titolo I nostri padri e le nostre madri, una fiction
diretta da Philipp Kadelbach ispirata a storie personali vere.
Nelle prime ore del 22 giugno del 1941 circa tre milioni e mezzo di
soldati tedeschi varcano il confine dell’Unione Sovietica, un confine lungo
1.600 chilometri. È la più grande avanzata di truppe della storia. A Berlino
cinque giovani amici, in età compresa tra i 18 e i 22 anni, pieni di idee per il
loro futuro, nell’estate calda di quell’anno sono costretti a lasciare la città: la
guerra li chiama. In un locale alzano allegramente un bicchiere e brindano
all’arrivederci sul quale, ancora, non hanno dubbi. Si scattano, in un ultimo
momento di spensieratezza, una foto di gruppo. Promettono di rivedersi, fra
non molto, a Natale per stare ancora insieme. Porteranno con sé la foto di
gruppo come promessa del loro futuro e certo ritrovo. Sono fiduciosi. Poi le
loro vite si dividono. Casualmente alcuni di loro si rivedranno a distanza di
qualche mese sul campo di battaglia, ma si riconosceranno appena, o meglio
i loro occhi saranno molto diversi e la “vita” in guerra li avrà trasformati.
Articolo 20, comma 4 (Principi dell’ordinamento statale – diritto alla resistenza):
«Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist» («Contro chiunque tenti di sovvertire questo ordinamento, tutti i tedeschi hanno il diritto di opporre
resistenza, quando non sia possibile un rimedio diverso».
25
26
La foto di gruppo presente nel film (ZDF - Televisione pubblica tedesca ©). Da sinistra,
in senso orario: Viktor (interpretato da Ludwig Trepte), Wilhelm (Volker Bruch), Charlotte (Miriam Stein), Friedhelm (Tom Schilling), Greta (Katharina Schüttler).
I loro nomi e le loro storie
Greta è figlia della Berlino sonora degli anni Venti e Trenta; vuole fare
carriera e vende se stessa, corpo e anima, a un gerarca nazista perché vuole
diventare attrice e cantante di successo. Al gerarca chiede in cambio che
Viktor, il suo innamorato non corrisposto, sia messo in salvo facendogli rilasciare un passaporto falso. Viktor ottiene il passaporto, ma il giorno della
sua partenza è rapito dalla polizia segreta e finisce, per ordine preciso dello
stesso gerarca, su un treno diretto a un campo di concentramento. Greta non
ha “sentito” la guerra fino a tutto il 1944, l’ha vissuta quasi di striscio, ma
negli ultimi mesi finisce in prigione, dialoga con un’altra condannata a morte e scopre la semplicità nel dare delle briciole a un uccellino che accorre
alla sua finestra, unico suo spiraglio di luce. Sarà fatta fucilare dal gerarca,
suo amante, a cui aveva rivelato di essere incinta; sarà sola, senza il suo
amato pubblico, davanti ad un gruppo di tiratori scelti. Greta esclamerà:
«Volevo vivere cantando e ho trovato la guerra!».
27
Charlotte si mette al servizio della “propria” gente nelle retrovie del
fronte come crocerossina (ce n’erano 600.000). È una ragazza candida e ingenua, “convinta” dell’ideologia nazista, e fa parte fin da subito
dell’organizzazione delle giovani ragazze del Terzo Reich. Tradirà la brava
collega ebrea ucraina, sua aiutante all’ospedale di campo, per dimostrare ai
superiori e a se stessa fedeltà ai loro comuni ideali. Se ne pentirà amaramente e non sopporterà la “croce” del tradimento. Sarà sorpresa dall’arrivo dei
russi, i soldati tedeschi feriti saranno massacrati nei loro letti e lei subirà
violenza. Sarà quasi subito salvata da una soldatessa russa che le darà degli
abiti e delle uniformi russe che le permetteranno di arrivare a Berlino qualche mese dopo. Sana e salva.
Friedhelm è un ragazzo anarchico e pacifista. In un momento di forte
tensione sul fronte russo, dirà a suo fratello Wilhelm, urlando: «Anche Dio
ci ha lasciati e non c’è alcun senso, nessuno in quello che facciamo!». La
guerra volge ormai alla fine, è il caos e le truppe al fronte sono senza guida.
Altre atrocità saranno commesse in quel “tempo di nessuno”. Friedhelm con
alcuni commilitoni cerca la via del ritorno nei radi boschi sovietici di pino e
betulle. È difficile nascondersi e sono sorpresi dai soldati russi che li attaccano. Si mettono a terra, protetti dagli alberi, unico loro rifugio. Friedhelm
prende dal taschino della giacca la foto degli amici, avverte che la fine è vicina; scrive sul retro l’indirizzo a cui dovrà essere inviata. La consegna a un
soldato perché la invii. Un commilitone gli rivolge la parola e gli chiede:
«che cosa aspettiamo ad attaccare i russi?». Friedhelm gli risponde con
un’altra domanda: «quanti anni hai?» e il giovane soldato risponde sicuro:
«dodici». Friedhelm è già molto più vecchio, ha dieci anni di più, ma la
guerra gliene ha “regalati” almeno il triplo. Non ha però la voglia e la forza
per far capire al ragazzo quanti decenni in pochi anni lui ha vissuto. Friedhelm si alza di scatto e all’impazzata spara e corre, corre e spara verso i soldati russi che lo trafiggono con numerosi colpi. Alle sue spalle i giovani soldati, i futuri padri, alzano le mani in segno di resa. Quella foto di gruppo
non giungerà mai a destinazione e forse nemmeno i giovani fatti prigionieri
dai russi.
Wilhelm è il fratello maggiore di Friedhelm, è un ragazzo che non sbaglia mai, è un soldato esemplare, con ruoli di responsabilità per volere della
sua famiglia, padre e madre entrambi molto esigenti e dai buoni costumi,
dalla solide tradizioni prussiane; egli vive il duro conflitto tra dovere collettivo e coscienza personale. Nelle ferraglie di un carro armato esploso trovano rifugio, nottetempo e dopo lunga battaglia, Wilhlem e un soldato russo.
28
Quest’ultimo semi carbonizzato in volto, ma ancora vivo, chiede, con un
cenno della mano, dell’acqua al nemico-amico tedesco; la ottiene e senza
scambiarsi una parola la vita del giovane soldato russo si consuma. Appena
fa giorno l’amico-nemico tedesco se ne va e vagando trova un altro rifugio
in una casa di legno con segni del forzato abbandono da parte dei proprietari. Davanti alla casa un laghetto e una solitaria betulla. Un gatto e un po’ di
pesce saranno le sue poche consolazioni. Sarà catturato dai soldati tedeschi
in ritirata, classificato come disertore e condannato a morte. Sarà maltrattato
per lunghi giorni e aspetterà il momento più adatto per pugnalare il capo
banda tedesco, un suo ex-collega impazzito. Riprenderà la via del bosco e
riuscirà ad arrivare a Berlino per la fine della guerra.
Viktor è un ragazzo ebreo che impara il mestiere nella sartoria di famiglia, Goldstein. È innamorato pazzo di Greta, che non ricambia. Prima di
partire per il fronte le regala una sua creazione artistica in segno d’amore: un
vestito rosso lungo di seta fatto su misura per lei. Greta lo indosserà nel suo
tour sonoro sul fronte russo per allietare le truppe tedesche. Qualche anno
prima, nell’appartamento di Berlino, il padre di Viktor, intento a cucire la
croce gialla sugli abiti di famiglia, aveva detto al figlio, che si diceva stupito
di quanto suo padre stava facendo: «Un bravo tedesco non disobbedisce mai
alla legge». Viktor sarà rapito dalla Gestapo mentre, sotto falso nome, sta
tentando di lasciare Berlino e sarà messo in un treno della morte. Durante il
viaggio riuscirà a fuggire dal treno in corsa assieme a Lilija, una ragazza polacca. Lei racconterà a Viktor la sua storia più recente. A Varsavia è stata
violentata da un gerarca nazista perché voleva assolutamente un figlio maschio data la sterilità della moglie. Era nata però una bambina che era stata
subito uccisa. La ragazza-madre Liljia è invece inviata per punizione in un
lager all’est. Viktor e Lilija vagheranno in terre ignote e una banda di partigiani polacchi li cattureranno. Viktor sarà usato per attrarre soldati tedeschi
in imboscate mortali. Viktor ha il torto di essere ebreo tra i tedeschi e di essere tedesco tra i polacchi. Avrà consolazione umana dalla sua involontaria
amica di viaggio che lo guiderà e lo salverà dai partigiani senza nemmeno
mai baciarlo.
in disordine e Viktor trova sue foto e alcuni suoi abiti. Nell’ufficio di Berlino, appena creato per la ricerca delle persone, ritrova il gerarca nazista che,
bruciati gli abiti ed eliminato il suo passato (ha ucciso moglie e figlia e fatto
uccidere Greta), si è dato un nuovo ruolo nella Germania sconfitta. Si riconoscono ma non succede nulla. Viktor sembra rassegnato e il gerarca si sente «graziato e perdonato». «Avanti il prossimo»…
A Berlino, nell’estate del 1945, in quel locale in cui si erano lasciati
quattro anni prima, si ritrovano Viktor, Wilhelm e Charlotte. Non si abbracciano, tra loro solo incroci di sguardi e di occhi spenti. La gioia di essere vivi non fa breccia; a che serve nella Berlino in stracci essere vivi? Le macerie
e la polvere sono il solo loro paesaggio. Si versano, ricercando un po’ di vita, un po’ di liquore, come promesso, e ricordano, facendo solo i loro nomi,
le vite “straperdute” di Greta e Friedhelm.
Dolore, colpa e silenzio
La tragedia di quegli anni e di quegli uomini, padri e madri, non è raccontabile, è muta, è senza parole e senza musica. Come il pianoforte che
Viktor prova a suonare senza che esca alcun suono, nessuna musica, come
invece era accaduto allora, ieri, quando, loro malgrado, si erano divisi.
Questi sono le madri e queste sono i padri che non troveranno, anche
negli anni a venire, il coraggio di parlare. Questa sembra essere la loro sola
unica “salvezza”, la sola via per non morire ancora.
C’è la sofferenza dei dannati e la sofferenza dei “carnefici”; entrambe
senza tempo, senza dialogo e per molti senza perdono. Molti di questi padri
e questi madri sono caduti, ma tutti sono “morti”, tutti, nessuno escluso; dei
sopravvissuti vivono solo i corpi e il ricordo non comunicabile di questa
smisurata tragedia senza alcun dio.
Il presidente tedesco Gauck, che ha visto il film, il 24 marzo scorso è
stato accompagnato dal presidente italiano Giorgio Napolitano a Sant’Anna
di Stazzema per ricordare le vittime civili dei nazisti del 12 agosto del 1944.
Gauck ha detto:
«Non è per nulla facile e semplice per un tedesco venire qui a Sant’Anna di Stazzema. Lo è ancora meno per un presidente tedesco quale rappresentante di un Paese
e della sua storia. Non è semplice, e così deve essere, riconoscersi nell’enorme colpa e confrontarsi con un terribile sterminio che è stato perpetrato da propri concittadini».
Il ritorno a Berlino
Tornato a Berlino, Viktor si mette alla ricerca di Greta, di cui non conosce ancora il destino. Torna nell’appartamento di lei, l’abitazione è tutta
29
30
Il Margine 33 (2013), n. 6
Mosé il maestro
PIERGIORGIO CATTANI
U
na delle ultime fatiche di Massimo Giuliani, Il bastone di Mosè (Il
Margine, Trento 2013), nel panorama spesso sterminato delle opere e
degli studi sulla Bibbia e sull’ebraismo, a mio parere brilla per chiarezza e
originalità. Oltre a testimoniare la sua competenza ed erudizione, lungo le
pagine si colgono l’umiltà dello studioso che sembra ricominciare ogni volta
dall’inizio, e la perizia del divulgatore che con pazienza offre ai lettori
l’esito delle sue ricerche. Ne esce un quadro sintetico e aperto che tocca le
questioni dirimenti relative non solo alla figura di Mosè o alla narrazione
biblica contenuta nella Torah ma al monoteismo stesso, alla visione religiosa
proposta dalla Bibbia, che poi ha influenzato pure a livello profano la storia
dell’occidente e non solo.
Mosè è senza dubbio un personaggio entrato nel nostro immaginario
collettivo. I dieci comandamenti, le piaghe d’Egitto, l’esodo verso la terra
promessa sono narrazioni presenti nella comune percezione della vita e della
storia. Sono griglie interpretative radicate nella nostra visione del mondo.
Secolarizzati e a volte banalizzati, questi racconti servono oggi per descrivere le code sulle strade delle vacanze; tuttavia rimangono fondamentali per
comprendere la civiltà occidentale e non solo. Si è perso forse il substrato
religioso (soprattutto ebraico) di tali concetti, mentre il cinema hollywoodiano sembra essersi completamente sovrapposto al retaggio della Bibbia:
Mosè ha l’atteggiamento statuario e vincente (e molto americano) di un
Charlton Heston, che in scene epiche del film del 1956, vede aprirsi le acque
del Mar Rosso e sale sul monte per tornare con le tavole della legge.
Il contesto cristiano-cattolico ha quasi dimenticato Mosè. Nelle vecchie
“storie sacre” il grande profeta di Israele viene presentato al “Roveto ardente” quando riceve la Rivelazione oppure quando fa miracoli al cospetto del
Faraone o al momento di rompere le tavole della Legge dopo l’idolatria del
“vitello d’oro”. Nei catechismi i dieci comandamenti sono presi ancora come base della morale proposta dalla Chiesa, ma il loro testo è diverso da
quella che si legge nella Bibbia; e Mosè sparisce. Mosè balbuziente, che uccide un egiziano, impegnato in riti di difficile comprensione, che muore
prima di compiere la sua missione per una colpa indeterminata e forse non
sua, non può essere il modello etico del “buon padre di famiglia”.
31
Nel libro Massimo Giuliani ci descrive un’altra storia. Per la tradizione
ebraica, antica e moderna, Mosè non è soltanto il condottiero di fronte alle
acque, il mediatore che vede Dio “faccia a faccia”, oppure il profeta e legislatore che svolge un ruolo indiscutibile al centro dell’accampamento, quanto piuttosto il maestro che, prima di comandare, insegna. «Mosè nostro maestro», osserva l’autore commentando l’affresco del Perugino scelto come
copertina del volume, è «un leader umile capace di studiare senza mai alzare
gli occhi dal libro. Come a dire: non c’è altra leadership che l’obbedienza al
comando divino, non c’è altra autorità che quella che deriva dalla conoscenza quale frutto del diuturno studio della Legge, non c’è altro potere che la
catena della trasmissione della conoscenza stessa di generazione in generazione» (p. 189). È dunque il prototipo del maestro che ascolta (in primis la
voce di Dio) e che insegna e che sempre impara, come testimoniato dai numerosissimi racconti di una tradizione ebraica sempre viva. La verità passa
attraverso la catena di maestri e discepoli, anzi è quella stessa catena interpretativa che nasce dal Sinai e prosegue fino ad oggi a essere una delle essenze stesse dell’ebraismo. Il biblista Piero Stefani annota:
«Lo studio umano del testo sacro rappresenta per converso sia un incontro effettivo
tra il divino e l’umano che un riconoscimento del perpetuo debito da noi contratto
rispetto a chi ci ha trasmesso la parola. La parola poi non avrebbe bisogno di essere
tramandata se si presentasse semplicemente come testo puramente dispiegato e scoperto nella sua immutabilità; al contrario essa ha la necessità di venire trasmessa
propri perché non può prescindere dall’essere fatta rivivere attraverso il suo accoglimento, la sua lettura e il suo commento. D’altronde non il testo in sé, bensì la fedeltà di chi ce lo ha trasmesso ne testimonia la natura sacra presentandolo come
luogo della rivelazione»1.
La trasmissione della rivelazione diventa un proseguimento
dell’incontro tra Dio e il popolo sul monte Sinai: i mediatori di un’alleanza
che si rinnova quotidianamente sono i maestri. Il luogo della rivelazione non
è più il monte ma l’aula dove si studia e dove, secondo un bellissimo midrash, Mosè stesso si siede durante una lezione sulla Torah e non capisce
nulla. Questo vale pure per la tradizione cristiana, come scriveva Gregorio
Magno: «Scriptura sacra aliquomodo cum legentibus crescit». È questo un
fondamentale principio ermeneutico per cui ogni testo si sviluppa, prende
1
Piero Stefani, Il nome e la domanda. Dodici volti dell’ebraismo, Morcelliana, Brescia
1988, p. 64.
32
nuovi significati, appunto “cresce” nella misura in cui viene studiato, interpretato, “ruminato”. Siamo tutti protagonisti di questa interpretazione infinita. Con una regola però: più che essere dotti o sapienti, è necessaria una
grande capacità di ascolto. Sapendo che non aggiungiamo nulla da soli, che
siamo sempre debitori di chi ci ha preceduto e di chi ci accompagna.
Nel libro, accanto a Mosè, compaiono altre figure decisive magistralmente descritte da Giuliani: Aronne, Miriam, Faraone e soprattutto Dio, protagonista di un’epopea del tutto originale. La vittoria sugli Egiziani ottenuta
«con mano potente e braccio teso» si trasforma nella compagnia al tortuoso
vagabondare del popolo nel deserto; la portentosa teofania con tuoni e fulmini sul Sinai è giustapposta alla «voce di silenzio sottile» con cui Dio si
presenta a Mosè in una caverna dell’Horeb. Non c’è mai un’epica nazionale,
come Mosè non è mai l’eroe o il dittatore. Qui sta la chiave per comprendere
il sottotitolo che parla di monoteismo e potere.
Che cosa c’entra il potere in racconti di quasi tremila anni fa? Esiste
un’attualità di Mosè capace di aiutarci a comprendere la situazione contemporanea e il delicatissimo rapporto tra religione e politica? Il monoteismo,
poi, è connesso con la violenza e con un sistema solamente teocratico? Oppure nei racconti dell’Esodo troviamo i semi dei concetti di rivoluzione, critica all’autorità, dissenso e divisione dei poteri?
Rifletteranno altri meglio di me su questi temi. Vorrei però aggiungere
alcune brevi considerazioni – che si trovano più volte nel libro – sul ruolo e
sul senso che per ognuno di noi ha la parola “missione”. È evidente come
Mosè riceva da Dio un compito, il mandato di ritornare in Egitto, di parlare
al Faraone nonostante fosse balbuziente, di liberare il popolo e di guidarlo
fino alla terra promessa. Questa “vocazione” diventa subito il prototipo per
ogni chiamata profetica successiva: Dio sceglie un profeta – sovente dal
labbro impuro e di malferme convinzioni, comunque quasi sempre inadeguato – per cominciare un’opera molto difficile. Voglio rimarcare il fatto
che il profeta deve “cominciare l’opera” e non compierla, secondo il celebre
detto rabbinico secondo cui «non sta a te compiere l’opera, ma non puoi
neppure sottrartene».
L’individuo ha la responsabilità di fare la sua parte ma alla fine deve
raggiungere la consapevolezza di essere, singolarmente, un “servo inutile”,
che conta ancora una volta solo perché fa parte di una catena più ampia.
Questo vale anche per Mosè, il più grande, colui che discuteva con Dio nella
tenda ma che morì ai margini della terra promessa, potendola osservare soltanto dall’alto, al limitare del deserto. Scrive Giuliani:
33
«Certe missioni – forse ogni vera missione, a cominciare dalla custodia delle generazioni future – non si concludono mai, sono per costituzione missioni aperte nelle
quali noi, che si sia leader politici o guide spirituali o maestri, non siamo che strumenti e anelli di una catena. Conta la catena, non il singolo anello; il senso di ogni
anello è dato proprio dall’unione e dalla resistenza della catena» (p. 52).
Un discorso molto simile a quello delineato per descrivere la catena dei
maestri che trasmettono l’interpretazione della Scrittura e così la arricchiscono di generazione in generazione.
La missione di Mosè non si conclude in gloria. C’è una sorta di malinconia in quello sguardo dal monte Nebo. In fondo questo sembra essere il
destino di tutti i maestri e i profeti. Così, per esempio, Martin Buber ci presenta la figura del maestro chassidico Rabbi Nachman di Bratzlaw:
«Talvolta lo assaliva la malinconia, ma non per il morire, bensì per il lavoro della sua
vita che non aveva portato i frutti sognati. Si chiedeva se non avrebbe fatto meglio ad
allontanare e respingere il mondo, e a scegliersi un luogo ove star solo, affinché il
giogo del mondo non gravasse su di lui. … Gli pareva inoltre di aver avuto ben scarsa
influenza e sentiva quanto è difficile rendere libero un uomo. … Rabbi Nachman non
aveva compiuto la sua opera … Senza compimento, era caduto lungo la via»2.
Mosè ha compiuto la sua opera? Sicuramente sì, ma con grande consapevolezza e umiltà. Ma pure, così almeno crediamo, ha lasciato questo
mondo senza comprendere tutto, ponendosi ancora domande. La redenzione,
il successo, la vittoria non scaturiscono tanto dall’effettivo compimento
dell’opera, quanto dalla memoria, dalla interpretazione continua di ciò che è
stato. Scrive Giuliani: «se la redenzione nasce dalla memoria, dall’oblio nasce l’esilio» (p. 18). Un esilio da cui siamo liberati mediante lo studio: infatti anche grazie allo studio la diaspora ebraica ha mantenuto la sua identità. E
antidoto a ogni esilio – pure quello di chi vive nel suo paese – è questo volume che non è solo un viaggio originale nella Bibbia ebraica, ma è un itinerario per capire l’oggi, meglio per farci ulteriori domande.
Paolo De Benedetti3 descrive magistralmente il giudaismo con una serie di aggettivi: esso esiste nella sua «vitale, antiapocalittica, misericordiosa,
saggia, libera fino al paradosso e allo humor, ubbidiente e ardita davanti a
Dio, terrena e utopica ispirazione di matrice farisaica». Questo è lo stile di
Massimo Giuliani ma pure la cifra del suo approccio esistenziale
all’amicizia, alla ricerca delle cose degli uomini e di quelle di Dio.
2
3
M. Buber, Storie e leggende chassidiche, Mondadori, Milano 2008, p. 62.
In Jakob J. Petuchowski, I nostri maestri insegnavano, Morcelliana, Brescia 1988, p. 8.
34
editore della rivista:
A SS OC IA ZI O NE
OSC A R
R O ME R O
Fondata nel 1980 e già
presieduta da Agostino
Bitteleri, Vincenzo Passerini, Silvano Zucal, Paolo
Ghezzi, Paolo Faes, Alberto Conci.
Presidente: Piergiorgio
Cattani. Vicepresidente:
Claudio Fontanari. Segretaria: Veronica Salvetti
I L MA R G IN E
Mensile
dell’associazione
culturale
Oscar A. Romero
Fondato nel 1981 e già
diretto da Paolo Ghezzi,
Giampiero Girardi, Michele Nicoletti.
Direttore:
Emanuele
Curzel. Vicedirettore:
Francesco Ghia. Responsabile a norma di
legge: Paolo Ghezzi.
Amministrazione: Luciano Gottardi. In redazione vi sono anche:
Fabio Olivetti, Leonardo Paris, Pierangelo
Santini, Silvano Zucal.
Altri collaboratori: Roberto Antolini, Celestina Antonacci, Renzo Apruzzese,
Anita Bertoldi, Omar Brino, Vereno Brugiatelli,
Paolo Calabrò, Fabio Caneri, Monica Cianciullo,
Giovanni Colombo, Alberto Conci, Francesco Comina, Mattia Coser, Dario
Betti, Fulvio De Giorgi,
Eugen Galasso, Lucia
Galvagni, Luigi Giorgi,
Paolo Grigolli, Fabrizio
Mandreoli, Paolo Marangon, Milena Mariani, Silvio Mengotto, Giuseppe
Morotti, Walter Nardon,
Michele Nicoletti, Vincenzo Passerini, Lorenzo
Perego, Enrico Peyretti,
Matteo Prodi, Federico
Premi, Chiara Turrini, Mauro Stenico, Urbano Tocci,
Grazia Villa.
Una copia € 2,00 - abbonamento annuo €
20, annuo + pdf euro
22, solo pdf euro 8,
estero € 30, via aerea €
35. I versamenti vanno
effettuati sul c.c.p. n.
10285385 intestato a:
«Il Margine», c.p. 359 38122 Trento o c.c.b.
Bancoposta
(IBAN
IT97 D076 0101 8000
0100 4299 887). Estero:
BIC: BPPIITRRXXX.
S
e vuoi sollevare un uomo dalla melma e dal
fango, non credere di poter restare in alto e
accontentarti di stendergli una mano soccorrevole. Devi scendere giù tutto, nella melma e nel
fango. Allora afferralo con forti mani e riconduci lui
e te alla luce.
Autorizzazione Tribunale
di Trento n. 326 del
10.1.1981.
Codice fiscale e partita iva
01843950229.
(Martin Buber, I racconti dei Chassidim, 1949)
Redazione e amministrazione: «Il Margine», c.p. 359, 38122
Trento.
http://www.ilmargine.it/it/rivista
[email protected]
Stampa: Publistampa
Arti Grafiche, Pergine
Il Margine n. 6/2013 è
stato chiuso il 19 giugno 2013.
«Il Margine» è in vendita
a Trento presso: “Artigianelli”, via Santa Croce 35
- “Centro Paolino”, via
Perini 153 - “La Rivisteria” via San Vigilio 23 “Benigni” via Belenzani
52 - a Rovereto presso
“Libreria Rosmini”, “Blulibri”.
Periodico mensile - Anno 33, n. 6, giugno 2013 - Poste Italiane S.P.A. spediz. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Trento - taxe perçue. Redaz.
e ammin.: 38122 Trento, cas. post. 359 – Una copia € 2,00 – abb. annuo € 20
http://www.il-margine.it/it/rivista