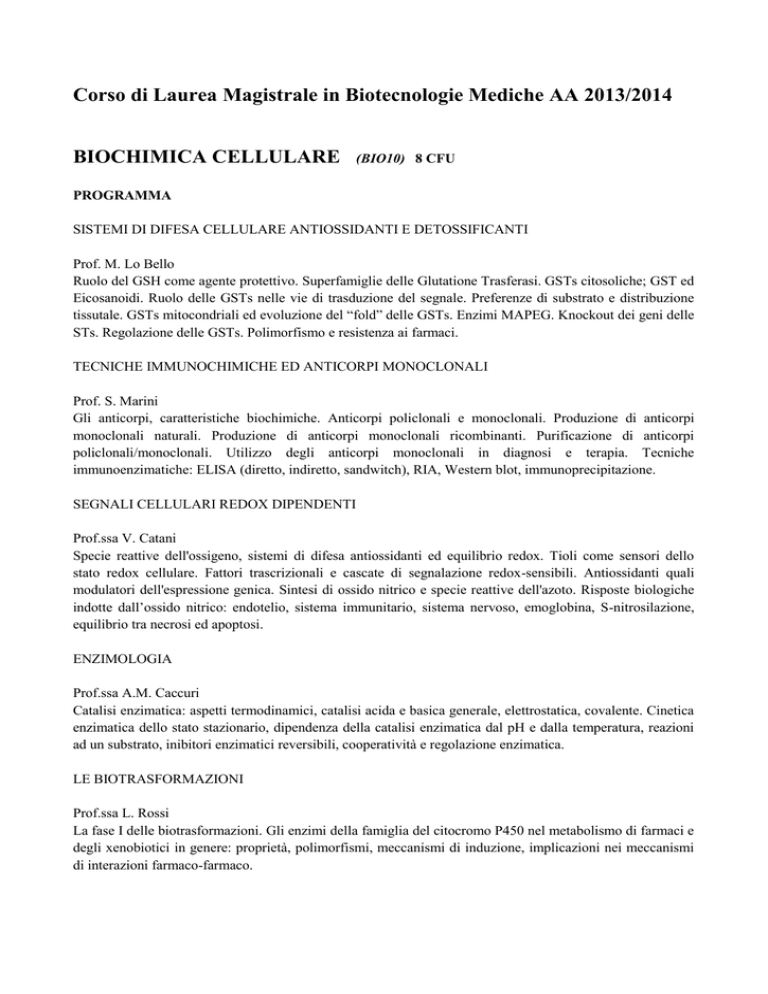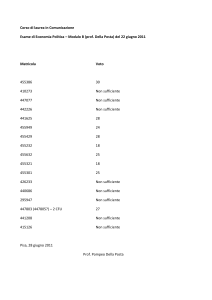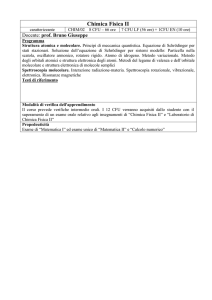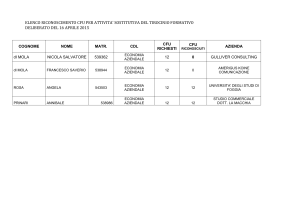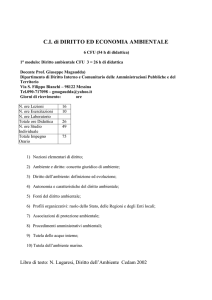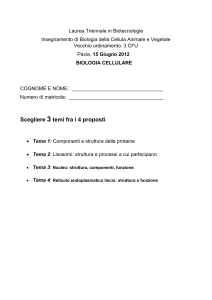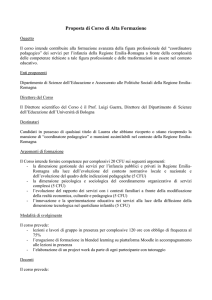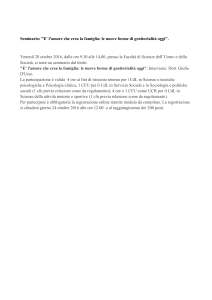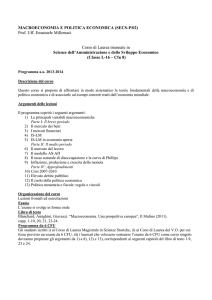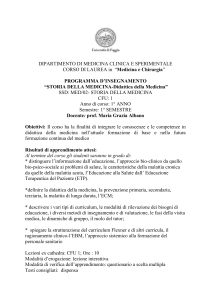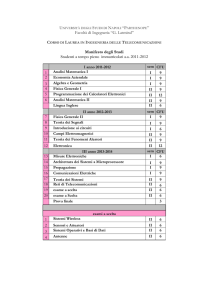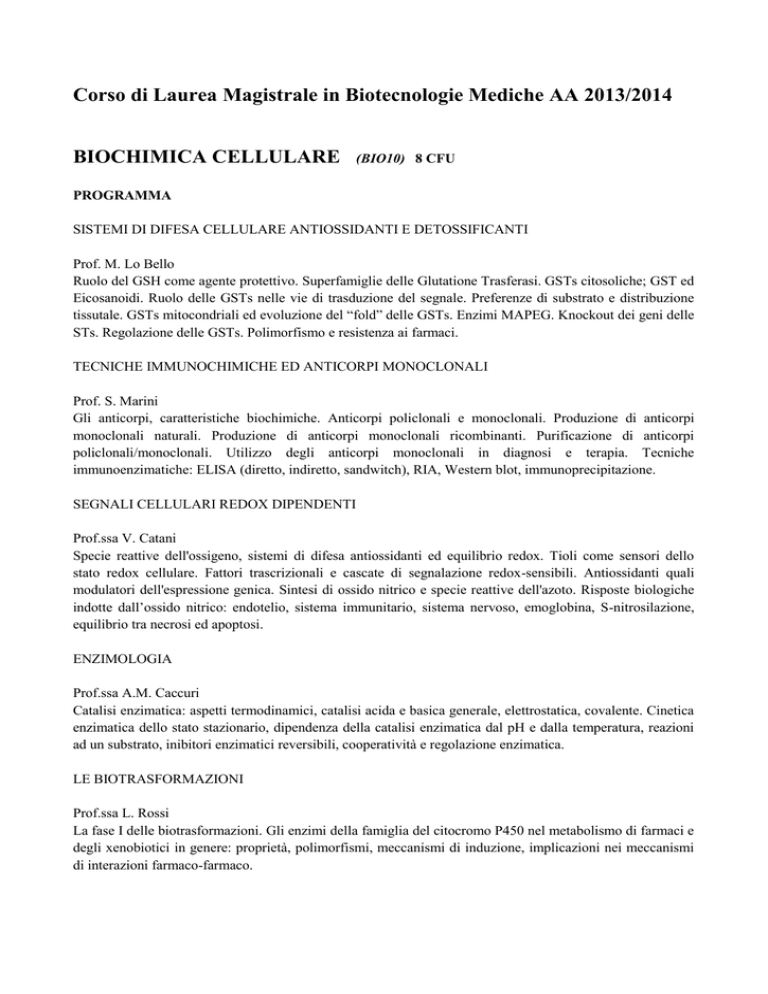
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
BIOCHIMICA CELLULARE
(BIO10) 8 CFU
PROGRAMMA
SISTEMI DI DIFESA CELLULARE ANTIOSSIDANTI E DETOSSIFICANTI
Prof. M. Lo Bello
Ruolo del GSH come agente protettivo. Superfamiglie delle Glutatione Trasferasi. GSTs citosoliche; GST ed
Eicosanoidi. Ruolo delle GSTs nelle vie di trasduzione del segnale. Preferenze di substrato e distribuzione
tissutale. GSTs mitocondriali ed evoluzione del “fold” delle GSTs. Enzimi MAPEG. Knockout dei geni delle
STs. Regolazione delle GSTs. Polimorfismo e resistenza ai farmaci.
TECNICHE IMMUNOCHIMICHE ED ANTICORPI MONOCLONALI
Prof. S. Marini
Gli anticorpi, caratteristiche biochimiche. Anticorpi policlonali e monoclonali. Produzione di anticorpi
monoclonali naturali. Produzione di anticorpi monoclonali ricombinanti. Purificazione di anticorpi
policlonali/monoclonali. Utilizzo degli anticorpi monoclonali in diagnosi e terapia. Tecniche
immunoenzimatiche: ELISA (diretto, indiretto, sandwitch), RIA, Western blot, immunoprecipitazione.
SEGNALI CELLULARI REDOX DIPENDENTI
Prof.ssa V. Catani
Specie reattive dell'ossigeno, sistemi di difesa antiossidanti ed equilibrio redox. Tioli come sensori dello
stato redox cellulare. Fattori trascrizionali e cascate di segnalazione redox-sensibili. Antiossidanti quali
modulatori dell'espressione genica. Sintesi di ossido nitrico e specie reattive dell'azoto. Risposte biologiche
indotte dall’ossido nitrico: endotelio, sistema immunitario, sistema nervoso, emoglobina, S-nitrosilazione,
equilibrio tra necrosi ed apoptosi.
ENZIMOLOGIA
Prof.ssa A.M. Caccuri
Catalisi enzimatica: aspetti termodinamici, catalisi acida e basica generale, elettrostatica, covalente. Cinetica
enzimatica dello stato stazionario, dipendenza della catalisi enzimatica dal pH e dalla temperatura, reazioni
ad un substrato, inibitori enzimatici reversibili, cooperatività e regolazione enzimatica.
LE BIOTRASFORMAZIONI
Prof.ssa L. Rossi
La fase I delle biotrasformazioni. Gli enzimi della famiglia del citocromo P450 nel metabolismo di farmaci e
degli xenobiotici in genere: proprietà, polimorfismi, meccanismi di induzione, implicazioni nei meccanismi
di interazioni farmaco-farmaco.
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
BIOLOGIA MOLECOLARE E METODOLOGIE
BIOINFORMATICHE E CHIMICHE (BIO11+CHIM01+CHIM02)
12 CFU
PROGRAMMA
BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOINFORMATICA (BIO11) 8 CFU
Prof.ssa E. Candi
Cenni di Biologia Molecolare e richiami di Tecniche di Base. Genomica e post-genomica. Tecniche del
DNA ricombinante. Tecniche per lo studio di un promotore. Metodi di trasfezione e terapia genica.Analisi
dell'espressione genica (array). Manipolazoni genetiche nel topo. Evoluzione delle tecniche di
sequenziamento del DNA. Genomica e post-genomica. Controllo dell'espressione genica e ruolo dei piccoli
RNA. Struttura della cromatina e modificazioni epigenetiche. Meccanismi di morte cellulare programmata.
Meccanismi molecolari di senescenza cellulare. Meccanismi di degradazione proteica. Modificazioni posttraduzionali. Differenziamento cutaneo. Malattie genetiche cutanee. Metabolismo e Cancro.
Prof.ssa M. Helmer- Citterich
Banche dati di acidi nucleici, proteine, letteratura. Metodi esaustivi ed euristici di allineamento e ricerca di
biosequenze in banche dati. Motivi funzionali. Browser genomici. Metodi per l'analisi del trascrittoma.
Previsione struttura secondaria e terziaria delle proteine: modelling per omologia, threading, metodi ab
initio. Reti di interazioni proteiche. Banche dati di Interazioni, pathways, malattie genetiche, SNPs.
SPETTROSCOPIA DI MOLECOLE BIOLOGICHE (CHIM02)
2 CFU
Prof L. Stella
Richiami generali di spettroscopia. La radiazione elettromagnetica. Velocità di propagazione, lunghezza
d’onda, frequenza ed energia della radiazione. Quantizzazione dell’energia: fotoni e livelli energetici. Lo
spettro elettromagnetico ed i gradi di libertà elettronici, vibrazionali e rotazionali. Richiami di spettroscopia
di assorbimento. La legge di Lambert-Beer. Scelta delle condizioni sperimentali. Cromofori di interesse
biologico. Solvatocromismo ed ipocromismo. Dicroismo circolare (CD). Luce Polarizzata circolarmente.
Chiralità. Fenomeno del dicroismo circolare. Ellitticità ed ellitticità molare. Descrizione schematica di un
dicografo. Scelta delle condizioni sperimentali. Dicroismo circolare e conformazioni di biopolimeri.
Determinazione della struttura secondaria di proteine. CD di acidi nucleici. CD indotto. Assorbimento IR.
Spettro IR di una proteina. Spettro IR e struttura secondaria. Lo spettro IR come “impronta digitale”.
Spettroscopia di fluorescenza. Il fenomeno della luminescenza. Distinzione tra fluorescenza e fosforescenza.
Diagramma di Jablonski. Tempo di vita di fluorescenza. Fluorofori. Schema di un fluorimetro. Intensità di
emissione. Resa quantica. Il fenomeno del filtro interno. Sensibilità della fluorescenza. Spettri di emissione.
Rilassamento del solvente. Spettri di eccitazione. Soppressione della fluorescenza. FRET. Teoria. Efficienza
di trasferimento. Applicazioni: GFP e altri metodi di marcatura delle proteine. Anisotropia di fluorescenza.
Fotoselezione. Dinamica molecolare e decadimento dell’anisotropia. Applicazioni
CHIMICA ANALITICA (CHIM01) 2 CFU
Prof. G. Palleschi
Cifre significative, accuratezza, precisione ed esattezza di un’analisi: Test Q e coefficiente di correlazione,
uso della bilancia analitica. Concentrazione di soluzioni: Concetto di Molarità, Normalità, numero di
equivalenti. Equilibri di ossido-riduzione, elettrolisi e pile. Misure elettrochimiche: potenziometria. Misura
pratica del pH. Elettrodi iono-selettivi: elettrodi a Sodio, Potassio e Fluoruro. Sensore ad ammoniaca.
Amperometria: Elettrodo ad Ossigeno (Clark) ed elettrodo ad acqua ossigenata, principi di funzionamento.
Biosensori, definizione ed esempi, immobilizzazione di enzimi. Sensori ad enzima: Biosensori a Glucosio, a
lattato, piruvato, biosensore ad Urea, Applicazioni dei biosensori nel settore clinico. Biosensori ad
inibizione. Immunosensori. Esempi ed applicazioni nel settore clinico ed alimentare. Sensori a DNA.
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA
(BIO16+BIO17)
6 CFU
PROGRAMMA
ISTOLOGIA UMANA
(BIO17) 3 CFU
Prof.ssa L. Campagnolo e Prof.ssa M. G. Farrace
Cenni di gametogenesi. Fecondazione. Tecniche di produzione di cellule staminali. Cellule embrionali
staminali murine ed umane. Cellule staminali adulte. Cellule staminali pluripotenti indotte. Clonazione.
Tecniche di fecondazione assistita. Le cellule staminali mesenchimali. Applicazioni in biomedicina. Proteine
di adesione cellula-cellula e cellula-matrice extracellulare. Struttura e funzioni della matrice extracellulare.
Cenni di produzione e utilizzo di tessuti artificiali. Sostituti artificiali della pelle e dei vasi sanguigni.
ANATOMIA
(BIO16) 3 CFU
Prof. R. Geremia
Livelli di organizzazione: Sistemi e apparati, organi, tessuti, cellule. Apparato locomotore: Struttura anatomo
microscopica dell’osso; caratteristiche strutturali delle ossalunghe; struttura anatomo microscopica del
muscolo e dei tendini. Articolazioni: classificazione; elementi costitutivi di una diartrosi; articolazione
scapolo-omerale; ginocchio; articolazioni intervertebrali. Apparato cardiocircolatorio e linfatico: circolazione
polmonare; circolazione sistemica; classificazione e struttura anatomo microscopica di arterie, capillari, vene
e linfatici; scambio di liquidi e soluti nei tessuti periferici; generalità sulla anatomia del cuore; ciclo
funzionale cardiaco; sistema di conduzione cardiaco, vasi coronarici. Apparato respiratorio: struttura
cartilaginea della laringe e concetti funzionali; gabbia toracica e cavità pleuriche; nozioni macro e
microscopiche di trachea, bronchi, polmoni; vascolarizzazione. Apparato digerente: organizzazione
macroscopica generale degli elementi costitutivi; organizzazione anatomo microscopica degli elementi
dell’apparato digerente; fegato; il sistema portale; pancreas; fasi della digestione e sedi della digestione di
zuccheri, proteine e grassi. Apparato escretore: posizione e struttura generale del rene; organizzazione macro
e microscopica del parenchima renale; vascolarizzazione; il nefrone; la vescica urinaria. Apparato genitale
maschile e femminile: descrizione generale delle componenti degli apparati genitali, gametogenesis. Sistema
nervoso: componenti princilale del sistema nervoso; il neurone; recettori; terminazioni sulla muscolatura
scheletrica, liscia e sulle ghiandole; componenti del sistema nervoso centrale; midollo spinale; l’arco riflesso;
tronco encefalico, diencefalo cervelletto e telencefalo; organizzazione neuronale delle vie sensitive coscenti e
non coscenti, delle vie motorie piramiodali ed extrapiramidali; cenni sulle aree funzionali della corteccia
cerebrale.
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA
(BIO12)
6 CFU
PROGRAMMA
Prof.ssa Ottavia Porzio
Introduzione alla Medicina di Laboratorio: variabilità biologica, preanalitica ed analitica. Il controllo di
qualità analitico interno ed esterno. L’automazione. Il laboratorio nelle malattie renali. Test di funzionalità
epatica e di danno epatocellulare. Elettroforesi proteica. Biochimica clinica del Liquido cefalo-rachidiano:
Indice di Link ed Indice di barriera. Marcatori cardiaci. Definizione e tipi di diabete mellito. Le basi
molecolari della secrezione insulinica: la glucochinasi ed i canali del potassio ATP-dipendenti. Meccanismi
di controllo di qualita’ del reticolo endoplasmico. Breve storia degli analoghi dell’insulina ad uso
terapeutico. Ormoni secretagoghi e nuove forme di terapia del diabete. Studio dell’asse ipotalamo-ipofisario:
asse ipotalamo-ipofisi-tiroide e ipotalamo-ipofisi-surrene. Biologia molecolare della sindrome
adrenogenitale. Marcatori tumorali: Classificazione e descrizione dei principali marcatori sierologici.
Autoimmunità: il laboratorio nella diagnosi delle malattie autoimmuni sistemiche. Allergologia: indagini
sierologiche per lo studio delle IgE totali e specifiche.
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2011/2012
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI
CHIM 11)
(BIO12+BIO13+
8 CFU
PROGRAMMA
LE IMMUNOTECNOLOGIE IN BIOLOGIA E MEDICINA (BIO12)
2 CFU
Prof.ssa S. Biocca
Anticorpi policlonali e anticorpi monoclonali. Anticorpi ricombinanti e frammenti anticorpali.
Librerie di anticorpi: il sistema del fago filamentoso M13. La selezione degli anticorpi dalle librerie fagiche.
Espressione di anticorpi in ambienti artificiali: batteri, cellule di mammifero non linfoidi.
Applicazione degli anticorpi in clinica: anticorpi terapeutici e diagnostici. Anticorpi umani e umanizzati.
Immunotossine e immunoconiugati. Anticorpi bispecifici.
La tecnologia degli anticorpi intracellulari: indirizzamento degli anticorpi in diversi compartimenti
intracellulari. Meccanismo d’azione e applicazioni degli anticorpi intracellulari alla malattie da prioni e loro
potenzialità terapeutica.
BIOLOGIA APPLICATA (BIO13) 2 CFU
Prof.ssa S.A. Ciafrè
Rilevanza degli RNA non codificanti nella complessità fenotipica eucariotica
MicroRNA: la storia della loro scoperta; biogenesi, processamento e loro regolazione; ruolo come regolatori
fini dell’espressione genica eucariotica; modalità di riconoscimento dei target e modalità di azione.
MicroRNA e cancro: ruolo come oncogèni e oncosoppressori; esempi specifici e meccanismi che portano ad
espressione aberrante di specifici microRNA nei tumori; microRNA e processo di metastatizzazione: esempi
specifici
Interazioni tra microRNA ed RNA non codificanti: il caso dei ceRNA (competing endogenous RNA)
Applicazioni biotecnologiche dei microRNA: utilizzo di siti target per microRNA per indirizzare
l’espressione di transgeni in maniera tessuto-specifica; metodi per inibire l’espressione di microRNA
endogeni o per reintegrare l’espressione di microRNA persa in condizioni patologiche
MicroRNA nei liquidi biologici: origine e utilizzo come marcatori di patologie; metodi per la rilevazione e
misurazione; esempi specifici. Classi di piccole molecole di RNA non codificanti che possono essere
impiegati in biotecnologia per inibire o modificare l’espressione di geni endogeni: siRNA, antisenso,
oligonucleotidi che inibiscono la traduzione, oligonucleotidi che modificano lo splicing ecc.
CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI (CHIM11) 2 CFU
Prof.ssa R. Menghini
Sviluppo di processi di fermentazione industriale. Produzione di enzimi. Produzione di acidi organici.
Produzione di amminoacidi. Produzione di vitamine. Produzione di antibiotici. Produzione di probiotici.
Produzione di farmaci biotecnologici.
PROTEOMICA (BIO12) 2 CFU
Prof. A. Urbani
Tecniche di separazione in alta risoluzione di proteine da miscele complesse. Spettrometria di Massa,
principi di base. Spettrometria di Massa MALDI-TOF-MS , MALDI-TOF/TOF-MS/MS e decadimenti postsorgente di proteine e peptidi. Spettrometria di Massa LC-MS ed MS/MS di proteine e peptidi, analizzatori
ibridi Q-TOF, triplo quadrupolo e trappole ioniche. Interpretazione dei dati di MS e MS/MS per sequenze
proteiche. Interpretazione dei dati di MS e MS/MS su banche dati di proteine e geni. Sviluppo e disegno di
esperimenti con codifica isotopica stabile (SILAC, ICAT, TMT, ITRAQ, etc). Modelli uni- e multivariati di
classificazione clinica basati su dati di proteomica. Proteoma del plasma ed urinario relazioni con
funzionalità renale. Proteoma liquorale ed indagini di neuroscienze cliniche. Proteomica di sistemi modello
in-vitro ed ex-vivo. Correlazione ragionata vie metaboliche ed espressione proteica, ontologie
geniche/proteiche.
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
PATOLOGIA GENERALE E GENETICA MEDICA
(MED03+MED04)
11 CFU
PROGRAMMA
PATOLOGIA GENERALE (MED04) 3,5 CFU
Prof. R. Bei
Basi molecolari del danno cellulare: Stress cellulare, necrosi, apoptosi, degenerazioni intracellulari.
Tesaurismosi. Lesione elementare, aspetti ultrastrutturali: alterazioni degli organuli subcellulari e della
membrana cellulare. Adattamenti cellulari. Microambiente. Patologia molecolare dei componenti della
matrice extracellulare. Alterazioni qualitative e quantitative della matrice extracellulare. Infiammazione.
Oncologia: basi molecolari della trasformazione cellulare. Microambiente tumorale. Biotecnologie applicate
alla medicina: Vaccini antitumorali. Classificazione antigeni tumore associati. Strategie di vaccinazione
antitumorale: vantaggi e svantaggi dei vari sistemi. Modalità di produzione di proteine ricombinanti. Vaccini
antitumorali virali. Vaccini antitumorali a DNA. Vaccini antitumorali basati sull’utilizzo di peptidi, esosomi.
Adiuvanti.
IMMUNOLOGIA (MED04) 3,5 CFU
Prof. M. Mattei e Dr. M. Amicosante
Il sistema immunitario: concetti di base, organi linfoidi primari e secondari, immunità innata, immunità
adattativa, riconoscimento di motivi strutturali, risposta agli agenti infettivi, il complemento. Riconoscimento
dell’antigene da parte dei linfociti B: gli anticorpi, caratteristiche dell’antigene per i linfociti B, interazione
antigene anticorpo, sistemi di identificazione degli epitopi B, sistemi di predizione degli epitopi B.
Riconoscimento dell’antigene da parte dei linfociti T: la processazione e presentazione dell’antigene ai
linfociti T, cellule presentanti l’antigene, genomica struttura e funzione delle molecole MHC di classe I e II,
sistemi di identificazione degli epitopi T, sistemi di predizione degli epitopi T. Modelli animali in
immunologia: classi di modelli, animali inbred outbred, ciclo di infezione nelle malattie infettive
(leishmaniosi). Fisiopatologia del Sistema Immunitario: l’immunodeficienza naturale e acquisita, allergia ed
ipersensibilità, autoimmunità e rigetto dei trapianti. Discussione di una selezione di articoli originali dalla
letteratura sui principali argomenti trattati.
GENETICA MEDICA
(MED03) 4 CFU
Proff G. Novelli e E. Giardina
Le basi molecolari dell’ereditarietà umana (basi, esoni, introni, geni, cromosomi). Cariotipo e nomenclatura.
Indicazioni per l’analisi del cariotipo. Anomalie cromosomiche segreganti e ad insorgenza de novo.
Definizione e classificazione delle anomalie cromosomiche numeriche. Esempi clinici. Definizione e
classificazione delle anomalie cromosomiche strutturali. Esempi clinici. Esempi clinici delle anomalie dei
cromosomi sessuali. Frequenza delle anomalie cromosomiche. Principi di diagnosi prenatale. Indicazioni alla
diagnosi prenatale. Diagnosi prenatale invasiva (amniocentesi, villocentesi, cordocentesi) . Diagnosi
Prenatale Non Invasiva (NIPT) (ultrasound, double test, triple test, NGS). Statistica e gestione dei casi. La
consulenza pre test. Eredità Mendeliana: autosomica recessiva, autosomica dominante, X-linked. Eredità
Mendeliana Atipica: eredità mitocondriale, mutazioni dinamiche, imprinting genomico, mutazioni
somatiche. Penetranza ed Espressività. Il concetto di anticipazione. Mosaicismo Germinale. Definizione e
Classificazione dei test genetici. La consulenza genetica. Le patologie ed i fenotipi complessi. Suscettibilità
genetica. Principi di Medicina Personalizzata e Genomica. Lo studio funzionale del genoma: i progetti
ENCODE and ROADMAP Epigenomics. Lo studio dell’interazione Geni e Ambiente: esempi
Farmacogenomica. Biomarcatori Genomici: definizione, studio ed applicazioni. Storia Familiare e
determinazione dei rischi individuali di malattia. Elementi di Genetica Forense.
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA MOLECOLARE
(MED07)
7 CFU
PROGRAMMA
VIROLOGIA MOLECOLARE
(MED07) 4 CFU
Prof. C.F. PERNO
Caratteristiche generali dei virus: natura, origine, morfologia, struttura, proprietà fisico-chimiche,
inattivazione. Classificazione dei virus: virus a DNA e a RNA. Fasi della replicazione virale: adsorbimento
(recettori, corecettori e ligandi), fusione, penetrazione, uncoating, replicazione del genoma (strategie di
espressione dei genomi virali a DNA e a RNA), assemblaggio, maturazione e rilascio. Genetica virale:
mutazioni, ricombinazione (riassortimento genomico, shift antigenico), complementazione, vantaggio
selettivo. Interazioni con l’ospite: tropismo cellulare, spettro d’ospite, stato di persistenza e di latenza,
risposta immune all’infezione virale, interferoni. Aspetti molecolari della patogenicità dei virus: virus
oncogeni e meccanismi di oncogenesi, apoptosi, alterazione di espressione di geni e/o proteine cellulari.
Metodi di studio e diagnostica in virologia: colture cellulari, isolamento, microscopia elettronica, titolazione
dei virus, indagini sierologiche, ricerca diretta degli antigeni virali, ricerca degli acidi nucleici virali (PCR,
RT-PCR, NASBA, Branched-DNA, Southern blot, Northern blot, ibridazione molecolare, Microarray),
tipizzazione genotipica dei virus, test di resistenza ai farmaci antivirali. Principali classi di virus di interesse
medico: Adenovirus, Herpesvirus, Poxvirus, Papovavirus, Parvovirus, Virus delle epatiti, Picornavirus,
Ortomixovirus, Paramixovirus, Rhabdovirus, Retrovirus, Reovirus, Togavirus, Flavivirus, Coronavirus,
Bunyavirus, Arenavirus, Calicivirus, Filovirus. Agenti infettivi non convenzionali: Prioni. Vaccini e farmaci
antivirali. Virus come vettori genetici. Strategie antivirali convenzionali e innovative (antisenso, ribozimi).
MICROBIOLOGIA
(MED07) 3 CFU
Proff. C. Favalli e C. D’Agostini
Struttura e funzione dei microorganismi. Struttura, morfologia e funzione batterica. Cenni sulla struttura e
funzione di miceti e protozoi. Metabolismo e crescita batterica. Colorazioni batteriche e test di Gram.
Farmaci antimicrobici. Classificazione e meccanismo d'azione dei principali antibatterici. Antibiogramma.
Genetica dei batteri. Principi di genetica batterica. Trasferimento intercellulare di informazione. I plasmidi.
Patogenicità batterica. Colonizzazione: flora microbica residente e microrganismi patogeni. Endotossina ed
esotossine. Interazioni ospite-parassita. Risposta immune. Disinfezione e sterilizzazione. Diagnosi di
laboratorio delle malattie infettive. Principi di diagnosi microbiologica, principali terreni di coltura. Diagnosi
delle infezioni batteriche. Diagnosi molecolare . Diagnosi sierologica. Le principali infezioni. Infezioni
respiratorie. Infezioni ospedaliere e sepsi. Infezioni genito-urinarie. Infezioni gastroenteriche. Infezioni del
SNC. Infezioni in gravidanza. MST. Epatiti
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
ANATOMIA PATOLOGICA E PATOLOGIA
(MED08)
MOLECOLARE
6 CFU
PROGRAMMA
ANATOMIA PATOLOGICA
(MED08) 5 CFU
Prof.ssa E. Bonanno
Principi di microscopia ottica ed elettronica (microscopi, allestimento dei preparati, colorazioni di base,
istochimica, immunoistochimica, ibridazione in situ). Infiammazione. Granulomi. Classificazione delle
neoplasie. Principi di diagnostica citopatologia. Patologia infettiva dei polmoni (polmoniti batteriche, virali).
Patologia ed immunologia della tubercolosi. Neoplasie polmonari. Patologia dell’apparato genitale
femminile: infezioni da HPV e carcinoma della cervice uterina. Patologia dell’apparato urogenitale:
patologia del glomerulo, neoplasie renali, neoplasie della vescica. Patologia dell’apparato digerente:
neoplasie dell’esofago, dello stomaco del grosso intestino. Patologie della mammella: fibroadenoma,
carcinomi in situ duttale e lobulare, carcinomi infiltranti duttale e lobulare. Patologia dei versamenti pleurici
ed ascitici. Patologia della tiroide. Valutazione dei marcatori prognostici e predittivi delle neoplasie della
mammella (stato dei recettori ormonali e di HER2) e del colon (EGFR e K-ras). Marcatori epigenetici delle
neoplasie. Valutazione della risposta alla terapia nella patologia oncologica. Modelli sperimentali in vivo di
patologia oncologica: esame macroscopico e microscopico dell’animale da esperimento. Aspetti
immunologici del trapianto d'organo o di tessuto. Meccanismi coinvolti nella tolleranza immunologia.
Problematiche comuni e specifiche dei vari tipi di trapianto d'organo. Aspetti molecolari del trapianto
d'organo o di tessuto. Rigetto acuto e vasculopatia cronica da trapianto. Complicanze del trapianto e cause di
perdita dell'organo. Il trapianto di tessuto. Aspetti clinici del trapianto di rene. Aspetti clinici del trapianto di
cute. Marcatori molecolari per la diagnostica del rigetto e della GvHD.
PATOLOGIA MOLECOLARE (MED08) 5 CFU
Prof.ssa S. Pucci
Lesioni elementari e meccanismi molecolari fisiologici e patologici. Patologia molecolare delle infezioni
diagnosi molecolare. Immunità innata e acquisita, alterazioni di funzioni proteiche e condizionamento micro
ambientale. Patologia molecolare delle infezioni da HPV. Meccanismi molecolari, diagnosi e terapie. Cancro
come malattia genetica. Meccanismi molecolari di trasformazione . Terapie personalizzate. Trafficking
cellulare ed alterazione geniche nei tumori. Piccole molecole nella diagnosi differenziale come target
terapeutici. Patologia molecolare del cancro della mammella sporadico ed ereditario. Antigeni tumore
specifici , tumori associati. Nuovi fattori prognostici molecolari. Patologia molecolare del cancro del colon,
sporadico ed ereditario. Terapie biologiche e successo terapeutico. Nuovi marcatori molecolari e
silenziamento della risposta immunitaria nelle patologie: diagnosi e prognosi. Nuove strategie terapeutiche
e diagnostica personalizzata.
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
FARMACOLOGIA APPLICATA ALLE BIOTECNOLOGIE
(BIO14)
8 CFU
PROGRAMMA
FARMACOLOGIA (BIO14) 6 CFU
Proff. B. Macchi e C. Muscoli
Le basi della Farmacologia
Farmacocinetica: Assorbimento e distribuzione, eliminazione, metabolismo.
Farmacodinamica: Meccanismo di azione dei farmaci: caratteristiche e proprietà dei recettori, interazione
farmaco-recettore, aspetti quantitativi delle risposte ai farmaci, interazioni tra farmaci.
Caratteristiche e sviluppo di un farmaco: Origine dei farmaci, scoperta e sviluppo di nuovi farmaci,
progettazione di un farmaco, ruolo della “System Biology” e della System Pharmacology” nella
progettazione di futuri potenziali farmaci, inibitori del codice genetico, strumenti per valutare l’ attività dei
farmaci.
Interazioni tra farmaci. Definizioni inerenti alla risposta ai farmaci in vivo.
Ruolo delle Biotecnologie nella Farmacologia: Approccio biotecnologico all’ allestimento dei farmaci,
sviluppo dei farmaci biotecnologici, uso delle proteine in terapia e terapia genica, farmaco genetica, farmaco
genomica, importanza delle biotecnologie nella terapia.
Principi di Neurofarmacologia: Principi di Farmacologia del sistema nervoso autonomo: farmacologia del
sistema colinergico, farmacologia del sistema adrenergico, farmacologia del sistema nervoso centrale,
farmacologia della neurotrasmissione eccitatoria e inibitoria, farmacologia dell’ analgesia.
principi di chemioterapia: Chemioterapia antimicrobica:farmaci antibatterici, farmaci antifungini, farmaci
Antivirali, chemioterapia antineoplastica: farmaci alchilanti, antimetaboliti, inibitori delle Topoisomerasi,
inibitori del fuso mitotico, farmaci inibitori della traduzione del segnale, anticorpi citotossici, cenni di
farmaco resistenza.
Farmacologia dell’ Infiammazione e della risposta immune: farmaci
Immunosoppressori,farmaci
Immunostimolanti, cascata dell’ acido arachidonico e azione dei farmaci antinfiammatori.
Principi di Tossicologia: principi di Tossicologia generale, esposizione a sostanze tossiche, meccanismi di
tossicità, valutazione del danno tossicologico.
ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P02) 1 CFU
Prof.ssa A.M. CIARRAPICO
Caratteristiche e funzionamento dell’attuale Sistema Sanitario. Costi e ricavi in Sanità. Valutazione
economica: metodi e case studies.
BIOETICA (IUS20) 1 CFU
Prof.ssa M.T. Iannone
Bioetica generale: la struttura dell’atto morale, i fondamenti della bioetica, modelli bioetici di riferimento.
Bioetica clinica: comitati etici e consulenza etica, inizio e fine vita,biotecnologie.
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
IGIENE E BIOSTATISTICA LEGISLAZIONE (MED01+MED42)
6 CFU
PROGRAMMA
STATISTICA MEDICA (MED01) 2 CFU
Prof.ssa C. Rossi
Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità. Le distribuzioni di probabilità. La funzione di ripartizione di
una variabile aleatoria. Descrizione sintetica delle distribuzioni di probabilità. I modelli statistici: studio di
alcune distribuzioni di probabilità. Un modello per variabili dicotomiche: la distribuzione binomiale. Un
modello per variabili conteggio: la distribuzione di Poisson. Un modello per gli “errori accidentali”: la
distribuzione gaussiana. Statistica inferenziale. Di che cosa si occupa la statistica inferenziale. Distribuzioni
campionarie. Come affrontare semplici problemi di stima parametrica, stima puntuale e di intervallo: media e
proporzione. Come impostare una verifica di ipotesi per modelli parametrici semplici per un campione.
Tabelle di contingenza. Applicazioni.
IGIENE (MED42) 2 CFU
Prof.ssa M. Cauletti
Igiene e medicina preventiva. Promozione della salute e prevenzione delle malattie. Individuazione dei
fattori genetici di malattia. Educazione sanitaria. Definizione ed evoluzione storica. Educazione sanitaria
nella legislazione italiana. Aspetti organizzativi ed ambiti di intervento. Epidemiologia generale delle
malattie infettive. Profilassi generale delle malattie infettive. Vaccini tradizionali. Vaccini derivanti
all’ingegneria genetica. Vaccinazioni: indicazioni, controindicazioni e precauzioni. Epidemiologia generale
delle malattie cronico-degenerative. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori sanitari.
Prevenzione del rischio biologico. Disinfezione e sterilizzazione.
LEGISLAZIONE E BREVETTI (IUS04) 2 CFU
Prof.ssa F. Massa
Il corso è strutturato in una prima parte di carattere fondamentale e concentrata sulla trattazione delle regole
basilari del diritto brevettuale, sia con riferimento all’ordinamento nazionale che a quello europeo e
statunitense; ed in una seconda parte dedicata ai profili della proprietà industriale collegati allo sviluppo ed
alla sperimentazione clinica dei farmaci, siano essi di natura biotecnologica o meno. Una particolare
attenzione è riservata, inoltre, alle regole contrattuali che disciplinano i contratti di ricerca nel settore
biotecnologico
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche AA 2013/2014
APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE IN MEDICINA
(MED05+MED09+MED12+MED15+MED26+MED36)
14 CFU
PROGRAMMA
MEDICINA INTERNA (MED09) 4 CFU
Prof. M. Federici
Osteoporosi. Obesità: aspetti molecolari e clinici. Diabete mellito: aspetti molecolari e clinici. Ipertensione
arteriosa. Aterosclerosi: aspetti molecolari e clinici. Insufficienza renale. Modelli sperimentali di malattie
metaboliche.
GASTROENTEROLOGIA (MED12) 2 CFU
Prof. G. Monteleone
Gli obiettivi principali del corso di gastroenterologia sono quelli di fornire gli elementi essenziali e cruciali
della patogenesi delle malattie infiammatorie e neoplastiche del tubo digerente (esofago, stomaco ed
intestino), del fegato e del pancreas. Una particolare attenzione sarà riservata allo studio di malattie croniche
gastrointestinali, quali la malattia celiaca, la malattia di Crohn e la rettocolite idiopatica, per le quali lo
sviluppo di nuove biotecnologie potrebbe essere determinante nella diagnosi, monitoraggio e prevenzione
delle complicanze. Il corso verrà integrato con lezioni finalizzate ad illustrare le tappe essenziali per lo
sviluppo di nuovi farmaci, biologici e non, da utilizzare in pazienti con malattie immuno-mediate e tumorali.
Durante il corso, gli studenti saranno coinvolti attivamente sia nella presentazione che nella discussione di
specifici argomenti, al fine di verificare il loro livello di apprendimento e l’ eventuale interesse per la
biotecnologia applicata alla gastroenterologia.
EMATOLOGIA (MED15) 2 CFU
Prof. F. Lo Coco
Introduzione alla diagnostica oncoematologica. Le principali malattie oncoematologiche. La citogenetica
convenzionale e molecolare. Tecniche di citofluorimetria. Biologia molecolare in oncoematologia. La
genomica di nuova generazione. Cellule staminali: caratteristiche ed impiego in ematologia.
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (MED36) 2 CFU
Prof. A. Orlacchio
Le radiazioni elettromagnetiche. I raggi X (cenni storici, produzione, caratteristiche e proprietà). Radiazioni
ionizzanti. Interazione tra radiazioni e materia e produzioni delle immagini. Immagini analogiche e digitali
(formazione, riproduzione ed archiviazione). Onde ultrasonore. Produzione, acquisizione e registrazione del
segnale ultrasonoro. Effetto Doppler. Principali quadri di semeiotica US normale e patologica. Tomografia
Computerizzata: principi di funzionamento; produzione e registrazione delle immagini; principali aspetti
semeiotici normali e patologici in TC. Tomografia a Risonanza Magnetica: principi di base; formazione delle
immagini; principali aspetti semeiotici normali e patologici in RM. Principi di Medicina Nucleare:
caratteristiche dei radioisotopi; meccanismi di produzione ed integrazione delle immagini di MN. Mezzi di
contrasto naturali ed artificiali. Integrazione delle informazioni mediante Diagnostica per Immagini.
NEUROLOGIA E NEUROSCIENZE (MED26) 2 CFU
Prof. A. Stefani
Basi di neuroanatomia funzionale; correlazione del deficit neurologico con aree e regioni del sistema
nervoso centrale e periferico. I circuiti e le reti neurali. Malattia di PARKINSON e parkinsonismi
sperimentali; contributo della diagnostica biochimica alla stadiazione di malattia. Demenze; il ruolo dei
biomarcatori.Sclerosi Multipla e “immunopatie” neurologiche. Patologie acute: Epilessia, emicrania,
canalopatie. Malattie del motoneurone e della placca neuromuscolare. Farmaci e neuro protezione; una
chimera. Neuroscienze Sperimentali ed etica.
IMMUNOEMATOLOGIA (MED05) 2 CFU
Prof. F. Zinno
Emopoiesi. La cellula staminale. Biologia della cellula staminale. Caratteristiche immunologiche della
cellula staminale. Fonti di cellule staminali. Il midollo osseo. La selezione del donatore di midollo osseo.
Prelievo del midollo osseo. Il sangue periferico. La selezione del donatore di cellule staminali circolanti. Uso
dei fattori di crescita emopoietici. Raccolta delle cellule staminali circolanti. Il sangue placentare. Le banche
del cordone ombelicale. Criteri di selezione delle donatrici. Prelievo del sangue placentare. Il trapianto di
cellule staminali. Indicazioni al trapianto di cellule staminali. Il trapianto autologo. Il trapianto allogenico. Il
trapianto singenico. La manipolazione cellulare. Criopreservazione. Tecniche di congelamento.
Manipolazione estensiva. Selezione immunomagnetica. Espansione in vitro. Ingegneria dei tessuti (cenni)
Recenti applicazioni nell’utilizzo delle cellule staminali.