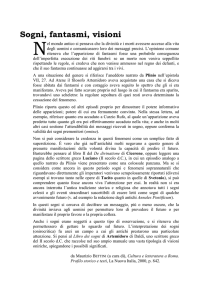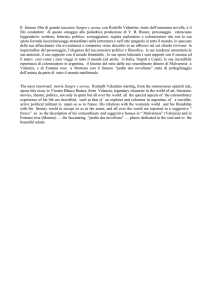I fantasmi dell’antropologia*
di Michele Parodi**
L’identità si costruisce, come noto, su un rapporto dialettico tra interno ed esterno, si
costruisce su una differenza, nello spazio instabile tra noi e gli altri, sui margini
mutevoli di una frontiera (U. Fabietti, L’identità etnica). È su questo confine che
nascono e proliferano una molteplicità di fenomeni complessi e variabili: storie di
sincretismo culturale, di metamorfosi identitaria, di scambio economico, insieme a
forme di segregazione, sfruttamento, manipolazione, ribellione ed espulsione. Tali
fenomeni rivelano presenze paradossali in cui convivono strategie eterogenee.
Manifestazioni ambigue in cui ciò che appare è il sintomo di un discorso traslato:
terreno scivoloso fatto di apparenze, desideri, proiezioni, fantasmi. Scena immaginaria
allo stesso tempo molto concreta, in cui il soggetto – sia egli l’antropologo e il
colonizzatore, ma anche il nativo e il colonizzato o lo straniero, figure paradigmatiche
che qui cercheremo di esplorare – è presente come protagonista e come osservatore.
La ricerca antropologica si è dedicata allo studio dell’alterità. Non poteva che cadere
nei tranelli che si nascondono nelle trame vischiose di un’attività costantemente esposta
al rischio della frontiera. L’altro, catturato nelle reti di attribuzioni dell’etnografo, si è
spesso dissolto in rappresentazioni caricaturali, svelando i dispositivi di un dominio
nascosto dietro “una relazione tra uomini che si pretendeva «osservazione»” (R.
Beneduce, Trance e possessione in Africa). Dalla convivenza con i “limiti” delle
identità, e da una difficile autocritica è nata una configurazione indeterminata della
pratica antropologica, nella quale l’invisibile (una metodologia senza metodo) tenta di
parlare con l’invisibile (i fantasmi che si nascondono dietro le nostre certezze, i
pregiudizi dell’antropologo e dei suoi interlocutori).
Nel tentativo di scoprire la complessità e l’intreccio di queste figure spettrali, il nostro
discorso si dipanerà dalle prime esibizioni dell’altro, iniziazioni all’alterità spesso già
cariche di conseguenze e presagi, dove il “contatto” con l’altro avviene a distanza.
Iniziazioni, dove un insieme sconnesso di aneddoti e frammenti del mondo reale, cose
non viste di persona, ma sentite per una lunga trafila di intermediari, fornisce la base di
un discorso privo di un referente più concreto. È su questi piani, su queste mediazioni
che si creano invenzioni narrative che immaginando il passato e il futuro progettano
nuove identità private e collettive.
Attività mimetiche dove l’incontro e l’intimità con l’altro, in quanto unilaterale,
produce strane proliferazioni: scene ricomposte a piacimento, feticci in potere dei propri
artefici. Si imita l’altro rappresentandolo o appropriandosi delle sue rappresentazioni.
Contatti a distanza
Nelle trasmissioni televisive globalizzate che raggiungono le località più remote, così
come nelle rappresentazioni europee, molto più antiche, dei “selvaggi” delle americhe,
prendono vita creature non pienamente visibili, oggetti d’“amore” malleabili
perpetuamente disponibili nella forma mediata o immaginaria, fantasmi di luoghi
lontani che spettatori e utenti diversi usano nei contesti specifici della loro ricezione.
*
Testo pubblicato in OT / Orbis Tertius, n. 1, a cura di Matteo Bonazzi e Francesco Cappa, Ed.
Mimesis.
**
Università degli Studi di Milano Bicocca.
1
Scene immaginarie intimamente collegate al desiderio e al contempo alla sua
negazione (il divieto), luogo di processi difensivi per lo più primitivi, come la
proiezione e l’identificazione e la conversione nell’opposto. Ciò nondimeno, tattiche,
strategie, risorse pragmatiche con cui affrontare la realtà di conflitti concreti e
quotidiani. Il luogo dell’altro assente si configura come spazio polemico propizio dove
sviluppare offensive indirette a bersagli vicini, proiettando sull’altro lontano un
contenuto che, al contrario, si intende trasmettere nel luogo più prossimo della propria
esperienza.
In questo campo retorico e sintomatico, l’altro diviene il campione innocente di una
contesa locale – più “oggettivo” in quanto neutrale. Così, le visioni mediatiche
dell’occidente contemporaneo, nell’immaginazione migratoria di molti giovani che
abitano le zone periferiche del sistema e dei flussi globali, funzionano come risorse
simboliche con cui criticare l’egemonia tradizionale delle istituzioni locali1. Astuzie
opportuniste non molto diverse da quelle della borghesia intellettuale nella Francia del
XVIII secolo, dove l’invenzione del buon selvaggio era una risorsa politica importante
nella disputa di potere con l’aristocrazia nobiliare ed ecclesiastica. Esempi che illustrano
principi strutturali che sopravvivono, al di là delle epoche e dei luoghi, nelle pratiche
discorsive dei protagonisti di conflitti asimmetrici, prendendo forme a noi consuete o
esotiche.
I riti di possessione e i rituali divinatori presentano una logica simile: lo spirito è
invocato per enunciare ciò che altrimenti non si potrebbe rivelare. L’individuo
posseduto parla con la voce di un altro: “fantasmi”, voci di un diverso sistema di
riferimento. Il messaggio a volte può essere criptato in modo che anche il destinatario
sia esentato da una assunzione senza mediazioni del suo senso. Si tratta di strategie
comunicative che allo stesso tempo configurano un culto religioso, un rituale
terapeutico, un discorso politico e una pratica di resistenza culturale (Beneduce, op.
cit.). Le medicine magico religiose e lo sciamanismo trasformano la malattia (sociale,
psicologica e incorporata), in quanto assenza di comunicazione, in struttura di
comunicazione guidata dal linguaggio degli dei.
Anche i culti del “cargo” della Melanesia forniscono un esempio di questa dialettica.
Le navi mercantili che agli inizi del XX secolo arrivavano cariche di merci nei porti
delle isole dell’arcipelago, provenivano da regioni sconosciute ai melanesiani. Ai loro
occhi i coloni europei che abitavano le isole si impossessavano magicamente di questi
beni scambiandoli con denaro. Secondo Worsley (La tromba suonerà, 1957), il
processo con cui avevano origine i culti del cargo presentava delle fasi tipiche. In un
primo tempo gli europei erano trattati come spiriti propizi che apportavano doni,
antenati mitici tornati a vivere con il loro popolo. Gli indigeni ben presto si accorgevano
che per accedere a questi doni, al contrario dei bianchi, erano costretti a compiere un
lavoro reale e gravoso. Per ottenere gli oggetti senza fatica gli indigeni tentavano allora
di scoprire il sapere segreto dei bianchi. Il depositario di questo sapere sembrava essere
la religione cristiana, perciò gli indigeni si convertivano nelle missioni. Dopo qualche
anno sorgeva il malcontento e la disillusione poiché la “fede” non procurava alcuna
ricompensa materiale. Infine i nuovi proseliti si allontanavano dalle missioni creando i
propri culti millenaristi sulla base di un insieme sincretico di dogmi cristiani e indigeni.
Un profeta annunciava il rovesciamento completo dell’ordine sociale: arriveranno dei
liberatori portando con sé dei beni materiali fortemente desiderati dalla popolazione. Per
prepararsi al grande giorno i seguaci del culto si organizzavano creando nuove insegne,
nuovi vestiti, nuovi codici morali o legali. Fabbricando aree di atterraggio, ricoveri e
1
Per una analisi del contesto africano vedi ad esempio Deborah Durham, Youth and the social
imagination in Africa, “Anthropological Quarterly”, 73(3), 2000.
2
magazzini per accogliere le merci. Immagini, copie della potenza occidentale. Simulacri
con cui accogliere i fantasmi della grande nave guidata dagli spiriti dei morti ancestrali2.
Se in Voltaire e Rousseau l’idealizzazione del selvaggio rappresenta un’evasione e
una soluzione posta sul terreno politico-sociale inerente al mondo occidentale, i culti del
cargo ugualmente risolvono un problema politico indigeno usando i magici messaggeri
della civiltà occidentale per immaginare una rigenerazione del mondo. Tentativo di
modificare l’enigmatico ordine sociale introdotto dai bianchi organizzando forme di
resistenza apparentemente regressive e fittizie, ma al contrario capaci alle volte di
generare movimenti politici in grado di fare e rifare la storia nazionale di questi
arcipelaghi.
Ma l’europeo nel contesto coloniale, come vedremo più avanti, rivela una
configurazione più oscura, presente e assente al medesimo tempo, minaccia prossima e
quotidiana la cui potenza si iscrive in territori lontani e misteriosi.
Faith47, Africa del Sud 2002
Proiezioni
Se l’altro assente è buono da pensare per fronteggiare una contesa interna, allo stesso
tempo, performativamente, questa mossa polemica fa ricadere su di esso la
responsabilità dell’affermazione. Tecnica millenaria di lanciare il sasso e nascondere la
mano. Strategia che assegnando la “colpa” a colui che non può replicare contiene
implicitamente altre inversioni. L’altro assente, vittima eternamente disponibile,
fantasma infinitamente trapassabile, diviene oggetto di una pratica persecutoria che
prefigura e prepara la possibilità compiuta di un incontro e di una conquista.
Lo stesso linguaggio che aveva raffigurato la grazia incontaminata dell’indigeno del
Brasile o delle Antille può diventare allora tagliente come una ghigliottina. Non a caso,
è un altro francese, Montesquieu, tra i protagonisti dell’“esecuzione sommaria” del
“nero” dell’Africa. Nello Spirito delle leggi, afferma senza esitazioni: “È impensabile
per noi supporre che essi siano uomini, perché, se li supponessimo tali, si potrebbe
cominciare a credere che noi stessi non siamo cristiani” (De l’esprit des lois, 1748). La
bocca che bacia il selvaggio delle americhe è qui la stessa che nega l’umanità del
“negro”, tramutandolo in una figura deforme capace delle peggiori atrocità. Il fantasma
delle barbarie che si è sul punto di rendere possibili è proiettato sulle future vittime.
2
Le culture melanesiane associano la morte ad un viaggio al di la del mare. I culti del cargo
profetizzano il ritorno delle anime dei morti da oltre l’orizzonte sulla grande nave.
3
Profezia che parla dei suoi autori (gli ideologi europei), più che dei soggetti a cui
attribuisce una violenza selvaggia. In questa operazione si realizza un doppio
disconoscimento: dell’altro, sottomesso e occultato dal meccanismo proiettivo, e del
proprio sé, che nelle rappresentazioni dell’altro non sa riconoscersi. Il dubbio ancora
vago, circa l’origine di queste immagini, affiora però proprio nelle ambivalenze dei testi
degli utopisti-romanzieri francesi, o nei generi intimamente ibridi dei romanzi di Aphra
Behn e di Daniel Defoe, dove realtà e finzione, attendibilità e sensazionalismo
convivono, come in Robinson Crusoe, nelle strane forme di memorie ispirate a fatti
realmente accaduti ma raccontate da falsi testimoni. Dubbi, inquietudini che
domanderanno ai colonizzatori, dopo l’assoggettamento delle popolazioni indigene,
continue prove della imparzialità e giustizia delle proprie illusioni. È lo specchio
coloniale, di cui parla Michael Taussig (M. Taussig, Cultura del terrore – spazio di
morte), che riflette sui colonizzatori la propria immagine. Ciò che l'ideologia coloniale
attribuisce all'altro è il riflesso degli atti che essa consente e genera. Proiezioni di un
rimosso fatale che scavalcando astutamente i meccanismi difensivi che regolano
l’inconscio politico occidentale, incarnandosi in un oggetto (il selvaggio), può, imitando
la sua creazione (le barbarie del selvaggio), realizzarsi integralmente.
Strane corrispondenze legano la violenza dei colonizzatori a quella dei sovrani locali
in Africa equatoriale. L’efferatezza di entrambi sembra erompere dalla paura, da
fraintendimenti preoccupati carichi di nervosismo e da un potere assoluto che
freneticamente cerca di nascondere la propria origine e la propria inefficacia. Nel 1897,
fu massacrata una missione di spionaggio ordinata dal Console britannico del “Niger
Coast Protectorate” James R. Phillips allo scopo di sondare le forze militari del re del
Benin. Una spedizione punitiva fu rapidamente inviata con l’obiettivo di saccheggiare e
radere al suolo la capitale del regno. Entrando nella città le truppe coloniali si trovarono
di fronte ad uno spettacolo raccapricciante: un grande numero di corpi di schiavi e
prigionieri sacrificati. Estremo tentativo organizzato dalla corte dell’Oba e dai suoi
sacerdoti di proteggersi dalla potenza incontrollabile e minacciosa delle forze coloniali.
Tale spettacolo divenne il soggetto di molti reportage nei giornali dell’epoca e “Great
Benin” fu proclamata “the City of Blood”. Dieci anni più tardi la pubblicazione delle
foto della città assicurarono che le memorie di tale evento rimanessero vive molto a
lungo nei ricordi dei lettori inglesi, giustificando altre azioni punitive e altre atrocità.
Nel 1909 Sir Ralph Moor, uno dei principali sostenitori dell’intervento armato contro
l’Oba del Benin, negli anni del saccheggio “Commander of the Niger Coast Protectorate
Force” e successivamente “High Commissioner for Southern Nigeria”, si suicidò all’età
di 49 anni nella sua casa di Londra.3
Incontri asimmetrici
È la figura dello straniero che meglio rappresenta l’ambiguità dell’incontro. Secondo
Simmel (Soziologie, 1908) lo straniero è colui che a differenza del viandante “oggi
viene e domani resta”. Colui che entra in contatto sociale permanente (o perlomeno di
lunga durata) con un gruppo a cui non appartiene dall’inizio e in cui introduce
caratteristiche che gli sono estranee. Lo straniero è vicino e lontano: incluso
spazialmente nei confini da cui non può essere escluso gratuitamente, al medesimo
tempo, in quanto isolato in una posizione marginale, è estromesso dalle posizioni
tradizionali più importanti. Lo straniero come il povero, come tutta una varietà di
«nemici interni», è un elemento del gruppo, ma la posizione che assume come suo
3
Per una analisi critica di questo episodio vedi Home R., City of Blood Revisited. A New Look at the
Benin Expedition of 1897, Rex Collings, Londra, 1982.
4
membro effettivo coinvolge una sospetta relazione esterna/frontale (id.). Lo straniero
occupa a volte i luoghi del comando, come giudice super partes, perfino come sovrano,
ma sempre in una condizione di subordinazione, dove l’autorità che gli è assegnata può
essere ad ogni momento revocata. Molti racconti, a metà strada tra mitologia e storia,
narrano in Africa sub-sahariana simili eventi: l’intronazione di uno straniero e la sua
successiva uccisione. L’assemblea degli anziani, dei sacerdoti, la società stessa (P.
Clastres), nelle cerimonie di successione, metterà a morte il re “outsider”. Il capo
“prigioniero del gruppo”, ancora in vita e nell’esercizio delle proprie funzioni, sarà
sacrificato ritualmente (di principio), affermando la supremazia del potere sull’evento e
sull’individuo (sulla malattia, sulla morte, sulla sconfitta, sul semplice decadere delle
forze del re). Allo stesso tempo è la violenza del sovrano dispotico ad essere espulsa in
queste pratiche rituali, assegnando implicitamente al fuori – al divino (al re sacro), o
all’esterno spaziale (al re alieno) – il male necessario incarnato dal tiranno (M. Augé,
Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort).
Lo straniero vive così una situazione precaria in cui la sua valorizzazione come
mediatore dell’interno con l’esterno nasconde la possibilità latente dell’inversione di
questa relazione: lo straniero, come l’odierno immigrato, è integrato nel sociale in modo
che dall’interno sia possibile la sua espulsione come vittima. Capro espiatorio allevato
in seno ad una comunità, lo straniero, in questo senso, è un morto vivente, figura
liminare anch’essa spettrale. Germe che deve essere immesso nella società per attivare
le sue difese latenti e saldare la coesione del gruppo secondo una pratica omeopatica di
protezione. Lo straniero immunizza il corpo sociale contro i pericoli di una
destrutturazione interna e i rischi di una aggressione dall’esterno. Come le immagini
esotiche del buon selvaggio, lo straniero diviene qui mediatore non dell’interno con
l’esterno, ma dell’interno con l’interno medesimo.4
Ciò che qui diventa spettrale però non è più una mera rappresentazione – di per sé,
nella plasticità dei significati, sempre sfuggente – ma un corpo e un soggetto vivo,
incluso in un mondo di rapporti concreti, che così perde una parte della sua sostanza.
Ciclicamente avviene la mattanza: piccoli o grandi genocidi, espulsioni in massa,
criminalizzazione generalizzata del diverso. Poi lentamente il “di fuori” e l’insolito
vengono reintrodotti a basse dosi nel gruppo.
Tali fenomeni si realizzano a partire da una fondamentale asimmetria di potere.
Beneduce, riferendosi al complesso insieme di attese e reciproci malintesi che si
generano nei rapporti con l’alterità, parla di “coercizione mimetica” (Beneduce, op.
cit.). È del resto una radicale sproporzione di forze che permette altre manifestazioni
patologiche. Decisiva non è solo la posizione eccentrica dello straniero, ma la sua forza
o la sua debolezza economica e militare, e l’adeguatezza del suo capitale culturale nel
contesto del suo approdo. Così capita che il nativo rispetto al colonizzatore goda di una
condizione simile a quella, più attuale, dell’immigrato clandestino rispetto agli abitanti e
alle istituzioni dei paesi in cui sbarca. Anche la terminologia qui si complica e diventa
ambigua.
Se l’altro, straniero o nativo, genera un effetto di rispecchiamento nel gruppo a cui si
oppone e che incontra – lo stimola a riconoscere il carattere etnocentrico del proprio
sguardo e prospetta la possibilità di un cambiamento – può anche diventare il banco di
prova dove il gruppo è in grado di sperimentare la propria potenza e i propri limiti.
Esperienza, quest’ultima, creativa e dialettica nel caso la resistenza di ciò che è esterno
costringa ad una mediazione, ad un confronto e quindi ad uno scambio. Ma quando le
forze in campo sono radicalmente squilibrate la relazione si irrigidisce in una totalità
4
Per un approfondimento teorico ed etnografico vedi Lorenzo d’Angelo, Bisogna difendere la
metropoli milanese. Biopolitica di uno sgombero, “Achab”, n. 8, 2006.
5
chiusa e solitaria. Al più forte è consentito imporre su una realtà resa docile il segno di
una volontà assoluta che naturalizza i risultati della sua applicazione.
Prendiamo come esempio la condizione del colono africano descritta da Mbembe
(Mbembe, Postcolonialism)5. La colonia, secondo Mbembe, è anzitutto “un labirinto di
forze in azione” dove “l’uso della violenza è demandato a persone in carne ed ossa”, e
“giustificato da un vero e proprio immaginario” (202-203): una cultura, una prassi
sociale che fa del suddito della colonia poco più di una “semplice parvenza”. Ma il
colono ha anche un corpo che il colonizzatore può “prendere, molestare, rinchiudere”.
Egli può “costringere il nativo ai lavori forzati, imporgli tasse o farne carne da
cannone”, può requisirlo “per servire i cibi in tavola, prenderlo a spintoni, stenderlo
sulla schiena o sul fianco, fustigarlo, renderlo esausto, impiccarlo in pubblico…” (218).
Il nativo, prosegue Mbembe, è colui che “rende possibile il costituirsi del colonizzatore
come soggetto per eccellenza… Per poter esistere, il colonizzatore, ha bisogno costante
del nativo, inteso come animale grazie al quale alimentare la propria coscienza di sé”.
Da un lato si appropria del “potere di tratteggiare il reale come vuoto o irreale”;
dall’altro, della forza di far sì che “ogni cosa rappresentata o rappresentabile sia
possibile e realizzabile” (220).
Il nativo conferma al colonizzatore la sua capacità di agire ai tropici, territorio ostile in
cui la sua presenza continuamente vacilla. Febbricitante, spossato, soggetto a nausea,
dolori reumatici, tremiti, dissenteria, il colonizzatore, non meno del nativo schiavizzato,
è una sorta di zombi: di lui non si può dire se è ancora vivo o è morto. Lo smarrimento
di cui è preda, l’incertezza della sua condizione, lo costringono a produrre
continuamente le prove della sua esistenza. Lo spaesamento dello straniero qui si
accoppia all’onnipotenza del colonizzatore, favorendo forme di regressione in cui il
proprio sé e quello dell’altro tornano a confondersi. Come il bambino che costruisce e
distrugge castelli di sabbia, e realizza in questa operazione un intimo piacere, così il
colonizzatore nelle sue attività frenetiche soddisfa un bisogno fondamentale. La
convivenza quotidiana con ciò che gli si oppone come incomprensibile, non agibile,
incontrollabile, rende necessario al colonizzatore in Africa dotarsi di surrogati, semioggetti, specie di enti transizionali manipolabili a piacimento, ma dotati, allo stesso
tempo, di vita propria. Persa la certezza quotidiana e rassicurante dei propri riferimenti
culturali e sociali, il colonizzatore vive una condizione di frustrazione generalizzata che
attenua formulando nuove illusioni: ibridi, tra realtà e immaginazione, in grado di porre
una resistenza, sostanze su cui è possibile operare. Il contesto della colonia è propizio. Il
colonizzatore sviluppa “una soggettività priva di limiti”, assoluta, “che tuttavia per
sperimentare tale assoluto, deve costantemente manifestarlo a se stessa creando,
distruggendo e desiderando la cosa e l’animale che ha precedentemente chiamato ad
esistere” (Mbembe: 222). Queste pratiche mortifere sono costantemente esibite dal
colonizzatore ai suoi complici, in un gioco di specchi in cui il superiore conferma
all’inferiore in grado (e viceversa) la legittimità e la naturalezza delle azioni
irragionevoli che entrambi propagano nella colonia. Modelli di intimità – del
colonizzatore con il nativo e del colonizzatore con il colonizzatore – caratteristici dei
rapporti che si generano quando l’incontro con l’alterità avviene senza mediazioni e
senza reciprocità.
Il colonizzatore delle zone più inospitali dell’Africa equatoriale ad un certo punto
tornerà in patria, così ritrovando la “meritata” pace interiore (seppur a volte percorsa da
incubi), o infine morirà prematuramente sul campo di questa guerra fantastica, ma il
colono e lo schiavo, al contrario, perdureranno indefinitamente nella loro condizione
5
Le citazioni che seguono sono prese dalla traduzione italiana: Postcolonialismo, Meltemi, 2005.
6
allucinatoria, almeno fino a quando, fuggitivi nella foresta, nei quilombos6, liberati da
forme consentite di emancipazione e socializzazione, troveranno altri compagni con cui
ricostruire una società e preparare, nel segreto, la rivolta, o, complici dei loro aguzzini,
sperimenteranno nuove forme di ascesa sociale.
Lo statuto spettrale del colono africano, la coscienza della sua esistenza fantasmatica
inscritta nella memoria incorporata nei traumi della colonizzazione e del lavoro forzato,
sembra prolungarsi nell’africa post-coloniale. Dopo la fine della colonia i fantasmi non
svaniscono, anzi si moltiplicano in una varietà di forme. L’economia liberale che
sostituisce il regime coloniale non è meno incomprensibile e aleatoria della violenza
coloniale. Del resto il dominio coloniale perdura nella post-colonia attraverso forme di
controllo indiretto che usano opportuni mediatori politici, economici e militari collusi
con gli agenti dei paesi occidentali, per mantenere lo status quo.
Come nei culti del cargo, per spiegare l’improvvisa ricchezza di alcuni e l’estrema
povertà dei molti, la variabilità delirante dei prezzi e dei salari, si ricorre agli spiriti e
alle accuse di stregoneria. Fantasmi, zombi, figure esili e inconsistenti tornano così a
popolare le strade ora asfaltate delle città e i sentieri delle campagne africane. Una
infinità di varianti regionali raccontano la medesima storia: un uomo, per mezzo degli
incantesimi realizzati da un vicino, da un bianco, a volte da un parente, è derubato della
sua identità, ipnotizzato e obbligato a lavorare durante la notte per il suo artefice. A
volte è ucciso e trasformato in uno zombi. A volte di giorno riprende coscienza, lo si
riconosce camminare confuso, esausto alle prime luci dell’alba, “part-time zombi”
(Comaroff & Comaroff, Occult economies and the violence of abstraction). A volte è
riposto in un guardaroba, avvolto in un lenzuolo in attesa di essere usato nell’ora
opportuna. La notte è trasportato in invisibili piantagioni sul Monte Kupe7 o in campi di
lavoro in Europa dove un’armata virtuale di operai fantasma alimenta con la propria
linfa vitale l’economia occulta e immorale dell’Occidente (Geschiere, Sorcellerie et
Politique en Afric – La Viande des autres).
Panni Stesi, foto di Lorenzo D’Angelo,
Area dismessa della Falk di Sesto San Giovanni, Milano 2006.
Immagine quest’ultima non molto lontana dalla realtà. I controlli alle frontiere, le
sempre più restrittive leggi sull’immigrazione, le procedure di catalogazione, i
censimenti, le statistiche, i procedimenti polizieschi di espulsione e le pratiche
6
7
Comunità di schiavi fuggiti nel Brasile coloniale.
Monte del Camerun.
7
burocratiche di regolarizzazione di coloro che sostano all’interno di uno Stato senza
regolare permesso di soggiorno, sono le moderne tecnologie di controllo e
manipolazione attraverso cui gli stati-nazione europei riproducono in patria le antiche
tecniche della colonia (cfr. d’Angelo, Negare l’ovvietà. Identità, violenza e razzismo). È
il corpo migrante a fornire ora la sostanza duttile su cui imprimere i segni di una
soggettività che nell’incertezza del mondo postmoderno e globalizzato afferma così una
residuale e flebile capacità di agire. Per il clandestino o il rifugiato non vi è cittadinanza
possibile, ma una situazione di anomia che ricorda quella dei moderni campi profughi.
Il clandestino vive in un limbo, in un paradossale non luogo temporaneo permanente
(Bauman, Lyquid Love). Altri fantasmi si animano nelle periferie delle città
dell’Occidente, trovando rifugio nelle fabbriche abbandonate, nelle aree dismesse,
capannoni spettrali, presagi, residui di una potenza mostruosa che avanza sorda alle sue
vibrazioni. Figure evanescenti che incontrano qui arcaici fantasmi di operai di altre
generazioni, divorati da macchine antropofaghe. Preti di “frontiera”, missionari
postmoderni, raggiungono questi territori “abbandonati da Dio”, mettendo in scena altre
forme di manipolazione, caritatevoli e pietose.
Meta-fantasmi
Fino ad ora abbiamo preso in esame relazioni duali. Nella perfezione esclusiva del
rapporto tra due, l’esistenza di ogni membro della coppia è conseguenza diretta
dell’esistenza dell’altro. Nessuno può abbandonare la diade senza distruggerla. Di qui
l’intimità, la chiusura difensiva e la dipendenza reciproca che caratterizzano la sua
condizione. Ogni terzo elemento è invadente, disturbando la pura e immediata (nonmediata) reciprocità della coppia (Simmel, op. cit.). Sia il colono che il colonizzato, sia
il servo che il padrone, non possono esistere l’uno senza l’altro. È difficile liberarsi da
questo tipo di relazioni senza generare un conflitto drammatico, a volte tragico.
Come evitare, allora, il punto di rottura che minaccia le relazioni duali? Altre forme
fantasmatiche si generano da questo problema. Prendiamo ad esempio l’evoluzione del
razzismo e dell’antirazzismo in Brasile. Nei paesi dominati durante il periodo coloniale,
e per un certo intervallo di tempo anche oltre l’indipendenza, da una economia
schiavista, la problematica razziale, dopo l’abolizione della schiavitù (avvenuta in
Brasile nel 1888), diventa una questione cruciale.
Nel Brasile e negli Stati Uniti di fine Ottocento, il “negro” non può essere idealizzato
facilmente come l’indio o l’indiano nord americano, il quale, immerso nella foresta o
confinato nelle riserve, escluso dal mondo delle relazioni quotidiane della città e dei
campi, è trasformato, senza troppi problemi, in puro oggetto di contemplazione esotica.
Negli Stati Uniti tutto un sistema burocratico segregazionista è organizzato per far
fronte a tale difficoltà. Paradossalmente, la discriminazione razziale dei neri, in un paese
che fonda la propria costituzione su principi egualitari, è mantenuta legalmente fino ai
primi anni Sessanta. In Brasile, dove una società fortemente gerarchizzata, patriarcale e
domestica, aveva consentito relazioni tra signori e schiavi molto più intime – una
particolare ambivalenza tra un dominio pervasivo e brutale e una certa cordialità
nell’esercitare l’autorità, insieme a forme di meticciato tra coloni europei e donne di
colore (Freyre, Casa-Grande & Senzala8) – meccanismi più raffinati consentono di
superare le inquietudini che sorgono in seguito all’abolizione. Il fantasma si modifica.
Dalle forme esangui dell’altro schiavizzato – che ora torna alla luce, resuscitato, almeno
apparentemente, dal suo stato di semi-uomo o di mezza-libertà – si sposta subdolamente
8
Casa-Grande e Senzala sono l’abitazione del fazendeiro e gli alloggiamenti destinati agli schiavi nel
Brasile coloniale.
8
e si installa nelle relazioni di dominazione, che così perdurano e si riproducono in forme
meno visibili. Il fantasma diviene meta-fantasma, assume cioè un carattere metamorfico più complesso, contaminando il livello più sottile dei discorsi e delle relazioni,
che divengono spettrali. In questo territorio, il dominio – che in precedenza,
applicandosi a esseri “inferiori” era del tutto visibile, oggetto di studi e dibattiti eruditi
che valutavano la sua efficacia e le sue possibilità, il giusto dosaggio dei castighi e delle
“cure” necessarie a riprodurre lo schiavo – assume forme di camaleonte che mutano
costantemente. Lo schiavo liberato diventa il soggetto di una situazione di doppio
vincolo, di “convivio/rigetto”, che perpetua una condizione schizofrenogenica in cui
ogni replica alle ingiunzioni del legame può realizzarsi solo indirettamente (Bateson,
Verso un’ecologia della mente). Si nega il dominio mascherandolo in forme di
tolleranza. Questa liberalità paternalista è però limitata dalle strutture burocratiche e dai
regimi discorsivi legittimi (organizzati dagli intellettuali e dalle istituzioni della cultura),
alle sfere del decoro sociale, del folclore, della religione, della vita sessuale. Anche il
“negro”, in una sorta di organizzazione dell’entusiasmo, ad un certo punto potrà
pubblicamente affermare la sua umanità e il subalterno le “ricchezze” della sua cultura.
Ma per entrambi diviene più difficile analizzare l’inganno di cui si è vittima.
Il dominio prende le sembianze di un inquietante Ianus a due facce, che mostra un
volto condiscendente di fronte ad ogni critica. Ma basta distogliere lo sguardo dal suo
sorriso cordiale perché con un rapido dietrofront egli rivolga la sua faccia oscura e
aggressiva.
Il “negro” liberato, abbandonato alla propria sorte in una società di classe, privo dei
mezzi materiali con cui affrontare un’economia competitiva, disoccupato o obbligato ad
accettare volontariamente i lavori più degradanti e mal pagati, percepisce la violenza
disarticolata di cui è oggetto nel proprio corpo, nella depressione, nelle angosce che in
lui proliferano mostrando una presenza che però egli non riesce più a toccare. Fantasma,
creatura invisibile che non sa dove colpire.
A partire dal governo populista di Vargas (1937-1940), una certa mobilità sociale è
consentita alle comunità nere brasiliane. Casi di ascensione sociale di alcuni membri di
questi gruppi, individualmente, conferiscono legittimità al mito della democracia
racial9. Nascondendo il processo di isolamento dei neri in quanto gruppo, si creano
degli ostacoli politici alla mobilitazione collettiva. Ciò che scompare non è il nero in
assoluto, ma il nero come gruppo organizzabile in un movimento di resistenza (H. M. B.
Bomeny, Paraiso tropical).10
Prende forma una situazione paradossale in cui le accuse di razzismo (anti-razzismo)
servono più all’oppressore che all’oppresso. Ogni reazione al dominio diventa sospetta.
La protesta, la critica divengono sintomi di irresponsabilità, irrazionalità, inferiorità.
Non avendo più degli oggetti “reali” su cui fare presa, né uno status su cui costruire un
capitale sociale spendibile, gradualmente scompaiono o si manifestano in forme
disorganizzate. Le alternative sono il cinismo e le arguzie di chi ha imparato a vivere di
espedienti (il celebre malandro cantato nelle samba dei primi anni trenta), l’autismo
politico e la religione, o una iper-eccitabilità che esplode senza preavviso, colpendo
bersagli aleatori, in forme sporadiche inefficaci, facilmente controllabili.
Parallelamente, si origina tutta una serie di mediatori simbolici che, come in epoca
schiavista il mulatto liberato, intervengono ad addolcire l’asprezza dei rapporti razziali e
dei rapporti di classe fino a confondere tutte le carte in tavola. Se prima dell’abolizione
della schiavitù, il nero africano in Brasile è invisibile, dopo la fase di passaggio in cui
9
Mito della pacifica convivenza e uguaglianza sociale, nel Brasile, delle tre “razze” fondatrici del
paese: africana, indigena ed europea.
10
I primi germi di una formazione politica nera furono interdetti e cooptati da Vargas nel 1937.
9
per un momento emerge alla luce nei discorsi razzisti delle prime decadi del ‘900 – in
quanto degenerato e causa di degenerazione –, torna a vivere un’esistenza incerta. Al
suo posto prende forma nei discorsi eruditi, nella propaganda politica e quindi nel senso
comune – con la “mistura” appropriata di bianco, nero e indio e di tutti i modelli
intermedi – il tipo brasileiro. Tipo che sarà esoticamente moreno: di carnagione
marrone chiara, di classe media, dotato di un corpo senza difetti, sempre giovane.
Votato ad un futuro radioso. Fantasma di bellezza e intraprendenza. Tipo ideale che
permette, alle differenti classi sociali e ai differenti gruppi di colore, di interpretare
positivamente la propria posizione, almeno come utopia da realizzare nel futuro,
occultando le relazioni che esprimono il campo più generale della struttura sociale
brasiliana (R. DaMatta, Relativizando). L’invenzione di un terzo irreale consente di
neutralizzare il potenziale esplosivo di un confronto duale.
In verità, nel lungo periodo che si protrae durante il lento processo di modernizzazione
delle istituzioni politiche e delle strutture produttive brasiliane, non si verifica una
semplice mescolanza di tutti i “tipi” razziali11, ma qualcosa di più sottile. Da un lato, si
assiste al graduale “sbiancamento” (branqueamento) del mulatto istruito – in genere
figlio legittimo di un padre bianco benestante –, che tenderà a scegliere di preferenza
una sposa meno scura di lui. Dall’altro al relativo “annerimento” e alla sostanziale
marginalizzazione del nero (preto) e del mulatto meno dotato di risorse economiche e
culturali, entrambi discriminati, soprattutto nel Sud del paese, lungo una irregolare linea
del colore mossa dalla rivalità con le classi inferiori degli europei di recente
immigrazione12.
Ciò che, sotto il velo della democracia racial, affonda ancora una volta nel rimosso
dell’inconscio nazionale brasiliano è il razzismo che persiste indisturbato nelle categorie
percettive, nelle forme di valutazione e classificazione, nelle strutture cognitive
incorporate nei processi di socializzazione che fanno sì che ognuno sappia, volente o
meno, qual’è il suo posto nella società: violenza simbolica (Bourdieu) iscritta negli
sguardi, nelle precedenze, nelle ingiunzioni, nelle battute spiritose e quindi nelle
procedure di selezione del personale e nella definizione dei salari e delle mansioni.
Così, alla fine di una storia punteggiata da brevi fasi di accelerato sviluppo industriale
e più lunghi periodi di recessione e declino, ciclici momenti di ribollimento sociale e
repressione autoritaria, e politiche neoliberiste di aggiustamento strutturale più o meno
corrotte, le maggiori città brasiliane, ad un certo punto, si dividono nei quartieri fortezza
dei “bianchi”, eredi dei capitali coloniali, e nei ghetti-favelas di “negri”, “pardos”,
“meticci”, “nero chiaro”, “nero scuro” ecc., ex-schiavi, ed ex-proletari (allineamento
perfetto di gerarchia di classe e stratificazione razziale). Con tutto ciò il razzismo in
Brasile sembra non esistere. Solo a partire dalla fine degli anni ’70, con la cosiddetta
“abertura” della dittatura militare brasiliana (1964-1985), un nuovo movimento negro
organizzato, insieme ai lavori teorici di alcuni sociologi e antropologi, ha contribuito a
decostruire il mito della democracia racial.
I giovani marginali delle metropoli brasiliane, però, continuano a morire, in disperati
tentativi di rapina, a causa di liti interne ai bairros delle periferie, nelle zone franche del
traffico della droga, in improvvisi momenti di follia, oppure “giustiziati”
11
Con il termine razziale mi riferisco qui ad un modello classificatorio basato sulla discriminazione di
tratti fisici dell’aspetto della persona attribuiti ad una supposta origine storico-geografica. Cfr. il lavoro
pionieristico di Oracy Nogueira, Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: sugestão de
um quadro de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil (1955).
12
A partire dalla fine dell’800 sono stimati tra 5 e 7 milioni gli immigrati europei in Brasile. Per una
discussione sintetica dei fattori storici e regionali del razzismo in brasile vedi: E. Telles, Racial Distance
and Region in Brazil, “Latin American Research Review”, v. 8, n. 2, 1993.
10
sommariamente da gruppi mercenari armati (Caldeira & Holston, Democracy and
Violence in Brazil). Situazione complicata in cui l’esclusione e l’impoverimento sono
prodotti da più ragioni concomitanti: forme sottili di razzismo a cui si sommano i
risultati di un decennio (gli anni ’90) di politiche neoliberiste di “riforma” del welfare. I
bisogni di protezione e impiego degli abitanti delle favelas, disattesi dallo stato e
dall’economia ufficiale, trovano una risposta nel traffico della droga che così viene ad
assumere un ruolo sociale che legittima il suo potere e ingrossa le sue file. La
complessità di questa logica mista è ridotta nel dibattito politico e giornalistico alla sua
faccia delinquenziale. Qui emerge l’ultima e più recente mutazione del fantasma. Un
disagio nella sua essenza tipicamente economico e culturale (una lunga storia di
discriminazione razziale e di classe) è occultato attraverso la sua trasformazione in
problema di ordine pubblico. In alternativa, sono gli stessi leader dei movimenti negri,
separando la discriminazione di classe dalla discriminazione razziale, la sola ad essere
enfatizzata nei media e dall’industria culturale, a dividere il fronte delle lotte di
rivendicazione di diritti, occultando ideologicamente la reale posta in gioca a cui
aspirano i gruppi di base.
In Europa sono le Banlieu francesi a manifestare, in modalità meno cruente, una
logica simile (Wacquant, L'etat incendiaire face aux banlieues en feu).
Se in America Latina, dove colonia/post-colonia e metropoli convivono in forme
ambigue e alterne, i fantasmi dei sistemi di assoggettamento presentano oggi
configurazioni ancora parzialmente visibili, è nel “centro” del dominio che il loro
funzionamento assume la forma perfetta. Nella “metropoli”, in Occidente e nelle sue
mutazioni asiatiche, le risorse accumulate nella fase primitiva del capitale esigono
dall’operaio, dal tecnico, dal giovane impiegato par-time, un surplus di collaborazione:
“l’umanesimo della merce prende a proprio carico gli svaghi e l’umanità del lavoratore”
(Guy Debord, La Société du Spectacle, tesi 43), mascherando premurosamente il
dominio nelle vesti del consumo. La fabbricazione ininterrotta di pseudo-bisogni riduce
tutti all’unico pseudo-bisogno del mantenimento della produzione (id.).
Dogh, Itatiba, Brasile 2004.
I fantasmi dell’antropologia
I fantasmi, di cui abbiamo tracciato l’evoluzione e le metamorfosi, hanno percorso
anche la storia e le pratiche della ricerca antropologica. Il cosiddetto “antropologo in
poltrona” della fine dell’800 raccontava di luoghi e persone che non aveva mai visto.
Confortevolmente accomodato nel suo studio, elaborava sistematicamente testi eruditi
sulla base di un vasto corpo di “note” raccolte da una varietà di informatori: esploratori,
missionari, amministratori coloniali, commercianti – raffinata tecnica di invenzione
11
“disciplinata”, dotto assemblaggio di collezioni di dati strappati ad una realtà ben più
oscura. Ma anche il più moderno antropologo “partecipante”, di ritorno dai suoi viaggi
esotici, impegnato nella scrittura di una monografia etnografica, garantiva con differenti
tecniche retoriche (il presente etnografico, l’occultamento della presenza sul campo
degli agenti occidentali e di primitive forme di globalizzazione e conflitto) la
dissimulazione della complessità dell’incontro, negando la prossimità, la coevità,
implicata dai vincoli conoscitivi della ricerca etnografica.
È del resto la condizione di spaesamento, intrinseca alla vita sul campo, ad aver
determinato negli etnografi forme di comportamento dissociate dai contesti dello loro
ricerche. Come il dominio coloniale, anche l’indagine antropologica si svolge lontano
dai propri affetti, esclusi per lunghi periodi di tempo da molte delle abitudini quotidiane
che organizzano la vita ordinaria. Si può resistere anche per anni a questa condizione
spaesante, guidati da una forza di volontà allenata ad una lotta senza fine per non
perdersi d'animo. Nel campo si manifestano tutti i dispositivi di controllo e
disciplinamento del sé. Il lavoro metodico e sistematico consente di resistere alla
pericolosa attrazione della frontiera. La personalità etica, sorvegliata, viene realizzata
incessantemente mediante il lavoro: “un credo deliberato, una fedeltà assoluta a certi
aspetti delle convenzioni” (J. Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura
e arte nel secolo XX). Così, anche sul campo, spesso l’altro scompare. Appare come
oggetto di studio, ma non come uomo con cui condividere la comune condizione di
essere-nel-mondo, e l’impegno gravoso di decidere e pro-gettare la propria esistenza.
Quando il nazismo porta gli orrori della colonia nelle città europee, quando il
guerrigliero nelle lotte di indipendenza in Africa o in Asia prende le armi e infligge i
primi colpi alla vanità occidentale, quando infine il nativo prende la parola e restituisce
all’etnografo un’immagine “distorta” da una prospettiva diversa – da altri schemi, altre
gestalt con cui organizzare il mondo –, qualcosa però muta profondamente. Nella torre
di avorio dell’uomo occidentale cominciano a formarsi crepe sempre più penetranti e le
inquietudini impercettibili del colonizzatore si diffondono su tutti i piani della cultura.
Come abbiamo visto, altri meccanismi e altri fantasmi, qualitativamente più raffinati di
quelli della colonia, saranno inventati affinché le posizioni di potere possano rimanere
sostanzialmente invariate. Tutto cambi senza che nulla cambi.
L’antropologia, che dell’alterità ha fatto il suo campo di studio, di fronte allo svelarsi
di un simile spettacolo, vacilla. Di fronte a crepe diventate così gravi, l’intera disciplina,
ad un certo punto, entra in una fase di ostinata e ciclica autocritica. A partire dalla fine
degli anni sessanta sono riconosciuti e vagliati attentamente i legami tra antropologia,
colonialismo e imperialismo, sia al livello delle connivenze dirette degli antropologi con
le amministrazioni coloniali, sia al livello delle retoriche e degli stili letterari inscritti
nelle monografie etnografiche, complici nel costruire la diversità come universo
conoscibile e quindi amministrabile.
Cosa è venuto fuori dal ribollire del conseguente processo di ripensamento dei modi,
degli “oggetti” e delle pratiche delle ricerche di campo? Dalla revisione delle forme di
scrittura e dei livelli di autocoscienza che ha coinvolto buona parte degli antropologi più
attenti del panorama internazionale? Dopo una fase di smarrimento collettivo una
molteplicità di contributi è andata organizzandosi in senso interdisciplinare, accogliendo
le voci dei nuovi ricercatori provenienti dal Sud del mondo. L’attenzione degli
antropologi si è rivolta ai complessi intrecci tra le pratiche simboliche e i sistemi di
potere, tra i processi di invenzione e riproduzione delle espressioni culturali e delle
identità e i dispositivi di controllo e le forme di resistenza contro egemoniche (studi
subalterni, antropologia del colonialismo, antropologia femminista, ecc.). Lo sguardo
antropologico riflessivamente si è curvato su se stesso riscrivendo una storia critica
della disciplina, al medesimo tempo rivolgendo il proprio interesse ai contesti e ai
12
presupposti della produzione del suo sapere e del sapere scientifico e tecnico di altre
discipline “occidentali” (antropologia medica, etno-estetica, antropologia dello
sviluppo, antropologia dei media).
Sia da un punto di vista teorico che metodologico, una sorta di meta-fantasmi sembra
però essersi riprodotta anche nelle maglie di questi approcci variegati. Le nuove
pratiche etnografiche ispirate al dialogismo e alla negoziazione sembrano collocarsi in
ultima istanza all’interno del grande ventre del liberalismo occidentale. A livello teorico
una specie di canone postcoloniale, politicamente connotato dal terzomondismo liberale
e dall’ibridismo riformista si è installato all’interno delle istituzioni e degli apparati
culturali
dell’Occidente:
accademia,
editoria,
media
(Ania
Loomba,
Colonialism/Postcolonialism). L’insistenza sulle categorie di meticciamento, fusione,
partecipazione, condivisione, conversazione, rivela l’invenzione di nuovi artifici teorici
ed etnografici con cui penetrare, più dolcemente, all’interno delle culture, occultando
ancora una volta i presupposti asimmetrici che governano l’incontro antropologico.
Quali strategie restano a disposizione per fare della disciplina una pratica in grado di
contrastare i fantasmi che riproducono costantemente forme di assoggettamento e di
alienazione? Roberto Malighetti, intervistato da Pietro Meloni, afferma la necessità di
dire cose fruibili senza abdicare alle articolazioni del pensiero antropologico, alla sua
vocazione critica e analitica, capace di mostrare il complesso gioco delle differenze: “la
rilevanza si gioca sullo scarto con i linguaggi dominanti, sulla capacità di mostrare
modalità alternative di vedere e forse anche di organizzare il mondo”13. Sicuramente
non è sul rapporto di forze che si può sostenere il ruolo critico della ricerca
antropologica. Come diceva anche Baudrillard, è “con la differenza che bisogna
attaccare” (Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte). Nel modo in cui i graffiti dei
neri e portoricani delle metropoli americane nella notte prendono forma sui vagoni dei
treni e dei metrò e alle prime luci dell’alba “esportano il ghetto in tutte le arterie della
città, invadono la città bianca e rivelano che questa è il vero ghetto” (id.), i graffiti
dell’antropologia risultano più efficaci quando riescono a sfuggire ad un discorso
facilmente organizzabile, segnalando, con circostanziate ricognizioni, le voci e gli
spostamenti delle forze in campo, la dinamica delle posizioni e i presupposti che
plasmano di volta in volta le strategie egemoniche (Manoukian, Considerazioni
inattuali14).
Forse non servono più diligenti monografie di centinaia di pagine (a chi sono mai
servite?), ma una proliferazione di testi sintetici, solidamente strutturati e documentati,
testi in movimento, collettivi, fluidi, interrelati, non fini a se stessi, ma in grado di
viaggiare, e segnare dei colpi penetrando nel tessuto dei poteri pervasivamente inscritti
nelle disposizioni, nei corpi, nei propri desideri e nel proprio sapere. I frutti più fecondi
di una ricerca di campo prolungata sono le decine di “intuizioni etnografiche” che
spesso non trovano posto nel rigore di una tesi scientificamente e convenzionalmente
controllata. Bisogna trovare i luoghi dove dare vita a queste idee, sia “a casa”, negli
spazi dell’accademia e della vita politica, sia nei territori dove si radicano le ricerche di
campo. Tattiche di guerriglia molto elaborate, al medesimo tempo simili ai gesti
situazionisti e ai graffiti fantasma che i giovani adolescenti insistentemente riproducono,
incompresi, nelle nostre città. “Nomi di battaglia nel cuore della metropoli” e nelle sue
periferie, tattiche che riterritorializzano lo spazio urbano in posti collettivi, ridando vita
ai muri, alle strade, ai quartieri (Baudrillard, op. cit.)
13
14
Intervista pubblicata in “Antropologie” , 18/06/2006.
Introduzione in Colonialismo, “Annuario di Antropologia”, n. 2, 2002.
13