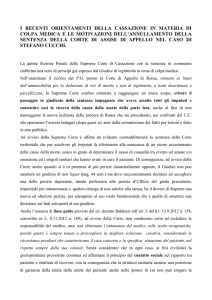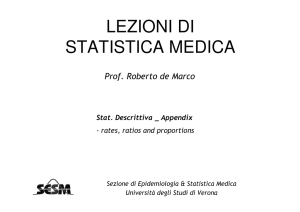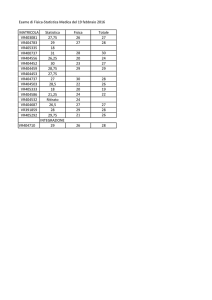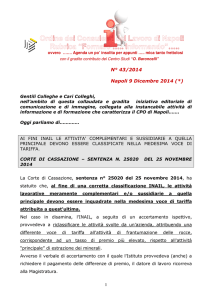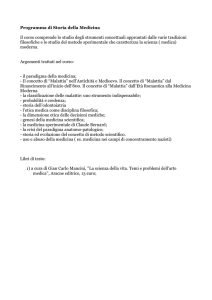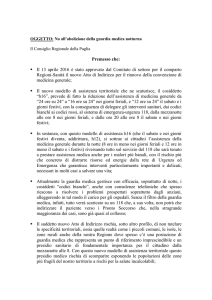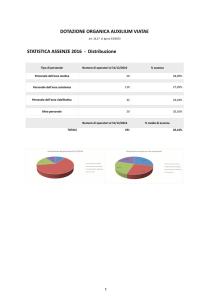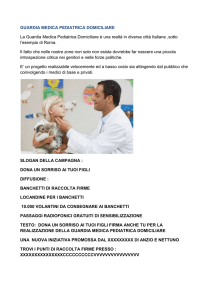Rassegna delle sentenze penali
tratte dalle newsletter dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Salerno
Direttore Dr. Bruno Ravera
Responsabile di Redazione Dr. Giovanni D’Angelo
Redazione Dr.ssa Rita Russo
ANNO 2007
Corte di Cassazione
Causalità omissiva e responsabilità medica.
La quarta sezione penale della Cassazione, con una sentenza depositata il 26
gennaio 2007, è tornata sul rapporto causalità omissiva - responsabilità medica. Nei
fatti, si addebitava a un chirurgo ospedaliero di aver cagionato, per colpa, la morte
di un paziente per “scompenso cardio-circolatorio acuto a causa di shock settico).
Nonostante i sintomi evidenti (dolore persistente, rialzi febbrili, fuoriuscita di siero
dalla ferita) in un paziente sottoposto oltre 20 giorni prima a intervento per ernia
inguinale e testicolo ritenuto, il medico non si accorgeva dell’infezione in atto, non
attuando le idonee iniziative diagnostiche e terapeutiche. In primo grado e in
appello, i giudici ritenevano sussistere la colpa del sanitario. In particolare, la Corte
di Appello fondava il suo giudizio sulle dichiarazioni del consulente tecnico del Pm,
che affermava l’esistenza di “una discreta possibilità di salvare il paziente” se fosse
stato eseguito un intervento tempestivo (che l’imputato sarebbe stato in grado di
effettuare). Dal citato parere, infatti, i giudici traevano il convincimento che, sulla
scorta della nota sentenza n. 30328/2002 (Franzese), se il medico si fosse attivato, il
decesso sarebbe stato evitato “con alto o elevato grado di credibilità razionale e
logica”. Pertanto, considerata la valenza semantica del termine “discreto”, era
possibile configurare una “elevata o comunque notevole probabilità di esito
favorevole conseguente alla corretta attivazione dell’imputato”. Il medico imputato
ricorreva per Cassazione denunciando la disapplicazione dei criteri di verifica della
causalità omissiva stabilita dalle Sezioni Unite. Ma la Cassazione ha rigettato il
ricorso, ritenendo esenti da censura i passaggi motivazionali della sentenza di
appello. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricordato l’esatto protocollo di
verifica del nesso causale sancito dalla sentenza Franzese, sostiene che la Corte di
Appello lo aveva correttamente applicato. E, dopo aver “richiamato l’elevato grado
di probabilità di sopravvivenza del paziente in caso di intervento tempestivo”, aver
esaminato tutte le circostanze del caso specifico e aver effettuato il giudizio
controfattuale, i giudici ritengono sussistente il nesso di causalità. Detta sentenza,
però, si pone in posizione di contrasto con gli orientamenti, ormai dominanti,
scaturiti dalla sentenza Franzese, avallando un riconoscimento del nesso causale in
un contesto probatorio deficitario. Infatti, non è dato cogliervi alcuna spiegazione
delle ragioni per cui, considerando gli elementi personali e fattuali rilevanti (età,
sesso, condizioni generali del paziente …), l’enunciato in termini di “discrete
probabilità di successo” dell’intervento omesso, come posto dal consulente, potesse
trasfigurare e lievitare al punto da assurgere a fattore fondante un giudizio di
“elevata credibilità logica” sull’efficacia impeditiva dell’azione non attuata. (da
notiziario del 19 febbraio 2007)
Certificazione medica e conseguenze penali.
La quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 3250 del 29/01/07, si è
occupata del reato di falsità ideologica per una certificazione medica. In concreto
all’imputato veniva contestato di avere, in qualità di medico incaricato del servizio di
medicina fiscale della U.S.L., falsamente attestato in un certificato medico-legale
l’avvenuta effettuazione di una visita medica in realtà mai avvenuta. Il medico,
infatti, incaricato di eseguire una visita domiciliare nei confronti di una dipendente
comunale, in malattia da alcuni giorni, si recava a casa della paziente verso le 15.30
– cioè prima dell’orario previsto dal contratto di lavoro per le visite, fissato dalle ore
17 alle 19 – dove trovava solo la sorella. A tal punto, affermando che gli era
impossibile ripassare, l’imputato rilasciava il certificato, completandolo in tutte le
sue parti e asserendo di aver svolto la visita alle 19 dello stesso giorno. Invitava,
quindi, la sorella della paziente a far firmare l’interessata e a riconsegnare il
certificato presso la portineria dell’ospedale in busta chiusa a lui indirizzata. In primo
grado e in appello il medico veniva riconosciuto responsabile del reato di falsità
ideologica in atto pubblico e condannato alla pena di legge. L’imputato propone
ricorso per Cassazione denunciando, nei primi due motivi, che le due sorelle erano
“concorrenti” nel reato e, pertanto, non potevano essere assunte come testimoni e,
nel terzo motivo, il difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza
dell’elemento psicologico del reato. Ma la Cassazione ritiene i motivi mere
riproposizioni di quanto già esplicitato in appello e rigetta il ricorso per le seguenti
considerazioni. Con riguardo ai primi due motivi, viene riconosciuto che,
correttamente, alle due sorelle non era stato addebitato alcun illecito in quanto le
rispettive condotte erano ben lontane dal lasciar ipotizzare qualunque forma di
reato e, pertanto, le stesse legittimamente potevano essere escusse come testi. “Era
quindi in potere del solo M., autore della falsità, desistere dall’inoltrare il certificato
al competente ufficio, assumendosene, in caso contrario, la responsabilità
esclusiva”. Ed in riferimento al terzo motivo, si riconosce che “l’elemento soggettivo
del reato è costituito dal dolo generico che nella specie risultava pienamente
integrato, essendo di tutta evidenza che l’imputato aveva piena coscienza e volontà
di attestare il falso”. Correttamente, inoltre, la sentenza afferma che non si
riscontrava lo schema legale dell’art. 480 del c.p. (relativo alle falsità in certificati e
autorizzazioni amministrative) in quanto il certificato in questione aveva natura
complessa: per una parte certificazione medica circa lo stato di salute del paziente e
per altri versi atto pubblico. “Il certificato rilasciato dal medico convenzionato con la
U.S.L., infatti, – concludono i giudici – per la parte relativa al giudizio diagnostico e
prognostico ha natura di certificato, essendo basato sulle conoscenze scientifiche
del sanitario, mentre riveste qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti la
provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le attestazioni relative, come
nella specie, all’attività svolta (visita medica) nonché ai fatti avvenuti alla sua
presenza, quali, in particolare, la presentazione del paziente”. Nel caso di specie,
pertanto, si configura il reato di falsità ideologica in atto pubblico con condanna alla
pena prevista dalla legge oltre le spese del procedimento. (da notiziario del 26 febbraio
2007)
Aborto colposo: medico condannato!
La quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 29352 del 20 luglio
u.s., ha confermato la condanna penale ai sensi della L. 194/78 (art. 17) e il
conseguente risarcimento danni per un ginecologo che non aveva seguito tutte le
“regole cautelari, volte a prevenire l’interruzione della gravidanza e la morte del
feto, a prescindere dalla possibilità di vita autonoma”. I giudici hanno, pertanto,
riconosciuto il medico colpevole di aborto colposo anche in mancanza di prove certe
sulla sopravvivenza del nascituro. Il medico, infatti, deve “dare priorità” a situazioni
di urgenza che deve dedurre da quanto riferitogli dalla paziente e dai collaboratori, e
può “salvarsi” solo dimostrando di essere stato “impegnato fisicamente in altra
attività più urgente o grave di quella che gli veniva prospettata”. “E, comunque, la
veste di responsabile del reparto poneva a suo carico il dovere di intervenire, se non
altro mediante disposizioni tempestive, accurate e precise”. Nel caso specifico,
invece, nonostante il tracciato cardiotocografico presentasse “chiare anomalie”, il
primario non intervenne con tempestivo parto cesareo e dopo poche ore si verificò
“la morte intrauterina del feto” con successivo parto avvenuto la sera stessa. Corte
di Appello e Cassazione rigettavano, inoltre, anche l’ipotesi, avanzata dai legali del
sanitario, secondo la quale il pronto intervento del medico non avrebbe comunque
garantito il buon esito del parto. “C’erano teoricamente – precisano, infatti, i giudici
– i tempi per allestire una sala operatoria e garantire un’adeguata assistenza alla
mamma e che, inoltre, alle ore 18 (sei ore dopo l’esame del medico) il bambino era
ancora vivo”. (da notiziario 12 ottobre 2007)
Il silenzio del medico sulla diagnosi e’ omicidio colposo.
La quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 39609 del 26 ottobre
u.s., confermando la condanna inflitta ad un medico dalla Corte di Appello, ha
sancito che commette il reato di omicidio colposo il medico che, dopo
un’operazione, non comunica la diagnosi di cancro al paziente. Nei fatti il silenzio
della divisione di ostetricia e ginecologia di un ospedale campano è stato letale per
una donna malata di cancro. Un leiomiosarcoma di grado G3 (tumore della fibra
muscolare liscia particolarmente maligno che dà precocemente metastasi) ha
progredito per un intero anno prima che la paziente e i suoi familiari ne scoprissero
l’esistenza in occasione del ricovero in un altro ospedale. E tra le due negligenze,
quella dei familiari che non si sono attivati per conoscere l’esito dell’esame
istologico e quella del medico che non li ha avvisati della situazione, solo la seconda
è penalmente rilevante. Infatti, la Corte ricorda che gli obblighi di garanzia connessi
all’esercizio della professione sanitaria e la salvaguardia del bene primario della
salute pongono carico del medico una responsabilità non delegabile. Detta
responsabilità, in realtà, non è eliminata da un semplice invito a presentarsi dopo un
mese dalle dimissioni per conoscere l’esito dell’esame istologico. Dinanzi a un
referto allarmante il medico deve attivarsi, contattare il malato e informarlo della
gravità della situazione. Né vale come giustificazione l’aver delegato, in qualità di
direttore di reparto, altri medici alle risposte degli esami istologici. In situazioni di
elevato allarme e rischio, il dottore che segue un’operazione, anche se capo di un
reparto, ha l’obbligo di seguire personalmente l’evoluzione della vicenda. (da notiziario
del 10 novembre 2007)
La guardia medica non può rifiutarsi di fare la visita !
La sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 31670/2007, ha
confermato le sentenze di primo e secondo grado di condanna di un sanitario per
omissione di soccorso, ribadendo i principi ai quali deve ispirarsi l’operato del
medico di guardia. Nel caso specifico, un uomo, in preda a dolore allo stomaco, si
era rivolto al medico di guardia che gli rispondeva “Vada a casa e attenda l’apertura
della farmacia”. Si trattava, in realtà, di un principio di infarto e l’uomo, il
pomeriggio successivo, veniva rinvenuto esanime sul letto. Determinanti, ai fini
dell’accertamento della responsabilità del medico, sono state le confessioni del
paziente ad amici e parenti. In quattro riferivano ai giudici che il medico di guardia
aveva ricevuto il loro caro sull’uscio, “e senza visitarlo l’aveva dirottato verso la
farmacia”. Le dichiarazioni testimoniali avevano fatto scaturire le condanne di
Tribunale e Corte di Appello per violazione dell’art. 328 del c.p.. Secondo la
Cassazione, infatti, le testimonianze hanno portato a una sentenza di condanna di
“assoluta plausibilità” e il medico di guardia non può difendersi sostenendo che il
quadro clinico prospettatogli (bruciore allo stomaco) non lo obbligava a una pronta
visita. “La richiesta di soccorso presentava degli inequivoci connotati di gravità –
replicavano i Supremi Giudici – perché riguardava un malato con chiari sintomi di
infarto e la Cassazione, in precedenti decisioni, ha già chiarito che la discrezionalità
riconosciuta dal medico non può mai sfociare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie”.
Il medico “è tenuto a compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti
direttamente dall’utente” e la sua discrezionalità nel valutare il quadro clinico del
paziente “può essere sindacata dal giudice sulla base degli elementi di prova”. (da
notiziario del 24 novembre 2007)
Lavoro in équipe e colpa medica.
La quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 41317/2007, ha
sancito la responsabilità di tutti i medici che fanno parte di una équipe anche se a
sbagliare è stato uno solo dei dottori. Ad adire la Suprema Corte sono stati un
primario di ginecologia, due medici della divisione e un anestesista condannati per
omicidio colposo in primo e secondo grado con obbligo di risarcimento danni alla
parte civile e rimborso integrale delle spese legali. La vicenda ineriva una gestante
sottoposta a parto cesareo. Durante l’intervento era insorto un edema polmonare e,
come hanno chiarito i periti, “dopo il secondo tentativo fallito di intubazione si
imponeva all’anestesista e ai ginecologi l’esigenza di estrarre il feto. La manovra
avrebbe con certezza salvato la vita del bambino e migliorato la ventilabilità della
madre”. Ma nulla di ciò fu fatto: sotto gli occhi dell’intera équipe medica che seguiva
“la tragedia che si stava consumando sotto i loro occhi” senza reagire, si arrivò al
decesso di madre e figlio. E la Cassazione, pur riconoscendo la prescrizione del reato
di duplice omicidio colposo, “estinto” in quanto sono decorsi cinque anni dalla
sentenza del tribunale, conferma l’obbligo di indennizzo per le due vittime. In realtà,
“i ginecologi si erano resi conto dell’errore commesso dall’anestesista nella fase
preparatoria e dei suoi deleteri tentativi di intubare la paziente. In sostanza erano
scelte errate e spettava loro, a quel punto, chiarire le priorità e imporre opzioni
diverse”. Nessuno del gruppo, però, intervenne assumendosi così la responsabilità
del duplice omicidio colposo. In caso di “negligenza altrui”, infatti, ogni dottore dello
staff “deve farsi carico dei rischi” provocati dai colleghi, intervenendo, se necessario,
per salvare la situazione. Il lavoro di équipe “fa sorgere rischi nuovi e diversi rispetto
all’attività medica mono-soggettiva, essenzialmente derivanti da difetti di
coordinamento o di informazione, da errori di comprensione o dovuti alla mancanza
di una visione di insieme, e spesso tra loro collegati”. (da notiziario del 6 dicembre 2007)
Tribunale
Continuità assistenziale e interruzione di pubblico servizio!
La sezione I del tribunale di Genova, con la sentenza depositata l’11 luglio 2006, ha
sancito che “integra il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall’art. 340
del codice penale, la mancata immotivata risposta alla chiamata del pubblico
ufficiale, tenuto in ragione del servizio volto, a rispondere a chiunque lo interpelli
per motivi attinenti alla sua funzione”. Nel caso specifico sottoposto all’attenzione
dei giudici, il figlio di una paziente, poi deceduta, provava alle 5.10 del mattino a
chiamare la guardia medica. Al telefono, però, al primo squillo rispondeva una voce
che informava che la segreteria telefonica era disattivata. I familiari, a tal punto,
chiedevano l’intervento del servizio di assistenza domiciliare del 118 ma non fu più
possibile alcun soccorso perché l’ammalata, nel frattempo, era morta. Un familiare,
verso le 7.30, 8.00, si recò di persona presso la sede della guardia medica senza
trovare alcuno. Anche il medico di base della paziente, contattato alle 6.30 e
recatosi a casa per redigere la certificazione di morte, provava a contattare la
guardia medica telefonicamente. Non riuscendo nell’intento il dottore si recò
personalmente alla guardia medica, verso le 7.10-7.15, poté constatare che non
c’era nessuno e lasciò un biglietto per il collega di guardia. In seguito all’episodio,
l’apparecchio telefonico (dotato di una segreteria che doveva lasciare il recapito del
telefono cellulare) fu sottoposto a ripetute verifiche da parte di una funzionaria ASL
e non venne riscontrata nessuna anomalia. I molteplici infruttuosi tentativi, sia
telefonici che di persona, dimostravano che il medico non era proprio presente nella
sua stanza. I giudici, nel motivare la sentenza, si richiamano, in primis, alla sentenza
della Cassazione n. 37459/2004, relativa a vicenda analoga, e così decisa: “Integra il
reato di un interruzione di pubblico servizio la condotta del medico in turno di
reperibilità presso una struttura ospedaliera che si renda irraggiungibile al recapito
fornito disattivando il telefono cellulare”. E così concludono. “… Rientra infatti nei
doveri di tale ufficio rendersi reperibile, per cui grava sul pubblico ufficiale l’onere di
provvedere in tal senso, non allontanandosi dal recapito telefonico ovvero lasciando
attivo e raggiungibile altro recapito. Proprio la delicatezza di tali funzioni deve porre
l’obbligato in stato di allerta tale da escludere che possa distrarsi o assopirsi al punto
da vanificare il dovere di reperibilità. Come osserva la giurisprudenza (Cass. sent.
n.33062 del 5/8/03) l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 340 c.p. non
consiste esclusivamente nel dolo diretto, corrispondente alla condotta volta a
provocare l’interruzione, essendo rilevante altresì il dolo indiretto o eventuale,
“fondato sulla consapevolezza che l’azione o omissione è idonea a cagionare
l’evento dell’interruzione o della turbativa e sull’accettazione del rischio della sua
verificazione”. Per tali motivi, il tribunale condanna il medico, viste le attenuanti
generiche legate allo stato di incensurato, alla pena di mesi 4, giorni 15 di reclusione
(ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p.), nonché all’obbligo del pagamento delle spese
processuali ed al risarcimento dei danni subiti dalla Parte Civile, la cui immagine era
stata compromessa dalla illecita condotta del medico con il quale aveva stipulato
convenzione e che pertanto operava per suo conto. E’, altresì, concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna sul
certificato penale. (da notiziario del 20 gennaio 2007)
Infarto, colpa medica ed esclusione.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza depositata il 4 settembre 2007, si è
pronunciato sulle problematiche inerenti la colpa medica in caso di infarto
miocardico. Nel caso esaminato, un paziente si era presentato al pronto soccorso
dell’ospedale lamentando un dolore cardio-palmare e precordiale; veniva
sottoposto ad elettrocardiogramma e a esami ematochimici: il primo controllo
evidenziava “esiti di necrosi; invariato rispetto al controllo 7 giugno 2002”, mentre
gli esami del sangue rilevavano dei valori di mioglobina pari a 322 ng/ml e di
troponina T pari a 0,34 ng/ml. Successivamente il paziente veniva sottoposto a visita
cardiologica urgente il cui esito fu di eseguire un ECG dinamico ed una visita
nefrologica presso l’Ospedale per un’eventuale dialisi. A tal punto il paziente veniva
dimesso. Alle 16.30 dello stesso giorno, però, veniva nuovamente colto da dolore
retrosternale e cardiopalmo e veniva ricoverato: all’Ospedale veniva diagnosticata
una necrosi miocardica documentata dal progressivo innalzamento di alcuni marker
di laboratorio (CKMB, mioglobina, troponina). La mattina dopo il paziente a seguito
di aggravamento veniva sottoposto d’urgenza a esame angiografico coronarico dal
quale emergeva una malattia coronarica trivascolare che comportava un ulteriore
peggioramento, fino alla morte sopraggiunta il mattino successivo. Per i familiari del
paziente, nell’atto di citazione, “la causa della morte … è da ravvisarsi in un’acuta
insufficienza cardio-circolatoria in soggetto affetto da angina instabile per sofferenza
ischemica diffusa del miocardio del ventricolo sinistro che ha condotto al cedimento
della funzione di pompa del cuore, ossia allo shock cardiogeno e quindi all’arresto
irreversibile delle funzioni vitali(…) il comportamento dei sanitari che ebbero in cura
signor C.R., presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale B., si pone in nesso di causa con
il decesso dello stesso”. Gli ulteriori punti di accusa concernevano il non aver
valutato l’incremento della mioglobina e della troponina nel sangue, non aver
considerato “lo stiramento dei segmenti ST in sede antero laterale” emergente
dall’elettrocardiogramma e nel non aver disposto la somministrazione di farmaci
trombolitici, unica terapia ritenuta possibile. Ma le risultanze della Ctu, disposta in
corso di causa, non deponevano in tal senso. La causa della morte, per il consulente,
va identificata in un “arresto cardiaco da grave compromissione contrattile del
ventricolo sinistro secondaria alla prolungata e diffusa ischemia subendocardica
legata ad una grave malattia ostruttiva coronaria”. Esclusa la causalità dell’evento
per mancata somministrazione di trombolitici sulla base della letteratura medica
internazionale, il consulente, inoltre, riconosce che “Le uniche chances di
sopravvivenza del paziente potevano essere legate ad un intervento per cutaneo
(angioplastica coronaria) o chirurgico (bypass aorto-coronarico)”, entrambi esclusi
dai sanitari per altri problemi da cui era affetto il paziente. Ma anche il requisito
della colpa professionale del personale del Presidio non è riscontrabile: dagli
elementi a disposizione dei sanitari “non emergeva in modo chiaro e definitivo il
fatto che il paziente avesse un infarto miocardico acuto in atto, né una sindrome
coronaria acuta con (tratto) ST sottoslivellato (sintomatica dell’ischemia
subendocardica rivelatasi letale). Evidenziando che il paziente era stato già colpito
da infarto, il Ctu osserva, infatti, che “… l’elettrocardiogramma già alterato di base
per il precedente infarto miocardico inferiore e per la presenza di un sovraccarico da
ipertrofia ventricolare sinistra non forniva alcun elemento chiaro e definitivo di una
necrosi miocardica in atto né tantomeno di una ischemia subendocardica”. Sulla
base di tali osservazioni il Ctu ritiene corretta la decisione di dimettere il paziente in
quanto non erano riscontrabili elementi oggettivi tali da supporre una condizione di
alta probabilità di angina. “Neppure i risultati degli esami ematochimici
consentivano – secondo il Ctu – di effettuare la diagnosi omessa, dal momento che
la presenza di patologie associate come la insufficienza renale cronica può far sì che
la specificità dei marker bioumorali di necrosi miocardica – quali troponina e
mioglobina – si riduca”. Il Ctu motiva tale affermazione sulla base dello studio
“Gestione delle sindromi coronariche acute in pazienti senza sopraslivellamento
persistente del tratto St alla presentazione” a cura della Task Force per la gestione
delle sindromi coronariche acute della European Society of Cardiologi, in European
Heart Journal. Pertanto, “… in assenza dei due principali elementi diagnostici (dolore
toracico ed ecg alterato) – si legge ancora nella relazione – la presenza di positività
della troponina in un paziente con insufficienza renale cronica non rappresenta un
indice di necrosi miocardica in atto”. Il paziente, inoltre, risultava già affetto da
bronco pneumopatia cronica ostruttiva e “in ogni caso la presenza di dispnea a
riposo o anche l’aggravamento della dispnea da sforzo associata o meno ad altre
manifestazioni cliniche come sudorazione, nausea, lipotimia, astenia possono essere
considerati “equivalenti anginosi” solo in presenza di segni elettrocardiografici di
ischemia acuta” nella fattispecie non presenti. Per tali motivi, il Tribunale, ritenendo
le conclusioni del Ctu “logiche, coerenti ed esaustive”, esclude ogni responsabilità
dei sanitari. (da notiziario del 20 settembre 2007)