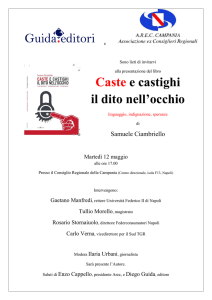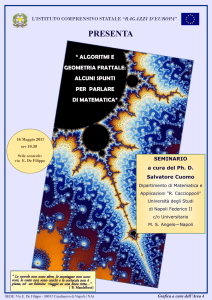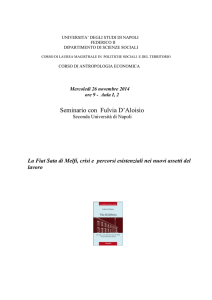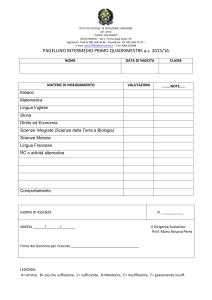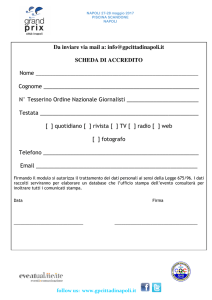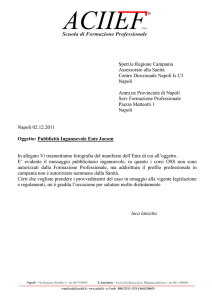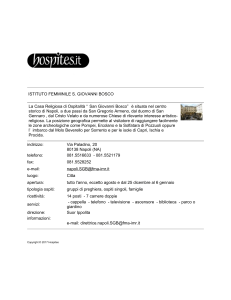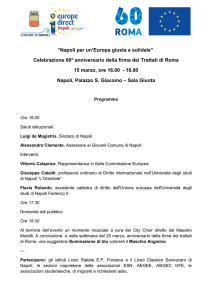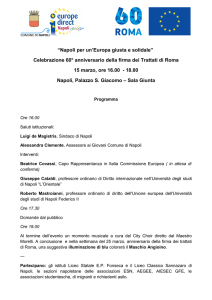Napoli
Parte III
Posillipo
Edificato per volere di Gioacchino Murat nel 1812-23, si arrampica sul
promontorio che separa il golfo di Napoli da quello di Pozzuoli ove già i
Romani fecero costruire le loro ville. Il nome Posillipo deriva dal greco
«pausilypon» (che calma il dolore) ed è evidentemente riferito alla
bellezza dei panorami.
Lungo la salita si incontrano raffinate residenze: il Palazzo di Donn'Anna,
costruita nel 1642 da Cosimo Fanzago per Anna Carafa, moglie del
viceré, rimasto incompiuto, appare oggi come un suggestivo rudere che si
specchia nel mare. Presso il quadrivio del Capo si apre il panorama
immortalato dai vedutisti settecenteschi. Altro luogo di suggestive
vedute e il parco di Posillipo; dalla rupe di Coroglio lo sguardo si spinge dai
vicinissimi golfi di Napoli e Pozzuoli ai Campi Flegrei, a Baia e Ischia e, sul
versante opposto, a Capri, alla penisola sorrentina e al Vesuvio.
Chiesa dei Girolamini
La chiesa fu edificata nel 15921619 dal fiorentino G.A. Dosio
ed è compresa nel grande
convento degli oratoriani.
La facciata venne modificata da
Ferdinando Fuga nel 1780;
eccezionale per l'omogeneità
delle decorazioni, l'interno è
opera di artisti di estrazione
tosco-romana ed emiliana (di
Pietro da Cortona è il S. Alessio moribondo nella prima cappella destra; di
Guido Reni e il S. Giovanni Battista nella sagrestia) e napoletana (di Luca
Giordano è la Cacciata dei profanatori dal tempio, nella controfacciata; di
Giovanni Bernardino Azzolino la Madonna della Vallicella, sull'altare
maggiore; di Giuseppe Sammartino gli angeli reggitorcia, collocati ai lati
del presbiterio).
Il convento accoglie una Pinacoteca con numerosi dipinti seisettecenteschi (opere di Guido Reni, Luca Giordano e lo Spagnoletto) e
Girovagando – Napoli – Parte III
17
una biblioteca, notevole sia per l'ambiente, settecentesco, sia per la ricca
dotazione.
Il rione sanità e il suo principe plebeo
La chiesa di S. Maria della Sanità da nome a uno dei quartieri più popolari
di Napoli. Se non si hanno i minuti contati vale la pena visitarlo, per alcuni
monumenti senza dubbio, ma anche per l'atmosfera verace che vi regna.
A sostegno di quest'ultima dichiarazione basti dire che uno dei suoi figli,
se non il più illustre certo il più noto, e il principe Antonio De Curtis, in
arte Toto, che nacque nel 1898 in una casupola di via S. Maria
Antesaecula.
Re dell'avanspettacolo e del cinema di cassetta ma anche sensibile autore
di poesie come 'A livella e di canzoni come Malafemmena, vi è ricordato
da un busto in bronzo, collocato dall'Associazione De Curtis, creata dalla
figlia Liliana, promotrice di tante iniziative in memoria del padre. La più
importante, è l'apertura, nel
Palazzo dello Spagnolo, del
Museo Toto, pensato come
centro culturale ma anche
come laboratorio di attività
artistiche per i ragazzi del
rione. Un'attenzione, questa,
in cui si riconosce il tratto
più
tipico
della
figura
teatrale e umana di Toto,
personaggio emblematico tanto per la tenace ricerca di sue origini nobili
quanto per l'attaccamento ai vicoli e alla povera gente della sua gioventù.
Identificare Antonio De Curtis con la sua città non è esagerato; i
napoletani, più che ammiratori del principe-attore, ne sono devoti. Basta
andare alla sua tomba, nel piccolo cimitero del Pianto, sulla strada per
Poggioreale, dove ogni giorno la gente lascia decine di biglietti rivolti al
comico morto nel 1967. Un'antologia spontanea del sentimento
partenopeo.
La rivolta dei poveri
In una Napoli stremata dalle continue epidemie e affaticata dalle crisi
economiche e dalle tasse, la rivolta del luglio 1647, mentre in Europa la
Girovagando – Napoli – Parte III
18
guerra dei Trent'anni volgeva al termine, fu certamente l'insurrezione più
eclatante ma non la sola e, come le altre, non portò alcun cambiamento.
La capeggio un pescivendolo di ventisette anni il cui nome sarebbe
divenuto sinonimo di pazzo e agitatore: Masaniello. Tomaso Aniello da
Amalfi si era ritrovato quasi per caso alla testa dell'ennesimo moto
popolare: fattosi nominare capo degli Alarbi (i monelli che battagliavano
alla giostra in occasione della festa della Madonna, il 16 luglio), sobillò la
gente
del
Mercato
contro i gabellieri. La
rivolta
crebbe
in
brevissimo tempo e
Masaniello
si
vide
catapultare
da
vincitore, anche grazie
ai suggerimenti del
giurista Giulio Genoino,
davanti al viceré, il
quale
lo
nomina
capitano generale del
popolo. Un tale balzo,
racconta la storia, lo fece uscire pazzo, costringendo i suoi stessi amici a
sbarazzarsi di lui; fu ucciso il 16 luglio, nel monastero del Carmine, e la
sua testa portata alla reggia.
Il tripudio del popolo, sempre pronto ad acclamare un nuovo vincitore, fu
ripagato con un rincaro del prezzo del pane. Il popolo allora capì; corse a
ricomporre i resti del suo condottiero. Masaniello fu sepolto con tutti gli
onori nella chiesa del Carmine.
Presepe settecentesco
La rappresentazione scultorea della nascita di Gesù in uno spazio e una
scenografia reali ha origini antiche, basti pensare al presepe di Arnoldo
di Cambio (XIII secolo) in S. Maria Maggiore a Roma. Ma è nella Napoli
del Settecento che si diffonde il presepe, forma d’arte "minore" in
contrasto con il razionalismo e il senso della misura tipici del secolo.
Girovagando – Napoli – Parte III
19
Il presepe napoletano è un gioco per il quale la nobiltà paga orafi,
intagliatori e ceramisti perché
creino scenari sempre più
complessi.
La scena della Natività vera e
propria restava idealmente al
centro, ma la rappresentazione
comprendeva ormai altri episodi
biblici, scene di vita quotidiana e di guerra; il mondo girava
vorticosamente intorno al mistero della nascita di Cristo.
Il presepe napoletano
Le prime testimonianze del presepe napoletano risalgono all'alto medioevo
e si sa con certezza che nel 1340 la regina Sancia d'Aragona fece dono
di un presepe alla nuova chiesa di S. Chiara. Povertà e semplicità erano i
caratteri essenziali dei presepi medievali, che s'ispiravano nell'umile
rappresentazione
della
Natività ai presepi viventi
ideati da San Francesco.
Ma è solo nel XVIII
secolo che nel Regno di
Napoli, per iniziativa di re
Carlo I di Borbone,
prende forma una vera e
propria arte presepiale,
fondata su una tecnica precisa e su una vivace e ricca ambientazione che
trae spunto dalla mescolanza tra sacro e profano e da un'aderenza laica e
quasi teatrale alla quotidianità. Compaiono nel presepe le statuine dei
personaggi del popolo: osti, ciabattini, pescatori, nani, arrotini e
tavernari, ossia il variegato mondo degli umili in cui nasce Gesù. Fanno da
cornice alle scene resti di templi greci e romani, a simboleggiare il trionfo
del Cristianesimo sulle rovine di religioni e divinità pagane. Significati
particolari vengono attribuiti a ciascun personaggio del presepe, e ai
singoli elementi che compongono l'intero quadro. Così il pescatore e
simbolicamente il pescatore di anime e i due compari, zi' Vicienzo e zi'
Pascale, la personificazione del Carnevale e della Morte.
Girovagando – Napoli – Parte III
20
La zingara, con la sua cesta piena di arnesi di ferro, che ricordano i chiodi
della crocifissione, predice con la sua presenza la morte di Cristo, mentre
l'acqua del fiume e un elemento spesso presente nell'iconografia che
ricorda la morte e la rinascita divina. Il realismo della composizione,
elemento distintivo dell'arte presepiale napoletana, e accentuato inoltre
dalla presenza sulla scena di personaggi della contemporaneità, abitanti di
un mondo in continua trasformazione nato dalla fantasia, ma anche
dall'acuto umorismo e spirito d'osservazione, dei maestri presepiai
napoletani.
Canta Napoli
Le ineffabili sensazioni di una passeggiata sotto le pergole maiolicate del
Chiostro delle clarisse sono state celebrate da Michele Galdieri nella
famosa canzone Munasterio 'e Santa Chiara. Il rischio corso dall'autore
era tremendo; la banalità. Eppure egli è riuscito a creare un piccolo
gioiello. La tanto discussa e, talora,
vituperata canzone napoletana deriva dal
melodramma e vanta musicisti e parolieri
fra i migliori del secondo Ottocento. Come
Teodoro Cottrau, che con Santa Lucia e
Addio mia bella Napoli può dirsi l'inventore
del nuovo stile, o Eduardo Di Capua, autore
di 'O sole mio. O ancora come Salvatore Di
Giacomo, che Benedetto Croce collocò nel
consesso dei grandi poeti italiani, autore
dei versi di 'A Marechiare e di 'E spingole
frangese.
Certo, vi furono anche autodidatti come Ernesto De Curtis che scrisse un
capolavoro come Voce 'e notte, ma ciò non toglie niente, semmai aggiunge
un tocco di pittoresco a un genere che ha goduto di un favore interrotto
solo dal prepotente ingresso dei ritmi americani. Oggi, dopo un lungo oblio,
la canzone napoletana e di nuovo in auge per merito dei veterani, ma anche
di più giovani eredi, come Pino Daniele, Edoardo Bennato, Teresa De Sio,
Toni Esposito ... Autori e interpreti che sposano la canzone napoletana con
ritmi e sonorità oggi in voga.
Girovagando – Napoli – Parte III
21
Nel teatro di Eduardo la Napoli che cambia
Che Napoli, nel bene e nel male, sia un teatro non c’è alcun dubbio. E che
Eduardo De Filippo (1900-1983) sia uno dei capocomici più geniali che ne
abbiano calcato le scene è altrettanto certo. Figlio d'arte - nacque dalla
relazione tra Luisa De Filippo ed Eduardo Scarpetta, l'inventore della
maschera di Felice Sciosciammocca - già da bambino recitò in varie
compagnie e presto entrò in pianta stabile in una di esse; da qui alla prima
esperienza come autore il passo
fu breve. Distinguendosi sia dal
teatro comico del celebre
padre, sia da quello populista di
Viviani, sia da quello "d'arte",
Eduardo compie il disincantato
esame della quotidianità, dei
fatti, piccoli ma rivelatori, che
mettono
in
risalto
le
contraddizioni del vivere, il
tutto sempre legato da un umorismo tragicomico, venato da un acuto
senso dell'assurdo.
La produzione di Eduardo si divide in due grandi periodi: la prima, che
egli definì «Cantata dei giorni pari» (Uomo e galantuomo, 1922; Ditegli
Sempre di Si, 1932; Natale in casa Cupiello, 1931) riunisce i lavori
precedenti la seconda guerra mondiale e corrisponde alle messe in scena
della compagnia fondata con i fratelli Peppino e Titina verso il 1930. La
seconda, la «Cantata dei giorni dispari» (Napoli milionaria, 1945;
Filumena Marturano, 1946; De Pretore Vincenzo, 1957; Sabato, domenica
e lunedi, 1959) rappresenta una rottura netta con il mondo teatrale
precedente e comprende le commedie scritte dopo la guerra, che sono
testimonianza della crisi della società napoletana del tempo e in cui si
assiste alla rimozione dei valori tradizionali senza che ne sorgano di nuovi.
Qui Eduardo tratteggia, in modo lucido e disincantato, un mondo che non
regge alla novità, che si sgretola nel suo elemento fondamentale, la
famiglia. Un grido d'allarme che non riguardava solo Napoli.
Girovagando – Napoli – Parte III
22
Pulcinella
Il teatro è una componente vitale dello spirito e della cultura di Napoli.
Uno dei suoi più emblematici protagonisti è Pulcinella, forse erede di
Maceo, la maschera nella quale le atellane, antiche farse di origine italica
ben note a Roma, identificavano lo stupidotto. Secondo un'altra ipotesi,
accreditata da Benedetto Croce, Pulcinella (che a Napoli e chiamato
"Polecenella") nacque solo nel Seicento e il suo nome sarebbe la
deformazione di quello di un certo Puccio D'Aniello. Dominato da una fame
atavica che orienta i suoi (pochi) pensieri e guida ogni sua azione.
Pulcinella, più che essere espressione dell'uomo comune, incarna il bisogno
allo stato puro, assolutamente privo della mediazione del pensiero.
Tra i molti angoli segreti
di Napoli, i chiostri riservano sempre qualche sorpresa. Spazi che
scandivano la vita monastica, con il tempo hanno perso il disegno primitivo
e la loro aura ascetica per trasformarsi in fastose quinte teatrali
dell'architettura barocca e rococò.
I chiostri del XVII e XVIII secolo
sono decisamente “laici" e in essi
divengono fondamentali elementi
tipici del gusto settecentesco: il
verde, come l'oasi improvvisa del
chiostro di S. Paolo Maggiore, e il
paesaggio, per il quale capita (e il
caso del chiostro della chiesa dei
SS. Marcellino e Festo) che si
rinunci a un'ala pur di aprirsi sul mare.
Girovagando – Napoli – Parte III
23