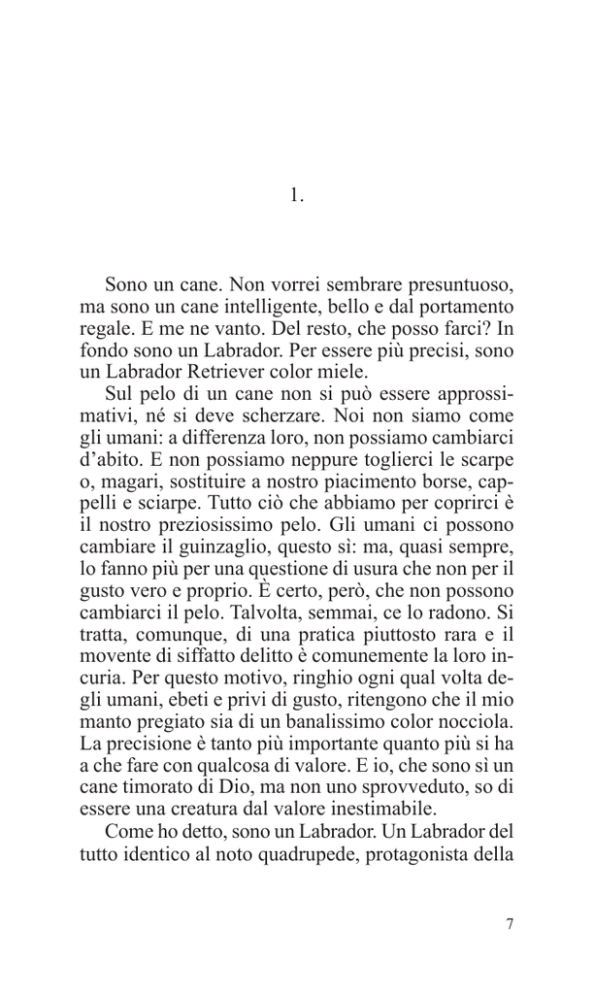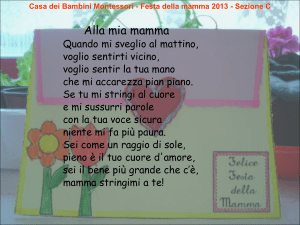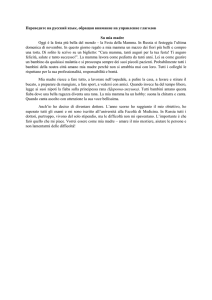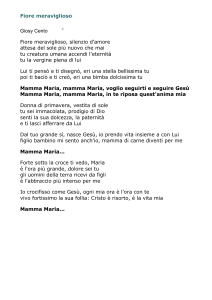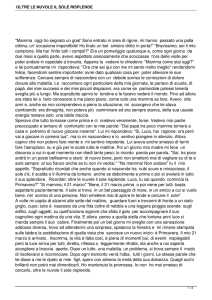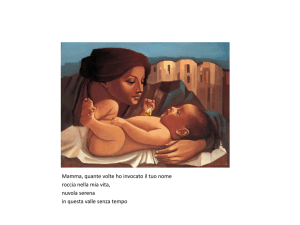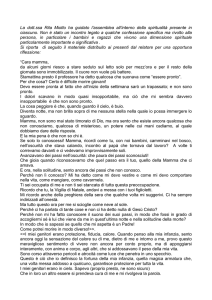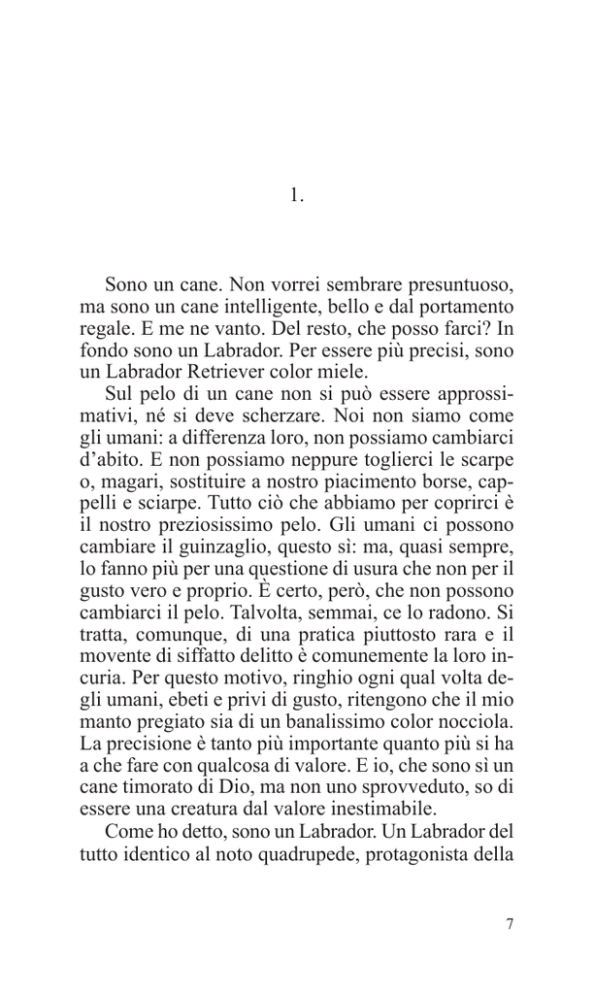
1.
Sono un cane. Non vorrei sembrare presuntuoso,
ma sono un cane intelligente, bello e dal portamento
regale. E me ne vanto. Del resto, che posso farci? In
fondo sono un Labrador. Per essere più precisi, sono
un Labrador Retriever color miele.
Sul pelo di un cane non si può essere approssimativi, né si deve scherzare. Noi non siamo come
gli umani: a differenza loro, non possiamo cambiarci
d’abito. E non possiamo neppure toglierci le scarpe
o, magari, sostituire a nostro piacimento borse, cappelli e sciarpe. Tutto ciò che abbiamo per coprirci è
il nostro preziosissimo pelo. Gli umani ci possono
cambiare il guinzaglio, questo sì: ma, quasi sempre,
lo fanno più per una questione di usura che non per il
gusto vero e proprio. È certo, però, che non possono
cambiarci il pelo. Talvolta, semmai, ce lo radono. Si
tratta, comunque, di una pratica piuttosto rara e il
movente di siffatto delitto è comunemente la loro incuria. Per questo motivo, ringhio ogni qual volta degli umani, ebeti e privi di gusto, ritengono che il mio
manto pregiato sia di un banalissimo color nocciola.
La precisione è tanto più importante quanto più si ha
a che fare con qualcosa di valore. E io, che sono sì un
cane timorato di Dio, ma non uno sprovveduto, so di
essere una creatura dal valore inestimabile.
Come ho detto, sono un Labrador. Un Labrador del
tutto identico al noto quadrupede, protagonista della
7
Omar Kamal
pubblicità di una celebre carta igienica. Ovviamente,
durante la mia infanzia, non avevo idea di che cosa
fossero la televisione, la pubblicità o – figuriamoci
– la carta igienica. Almeno fino a quando non me
lo spiegò mia madre. Un bel dì, mamma mi disse
che appartenevamo a una razza piuttosto amata dagli
umani: il grande merito di tanta benevolenza, a suo
dire, era della pubblicità. Mamma m’informò dell’esistenza di un accrocco di plastica e vetro che prendeva il nome di televisione: un aggeggio presente in
modo capillare nelle case dei bipedi. Mi raccontò
che in alcune abitazioni le televisioni potevano arrivare anche a tre, se non addirittura a quattro unità.
Da questo accrocco, mamma diceva che fuoriuscivano prevalentemente un sacco di stupidaggini, capaci
però di distrarre e attrarre al tempo stesso gli umani:
l’accrocco veniva guidato da un altro aggeggio noto
come “telecomando”. Usando per lo più il pollice
opponibile, gli umani potevano cambiare canale e
quindi frequenza da cui ricevere le stupidaggini che
più gradivano.
Fra una stupidaggine e l’altra, l’accrocco di plastica
e vetro sputava fuori la cosiddetta pubblicità, detta anche “reclame”, “suggerimento commerciale”,
“consiglio per gli acquisti”, o più semplicemente “spot”. Tra questi ne compariva frequentemente
uno particolarmente grazioso commissionato da tale
“Scottex”, che si avvaleva della collaborazione di
un cucciolo di Labrador Retriever color miele, per
reclamizzare il proprio prodotto. “Fico” dissi a mia
madre, la quale subito dopo mi spiegò cosa fosse la
carta igienica e a cosa servisse. Dopo aver appreso la
notizia, passai un mese della mia vita a camminare
8
Artù alla conquista del mondo
mogio per casa: mi sentii apparentemente disorientato e incredulo. Nonostante i miei sforzi, non riuscivo
a comprendere che legame logico ci potesse essere
fra un Labrador e la carta igienica. Per quanto fossi
di mentalità aperta, immaginavo che ciò che non era
indispensabile per i Labrador non dovesse esserlo
neppure per quei goffi bipedi.
Mamma – davvero onnisciente – mi disse che
quella pubblicità andava in voga dalla fine dagli anni
’80, non prima però d’aver usato come apripista un
meticcio di nome Spino. Un bastardo senza arte né
parte che serviva soltanto per fornire l’assist al cucciolo di Labrador. Mentre Spino era l’esca, il Labrador doveva occuparsi del lavoro pesante. Lo spot era
piuttosto banale ma efficace. Il cucciolo, una volta
in azione, non faceva altro che dimenarsi con patetiche piroette dentro la carta igienica, mentre una voce
insopportabile cantava un motivetto altrettanto ignobile. Alla fine del numero da circo, quel quadrupede
declassato a beota se ne andava via col rotolo di carta
igienica in bocca accompagnato da un semplice effetto dissolvenza. Non posso negare che inizialmente
presi a odiare quel ciuco camuffato da Labrador: soltanto in un secondo momento riuscii a razionalizzarlo. Mi dissi “poco male, il beota si è immolato quale
nostro cavallo di Troia”. Di fatto, da quel momento
in poi, la nostra razza iniziò a godere di fama, onore
e gloria: proprio per merito di quell’incomprensibile
spot pubblicitario, che reclamizzava un prodotto a
mio avviso inutile, attraverso un insulso accrocco di
plastica e vetro. Rendermi conto che da quel concentrato di stupidità era nata la nostra notorietà, rischiò
più volte di farmi venire un esaurimento.
9
Omar Kamal
Da che sono nato, ho sempre vissuto a Roma, città
infernale per il traffico e gli schiamazzi. Appresi –
non più da mia madre, quanto dall’accrocco di plastica e vetro – che in realtà la “Città Eterna” era la
più importante fra le capitali d’Europa. Se non altro,
per la sua storia. Lo scoprii da una trasmissione televisiva sul primo canale condotta da un signore anziano molto bene educato: parlava entusiasta dei fasti di
una grande civiltà – quella dei romani – ormai irrimediabilmente decaduta. Il mio unico rammarico era
che tanta magnificenza avesse avuto come simbolo
una lupa spelacchiata. Un Labrador sarebbe stato
certamente più elegante.
Fin da piccolo, mamma mi raccontò che ero l’ultimo nato di una cucciolata di sei Labrador di razza
purissima. Fra questi io fui l’unico ad avere il privilegio di restare con mamma. Papà non lo rividi per
almeno due anni. Se n’era andato prima del parto.
Lui, fulgido esempio di padre coraggio. “Curioso”
pensai “come un cane possa esser di razza e bastardo
al tempo stesso”.
I miei fratelli vennero tutti quanti venduti, un po’
come ai tempi dello schiavismo coloniale: si trattava di quattro maschi e una femmina. Scoprii che gli
umani che li comprarono li chiamarono rispettivamente Frodo, Lenny, Vasco, Rocco e Luna. A mia
madre, per inciso, diedero il nome più originale: Dorothy. Le diedero lo stesso nome di Dorothy Gale,
la protagonista di un celebre libro di un umano di
nome Frank Baum, intitolato Il meraviglioso mago
di Oz. Di questo libro gli umani fecero un film trasmesso anche dall’accrocco di plastica e vetro. Una
cosa avevo appreso con certezza degli umani: non
10
Artù alla conquista del mondo
accettavano che la carta non finisse in qualche modo
in televisione.
Vivevo in una villetta disposta su due piani con un
bel pezzo di terra che circondava l’intera proprietà. Di
prim’acchito pareva che la mia esistenza fosse quella
di un Labrador borghese che conduceva una vita agiata, ma non era così. Ad esempio, l’insulso pezzo di
terra che gli umani erano soliti chiamare giardino, per
noi altro non era che un territorio inospitale. Tant’era
tenuto male, che era e restava soltanto un miserabile
pezzo di terra, con qualche albero da frutta piantato
qua e là senza alcuna logica. In un angolo di quella
selva c’era anche la mia cuccia, che per motivi di praticità dividevo con mamma.
Durante i primi mesi di vita, non provai alcun desiderio d’indipendenza nei confronti di Dorothy. In
fondo eravamo madre e figlio e fra noi non c’erano
particolari problemi di convivenza. Nessun tipo di
attrito. Soltanto una volta raggiunta la maturità sessuale, mi accorsi di avere i turbamenti di uno stallone racchiusi dentro il corpo di un Labrador. Il primo
raptus mi colse violentemente dopo un anno di vita:
era da poco iniziata la primavera e in quel periodo
sentivo i miei ormoni prendere il sopravvento sulla mia mente. Fu da quel momento che i problemi
se li pose qualcun altro. I nostri padroni umani, ad
esempio. Una coppia di anziani, che avevano ricevuto Dorothy come dono dal loro unico figlio, emigrato
da anni nella campagna toscana. I due si chiamavano
Bernardo e Rossella. Due nomi che io e mamma abbreviammo con Bern e Ross.
Un bel giorno – di prima mattina – Bern sollevò
mamma da terra proprio mentre le stavo girando in11
Omar Kamal
torno, preso da uno dei miei incontrollabili impulsi
ormonali. La fece salire nella sua macchina, una vecchia Fiat 500 color grigio topo. La Fiat 500 era una
bella auto d’epoca, profondamente chic, ma purtroppo priva di qualsiasi comfort. Anche un cane snob
e anticonformista come me alla fine dovette riconoscerlo. Mamma si sedette sui sedili posteriori, quindi
mi fissò dal micragnoso finestrino posteriore della
500. Io rimasi immobile, impietrito. Neppure un
latrato. La guardai standomene seduto sulle zampe
posteriori, con il collo piegato a sinistra, un orecchio
alto e uno abbassato. Rimasi esterrefatto. Per la prima volta in un anno di vita stavo per rimanere senza
Dorothy. Prima di allora non mi era mai successo
di passare neppure un minuto senza di lei e in quel
momento, impotente, vedevo Bern che se la stava
portando via. Lui, il mio vecchio e saggio padrone,
ai miei occhi si era tramutato in un orco. Preso dall’istinto e dalla disperazione provai a correre verso il
trabiccolo di Bern abbaiando a squarciagola, ma era
ormai troppo tardi. Bern mise in moto quel suo vecchio catorcio e se ne andarono via. Mamma mi guardò incupita, con occhi sottili e volti verso il basso.
“Dove diavolo la starà portando?” pensai. Tentai di
scagliarmi fuori dal cancello, ma tutto ciò che ottenni fu andare a sbattere rovinosamente contro la ringhiera di casa. Il mio patetico tentativo di liberazione
fu rovinato da sbarre altrettanto patetiche, oltretutto
vecchie e arrugginite.
Data l’eccezionalità del momento, Ross mi fece
entrare in casa. Mi resi subito conto che si trattava di
un caso del tutto singolare. Generalmente io e mamma potevamo godere di tale concessione soltanto nei
12
Artù alla conquista del mondo
giorni di pioggia. Giorni in cui il nostro pezzo di terra
si trasformava inevitabilmente in una sorta di acquitrino, o peggio ancora in una vera e propria palude.
Trascorsi quella malinconica mattinata stando tutto
il tempo con Ross. Camminai per casa a zonzo e a
coda bassa, chiedendomi dove l’orco avesse trascinato mamma. Inspiegabilmente avvertii il mio cuore
battere all’impazzata: sembrava un tamburo che suonava violentemente e a intermittenza. Qualche giorno più tardi, Dorothy mi spiegò che quella sensazione prendeva il nome di “ansia”, una mistica inquietudine piuttosto insolita per noi cani, tant’è vero che
c’era stata trasmessa direttamente dagli umani. Una
sorta di pareggio, dato che noi potevamo passargli
la “rabbia”. Gli occhi docili e sottomessi di Dorothy
erano un’immagine che la mia mente non riusciva
a eludere. Li rivedevo in ogni angolo di quella così
vecchia, malconcia e vissuta casa: ma pur sempre intrisa dell’odore di cibo. L’unico artifizio capace di
distrarre i miei poco edificanti pensieri. Dentro casa
regnava l’odore del pranzo che Ross stava preparando. Ross era una cuoca sublime, una donna di quelle
che non si risparmiava sulle quantità: il suo pranzo
tipico era costituito da molte portate. Ma nonostante
questo lei era magra, perfettamente longilinea.
In cuor mio sperai che mamma fosse uscita per
rivedere finalmente papà. Il bastardo, senz’altro pure
un po’ ipocrita, che però, a giudicare dal mio aspetto,
doveva essere bellissimo. Fantasticavo: magari saremmo potuti tornare a essere una famiglia. Noi tre,
senza gli altri, troppo presi dal farsi una vita altrove.
In questo quadretto ideale sarei stato io l’unico a godere di papà e mamma.
13