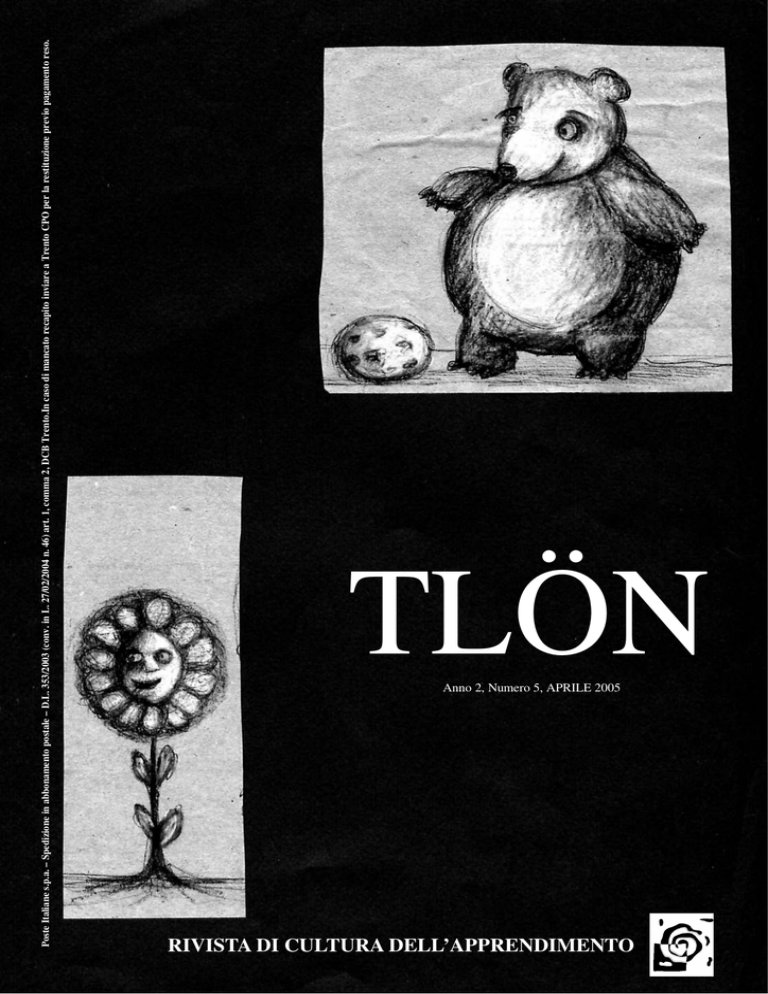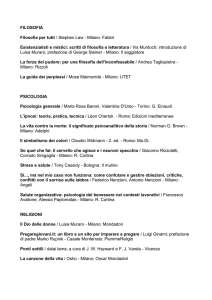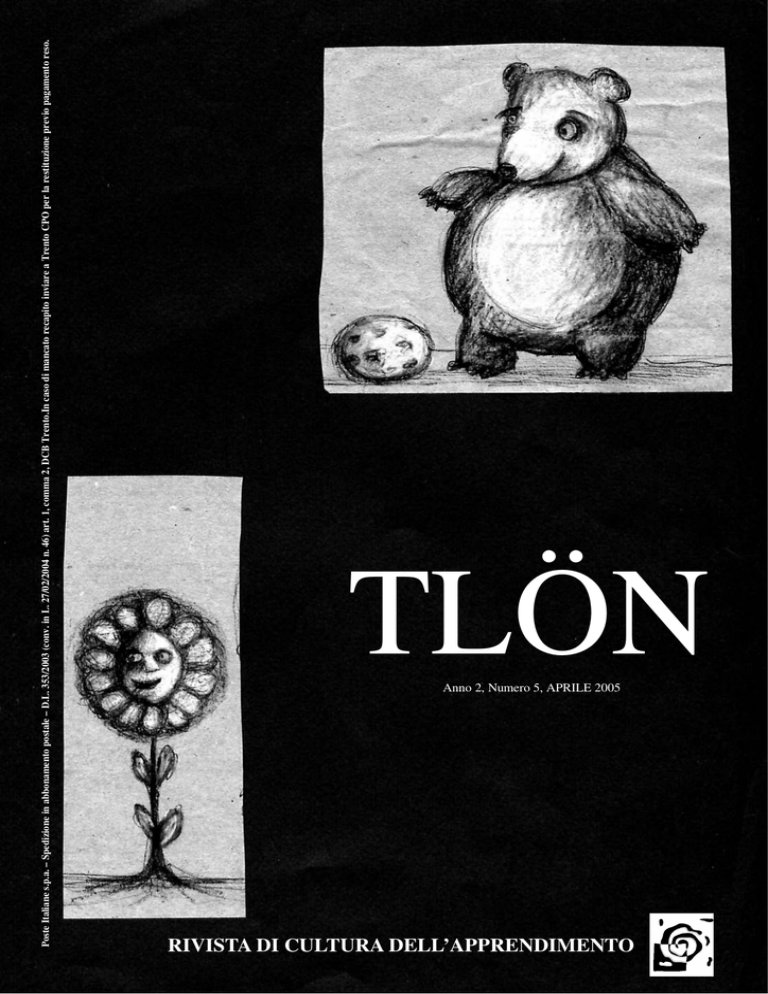
Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Trento.In caso di mancato recapito inviare a Trento CPO per la restituzione previo pagamento reso.
TLÖN
Anno 2, Numero 5, APRILE 2005
RIVISTA DI CULTURA DELL’APPRENDIMENTO
Che deve fare la psicologia
per diventare più utile
all'apprendimento a scuola?
In questo numero...
N
!
"
#
#
$#!
#
%
!
&
'
!
(
)
* +
-
,
)
el
mi o art icolo “La ps icol ogia
dell’appr endimento
è utile
alla
scuola?” (pubblicato nel numero scorso di
questa rivista) abbiamo visto una serie di
ragioni per cui la psicologia dell'
apprendimento serve poco
alla scuola. Quello che la psicologia deve fare se vuole
essere più utile a una scuola che ha molto bisogno di aiuto e
se vuole incidere in concreto sui modi in cui a scuola vengono
insegnate le diverse materie, è semplicemente cercare di
eliminare queste ragioni. Vediamo come.
Il cognitivismo ha rappresentato per molti aspetti un
passo avanti in psicologia, soprattutto perché ha permesso
alla psicologia di superare il divieto comportamentista di
studiare e fare ipotesi su quello che succede dentro
l’organismo quando arriva uno stimolo e l’organismo
risponde con un comportamento. Tuttavia, il cognitivismo
sembra avere ormai esaurito la sua spinta propulsiva,
soprattutto perché con il tempo è diventato sempre più chiaro
che l’analogia tra la mente umana e il computer, su cui si
basa il cognitivismo, è limitativa e per molti aspetti sviante.
Non si può pensare che un essere umano, tranne in casi
particolari, funzioni sulla base di simboli e rappresentazioni
simboliche simili a quelle di un computer, o seguendo regole e
procedure come fa un computer. La dimostrazione di quanto
sia inadeguata l’analogia “mente uguale computer” viene
proprio dall’apprendimento.
Come abbiamo visto, una delle ragioni per cui il
cognitivismo che ha dominato la ricerca in psicologia negli
ultimi decenni si è occupato poco dell’apprendimento è che
il computer è un sistema che non è portato di suo ad
apprendere, ma piuttosto ad essere programmato. Una delle
cose che la mente umana, a differenza del computer, fa
spontaneamente e sa fare meglio, è apprendere, e ciò dovrebbe
scoraggiare dall’affidarsi all’analogia “mente uguale
computer”.
D’altro canto, negli ultimi 10-20 anni in psicologia è
emerso un nuovo paradigma teorico e metodologico che
condivide con il cognitivismo il rifiuto del divieto
comportamentista di occuparsi di quello che succede dentro
la testa, ma interpreta quello che succede dentro la testa non
in analogia a ciò che succede dentro a un computer ma in
base a quello che esiste fisicamente dentro la testa: il
cervello. Si tratta del paradigma teorico delle reti neurali o
connessioniste, che sono modelli del
comportamento e delle attività cognitive
direttamente ispirati alle caratteristiche fisiche e al
modo di funzionare del sistema nervoso. Se per il
cognitivismo la “mente” si può e si deve studiare
ignorando il cervello, così come il software del
computer viene studiato e costruito dagli
informatici ignorando l’hardware del computer
studiato e costruito dai fisici elettronici, per le reti
neurali questo non è possibile. Il modo migliore
di studiare la mente è considerarla come un
cervello. Anche dal punto di vista del metodo il
paradigma delle reti neurali è diverso dal
cognitivismo. I cognitivisti costruiscono modelli
ispirati al computer ma poi li mettono alla prova
con i tradizionali esperimenti psicologici in
laboratorio. Le reti neurali sono invece modelli
simulativi, cioè modelli espressi come programmi
di computer. Se il computer non è più una fonte di
ispirazione (analogia) per capire come funziona la
mente, esso resta lo strumento pratico che serve a
fare girare le simulazioni. Una volta realizzata, una
simulazione diventa un laboratorio sperimentale
virtuale in cui il ricercatore osserva i fenomeni in
condizioni controllate, manipola queste
condizioni e osserva le conseguenze delle sue
manipolazioni (Parisi 2001).
Non entreremo qui nel merito dei modelli a
rete neurale, per i quali rimandiamo a Floreano
(1995) e a Parisi (1999). Quello che è importante
osservare è che per i modelli a rete neurale,
diversamente dai modelli cognitivisti,
l’apprendimento ha un ruolo centrale. Una rete
neurale sa fare un certa cosa, esibisce un certo
comportamento, non perché è stata programmata
in un certo modo, ma perché ha appreso a fare
quella cosa, a esibire quel comportamento, sulla
base di una lunga esperienza di apprendimento
entro le condizioni fissate dal ricercatore. Ci si
deve quindi augurare che con il progressivo
diffondersi dei modelli a rete neurale si riattivi
l’interesse degli psicologi per l’apprendimento.
Anche l’altra ragione per cui il cognitivismo
tende a ignorare l’apprendimento, e cioè il fatto che
le capacità cognitive tendono ad essere
interpretate dai cognitivisti, sulla scorta delle
teorie linguistiche di Chomsky, come
fondamentalmente innate e quindi tali da
svilupparsi senza un ruolo veramente
significativo
dell’esperienza
e
dell’apprendimento, viene ridimensionata nelle
nuove teorie connessioniste. È giusto cercare di
determinare quali sono le basi genetiche delle
capacità linguistiche umane, che certamente sono
importanti, ma non lo si può fare nel modo
puramente deduttivo e a priori tipico di Chomsky
e del cognitivismo in genere, e in particolare di
quella che oggi viene chiamata la “psicologia
evoluzionistica” (Parisi in corso di pubblicazione).
Non solo tutto fa pensare che l’esperienza e
l’apprendimento siano per lo meno altrettanto
importanti delle basi genetiche nello sviluppo
delle capacità umane, ma soprattutto è necessario
che le ipotesi sulle basi genetiche di questa o
quell’altra capacità, di questo o quell’altro
comportamento, e sulle condizioni evolutive che
ne sono la causa lontana, siano formulate in
modo dettagliato e soprattutto tale da poter essere
messe in qualche modo alla prova, non soltanto
con argomenti verbali ma con dimostrazioni
sperimentali.
Questa è la direzione in cui si muove la Vita
Artificiale, un’area di ricerca in cui rientrano le reti
neurali (Parisi 2000a). La Vita Artificiale studia
non soltanto, usando i modelli a rete neurale, il
sistema nervoso e il modo in cui il sistema nervoso
apprende capacità e comportamenti, ma studia
anche i processi di evoluzione biologica in
popolazioni di organismi che danno come
risultato le basi genetiche che contribuiscono a
determinare come il singolo individuo si
sviluppa e si comporta. In questo modo le ipotesi
sulle basi genetiche del comportamento possono
diventare esplicite, possono essere studiate le
complesse interazioni tra basi genetiche e
condizioni di esperienza (Elman, Bates,
Johnson, Karmiloff-Smith, Parisi e Plunkett
1996), e tutto questo può avvenire nelle
condizioni e con le manipolazioni sperimentali
rese possibili dalle simulazioni.
Ma l’adozione delle rete neurali e dei
modelli della Vita Artificiale non risolve certo il
TLÖN — Cultura dell’apprendimento è una pubblicazione trimestrale edita dall’Associazione di Promozione Sociale Tlön. Direttore: Gabriele
Lo Iacono. Direttore responsabile: Anna Lo Iacono. Comitato di redazione: Marina Manotta, Anna Brunori, Chiara Cannerozzi, Alessandra
Gasperi, Barbara Lamedica, Susanna Meržeck Masu, Luigi Ranzato. Grafica e impaginazione: Gabriele Lo Iacono. Illustrazione di copertina: Michela Bresciani. Fotografie: Gabriele Lo Iacono. Redazione: Associazione Tlön, Via V. Veneto n. 146, 38100 — Trento. E-mail: [email protected]. Tel. e fax: 0461 920946. TLÖN ONLINE: http://xoomer.virgilio.it/tlon
Stampato a Trento da Rotooffset Paganella nel mese di giugno 2005. Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 1206 del 25 /03/04 Per ricevere Tlön contatta la
redazione!
/00/1
2
.
.
problema della limitata rilevanza della psicologia dell’apprendimento per
la scuola. Le reti neurali sono modelli molto semplificati
dell’apprendimento e appartengono ancora oggi alla ricerca “di base”
piuttosto che a una ricerca applicata a problemi e a condizioni concrete,
come richiederebbe una psicologia dell’apprendimento utile alla
scuola. Quello che è necessario è che, superando la scarsa propensione
della psicologia cognitivista a studiare l’apprendimento, gli psicologi si
rimettano a studiare nel dettaglio e nelle loro caratteristiche specifiche,
e che variano da materia scolastica a materia scolastica, e cosa
chiediamo veramente agli studenti di fare e di imparare quando li
teniamo per ore in classe. Quello che i comportamentisti hanno
scoperto sull’apprendimento in generale sulla base dei loro
esperimenti con gli animali può essere utile ma non è sufficiente.
Sia il cognitivismo che le reti neurali possono offrire suggerimenti e
idee utili ma il grosso del lavoro è ancora da fare.
Quella che vogliamo suggerire è una strada che gli psicologi
dell’apprendimento dovrebbero seguire se vogliono essere utili alla
scuola, una strada che oggi è resa possibile e anzi richiesta dalle nuove
tecnologie digitali. Invece di studiare in astratto, o magari in condizioni
sperimentali necessariamente artificiose, i processi mentali coinvolti
nell’apprendimento delle diverse materie scolastiche, gli psicologi
dovrebbero diventare membri di équipes che hanno il compito di
costruire effettivi sistemi basati sulle nuove tecnologie digitali
(multimedialità, ipertesti, Internet, simulazioni) e realizzare
concretamente applicazioni che producano dimostrabilmente risultati
interessanti in termini di apprendimento nel campo della
matematica, della storia, delle scienze, e delle altre materie scolastiche.
Come si è detto, le nuove tecnologie digitali hanno grandissime
potenzialità dal punto di vista dell’apprendimento, ma il problema è
riuscire a individuare e a realizzare queste potenzialità. Tra le loro
potenzialità più importanti da sfruttare ci sono la loro interattività e il
loro non fare affidamento sul linguaggio come canale di
apprendimento. Chiudiamo questo articolo con qualche commento su
queste due caratteristiche delle nuove tecnologie digitali.
Interattività significa che l’informazione che di momento in
momento arriva allo studente è strettamente dipendente da quello che
lo studente fa. Anche la navigazione di un ipertesto o su Internet è
interattività, ma le nuove tecnologie permettono di andare molto al di
là di questo tipo primitivo di interattività in cui l’utente decide solo
quale informazione gli arriva subito dopo ma poi interagisce in modo
tradizionale con tale informazione (tipicamente legge un breve testo e
guarda una figura o una animazione). L’interattività più promettente
dal punto di vista dell’apprendimento è quella in cui il computer
incorpora un modello di qualche aspetto, meccanismo, processo della
realtà e l’utente interagisce con tale modello nello stesso modo in cui
interagisce con la realtà, cioè compiendo azioni sul modello (sulla
realtà) e osservando le conseguenze delle sue azioni sul modello (sulla
realtà).
I ragazzi a scuola hanno difficoltà, per ragioni cognitive o per
ragioni di scarsa motivazione, a imparare la matematica (aritmetica e
geometria), l’italiano in quanto comprensione dettagliata di un testo, la
storia, le scienze. Per tutte queste materie non è difficile pensare a usi
del computer in cui si realizzino le condizioni di interattività che
2
abbiamo visto. L’importante è:
a)
rendersi conto che il computer offre
possibilità di fornire all’utente una varietà
di tipi di informazione, di ricevere azioni
dell’utente, di reagire a queste azioni, in
modi neppure lontanamente immaginabili
con gli artefatti tecnologici tradizionali (ad
esempio un libro, compreso un libro di
esercizi), e
b)
riuscire a sfruttare queste possibilità.
Accanto al grafico, al programmatore, al
realizzatore di interfacce, il compito dello
psicologo è quello di immaginare,
analizzare, progettare e realizzare quello
che dovrebbe accadere nella interazione
tra lo studente e il computer in modo che
questa interazione pr oduca gli
apprendimenti desiderati.
L’altra grande potenzialità offerta
dalle nuove tecnologie digitali ai fini
dell’apprendimento è quella che consiste
nell’aggiungere un importante canale del vedere e
del fare al predominante e praticamente
esclusivo canale del linguaggio come strumento di apprendimento. Molti dei problemi di
apprendimento e di motivazione dei ragazzi oggi
derivano da questo affidarsi esclusivamente al
linguaggio che caratterizza la scuola tradizionale, i
suoi strumenti didattici, la formazione degli
insegnanti, la stessa “cultura” della scuola. Il
problema è complesso e l’abbiamo discusso altrove
(Parisi 2000b). Anche se chi è cresciuto nella
cultura tradizionale ha difficoltà ad ammetterlo, il
linguaggio ha dei limiti come strumento di
apprendimento, sia nella scuola in generale perché
può dar luogo a apprendimenti e a comprensioni
puramente verbali e meccaniche, sia soprattutto in
una scuola che, come quella di oggi, si rivolge a
tutti i ragazzi, con diverse capacità linguistiche e
diverse motivazioni ad apprendere. D’altro canto,
una delle caratteristiche delle nuove tecnologie
digitali è che queste tecnologie amplificano di
molto le possibilità dei canali non verbali del
vedere e del fare rispetto alle tecnologie del passato,
e perciò non ha più senso affidarsi unicamente al
linguaggio come accadeva in passato perché allora
il linguaggio era l’unico strumento di
apprendimento sufficientemente flessibile e
usabile. Il compito degli psicologi è indicare in
concreto, con esempi, realizzando specifiche
applicazioni, come sfruttare queste possibilità ai
fini dell’apprendimento.
D’altro canto non si deve pensare che il
linguaggio e il vedere e il fare siano necessariamente
in contrasto tra loro. Lo scenario è quello di una
interazione a tre: lo studente, la simulazione
(essenzialmente non verbale) e l’insegnante. Lo
studente impara e capisce interagendo con la
simulazione, che è qualcosa di essenzialmente non
verbale, ma l’insegnante ha il compito di introdurre
le espressioni e le formulazioni verbali che
permettono allo studente di trasportare quello che
impara sul piano di quella conoscenza e
comprensione riflessa e comunicabile che è
possibile solo con il linguaggio. I vantaggi di
questo sistema integrato sono altrettanto importanti
per le capacità linguistiche degli studenti che per i
contenuti che essi vanno imparando. Il linguaggio
emerge, nella specie e nell’individuo, perché è
integrato con l’esperienza del vedere e del fare. Solo
a scuola pretendiamo che le capacità linguistiche
crescano da sole, lontano dal vedere e dal fare. Le
nuove tecnologie permettono di superare questo
limite. Con le nuove tecnologie i concetti astratti
possono venir acquisiti nell’ambito di una
esperienza che, per quanto simulata, è una
esperienza del vedere e del fare.
La bibliografia di questo articolo è disponibile
presso la redazione.
Domenico Parisi, dirigente di ricerca all’Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, insegna Psicologia generale presso la LUMSA a Roma
e dirige la rivista “Sistemi intelligenti”.
Psicoterapia, valori, utopia
C
ent’anni di psicoterapia e il mondo va
sempre peggio". Con questo titolo
James Hillman ha "celebrato" qualche
anno fa in un libro il centenario della
psicoterapia in generale e della psicoanalisi,
psicoterapia prima (in ogni senso), in particolare.
E’ chiaro in questo titolo l’intento critico
dell’autore che sottolinea il fallimento della
psicoterapia nella realizzazione delle sue
promesse. Ma quali erano realmente le sue
promesse? Il fatto che si supponga che una
pratica clinica debba avere una influenza
sull’andamento del mondo è disvelatore della
carica utopica che la permea e ci permette di
effettuare un parallelismo fra teoria del
cambiamento umano e teorie del cambiamento
sociale, ovvero politiche.
La storia della psicoterapia è infatti, come
quella delle dottrine politiche, una successione di
utopie. Il parallelismo, apparentemente ardito,
appare proponibile allorquando si ragioni su una
serie di fatti. Il primo è che ogni teoria
psicologica è un'
ipotesi sull'
uomo e, in quanto
tale, un'
idea del mondo. Ogni psicoterapia,
quindi, veicola tale ipotesi e si fa partigiana di
questo mondo. In pratica, ogni teorizzazione
politica o psicologica presuppone una lettura del
mondo e dell’uomo assolutamente specifica e
differente dalle altre e difficilmente invalidabile
dall’esterno, ossia è frutto di un’ episteme
incommensurabile. Letture che sono strettamente
collegate ad alcuni "valori", essi stessi
incompatibili. L’uomo freudiano, ad esempio, è
intrinsecamente hobbesiano, legato ad un'
idea di
uno stato di natura di guerra perenne, di un uomo
individualista e di una repressione benigna da cui
deriverebbe la civiltà ed il suo "disagio", di una
libertà quindi "negativa" (nel senso di Berlin),
pertanto incompatibile con quello di Marx o di
Rousseau, strutturalmente sociale e legato ad un
concetto di libertà "positiva", cui è legata la
teorizzazione di tanta psicologia umanistica. Con
1
buona pace di Fromm e di tutta la scuola di
Francoforte che - utopia - professava una
convergenza freudo-marxista e vagheggiava altra utopia - socialismi umanistici e superamenti
del "principio di prestazione", ovvero
l’inaugurazione di una società ludica. Esempio,
questo, scontato, al limite del luogo comune, ma
che ci dimostra anche la non rara frequentazione
fra gli ambiti psicologico e politico, ovvero la
reciproca inseminazione fra utopie1.
Carl Popper, in verità, ci aveva già messo
in guardia circa entrambi i paradigmi,
psicoanalitico e marxista, quando ne sottolineò la
"non falsificabilità". In altri termini, è
l’eccezionale potere esplicativo delle due teorie a
non convincere Popper che notava come i suoi
amici marxisti trovassero in qualunque evento
una conferma alla teoria della storia descritta dal
filosofo di Treviri e mai delle smentite, così come
ogni sintomo veniva letto dagli analisti, senza
possibilità di smentita, in termini di conflitti
inconsci a carattere sessuale o aggressivo. In
particolare, Popper racconta di un incontro con
Adler, teorico di una setta eretica analitica, quella
della psicologia individuale, elemento questo che
ci fa capire la natura eminentemente "chiesastica"
delle dottrine non falsificabili, a cui raccontò di
un caso che l’analista non ebbe difficoltà a
leggere in base alla sua teoria sui sentimenti di
inferiorità, senza neppure vedere il soggetto.
Sconcertato, Popper gli chiese come poteva
essere così sicuro e Adler gli rispose: "a causa
della mia esperienza con mille casi simili".
Popper concluse, un po’ sprezzantemente, "e con
questo ultimo, suppongo, la sua esperienza vanta
milleuno casi".
In altri termini, secondo il criterio di
demarcazione popperiano, una teoria priva di
"falsificatori" potenziali è priva di contenuto
empirico (e di utilità). Un ovvio crimine
nell’epoca storica dominata dal valore della
"scientificità". Questo valore, però, ci porta ad
Si pensi a quante dottrine politiche ritengono che il fine dell’azione sociale sia la costruzione di un homo novus.
3
un’altra utopia, quella della "validità" di alcune
visioni del mondo, dell’essere cioè queste
specchio fedele della "realtà". Ciò, fino a tempi
recentissimi, ha alimentato una visione
positivistica ed empirista basata su una supposta
"verità" del mondo da scoprire a piccoli pezzi
mediante l’esperienza e in modo induttivo,
baconiano. Ciò significa trarre conclusioni, cioè
teorie generali, dall’osservazione di fatti
particolari, vale a dire teorizzare con Hume che il
sole sorge ogni mattina perché finora è andata
così. Questo fa di una teoria del mondo una
"verità", ma anche questa è un’utopia. Bertrand
Russell, raccontava la storia del "tacchino
induttivista" il quale veniva cibato ogni mattina
alle 9. Da buon induttivista, prima di trarre
conclusioni affrettate, il tacchino valutò ogni
variabile di temperatura, di giorno della
settimana, ecc. finché non poté concludere con la
sua "verità" scientifica: "mi danno da mangiare la
mattina alle 9". La cosa risultò vera fino alla
vigilia di Natale quando il tacchino venne
sgozzato. Alle 9.
Mi è quasi automatico fare un parallelo fra
il tacchino induttivista di Russell ed un altro
celebre pennuto, ovvero il "piccione
superstizioso" di Skinner, paragone non peregrino
considerato che Skinner è l’ esempio massimo
dell'
utopia scientista, induttivista e realista in
psicologia. E’ risaputo che egli "condizionò" dei
piccioni a compiere delle attività senza senso
mediante rinforzi comportamentali molto simili a
quello che rappresentava la conferma alla teoria
del tacchino, ovvero il cibo.
Certo, mi si obietterà che una "scatola
nera" - quale viene trattata la scatola cranica di
piccioni, ratti ed umani dai comportamentisti
ortodossi - non è induttivista né ipoteticodeduttiva, ma il mio riferimento non è ai piccioni,
sto parlando di Skinner…
Mi riferisco, insomma, a quel gruppo di
teorici che per fare della psicologia una scienza
esatta, in completa antitesi alla metafisica
freudiana, ne hanno fatto una scienza naturale,
baconiana ed induttivista basata sul principio
della "verificabilità empirica". Quella concezione,
per intenderci, che farà dire a Noam Chomsky
che ci sono scienziati che "non sanno distinguere
un poeta da un piccione". La psicoterapia che ne
deriva, meglio, la "tecnica di modificazione del
comportamento" che ne è il risvolto pratico, vuole
avere quale punto di forza la "prevedibilità" ,
altro valore cult. Ma Popper ci ricorda che aver
visto sempre dei cigni bianchi ci farà prevedere di
vederne sempre di bianchi. Ciò non esclude la
esistenza di quelli neri.
Insomma, esiste l’utopia di un "universo",
ovvero di un mondo oggettivo, vero e prevedibile
fuori dall’osservatore, concetto questo
assolutistico al quale il neuroscienziato Maturana
contrappone il concetto libertario di "multiversa".
Hans Kelsen, in ambito politico, ha chiarito che
solo il relativismo permette la tolleranza in
quanto chi ritiene di detenere la verità cercherà di
imporla agli altri. E’ allora estremamente
interessante considerare che tipo di utopia sociale
possa venire ad essere legata a doppio filo a
quella della scienza umana come scienza naturale
e della razionalità di un paradigma rispetto ad un
altro: la allettante idea di una società
completamente scientificamente organizzata,
prevedibile, "condizionata". Un panorama
orwelliano che lo stesso Skinner presentò in un
suo romanzo "utopico" intitolato Walden Two. Vi
si ipotizzava una "società perfetta" in cui tutti
individui sono "condizionati" . La società come
un’enorme "Skinner box". Una psicoterapia
globale che conducesse il mondo alla sua "giusta"
organizzazione! La tecnica come controllo
sociale!2 Queste concezioni sono anche espresse
2
Approfondimento: Skinner, inoltre, era convinto che "il controllo della popolazione nel suo insieme dev’essere
delegato a specialisti: poliziotti, preti, imprenditori, insegnanti, terapeuti, ecc., che dispongono di rinforzi
specializzati e di contingenze di rinforzo codificate". Il controllo, in altri termini, è benefico perché rende il mondo
più sicuro. Quest’ultimo è molto critico circa una tecnologia del comportamento il cui dichiarato fine è di
"progettare un mondo in cui il comportamento probabilmente soggetto a punizione dovrebbe presentarsi raramente
o addirittura mai" . Skinner è esplicito: "Uno stato che trasformi tutti i suoi cittadini in spie, o una religione che
promuova il concetto di un Dio onnisciente, eliminano ogni possibilità di sottrarsi alla punizione e dànno quindi
efficacia estrema al sistema punitivo. La gente si comporta bene benché non vi sia una supervisione percepibile".
Questa sarebbe la condizione ideale perché, "ovviamente" la libertà "cresce al diminuire dei controlli visibili".
Concetto un po’ bizzarro di libertà. Più che un’utopia, insomma, questa è una distopia, uno scenario da romanzo
cyberpunk alla Gibson o alla Sterling.
4
in un noto saggio che è stato l’oggetto di una
feroce critica di Chomsky, psicolinguista, uno
degli uomini cui si deve la "rivoluzione
cognitiva" in psicologia e, giacché si è in
argomento, utopista anarchico. Ancora una volta,
dunque, una contrapposizione non solo
scientifica – non solo, cioè, concernente
paradigmi ipoteticamente neutri - ma anche e
prevalentemente ideologica, ovvero una
contrapposizione fra utopie. La psicoterapia non
sfugge a questi impaludamenti ideologici. Si
confronti, a mò d’esempio, questa concezione
psico-totalitaria con la psicoterapia "liberale"
degli umanisti americani, come Abraham Maslow
o Carl Rogers che ha quale fine il "divenire ciò
che si è", fine che si raggiunge abbandonando i
falsi sé costruiti adeguandosi ai valori societari3.
Una buona spallata alla concezione
assolutistica ed a-relativistica della conoscenza
l’ha data l’epistemologo Paul Feyerabend. Questi
ha messo in crisi l’idea di una scienza che
progredisce in modo "razionale" e metodico
dimostrando che l’impresa scientifica ha un
carattere "opportunista" ed illogico (everything
goes) e che non esista "regola" scientifica che non
sia stata violata, concezione che è passata alla
storia come "anarchismo metodologico" ma che
s a r eb b e m eg l i o d ef i n i r e da da is m o
epistemologico. Soprattutto però Feyerabend
contesta l’idea di una "realtà" vera come quella
del raggiungimento di tale realtà quale fine della
scienza che dovrà piuttosto occuparsi di ciò che è
"utile" invece che del "vero".
La prima fase della elaborazione
cognitivista, che cerca di supplire alle evidenti
car enze esp licat ive comp or ta ment ist e
introducendo la "O" di "organismo" fra la "S" e la
"R" di "stimolo" e "risposta", non si allontanava
invece granché dal paradigma "realista", cioè
della "verità". Si veda la concezione dell’ansia
nella psicologia cognitiva di Beck. Seconda la
nota definizione di Beck si tratta di un
"campanello di allarme ipersensibile", che, cioè
"produce troppi falsi positivi e niente falsi
negativi". Checché se ne possa dire, un impianto
di allarme che suona in assenza di pericolo è
3
qualitativamente differente da un analogo
impianto che si comporti nel modo in cui ci si
aspetta che si comporti. Potremmo dire che uno
funziona bene e l’altro male.. Ad ogni modo,
l’origine di tale differenza viene rintracciata nella
strutturazione di una teoria del mondo
disfunzionale, ossia una interpretazione del
mondo come pieno di pericoli quando ciò non
sarebbe "vero". Meglio, quando invece i pericoli
sono probabilisticamente poco importanti.
Sarebbe insomma "errata" l’interpretazione, il
"belief" sul mondo che in realtà non è poi così
pericoloso. Insomma, un paradigma è "giusto" e
l’altro è "sbagliato". E’ questa un’ottica "realista"
e che mira alla correzione dei "pensieri illogici".
Ciò non toglie che i "sani" muoiano spesso in
incidenti stradali perché non portavano le cinture
di sicurezza allacciate in quanto avevano
induttivamente realizzato, in base alla propria
esperienza precedente, che non portare la cintura
non è pericoloso, fino a che non sono incappati
nel cigno nero di Popper; né esclude che gli stessi
"sani" che valutano la probabilità che si verifichi
un evento negativo talmente bassa da non mettere
in pratica alcuna attività difensiva, valutino
probabilità statisticamente paragonabili a queste
abbastanza possibili quando si tratta di giocare
alla lotteria. Insomma, la pretesa scientificità o
anche solo "logicità" del pensiero sano è
abbastanza discutibile. La psicoterapia, in
quest’ottica "realista", viene a configurarsi come
la sostituzione, indotta con una metodica
pedagogica, di una ipotesi del mondo con
un’altra. Sostituzione arbitraria? Niente affatto;
innanzitutto, perché è sempre meglio una teoria
utile piuttosto che una vera, in secondo luogo
perché altrimenti si cade in un’altra utopia, ossia
si rischia di scivolare su certe sbavature
dell’"anti-psichiatria" (Laing, Esterson e loro
adepti convinti o per "moda") o addirittura della
"non psichiatrica" (Thomas Szasz). L’utopia,
cioè, nel primo caso, che la malattia psichiatrica
possa essere messa "tra parentesi" e la terapia
passi per l’opposizione alla struttura sociale che
la origina, nel secondo caso, addirittura, che la
malattia non esista per nulla e che il delirio,
Approfondimento: la cosa si fa particolarmente evidente con la cosiddetta terapia della Gestalt, una delle più
diffuse pratiche umanistiche, in cui la libertà di autodeterminazione e individuazione assume connotati libertari
estremi e i cui fondatori Fritz Pearls e Paul Goodman non hanno mai fatto mistero della loro adesione
all’anarchismo militante. Si può perfino affermare che, sia come luogo "ideale", sia come espressione massima
delle propria filosofie, Walden Two sia il contraltare, l’opposto esatto di Esalen, la comunità proto-hippie e
libertaria che è il centro propulsore della Gestalt Therapy.
5
l’allucinazione ecc. siano tratti personali non
giudicabili quali gli occhi chiari o i capelli biondi.
In tal caso, la terapia non sarebbe altro se non un
abuso ai danni della libertà personale. Se
curiosiamo nelle fedi politiche di chi ha espresso
queste visioni "alternative" non ci si dovrà
sorprendere nello scoprire il terreno di coltura
(pseudo)socialista nel primo caso, né scoprire che
T. Szasz è un fautore del libertarianism, ovvero
quello strano anarchismo capitalista americano
che si configura come un liberalismo ultrà,
jeffersoniano, tutto centrato sulla difesa della
libertà individuale. Due visioni contrapposte,
quindi, anche se appaiono una l’estremizzazione
dell’altra. In conclusione, ogni idea dell’uomo è
un’idea sociale; ogni teoria della modificazione
dell’uomo veicola un’utopia. E’ in tal senso, ad
esempio, che perfino Giovanni Jervis può
affermare, in anni a dire il vero piuttosto sospetti,
che "l’ ossessività è la virtù media del
capitalismo" e che la terapia dell’ossessività "è
educazione al coraggio, all’anticonformismo e al
dissenso".
Tutte queste considerazioni mi inducono a
guardare con occhio particolarmente benevolo gli
sviluppi costruttivistici della psicoterapia
cognitiva (Kelly, Guidano e Liotti, ecc.). In tale
ottica si abbandona la presunzione di poter
cogliere una realtà ontologicamente data e con
essa l’idea di portare gli individui a coglierla, a
conformarvisi o ad opporvisi. Si riconosce, in
pratica, un relativismo che ammette l’esistenza di
tante realtà quante sono le costruzioni individuali;
queste non sono più o meno vere, bensì più o
meno utili, adatte, funzionali, viabili, percorribili.
Ognuno struttura la propria esperienza, il proprio
flusso in modo attivo e dà significato al mondo.
Ogni paradigma ha quindi la sua dignità. La
patologia sorge laddove una costruzione non
riesce più a garantire la propria coerenza, il
proprio adattamento e continui a venire utilizzata.
In questo caso la terapia non sarà più la
ricostruzione di una coerenza fra un mondo
interno ed uno esterno (incoerenza interparadigma), bensì la riequalibratura dei propri
costrutti che vengono a trovarsi in una incoerenza
interna (intra-paradigma). Von Glaserfeld ci
fornisce l’esempio più chiaro di cosa comporti
l’adozione di questa visione scevra da utopie e
missioni: egli mette a confronto i termini match
("corrispondenza") con fit ("adattamento").
Il realista cerca una conoscenza che
corrisponda alla realtà (quello che conosco è una
copia identica di ciò che è fuori) ma se diciamo
invece che una cosa è adatta, ciò corrisponde ad
una diversa relazione: "una chiave è adatta se
apre la serratura. L’adattamento descrive una
capacità della chiave, non della serratura. Grazie
agli scassinatori di professione, sappiamo anche
troppo bene che esistono molte chiavi che, pur
avendo delle forme molto differenti dalla nostra,
aprono le nostre porte". Insomma, questo non ci
dice niente sulla serratura, su chi l’ha costruita e
su come sarebbe meglio modificarla. Ancora, ci
può solo dire se una chiave sia "non adatta", "da
riparare" ma non detta leggi su quale sia la chiave
ideale.
Si ricostruisce così quel relativismo che è
realmente libertario nonché il rispetto per la
dignità delle costruzioni individuali di significato
di ogni unico, irripetibile ed inconoscibile uomo
che, come dice il poeta Sergej Evtushenko, "è un
pianeta".
Luigi Corvaglia è psicologo psicoterapeuta, studioso di psicologia e filosofia politica, in particolar
modo di pensiero libertario. Ricercatore presso la
cattedra di criminologia e psichiatria dell'
Università di Lecce dove è impegnato in un lavoro sull'
anarchismo. Si occupa di deistituzionalizzazione e
riabilitazione psicosociale in un'ottica
"alternativa". Ha pubblicato libri (Riabilitazione
psicosociale, Torino, 2000; Psicopatologia della
libertà, Chieti, 2003) e vari articoli su riviste di
psicologia, psichiatria e musica. Inoltre è caporedattore della rivista di scienze umane "La Torre e
l'
Arca".
6
Realtà, mente, linguaggio:
i paradigmi della filosofia occidentale
I
n questo lavoro vorrei proporre una ricostruzione ideale della storia della filosofia per temi, più precisamente per paradigmi.
Descriverò infatti le principali concezioni della filosofia che si possono distinguere nella storia del pensiero occidentale e – riprendendo il
celebre termine introdotto dal filosofo della scienza
Thomas Kuhn – chiamerò queste concezioni
“paradigmi”. Con paradigma si intende, generalmente, una tradizione di pensiero che si estende per
un certo periodo di tempo, e che a un certo tipo di
problemi offre un certo tipo di soluzioni. Più precisamente, un paradigma è quella concezione che domina la cultura filosofica per un certo periodo: esso
ha origine in un’esperienza, in un atteggiamento
dell’uomo, e ha il compito di rispondere alla domanda che scaturisce da quest’esperienza. Un paradigma si contraddistingue dunque per i problemi
sollevati dall’esperienza umana, per gli oggetti a
cui si riferiscono tali problemi e per le risposte che
prova a dare a tali problemi. Ogni paradigma si sviluppa partendo da una certa esperienza, ponendo
certe domande e indagando un certo tipo di oggetti.
La raffigurazione storica per paradigmi è solo una ricostruzione ipotetica della storia del concetto di filosofia, che porta con sé ovviamente una
grossa semplificazione. Però adottando questo punto di vista si ottiene un idea del tutto corretta, che è
possibile poi precisare e criticare alla luce di ricerche storiche più dettagliate.
La storia della filosofia è stata dominata da
tre modelli fondamentali, che si sono succeduti l’un
l’altro. Il primo modello – quello ontologico – si è
esteso da Platone fino all’inizio dell’età moderna. Il
secondo modello – quello mentalistico – ha contrassegnato l’età moderna da Cartesio fino al XX
secolo. Il terzo modello – quello linguistico – è
quello dominante nella filosofia contemporanea.
Nessuno di questi modelli, naturalmente, va considerato come un monolite: vale a dire, le domande, i
problemi e le risposte che emergono in un determinato modello non scompaiono del tutto nel modello
successivo, così come le domande , i problemi e le
risposte del modello posteriore sono presenti in
qualche modo già nel modello precedente. Quando
diciamo che con Cartesio la filosofia diventa co7
scienzialistica, non intendiamo certo dire che da
quel momento in avanti non si fanno più ricerche
ontologiche, cioè ricerche sull’essere. Vogliamo
soltanto dire che, in una certa epoca, alcuni determinati caratteri prevalgono rispetto ad altri.
Il paradigma ontologico
Questo paradigma è esemplificato nel pensiero di
Platone e Aristotele, ed è un paradigma che determinò la forma e i contenuti del pensiero occidentale fino all’età moderna.
Che cosa significa paradigma “ontologico”?
Significa un filosofare a partire dall’oggetto. A tutti
gli effetti, questo sembra la maniera più plausibile
e più ovvia di filosofare: se intendiamo la filosofia
come scienza, cioè conoscenza, è ovvio che tale
conoscenza è contraddistinta da ciò di cui è conoscenza, cioè dal suo oggetto. Ogni conoscenza deve
essere conoscenza di qualcosa, e questo qualcosa
deve essere, non può esserci conoscenza di qualcosa che non è. Oggetto della filosofia è quindi l’ente,
ciò che è in un senso generale. L’esperienza originaria, quella che dà avvio al filosofare, è in questo
paradigma l’esperienza della meraviglia: secondo
Platone “la filosofia non ha altra origine che questa: la meraviglia” (Teeteto), e secondo Aristotele
“gli uomini furono mossi a filosofare, allora come
ora, dalla meraviglia, rimanendo dapprima attoniti
innanzi ai problemi più ovvii, e poi progredendo a
poco a poco sino a proporsi questioni molto superiori: ad esempio sulle condizioni della luna e quelle del sole, sugli astri, sull’origine del tutto” (Metafisica). Queste indicazioni ci invitano a
considerare il carattere essenzialmente patetico della spinta filosofica. Il filosofo è infatti colui che,
soggiacendo al páthos della meraviglia, del thaumázein, tradisce la sua natura fondamentalmente
passionale, carica di sentimento. Il meravigliarsi
appare cioè quale timbro emotivo tipico del filosofo: esso costituisce per Platone e Aristotele
l’essenziale reazione di chi rimane turbato, rapito
ed estasiato dinanzi all’inspiegabile, e talvolta paradossale, spettacolo del mondo. Ma la meraviglia
del filosofo, lungi dal produrre la paralisi e la mor-
tificazione del pensiero, rappresenta l’inizio di un
peculiare modo del pensiero. La filosofia infatti induce a muovere oltre l’immediata e passiva registrazione della propria esperienza. Essa cioè , attraversando l’inquietudine che l’alimenta, si pone la
domanda fondamentale: ti esti?, che cos’è? Il dato
immediato, il fenomeno singolare che aveva suscitato la meraviglia, richiede di essere indagato. La
filosofia greca è totalmente immersa nel suo oggetto, di cui cerca di scoprire la natura, la struttura e le
leggi che lo determinano. La filosofia concepisce
infatti se stessa come una restituzione fedele
dell’oggetto che indaga: essa vuole fornire una descrizione fedele di ciò che è in sé e per sé, senza
interventi o intrusioni di carattere soggettivo. In
questo senso essa è nel senso più pieno “scienza”,
perché la scienza privilegia il riferimento
all’oggetto, comprende se stessa a partire
dall’oggetto, sia questo un fenomeno della natura,
(il cielo, gli astri, le piante) o appartenga esso
all’ambito più strettamente umano (pensiamo alle
domande socratiche: che cos’è la virtù? che cos’è il
bene? che cos’è il bello?).
Paradigma mentalistico
Che la filosofia voglia conoscere ciò che è, sembra
dunque un’ovvietà. Per questo il modello ontologico ha tanta forza d’attrazione, perché con esso si
impara qualcosa sul mondo. Ora, la filosofia a partire da Descartes diventa mentalistica e si ritira, per
così dire, all’interno della coscienza – ciò che può
apparire come una perdita, come una regressione
rispetto al modello ontologico, o meglio come una
deformazione di quell’originario e “sano” rapporto
tra soggetto e oggetto. Il motivo per cui si passò,
con Cartesio, al paradigma mentalistico e si abbandonò quello ontologico è molto semplice. Chi vuole conoscere ciò che è, deve presupporre che ciò
che è si lasci conoscere. Ma ciò che è, l’ente, è in
generale conoscibile? Come posso essere sicuro
che ciò che dico di conoscere è effettivamente la
verità? Una volta che si sia messo in dubbio che la
conoscenza colga effettivamente ciò che è così come è, il filosofare ontologico diventa impossibile.
Consideriamo, ad esempio, la classica definizione
della verità come corrispondenza dell’oggetto con
la coscienza (in latino: adaequatio rei et intellectus). Se questa corrispondenza è messa in dubbio,
noi non possiamo più riferirci direttamente alla res,
alla cosa, all’oggetto del mondo, ma rimaniamo
soltanto col nostro intellectus. Se si vuole procedere alla conoscenza dell’oggetto, di ciò che è, si deve per prima cosa eliminare il dubbio. Ne consegue
che la filosofia non può più cominciare con
l’esperienza della meraviglia e della “seduzione”
da parte del mondo oggettuale. Essa deve prendere
sul serio quel dubbio, fare di esso una sua faccenda, cercare di eliminarlo in modo che sia nuovamente possibile la filosofia come scienza dell’ente.
La domanda di partenza, che guida la filosofia nella sua ricerca, non è più “che cosa è?”, bensì “che
cosa posso sapere?”.
Dobbiamo però precisare in che senso
l’esperienza del dubbio come inizio, avvio del filosofare porta con sé un mutamento del paradigma,
da quello ontologico a quello mentalistico.
L’esperienza del dubbio non compare certo
con Cartesio: già gli scettici del IV secolo a.C. avevano messo in dubbio la possibilità di conoscere
l’essere. Da quando affiorò la prima forma di filosofia scettica, ogni filosofare comincia col dubbio.
Da allora tutti i filosofi hanno dovuto reagire a tale
dubbio, per superarlo e per dimostrare con ciò la
conoscibilità del reale. Prima di Cartesio, a presentare un argomento non toccato dal dubbio scettico
fu Agostino. Secondo Agostino, c’è qualcosa di cui
colui che dubita non può assolutamente dubitare, e
questo è il fatto che egli dubita, e che per poter dubitare, egli deve esistere: “Dubito, quindi sono”,
afferma Agostino nel De libero arbitrio. Non può
7
7
essere messo in dubbio l’esistenza della coscienza
di colui che dubita nel momento in cui dubita. Con
questo argomento Agostino sconfigge lo scetticismo con le sue proprie armi. Ma ciò significa cominciare a filosofare a partire dalla coscienza. La
domanda che “che cosa posso sapere?” può ricevere ora una risposta: questo io posso sapere, che io,
nella misura in cui dubito, sono, esisto.Potrebbe
sembrare a questo punto che il “cogito, ergo sum”
di Cartesio non reca nulla di nuovo all’argomento
di Agostino, e che forse bisogna far coincidere il
passaggio dal paradigma ontologico a quello mentalistico nella persona di Agostino. In verità c’è
qualcosa di completamente nuovo nell’argomento
di Cartesio, che autorizza a riconoscere in Cartesio,
e non prima, l’inizio dell’epoca moderna e della
nuova concezione della filosofia. La novità consiste nel modo di intendere l’io che è il soggetto del
cogito. Agostino concepisce l’io che dubita come
una creatura di Dio, ed è sicuro di ritrovare nell’io
le tracce del Dio creatore. Ricordiamo il monito di
Agostino: “Non andare fuori di te, ritorna in te stesso. Nell’uomo interiore abita la Verità”. Descartes
invece si distacca da questo quadro teologico: l’io
del cogito si appoggia unicamente su se stesso.
L’io di Cartesio esprime il bisogno di indipendenza, di autonomia intellettuale e di certezza nel sapere acquisito con le proprie forze, che è proprio del
soggetto moderno. L’io di Cartesio non è la creatura di Dio, è il soggetto autonomo che non ha bisogno dell’autorità della tradizione teologicamente
legittimata per affermare se stesso. Anche se un
genio maligno mi ingannasse, questi non potrà mai
ingannarmi sul fatto che, se penso, allora io sono,
io esisto. Con la scepsi e con l’abbandono del quadro teologico la filosofia comincia veramente ora
come pura filosofia della coscienza.
Una filosofia della coscienza può ancora
chiamarsi scienza? Consideriamo cosa significa
partire dalla coscienza: la filosofia non comincia
indagando gli oggetti, gli enti, ma indagando la
possibilità e i limiti della nostra conoscenza riguardo agli oggetti, cioè indagando i principi, le forme,
le strutture, in breve il modo che noi abbiamo di
conoscere gli oggetti. Prima facciamo esperienza
della nostra coscienza, poi facciamo esperienza
dell’oggetto. Una volta riconosciuta l’esperienza
del dubbio come esperienza originaria del domandare filosofico, la filosofia si concepisce soltanto, o
prevalentemente, come analisi del nostro pensiero e
dei nostri concetti.
Qual è il prezzo che si paga per questo rivolgimento? È un prezzo piuttosto alto. Se l’unica certezza che posso raggiungere, quella certezza che
resiste ad ogni dubbio, riguarda il mio io e il suo
7
modo di conoscere gli oggetti, ne viene che gli oggetti in sé mi restano ignoti, sconosciuti. Ciò che
noi conosciamo sono propriamente ed esclusivamente le nostre proprie rappresentazioni, le nostre
idee o i nostri pensieri. Noi abbiamo certezza solo
riguardo ai contenuti della nostra coscienza. Gli
oggetti, i quali esistono indipendentemente da noi,
ci sono noti nella misura in cui si adattano alle nostre capacità mentali, nella misura in cui si conformano alle strutture della nostra mente. Ma ciò che
essi sono in sé, indipendentemente da come noi li
conosciamo, ci resta ignoto: noi conosciamo le cose solo così come a noi si presentano, relativamente
alla nostra mente o coscienza. Vale a dire, noi conosciamo solo i “fenomeni” delle cose: le “cose in
sé” sono per noi irraggiungibili, sono e rimangono
una x. È la nota distinzione kantiana tra le cose,
quali sono in sé, e le cose quali appaiono a noi.
Tutti gli enunciati che riguardano non le cose come
ci appaiono, ma le cose come sono in se stesse, cadono fuori dall’indagine filosofica perché indimostrabili.
Paradigma linguistico
Il passaggio dal modello ontologico a quello mentalistico avviene attraverso una perdita
dell’ingenuità: con il cartesianesimo si riflette su
ciò che prima era considerato ovvio, banale; a partire da Cartesio diventa un problema ciò che fino
ad allora era ritenuto la soluzione di ogni problema:
cioè la conoscenza del mondo. Ora il dubbio diventa per così dire “istituzionale” ed è assunto come il
punto di partenza di ogni filosofare che non vuole
essere dogmatico.
Al nome di Wittgenstein è invece legato il
terzo paradigma della filosofia, quello linguistico.
Wittgenstein si oppone decisamente all’intera tradizione filosofica che lo aveva preceduto, affermando
che “la formulazione di problemi filosofici si fonda
sul fraintendimento del linguaggio”. Tutti i problemi formulati dalla filosofia, sia dal modello ontologico – che cos’è la realtà? – sia dal modello mentalistico – di che cosa posso essere certo? – sono per
Wittgenstein il frutto di un cattivo uso del linguaggio: noi ci immergiamo nei problemi filosofici perché non vediamo chiaramente l’uso delle nostre parole. L’esperienza di partenza del modello linguistico della filosofia è per Wittgenstein il
“fraintendimento”, la confusione, l’incapacità di
comprendere gli enunciati del linguaggio: per Wittgenstein “un problema filosofico ha propriamente
la forma: io non mi ci raccapezzo”. Se la domanda
di partenza di Cartesio e Kant era: “che cosa posso
sapere?”, la domanda del nuovo paradigma della
filosofia, inaugurato da Wittgenstein, è invece:
“che cosa posso comprendere?”. La filosofia deve
porsi per lui un nuovo compito: quello della chiarificazione dei pensieri che sono per lo più torbidi e
indistinti. Poiché è nel linguaggio che i pensieri
trovano espressione, è nel linguaggio che i pensieri
possono diventare chiari e distinti. La chiarificazione consisterà nel distinguere le proposizioni dotate
di senso, che si possono legittimamente proferire,
dalle proposizioni assurde e insensate, che non debbono essere dette. Ogni filosofia sarà dunque
“critica del linguaggio”, e dovrà tracciare i confini
tra ciò che si può dire sensatamente e il non senso.
Ma che cos’è ciò che si può dire sensatamente? Come si può distinguere una proposizione dotata di
senso da una proposizione insensata?
Per Wittgenstein una proposizione è dotata
di senso quando può essere o vera o falsa. Una proposizione è infatti la raffigurazione di come stanno
le cose. Una raffigurazione può essere fedele o infedele, può fornire cioè un’immagine vera o falsa
dei fatti: è vera se raffigura esattamente come stanno le cose, è falsa se non rappresenta in realtà come
stanno le cose. La proposizione “il libro è sul tavolo”, ad esempio, è vera se il libro è effettivamente
sul tavolo, è falsa se il libro è nello scafale. In entrambi i casi, comunque, essa è una proposizione
dotata di senso, che può a buon diritto essere enunciata. Non-sensi sono invece tutte le proposizioni
che non possono essere né vere né false, ad esempio: “Dio esiste”, “la storia è l’oggettivazione dello
spirito”, “penso, dunque sono”. Le prime due proposizioni sono insensate perché di esse non possiamo provare né la verità, né la falsità: non possiamo
dire se esse raffigurano come stanno esattamente le
cose, perché la prima è una proposizione di tipo
religioso, che presuppone un atto di fede, e la seconda è una proposizione di tipo metafisico, quindi
per definizione un’ipotesi che non può essere verificata. Ma anche la terza proposizione è insensata,
per il fatto che essa è sempre, incondizionatamente,
vera: nel momento in cui penso, esisto e non possiamo immaginare una circostanza in cui, pur pensando, non esistessimo. Si tratta di una proposizione indubitabile e proprio per questo non funziona
all’interno del nostro sistema linguistico: essa gira,
per così dire, a vuoto. Dall’analisi di Wittgenstein
risulta che sono dotate di senso solo le proposizioni
della scienza naturale, o del linguaggio ordinario,
mentre risultano prive di senso, ossia né vere né
false, tutte le proposizioni della metafisica,
dell’etica, dell’estetica – in breve tutto ciò che fino
a Wittgenstein abbiamo chiamato “filosofia”. Gran
parte dei problemi della filosofia che si sono tra-
mandati per secoli, non sono altro che l’espressione
di un cattivo uso del linguaggio. L’autentico compito della filosofia, in quanto attività chiarificatrice
dei pensieri, deve essere quello di smascherare
l’insensatezza della metafisica, i cui enunciati sono
solo apparentemente corretti.
Con Wittgenstein assistiamo a un riorientamento del pensiero filosofico. Per Wittegenstein la filosofia non è un corpo di dottrine, una
scienza, ma un metodo, un’attività di chiarificazione del linguaggio, che mira a smascherare
l’insensatezza delle proposizioni filosofiche: “le
proposizioni e le domande che si sono scritte su
cose filosofiche sono non false, ma insensate.
Perciò a domande di questa specie noi non possiamo rispondere, ma possiamo solo constatare la loro
insensatezza. Le domande e le proposizioni dei filosofi si fondano per la maggior parte sul fatto che
noi non comprendiamo il nostro linguaggio. Esse
sono domande di questo genere: il bene è più o meno identico del bello? Ne risulta che i problemi più
profondi propriamente non sono problemi”. In questo senso. la filosofia come critica del linguaggio si
configura come una tecnica medica, una terapia, un
metodo di guarigione. Per Wittgenstein “il filosofo
tratta una questione; come una malattia”. I risultati
della filosofia sono “la scoperta di qualche schietto
non-senso e la scoperta di bernoccoli che
l’intelletto si è fatto cozzando contro i limiti del
linguaggio”. Compito della filosofia è allora di trasformare il non-senso latente in un non-senso palese. Quando soffriamo di problemi filosofici in senso tradizionale, infatti, abbiamo del non-senso nascosto nella nostra mente, e l’unica via per curarlo
è di portarlo alla scoperto. Fare filosofia equivale
ad esercitare una forma di terapia psico-analitica,
nella misura in cui trasforma in un non-senso esplicito ciò che nella nostra mente era un non-senso
represso.
Vorrei concludere precisando una cosa: una
volta che tutte le nostre affermazioni su Dio,
l’essere, il bello o sull’immortalità dell’anima sono
state riconosciute come non-sensi, che ne è di esse?
Vale a dire, esse non possono essere dette chiaramente nel linguaggio, abbiamo riconosciuto la loro
insensatezza. Su di esse dobbiamo tacere, dice Wittgenstein. Cosa significa ciò?
Quando Wittgenstein afferma, “su ciò di cui
non si può parlare, si deve tacere”, aggiunge “vi è
dell’ineffabile. Esso è il Mistico”. C’è qualcosa che
trascende i limiti del pensiero e del linguaggio umani. Nessuna proposizione può esprimere il senso
del mondo. Una volta che noi abbiamo chiarificato
tutte le proposizioni del nostro linguaggio, che abbiamo eliminato ogni fraintendimento, che abbia7
.
mo terminato cioè il compito della filosofia, ci accorgiamo che i nostri problemi vitali non sono neppure stati sfiorati. I problemi vitali, cioè i problemi
morali, religiosi ed etici, cioè i cosiddetti “valori”,
non sono formulabili nel linguaggio, perché il linguaggio si riferisce soltanto a fatti che sono empiricamente verificabili. Ma i problemi morali, religiosi, estetici, psicologici, si situano all’esterno delle
possibilità del linguaggio. Una volta chiariti le proposizioni del linguaggio, noi “sentiamo” che i nostri problemi vitali rimangono non toccati e che essi appartengono al dominio dell’inesprimibile. “Su
ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”: questo è un invito all’uomo ad essere consapevole dei
suoi limiti. Il dovere di tacere su ciò che trascende
la possibilità del linguaggio non esclude e non nega
ciò che si tace: significa semplicemente che noi uomini siamo inadatti a parlarne. Il senso del mondo è
ineffabile: la comprensione del senso del mondo
per Wittgenstein rimane affidata all’esperienza etica, o estetica e religiosa, ma non è affrontabile razionalmente, cioè filosoficamente. Il senso del
mondo trascende le capacità della filosofia, che sono le capacità del linguaggio. Questo è un grande
atto di umiltà da parte di un filosofo: l’esperienza
logico-filosofica sono una cosa, l’esperienza morale, religiosa ed estetica sono un’altra cosa. E sono
queste ultime esperienze che aprono all’uomo la
possibilità di comprendere il senso del mondo.
Tuttavia, questa non è l’ultima parola sulla
filosofia. Nella nostra ideale ricostruzione, siamo
giunti fino agli inizi del XX secolo. Il paradigma
linguistico inaugurato da Wittgenstein non si esaurisce nella concezione ora esposta, che è quella che
ritroviamo nel Tractatus ed anche nelle Ricerche
filosofiche. Un modello più complesso e articolato,
che assegna alla filosofia altri compiti oltre a quello
di curarci dai problemi filosofici nascosti nel linguaggio, emergerà in seguito nel pensiero di Wittgenstein e caratterizzerà il sistema di pensiero che
si è sviluppato negli ultimi decenni. Ma questa è
un’altra storia, di cui racconteremo in un secondo
momento.
Marina Manotta è dottore di ricerca in filosofia.
Attualmente sta svolgendo attività di ricerca postdottorato presso l’Università di Graz (Austria).
esperienze
Ricordando l’Angola
Due pagine di diario scritte a distanza di due anni l’una dall’altra che si riferiscono a una
stessa esperienza: quindici mesi di volontariato in Angola, dove l’autrice ha lavorato come
pediatra in condizioni “molto diverse” da quelle a cui è abituata. Il primo brano è stato
scritto “a caldo”, a un mese e mezzo dal ritorno. Il secondo è stato scritto dopo il decesso
di Maria, la pediatra che è ha sostituito Alberta quando lei è tornata in Italia.
12 luglio 2003
È
più di mezz'
ora che sono seduta
davanti al computer nel
tentativo di buttare giù qualche
pensiero sull'
Angola; me lo
sentivo che sarebbe stato più difficile del
previsto. Sono tornata da quel Paese
ormai da un mese e mezzo e, a parte
qualche scambio di idee con mio marito o
con don Dante e qualche rara e-mail agli
amici rimasti laggiù, con inconsapevole
abilità ho schivato tutte le occasioni di
7
2
incontro, conferenze, interviste, articoli e
quanto poteva essere testimone del periodo
trascorso a Negage e Uige. Sono rimasta in
stand-by per tutto questo tempo, lasciando
sedimentare dentro di me ricordi,
impressioni, emozioni, nell'
attesa che
questa mia esper ienza angolana
riemergesse con tutto il suo carico di
"saudade" e con tutta la forza che può avere
solo ciò che coinvolge anima e corpo.
Stavo reagendo esattamente all'
opposto di
quando alcuni anni fa sono
tornata dal Rwanda: ho sempre
detto che in Rwanda ho lasciato
una parte della mia anima, ma qui
in Angola mi pare invece di avere
lasciato una parte del mio corpo,
del mio fisico, come se questo
Paese fosse capace, non senza
dolore, di penetrarti fin nelle
ossa, nel sangue, nei polmoni:
come se riuscisse a trasformare
sentimenti ed emozioni in
qualcosa di fisico che investe
tutti i sensi. Così la sofferenza e
la morte prendono l'
immagine dei
bambini agonizzanti stesi sui
lettini da visita o dei colori
sgargianti dei panni con cui le
madri ne avvolgevano il corpo
senza vita. Nelle orecchie
restano il gemito continuo dei
più gravi e le urla incontrollate e
i gesti ritualizzati dell'
"obito",
che la famiglia faceva scattare
nell'
istante stesso in cui il
bambino moriva. Al tatto mi pare
di sentire ancora il freddo
metallico del lettino messo
nell'
atrio della Pediatria, un punto
strategico per tenere s ott o
controllo bambini critici ma
infelicemente esposto agli
occhi di tutti. E poi gli odori, forti, pungenti,
capaci di toglierti il fiato; ti investivano
appena entravi nel corridoio dell'
Ospedale di
Negage, così come nel Banco di urgenza, nella
Pediatria o nella sala parto dell'
Ospedale di Uige.
Uno in particolare, meno forte degli altri, ma più
penetrante, mi è rimasto impresso. Mi sentivo quasi
terrorizzata ogni volta che lo percepivo: era l'
odore
che emanavano certi bambini fin dai primi momenti
di ricovero e che io avevo identificato come odore di
morte, un presagio assurdo e irrazionale ma che
quasi immancabilmente si avverava.
Il ricordo di un sentimento, di un'
emozione,
possono affievolirsi con il tempo, ma non ciò che è
passato attraverso la pelle: questo viene a fare parte
di te, del tuo corpo: che ti piaccia o meno, che ci
pensi o no, ormai vive con te e muore con te. È con
questa chiave di lettura che l'
essere ritornata in uno
stato di salute non proprio ottimale mi è sembrato
un'
ulteriore conferma del legame fisico che si è creato con questa terra. Mi rendo conto che quanto scritto
finora non ha nulla di logico, di razionale, probabilmente non è nemmeno condiviso da altri che hanno
vissuto e lavorato nello stesso ambiente angolano,
ma si sa, ogni esperienza è peculiare ed esclusiva
come ciascuno di noi.
11 aprile 2005
L
e dolorose vicende successe in questi ultimi tempi in Angola hanno fatto riemergere prepotentemente ricordi e momenti
del periodo che ho trascorso in quel paese e nello stesso tempo riaperto interrogativi e dubbi rimasti latenti, in attesa forse che il tempo li rimuovesse definitivamente.
La mia esperienza in Uige è cominciata
esattamente il primo settembre 2002, con 1'
inizio del progetto che ha visto il CUAMM farsi carico della Pediatria dell'
Ospedale di quella città. Lavoravo già da alcuni mesi nell'
Ospedale di Negage
e mi dispiaceva lasciare quella Pediatria caotica
ma ormai familiare, dove cominciavo a vedere
qualche risultato del nostro lavoro nei bassi livelli di mortalità intraospedaliera, nella maggiore
7
Alberta Valente
al lavoro a Uige.
autonomia degli infermieri e nel rapporto di
fiducia e collaborazione
reciproca instaurato.
Dovevo lasciare tutto
questo per essere catapultata in una realtà di
cui avevo solo notizie
frammentarie e in un
progetto che non mi aveva vista coinvolta minimamente.
La prima impressione sulla Pediatria di Uige era quella di entrare in un formicaio, con un
via vai incessante di bambini più o meno gravi, in
braccio o sulla schiena di madri che facevano la
spola tra il piano rialzato del Reparto, il seminterrato del Pronto soccorso e il Centro Trasfusionale
distaccato e più lontano; un vociare continuo, interrotto troppo spesso dalle urla per la morte del
figlio. Il flusso di malati era continuo di giorno
come di notte, una processione senza fine. Di
fronte a tanta disperata confusione mi sono
chiesta spesso che cosa potevano fare due medici e un'
infermiera a mezzo servizio, messi a
disposizione dal CUAMM; che cosa ci si aspettava da noi. All'
inizio, ho avuto spesso
l'
impressione che la nostra presenza fosse secondaria rispetto alla fornitura di farmaci e
presidi sanitari, come dire che erano più importanti le cose delle persone. più importante
possedere materiali che non imparare ad usarli
con intelligenza e competenza. Quel che è seguito
al primo settembre 2002 è stato un lavoro paziente per vincere la diffidenza iniziale e guadagnarsi
giorno dopo giorno la stima e la fiducia degli infermieri e degli chefs della Pediatria, nel tentativo
di costruire una collaborazione essenziale per tenere in piedi il progetto stesso.
Per quanto mi riguarda, il riconoscimento
del nostro ruolo clinico e professionale non ha
tardato ad arrivare, come dimostrato dalla frequente richiesta di valutare assieme i casi più
complessi o dalla domanda di aggiornamento.
Quasi nullo invece il nostro coinvolgimento negli
aspetti organizzativi del Reparto e poiché, come
mi ha insegnato un mio ex primario, si può morire non solo di malattia o di miseria, ma anche di
mala organizzazione, sono convinta che nel formulare un progetto va tentato tutto il possibile
per avere un peso. anche minimo, in questo
campo. pur con i limiti imposti dal lavorare in
E’ interessante notare la differenza di toni emotivi tra il primo e il secondo scritto di Alberta,
che forse rispecchia anche un percorso interiore che si è potuto compiere nel giro di due anni e
che ha permesso di realizzare un’analisi più dettagliata dell’esperienza. Nel primo scritto si
sente la sofferenza del tradurre in parole un’esperienza così toccante e profonda, risalta
l’aspetto sensoriale, quasi corporeo, del dolore: dall’odore dei morti, al sentire le urla strazianti, vedere i bambini agonizzanti, toccare il freddo del lettino metallico. E’ come se la rielaborazione emotiva di questa esperienza sia dovuta passare prima di tutto attraverso il corpo: i pensieri e le emozioni possono comparire ed essere esplicitati soltanto in un secondo tempo. Infatti nel secondo scritto è possibile cogliere pensieri articolati, suddivisi in punti che portano a
una riflessione su diversi temi che riguardano l’aspetto oggettivo esterno dell’esperienza e non
solo quello strettamente soggettivo, emotivo, sensoriale.
Barbara Lamedica
7
3
un ospedale governativo. Ricordo la fatica di proporre qualche cambiamento: introdurre un protocollo diagnostico o uno schema terapeutico. suggerire qualche nuova tecnica anche semplice richiedeva uno sforzo enorme, una tenacia non comune e la ferma convinzione che "a forza di battere il chiodo" qualcosa sarebbe passato.
Che la realtà della Pediatria di Uige fosse
particolarmente complessa è balzato agli occhi a
tutti quelli di noi che l'
hanno frequentata; in particolare tre aspetti a mio avviso la rendevano tale.
Primo aspetto: il gran numero di pazienti che passavano di là. Basta leggere i numeri: più di 150 accessi giornalieri al Banco de urgencia, in media
150 degenti in un reparto con 70 posti letto, si superavano spesso i 1000 ricoveri al mese e i 10.000
ricoveri all'
anno con cifre che sono andate aumentando nel tempo. In questo contesto, la mortalità
intraospedaliera era altissima: il 12-13% non sono
solo cifre spaventose, sono anche un carico immenso di dolore e un incubo costante per chi ci
lavora dentro.
Il secondo aspetto era legato alla complessità
stessa del nostro lavoro che implicava far assistenza nel reparto di Pediatria e nel Pronto soccorso pediatrico, rispondendo contemporaneamente alle
non rare chiamate dalla Maternità e rendendosi disponibili anche per la Malnutrizione; il tutto in ogni
ora del giorno e della notte, tutti i giorni, feste
comprese.
Il terzo aspetto, infine , riguardava la patologia locale. Non credo che a Uige le malattie fossero
diverse da quelle presenti in altri Paesi africani, ma
qui pareva assumessero una particolare gravità e
virulenza: la malaria ne era l'
esempio più lampante. Le forme complicate e mortali erano all'
ordine del giorno mentre la frequenza delle ricadute, anche a breve distanza , ci avevano perfino
fatto dubitare su una possibile resistenza al chinino.
Accanto a queste, una varietà di altri quadri morbosi
tanto drammatici quanto strani. Arrivare ad una diagnosi era davvero difficile , non solo per la quasi totale assenza di mezzi diagnostici ( la radiologia ad
esempio era inesistente) ma anche per una serie di
variabili che contribuivano non poco ad aggravare le
patologie e ad ostacolarne la comprensione. Tra queste, il ricorso frenetico alla trasfusione di sangue come rimedio a tutti i mali, cosa che non aveva uguale
riscontro al di fuori di Uige: i genitori dei bambini
la richiedevano con insistenza snervante, disposti a
pagare ad estranei qualunque cifra pur di ottenerla.
Sulla loro sofferenza, intorno al Centro trasfusionale, era nato così un "mercato del sangue"
invisibile ma florido.
Altro fattore di confusione era l'
uso generalizzato di
medicamenti tradizionali, somministrati prevalentemente per clistere; molte volte abbiamo pensato che
questo fenomeno avrebbe meritato di essere studiato con la stessa serietà e lo stesso rigore di una
ricerca epidemiologica. A volte era evidente che
questi trattamenti erano la causa diretta della morte
del bambino, ma specie nei casi più strani e inspiegabili rimaneva sempre il dubbio di un loro utilizzo
sempre negato e di un possibile effetto tossico sconosciuto.
In questa quotidianità dove mi sentivo spesso
impotente e inadeguata, l'
arrivo di altri medici diventava un momento di confronto indispensabile e salutare, una boccata di ossigeno che mi ricaricava. Ma
più di tutto, aspettavo con ansia l'
arrivo di
Maria Bonino che avrebbe dovuto sostituirmi e
continuare il progetto nella Pediatria di Uige. Non la
conoscevo personalmente ma sapevo che era ormai
una "esperta d'
Africa" con alle spalle quasi dieci
anni di servizio: pensavo che con lei avrei trovato
risposta ad alcuni dubbi e sviscerato i casi clinici più
ostici. Non sempre è stato possibile, ma il periodo
trascorso assieme è stato per me intenso ed istruttivo.
Abbiamo condiviso le fatiche quotidiane e il peso di
tutto quel "dolore bambino" che ci sommergeva. Insieme abbiamo ragionato sui nostri dubbi, cercato
improbabili soluzioni e scambiato opinioni ed intuizioni sulla situazione sanitaria locale, arrivando forse molto vicino e quasi senza rendercene conto ad
ipotizzare la tragica realtà di questi giorni. Abbiamo condiviso la casa, il mangiare ( Maria "ottima
pediatra, pessima cuoca" le dicevo) ed anche qualche momento di relax. Le ho sempre invidiato la capacità di non arrabbiarsi anche con le madr i
più petulanti e quella pazienza infinita che
io invece stavo esaurendo, complice uno stato di
salute un po'deteriorato.
A fine maggio 2003, sono partita definitivamente da Uige e le ho passato il testimone. Nei due
anni che lei ha trascorso lì. altre persone le si sono
affiancate per sostenere la Pediatria, lavorando con
passione e senza risparmiarsi. So che molte cose
erano migliorate rispetto alla situazione iniziale
che ho descritto, alcune invece erano rimaste
"sempre na mesma", come mi scriveva Maria. Ora che lei non c'
è più, a me rimangono tanta "saud
de" e la consapevolezza di aver vissuto, nell'
esperienza angolana e nell'
incontro con Maria, un privilegio riservato a pochi.
Alberta Valente è pediatra nel reparto di neonatologia
dell'
Ospedale S. Chiara di Trento.
7
4
Mario Alexandro Santini
recensioni
'
)
Q
!
(
9
uesto libro, che è rivolto
a tutti e forse principalmente a chi ritiene che
'
informatica non lo riguardi, spiega in modo semplice
alcuni processi in atto che minacciano i territori pubblici rappresentati dalla condivisione della
conoscenza di base.
Per rendere più immediata
l'
informazione, l'
autore ricorre
spesso alla forma del dialogo per
illustrare i punti principali della
questione. Nella nota dell'
Editore
che correda il volume, si legge tra
l'
altro che il movimento del free software, con i
suoi risultati e le sue ambizioni, è senz'
altro uno dei
più intelligenti e fruttuosi processi di critica al sistema e di costruzione di un'
alternativa concreta
alle diffuse pratiche gerarchiche di dominio e di
concentrazione del potere.
Nonluoghi Libere Edizioni è una piccola casa editrice che si caratterizza, tra l'
altro, per la scelta di fondo di utilizzare per la produttività solo applicativi su piattaforma Gnu-Linux. Anche questo
volume, dunque, come i dieci che l'
hanno preceduto in questi 18 mesi di vita della casa editrice, è stato realizzato utilizzando per grafica e impaginazione solo programmi rilasciati con licenza pubblica
Gpl su piattaforma Linux (in particolare, Scribus,
OpenOffice, Gimp e Xpdf). La scelta informatica
dell'
Editore è indicata nell'
ultima pagina di ogni
volume. Nella prefazione, Fiorello Cortiana scrive
tra l'
altro che la raccolta di storie contenuta in questo libro coglie differenti percorsi di persone simili
a noi, che vivono in ambienti che ci sono familiari
ed usano strumenti informatici come capita a noi.
Attraverso diversi percorsi, attraverso diversi problemi, queste persone scoprono la questione della
disponibilità della conoscenza, che fino ad allora
avevano ignorato, dietro il click su un tasto o su
uno schermo al fine di attivare un comando per la
soluzione di una esigenza particolare. Le storie narrate ben descrivono il prendere corpo di una consapevolezza individuale, premessa e preludio a una
consapevolezza collettiva.
7
5
)
!
8
$
La conoscenza è un bene particolare, la sua
natura è tale che più essa viene scambiata meno si
consuma e, anzi, aumentano le probabilità di una
sua crescita tanto quantitativa quanto qualitativa.
Ora, se si vuole applicare alla conoscenza e alle sue
reti di produzione e di comunicazione lo stesso modello produttivo di tipo agricolo o industriale, al
fine di ricavarne le stesse modalità di consumo e di
rendita, occorre creare delle condizioni di scarsità.
Queste sono condizioni che di per sé non si danno,
per cui per via tecnologica (standard particolari
proposti come universali) o per via di convenzione
o di norma (accordi Trips dell'
Organizzazione
mondiale del commercio, Wto, piuttosto che direttive e leggi parlamentari per la brevettazione del
software) coloro che detengono le loro rendite di
posizione, altrimenti minacciate dalla condivisione
della conoscenza, da tempo si sono attivati con le
buone e con le cattive affinché si diano le condizioni di scarsità.
Conoscenza, comunicazione, informazione,
partecipazione, costituiscono nuovi ambiti concettuali e pratici che non dipendono strettamente dall'
essere centrali o periferici rispetto a condizioni
economiche. Coloro che stanno prendendo consapevolezza del diritto alla condivisione della conoscenza pongono e porranno sempre più questioni e
conflitti non riducibili a ragioni e a rappresentanze
di classi sociali economicamente definite. Questo
comporterà anche un cambiamento nelle forme e
nella rappresentanza dei conflitti non riconducibile
automaticamente ai tradizionali assi di distinzione
destra-sinistra.
!" #
Gus Van Sant
*
I
+
eri sera alla TV (RAI 1) c’è stato un bel film.
Will Hunting è un ragazzo di vent'
anni che fa le
pulizie in una prestigiosa università americana
(Harvard). A tempo perso dimostra teoremi e
risolve i problemi complicatissimi che un eminente
professore di matematica sottopone ai suoi allievi
scrivendoli sulla lavagna. Il professore si chiede chi
sia il genio che alla mattina fa trovare le soluzioni,
identifica Will, vorrebbe fargli fare carriera. Ma prima di poter fare tutto ciò bisogna far passare Will
dallo psicologo, perché ha un passato da delinquente.
Anzi, il professore va a prenderselo proprio in galera
dove finisce per una scazzottata. Ma gli psicologi
non riescono non solo a addomesticarlo ma neppure
a usare le loro normali tecniche di colloquio. Finché
il professore non si rivolge a Sean (Robin Williams
prende l'
Oscar per questa interpretazione), un vecchio amico insegnante di psicologia, che riesce a stabilire un rapporto sincero e di fiducia con Will e lo
aiuta a conoscersi meglio.
Perché il professore ci tiene tanto che Will usi
la sua propensione per la matematica per trovare un
"buon lavoro"? Il film lo dice: perché questo è quello
che ha fatto lui. Inoltre il professore coglie la superiorità di Will e al suo cospetto si sente inferiore. Ma
come - deve avere pensato - io costruisco sulla mia
conoscenza della matematica una carriera prestigiosissima di cui vado orgoglioso e per la quale la gente
mi stima, quando invece rispetto a Will sono un inetto?
Fra l'
altro il "normale" interesse per il denaro e
la carriera del professore sono un elemento che lo
allontana dall'
amico, ed ex compagno di studi, psicologo che il professore dice di considerare "fallito".
Ma forse lo affonda in questo modo perché teme il
coraggio di costruire una vita perseguendo valori diversi, come ha fatto lo psicologo e come ha fatto e
continuerà a fare, spiazzando tutti, anche Will.
La figura dello psicologo è tutt'
altro che banale. Riesce ad agganciare Will per diversi motivi extraprofessionali. Innanzitutto non fa consulenze di
professione. Poi ha uno studio che al ragazzo piace
subito. I due condividono diverse cose che a Will devono sembrare importanti: la provenienza dallo stesso quartiere (non benestante), la lettura di ceri libri,
la forza fisica, la sincerità. E ciò probabilmente fa
-
)
sembrare a Will che valga la pena conoscere questa
persona.
Di fatto, al primo colloquio, il ragazzo coglie
rapidamente alcuni aspetti delicati e importanti della biografia dello psicologo semplicemente guardando un quadro dipinto da lui. “Gioca allo psicologo” e dimostra il suo acume spiattellando in faccia allo psicologo vero alcune ipotesi, o
"interpretazioni" per dirla in gergo psicodinamico,
sulla sua situazione affettiva, facendo decisamente
centro e mettendo a nudo certi aspetti della vita privata dello psicologo che lui vorrebbe fossero trattati con più tatto o che magari fatica persino ad accettare.
I colloqui successivi sono una partita alla pari: ognuno impara qualcosa dall'
incontro con l'
altro.
Ma il ragazzo mira a demolire e lo psicologo, a costruire. Molto bella e istruttiva la sua figura: non
vuole affatto normalizzare il ragazzo, spingerlo
verso il denaro e la carriera, come il professore vorrebbe e presume che lui faccia, ma accetta di dialogare con questo ragazzo, discutendo di qualunque
argomento mettendosi sinceramente in gioco, rivelando le sue debolezze, accettando le sofferenze
che il ragazzo gli provoca e manifestandole vincendo dolorosamente il pudore ad ammetterle di fronte
a lui. Mi piace questo mettersi in gioco totale, questa apertura. Normalmente (parlo di una normalità
statistica) lo psicologo svolge una funzione professionale sicuro dei ruoli e delle competenze e cerca
di imporre al paziente questa sua visione delle differenze: sei tu quello che soffre e che ha bisogno di
me per stare meglio; io so come si fa e ti dico cosa
devi fare; tu lo fai e poi stai meglio; e se non fai
come dico io, allora te ne puoi andare perché io devo lavorare; e se poi mi fai stare male… non ne
parliamo proprio. Invece inizialmente lo psicologo,
dopo che Will ha rivoltato il coltello nella sua piaga, passa un notte insonne, pensoso e angosciato. Il
ragazzo gli ha detto alcune cose delicate senza il
minimo di tatto; lui non le condivide. Immagino i
pensieri dello psicologo: Chi avrà ragione? Se queste affermazioni mi sembrano false non sarà forse
una difesa psicologica? Che prove ho io, che prova
ha Will? Ma alla fine riesce a dormire e al colloquio successivo spiega a Will come ha fatto.
7
6
Anche questo è un punto che mi è piaciuto
molto del film. Lo psicologo per quietare le sue
angosce si appella a un dato di buon senso: io sono un adulto, tu Will sei un ragazzo. E questo
vuol dire che le tue opinioni sulle mia situazione
affettiva derivano da letture, discorsi, teorie e ragionamenti, mentre le mie derivano da una conoscenza diretta delle situazioni della vita (sesso,
lutti, guerra, ecc.). La spiegazione è autentica e
convince il ragazzo; su questo piano non può
"competere" ma anzi gli conviene "collaborare":
ha la fortuna di godere della conversazione con
un uomo maturo per certi versi simile a lui che gli
parla disinteressatamente e con sincerità delle
scelte più importanti della vita.
"Devi sfruttare le tue doti". Sembra una
frase sensata. Me l'
hanno ripetuta i miei insegnanti, genitori, amici e parenti. La sento dire dagli
insegnanti di mio figlio. Sembra una verità lapalissiana: hai delle doti e non le usi? Ma che, sei
scemo?
Purtroppo quando si dice sfruttare - o nella
versione più soft "usare" - si intende a scopo lavorativo e in definitiva economico.
Tuttavia si trascurano alcune cose importanti. Quello che riesce bene per passione o per
gioco, non necessariamente riesce bene per lavoro. La passione e il gioco sono dominio del piacere. Il lavoro, del dovere. Quando una cosa la si fa
per dovere, non piace più e non riesce più bene
come prima. Chi fa una cosa per piacere la fa secondo i propri ritmi e con le proprie modalità; chi
la fa per lavoro è costretto a ubbidire ai suoi superiori o ai suoi clienti. Risultato: quella che prima
era una passione ora è un dovere. Hai perso una
passione, una preziosissima ragione di vita.
Il professore prospetta a Will i risultati che
potrebbe conseguire mettendo le sue potenzialità
al servizio della nazione. Ma Will non vuole trasformare la sua dote e la sua passione in uno strumento per arricchirsi, guadagnare la stima di per-
)
$%
$(
5
#
. 4
2
:7
; 4
&
,
$2
$-
%
)
'(
)
*(
sone noiose imbecilli disgustose ciniche e disumane, consentire ad altri di perseguire i loro obiettivi,
primo fra tutti lo sfruttamento economico di altre
persone attraverso la violenza, la guerra e la colonizzazione economica. Lui con la sua cultura ci
gioca, conversa piacevolmente con gli amici, aiuta
a studiare la ragazza che gli piace, smerda i secchioni arroganti dell'
università.
Ma perché fa così? Dev'
essere malato - pensa il gregge personificato dal professore. Va
"curato". Gli psicologi si prestano a questo genere
di cure. Nel film quelli che ci provano falliscono
tutti.
Lo psicologo protagonista fa una cosa diversa; non cerca di spingere Will a fare quello che non
vorrebbe. Tanto più che a questo psicologo non sta
a cuore il "mandato" definito dal professore, lo scopo per lui implicito e scontato. Ma sta a cuore che
Will compia la sua scelta liberamente, cioè consapevolmente e deliberatamente. C'
è una possibilità
che lo psicologo vuole vagliare: non è che Will non
accetta le offerte di lavoro che riceve perché si sente emotivamente impedito, perché si sente incapace
o cattivo o indegno o qualche altra cosa del genere?
Lo psicologo capisce che Will non ha avuto l'
amore
dei genitori, che l'
hanno addirittura seviziato. Riesce con molto tatto e umanità a portare la conversazione su questo tema - e lo fa ammettendo la propria triste situazione familiare, l'
alcolismo del proprio padre violento. A quel punto Will smette di
mostrarsi duro, scoppia a piangere e abbraccia lo
psicologo. Lo spettatore abituato alla psicologia e
ai film psicologici pensa che a quel punto Will si
"sbloccherà". E così in effetti il film lascia credere.
Ma come si manifesta questa ritrovata armonia interiore? Il finale è un altro aspetto che ho apprezzato molto di questo film: Will rinuncia a un'
offerta
di lavoro che ha appena accettato, dopo la catarsi,
e, libero dalle sue barriere emotive, prova ad accettare le offerte di amore della ragazza che gli piace.
Gabriele Lo Iacono
%
&
+
$.
/
0
1
34
.
/
0
1 )
%
1
6
&
7 0
1
)
- 8 9 1
7 )
4
;
9 1 2
. '
%
# %
1 < =. '
2
7 7
2
0
'
> $? 0
@@ A .
$
"=