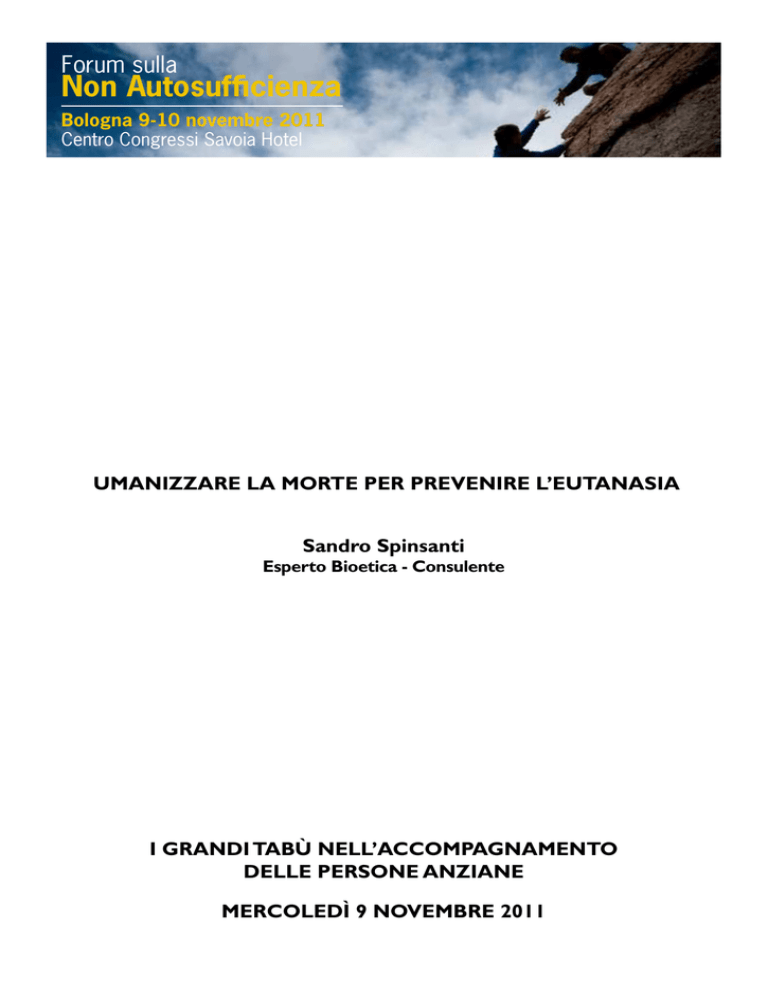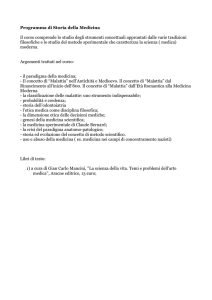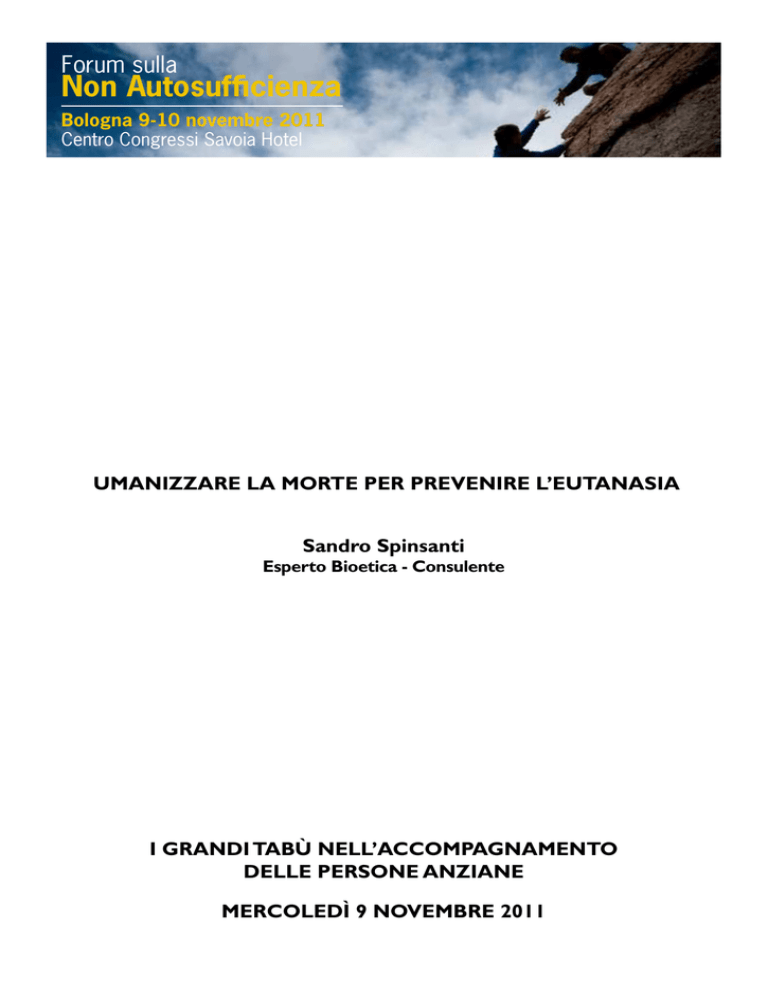
Forum sulla
Non Autosufficienza
Bologna 9-10 novembre 2011
Centro Congressi Savoia Hotel
Umanizzare la morte per prevenire l’eutanasia
Sandro Spinsanti
Esperto Bioetica - Consulente
I GRANDI TABÙ NELL’ACCOMPAGNAMENTO
DELLE PERSONE ANZIANE
Mercoledì 9 novembre 2011
Umanizzare la morte per prevenire l’eutanasia
Sandro Spinsanti
La preoccupazione dei medici di far sì che il paziente non muoia nel dolore è
relativamente recente. Essa introduce un cambiamento notevole nell’etica medica
tradizionale. Per rendersene conto, si può confrontare la sensibilità attuale con una
situazione ideale, rispecchiata letterariamente in un episodio del romanzo I
Buddenbrook, di Thomas Mann. In una scena culminante l’anziana madre del
console Thomas Buddenbrook giace sul letto di morte. L’agonia si protrae
dolorosamente. La morente in grandi difficoltà respiratorie, chiede ai due medici che
l’assistono un calmante per dormire. Supplica: “... Qualcosa per dormire... Dottori
per pietà! Qualcosa per dormire!”. Ma i medici sanno che l’azione di un sedativo
abbrevierebbe la vita. Per cui respingono la richiesta, rifacendosi a dei vaghi motivi
etici che non sanno articolare, ma che nondimeno sentono come vincolanti. “Ma i
medici - annota lo scrittore - conoscevano il loro dovere. Bisognava in ogni caso
conservare ai parenti il più a lungo possibile quella vita, mentre un calmante avrebbe
subito provocato la resa dello spirito senza più opposizione. I medici non sono al
mondo per facilitare la morte, ma per conservare la vita a qualunque prezzo. In
favore di ciò spingono anche certi principi religiosi e morali, dei quali avevano
sentito parlare all’università, anche se in quel momento non se li ricordavano
bene...”.
Le considerazioni dei medici sintetizzano efficacemente il punto di vista della
tradizionale etica medica. La quale, dopo un secolo dalla scena ipotizzata dal
romanzo, non potrebbe più sottoscrivere quella posizione. Il prolungamento non può
più essere l’unico obiettivo dell’azione medica. L’etica del medico deve saper
accogliere la supplica del malato, che domanda il lenimento delle sofferenze.
L’elaborazione di un discorso etico che sappia integrare la gestione etica dei
problemi creati dal trattamento efficace del dolore - mediante l’introduzione di
categorie come azione diretta e indiretta, mezzi ordinari e straordinari, proporzionati
o sproporzionati - è una grande novità degli ultimi decenni.
Ma non è ancora la novità. Finché l’etica medica girerà attorno al medico, alla
sua scienza
e alla sua coscienza, continueremo a muoverci in uno scenario
tolemaico. L’etica medica ha bisogno di una rivoluzione copernicana. Questa
avviene mediante l’introduzione del paziente come soggetto, e non solo come
oggetto di trattamento (anche se è un trattamento umanitario, consapevole anche
delle implicazioni etiche). Il paziente come soggetto ha valori unici, articola scelte e
preferenze, si autodetermina in base alla sua concezione della qualità della vita.
È un universo molto più complicato quello che ci si apre di fronte dopo aver
abbandonato la fissità tolemaica. Non si può neppure dire che ora sia il medico a
gravitare attorno al paziente, diventando semplice esecutore dei suoi desideri. L’uno
e l’altro, conservando la specifica identità - come la considerazione paritetica e non
gerarchizzata dei principi di beneficità e di autonomia ci permette di fare - sono
chiamati a entrare in un processo decisionale dove il rispetto delle procedure diventa
essenziale.
La novità per l’etica medica è che il rispetto di questa dimensione soggettiva
non è indifferente per qualificare eticamente l’atto medico. La sistematica omissione
della volontà del paziente e delle procedure messe in atto per renderne possibile
l’esplicitazione - comunicazione della diagnosi; sollecitazione del consenso agli
interventi diagnostici e terapeutici; rispetto di “policies”, un’etica che non ha ancora
osato fare il passo che la porta nell’epoca moderna, dove l’autonomia qualifica la
persona umana.
Il nuovo modello, in cui le scelte nella fase terminale della vita nascono da un
rapporto qualitativamente diverso tra medico e paziente nel contesto clinico, stenta a
farsi strada nella cultura contemporanea. Possiamo assumere come indicatore del
malessere la crescita della domanda di eutanasia.
Perché tante persone vogliono appropriarsi della morte e propongono
iniziative legislative in tal senso? Ha forse l’istinto di morte preso il sopravvento su
2
quello della vita? Il diffondersi di un movimento a favore dell’eutanasia è un
fenomeno da interpretare.
Se letto in profondità , ci può portare a capire un cambiamento culturale che
sta avvenendo grazie o a causa della medicina, e ci induce a rispondere a tale
cambiamento in maniera adeguata. La morte ci preoccupa, anche se buona parte della
nostra attività conscia è organizzata in modo da tenerne lontano il pensiero. In questo
senso la morte, oltre ad essere una modalità essenziale dell’essere umano, è anche un
fantasma. Uno dei fantasmi che bisogna tener presente per capire il fenomeno della
domanda così insistente di poter decidere della propria morte, è quello di cader in
mano, alla fine della propria vita, a un certo tipo di medici. Vorrei togliere da questa
espressione ogni senso di polemica malevola. Abbiamo certo timore di essere curati
da medici incompetenti (che pur esistono...); ma non è minore il timore che suscita
una competenza non abbinata a umanità. La paura di molti nostri contemporanei è
che la nostra morte sia gestita da un medico e, paradossalmente, da un medico tanto
bravo e coscienzioso, che farà di tutto per impedire la morte.
Ora, questo “tutto” è diventato “troppo”. Le possibilità della tecnologia
applicate alla medicina hanno esteso a un limite impensabile in passato la possibilità
di opporsi alla morte, e quindi di protrarre nel tempo la condizione di morente. In
rapporto a questo stato sorge il fantasma della morte negata. A questo punto l’opera
del medico subisce un rovesciamento di senso: da alleato del malato nella lotta
contro la morte, sembra mutarsi in insidioso nemico che priva il morente della sua
morte.
La rivendicazione di un diritto a morire, paradossale quanto si voglia - perché
se esiste un diritto è quello di vivere, non quello di morire! - mostra il suo significato
se la si colloca sullo sfondo di una eccessiva medicalizzazione del morire. Essa
comporta la rottura di un patto implicito esistente tra il medico e il malato. Tale patto
esiste tradizionalmente in tutte le formulazioni deontologiche e di etica medica, e a
buon diritto lo si fa risalire al giuramento di Ippocrate: il medico si impegna a non
dare la morte; non è opera sua abbreviare la vita o affrettare la morte. La semplice
3
riproposta di tale impegno, nelle mutate condizioni medico-sanitarie e culturali, può
portare a un profondo travisamento di questo tradizionale dovere dell’etica
professionale medica. È proprio il medico “ippocratico” quello che rischia di essere
vissuto come un avversario, un nemico. Quando il medico dice: “Io non farò niente
per abbreviare la vita”, la sua promessa rischia di essere percepita come una
minaccia: “Io farò di tutto per non permetterti di morire”.
L’impegno ippocratico ha un senso psicodinamico positivo molto valido.
Sapere che il medico non farà niente per abbreviare la vita dà a me, in quanto essere
umano che oggi o domani può cadere in situazione terminale, una profonda
sicurezza. Mi libera da una fantasia paranoica possibile e diffusa in quello stato,
quando il controllo della situazione mi sfugge di mano, lo stato terminale si prolunga
e io sento che divento un peso per me e per gli altri. Il sospetto che qualcuno possa
volermi togliere di torno, che quell’iniezione che ricevo e quell’intervento che non
capisco non sia per procurarmi un beneficio, ma per accelerare la mia morte, fa
scattare con una certa frequenza un atteggiamento paranoico e persecutorio. Per
questo motivo l’impegno formale del medico, la parola di tranquilizzazione rivolta al
paziente: “Io non ti darò mai la morte, non farò mai niente per abbreviare la tua vita,
puoi fidarti”, assumono un importante significato positivo.
Ma oggi il paziente non si affida più perché ha paura che quello che il medico
farà non corrisponda al suo vero profondo interesse. Teme cioè che il medico metta
tutti i suoi sforzi e impieghi tutte le possibilità che l’arte medica gli mette oggi a
disposizione soltanto sul versante del prolungamento della vita, ma faccia mancare
proprio quello che il morente in fase terminale richiede. Si tratta essenzialmente di
due cose: non soffrire e non essere lasciato solo. Per questo non è sufficiente oggi
ripetere, appoggiandosi sulla deontologia professionale, sull’etica o sulla morale
religiosa, un “no” all’eutanasia. Bisogna dare positivamente una risposta ai bisogni
dei malati terminali, reimparando l’arte dell’accompagnamento dei morenti.
4