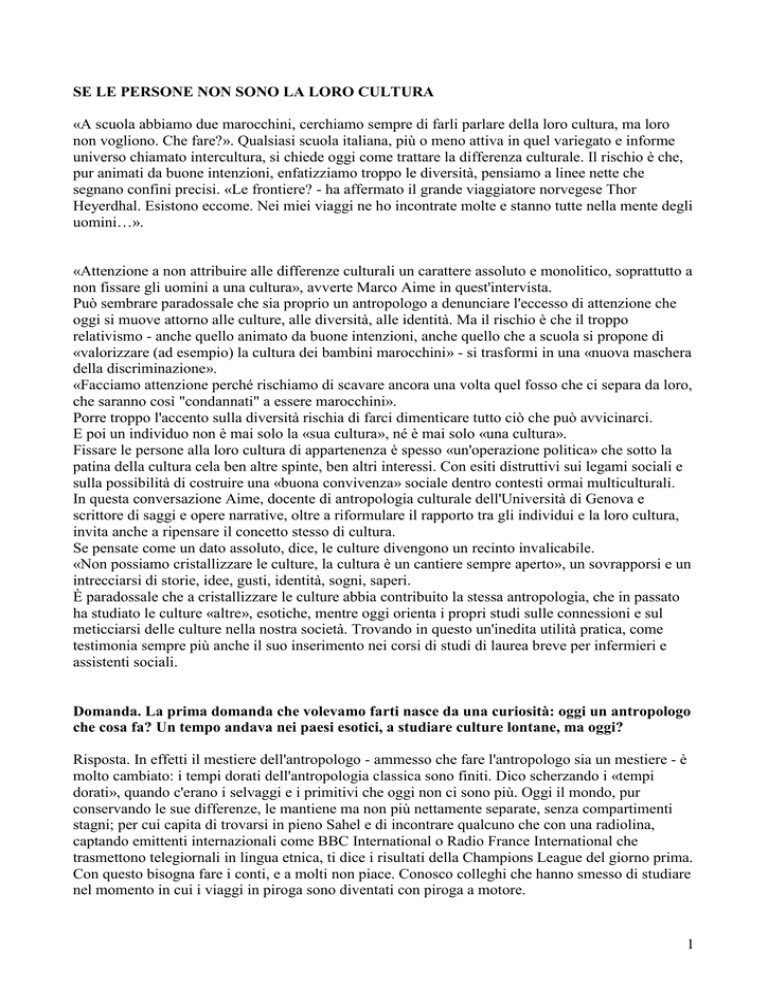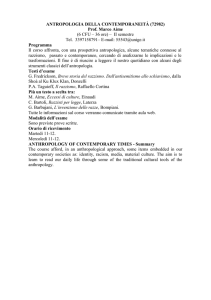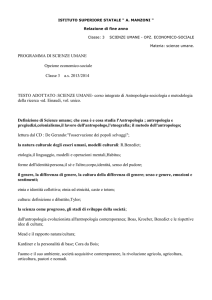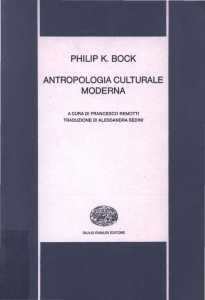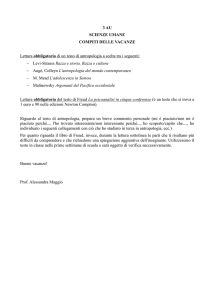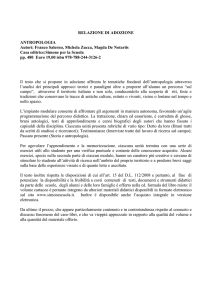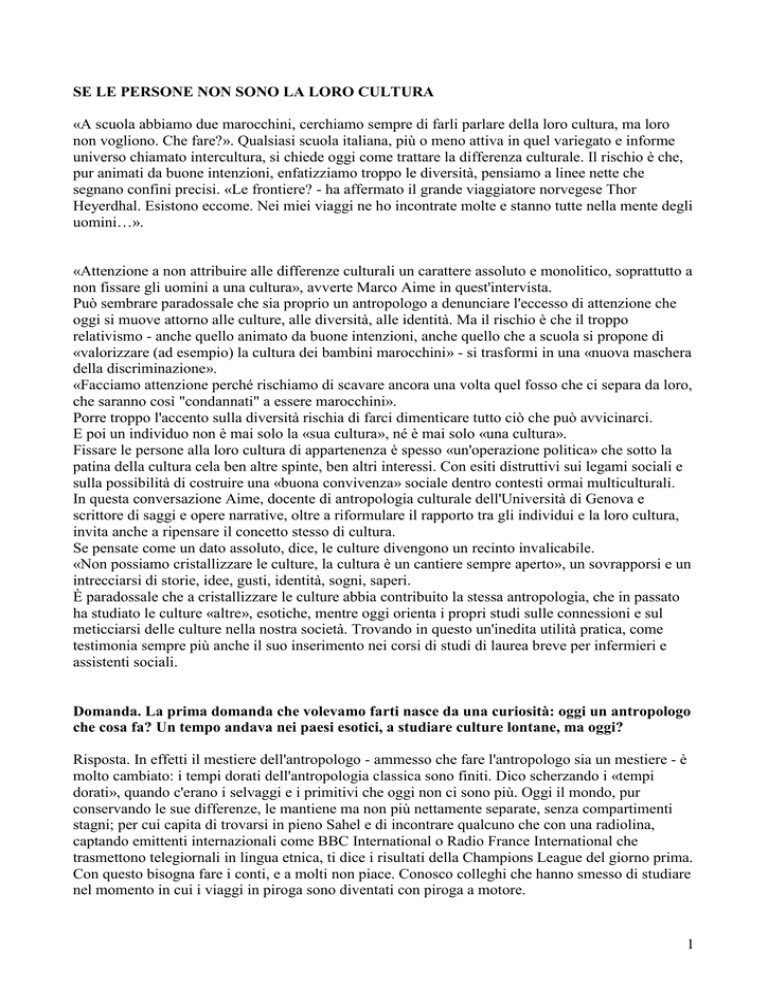
SE LE PERSONE NON SONO LA LORO CULTURA
«A scuola abbiamo due marocchini, cerchiamo sempre di farli parlare della loro cultura, ma loro
non vogliono. Che fare?». Qualsiasi scuola italiana, più o meno attiva in quel variegato e informe
universo chiamato intercultura, si chiede oggi come trattare la differenza culturale. Il rischio è che,
pur animati da buone intenzioni, enfatizziamo troppo le diversità, pensiamo a linee nette che
segnano confini precisi. «Le frontiere? - ha affermato il grande viaggiatore norvegese Thor
Heyerdhal. Esistono eccome. Nei miei viaggi ne ho incontrate molte e stanno tutte nella mente degli
uomini…».
«Attenzione a non attribuire alle differenze culturali un carattere assoluto e monolitico, soprattutto a
non fissare gli uomini a una cultura», avverte Marco Aime in quest'intervista.
Può sembrare paradossale che sia proprio un antropologo a denunciare l'eccesso di attenzione che
oggi si muove attorno alle culture, alle diversità, alle identità. Ma il rischio è che il troppo
relativismo - anche quello animato da buone intenzioni, anche quello che a scuola si propone di
«valorizzare (ad esempio) la cultura dei bambini marocchini» - si trasformi in una «nuova maschera
della discriminazione».
«Facciamo attenzione perché rischiamo di scavare ancora una volta quel fosso che ci separa da loro,
che saranno così "condannati" a essere marocchini».
Porre troppo l'accento sulla diversità rischia di farci dimenticare tutto ciò che può avvicinarci.
E poi un individuo non è mai solo la «sua cultura», né è mai solo «una cultura».
Fissare le persone alla loro cultura di appartenenza è spesso «un'operazione politica» che sotto la
patina della cultura cela ben altre spinte, ben altri interessi. Con esiti distruttivi sui legami sociali e
sulla possibilità di costruire una «buona convivenza» sociale dentro contesti ormai multiculturali.
In questa conversazione Aime, docente di antropologia culturale dell'Università di Genova e
scrittore di saggi e opere narrative, oltre a riformulare il rapporto tra gli individui e la loro cultura,
invita anche a ripensare il concetto stesso di cultura.
Se pensate come un dato assoluto, dice, le culture divengono un recinto invalicabile.
«Non possiamo cristallizzare le culture, la cultura è un cantiere sempre aperto», un sovrapporsi e un
intrecciarsi di storie, idee, gusti, identità, sogni, saperi.
È paradossale che a cristallizzare le culture abbia contribuito la stessa antropologia, che in passato
ha studiato le culture «altre», esotiche, mentre oggi orienta i propri studi sulle connessioni e sul
meticciarsi delle culture nella nostra società. Trovando in questo un'inedita utilità pratica, come
testimonia sempre più anche il suo inserimento nei corsi di studi di laurea breve per infermieri e
assistenti sociali.
Domanda. La prima domanda che volevamo farti nasce da una curiosità: oggi un antropologo
che cosa fa? Un tempo andava nei paesi esotici, a studiare culture lontane, ma oggi?
Risposta. In effetti il mestiere dell'antropologo - ammesso che fare l'antropologo sia un mestiere - è
molto cambiato: i tempi dorati dell'antropologia classica sono finiti. Dico scherzando i «tempi
dorati», quando c'erano i selvaggi e i primitivi che oggi non ci sono più. Oggi il mondo, pur
conservando le sue differenze, le mantiene ma non più nettamente separate, senza compartimenti
stagni; per cui capita di trovarsi in pieno Sahel e di incontrare qualcuno che con una radiolina,
captando emittenti internazionali come BBC International o Radio France International che
trasmettono telegiornali in lingua etnica, ti dice i risultati della Champions League del giorno prima.
Con questo bisogna fare i conti, e a molti non piace. Conosco colleghi che hanno smesso di studiare
nel momento in cui i viaggi in piroga sono diventati con piroga a motore.
1
Il mito delle culture pure
A me personalmente interessano di più queste trasformazioni.
Tutti noi quando si parla di antropologia pensiamo: «Antropologia è lo studio degli altri popoli».
Ma questo è vero solo in parte. In realtà la metafora più bella è quella coniata da un antropologo
americano di inizio secolo scorso, il quale aveva parlato del «giro lungo»: l'antropologo deve fare il
giro lungo, deve andare lontano, ma in fondo l'andare lontano è funzionale a studiare meglio il
vicino, noi.
Non a caso il titolo del libro forse più bello e più celebre di Kluckhohn - l'antropologo a cui mi
riferivo - era proprio Lo specchio dell'uomo.
Andare lontano, e vedere il diverso, per capire meglio noi stessi.
Oggi il diverso è sempre più tra noi e l'antropologo si trova a fare i conti con la propria società, a
studiare quasi sotto casa e non solo per l'immigrazione - che l'Italia vive solo da qualche decennio ma anche per altri fenomeni, come il turismo. Ci troviamo a riflettere sempre più su di noi.
Il periodo classico dell'andare a studiare per primi le popolazioni lontane è stato fatto. Oggi bisogna
inventarsi un modo nuovo di guardare il mondo. Le culture pure, che dubito siano esistite in
passato, oggi di sicuro non ci sono; allora proviamo a studiare questi meccanismi di connessione, di
meticciato, di trasformazione ed evoluzione.
Domanda. Oggi nelle scuole di ogni ordine e grado convivono bambini e ragazzi provenienti
da diverse parti del mondo. Nel tuo libro Eccessi di culture (Einaudi, 2004) avverti: «Bisogna
fare attenzione a non attribuire alle differenze culturali un carattere assoluto e monolitico,
soprattutto a non fissare gli uomini a una cultura. Gli individui cambiano cultura nel corso
della loro storia; non congeliamo il maghrebino o il marocchino alla nostra idea di ciò che
deve essere un marocchino». È sbagliato dare troppo peso alle culture degli altri?
Risposta. La prima idea è che nell'enfatizzare troppo, anche a fini buoni, le culture degli altri, si
rischia di scavare sempre di più il fossato tra noi e gli altri.
Devo dire che, mentre scrivevo quel libro, mi accorgevo anche del paradosso, nel senso che gli
antropologi sul concetto di relativismo culturale hanno fatto fortuna! E da antropologo trovarsi a
dire: «Attenzione a questo eccesso di attenzioni alle culture diverse» sembra quasi di sputare nel
piatto in cui mangi… Però questa riflessione nasce da una serie di esperienze concrete, da corsi di
intercultura nelle scuole, da situazioni quindi extra-accademiche.
Oggi ci si trova in una situazione un po' paradossale, in cui tutti usano il relativismo da una parte e
dall'altra.
Da un lato abbiamo gli xenofobi: qual è oggi il discorso di molte élite e gruppi xenofobi?
«Noi siamo per la valorizzazione delle culture e dei popoli».
Questi discorsi li fa anche la Lega con l'«Europa dei popoli».
Ma siccome tutte le culture devono rimanere pure e incontaminate, allora ognuno a casa propria!
Quindi anche i leghisti sono molto relativisti.
Si utilizza il relativismo anche per creare l'apartheid. L'apartheid sudafricano, merita ricordarlo, si
fondava sulla stessa filosofia: «Neri e bianchi hanno culture diverse, sono incompatibili, e quindi
ognuno deve avere il suo sviluppo»; questo è un atteggiamento che in pratica costituisce il vecchio
razzismo biologico del secolo scorso. Oggi abbiamo il razzismo senza razza, ma al concetto di razza
è stato sostituito quello di cultura. Si intende la cultura come un'entità, così come la razza era intesa
come un dato biologico, a cui corrispondevano anche caratteristiche culturali. La genetica oggi ha
smontato il concetto di razza; così lo si è sostituito con quello di cultura, ma dando per scontato che
se si nasce in un posto, per forza si ha quella cultura e per tutta la vita. Racconto un aneddoto, citato
2
in un libro di uno dei padri dell'antropologia, Raymond Firth, neozelandese di scuola britannica,
antropologo degli anni 30-40. Aveva fatto un lavoro interessante a Tikopia, isoletta della Polinesia.
Un giorno mentre parlava con un suo informatore polinesiano, di nome Tiforau, questi gli fa: «Tu
vieni sempre qui a trovarci. Mi piacerebbe che una volta mi portassi in Inghilterra, a vedere il suo
paese». Firth, forse con un po' di paternalismo colonialistico da uomo del suo tempo, gli dice: «Io ti
porto però guarda che da noi il modo di vita è tutto diverso, non so se ti troveresti bene…». E
questo Tiforau, nato e vissuto in questa isoletta, ribatte: «Che cos'è un uomo? Un sasso?». Come a
dire: «Non credi che io possa cambiare il mio modo di vita?». È stato un grosso atto di umiltà di
Firth citare questo episodio. Poteva evitarlo. Il fatto che l'abbia inserito è un grosso punto a suo
favore!
Da parte di chi invece vuole valorizzare il multiculturalismo o la pluricultura, oggi si svolge
un'operazione che a volte è rischiosa tanto quanto quella xenofoba.
Ricordo l'affermazione di un'insegnante: «Noi a scuola abbiamo due bambini marocchini; io cerco
sempre di farli parlare della loro cultura e delle loro tradizioni, ma loro non vogliono».
A me era venuto spontaneo dirle: «Ma perché devono fare i marocchini?».
Un bambino nato in Marocco, che oggi è qui, forse vuole il più possibile integrarsi, assomigliare ai
suoi coetanei, condividere giochi, passatempi e studio con loro e con noi. E noi, in nome della
nostra bontà di valorizzare le culture degli altri, rischiamo di continuare a farlo essere diverso.
Allora facciamo attenzione, perché volendo a fin di bene e con ottimi intenti valorizzare l'altro,
rischiamo di scavare ancora una volta quel fosso che ci separa da lui, che sarà in questo modo
«condannato» a essere marocchino! Poi potremo anche dire tutto il bene della cultura marocchina,
ma lui comunque resterà «un marocchino».
Il diritto di giocarsi le carte dell'identità
Domanda. Non condannare gli altri a essere ciò che noi vogliamo che siano, è l'invito che da
antropologo fai a insegnanti ed educatori?
Risposta. Sì. Non è infrequente nelle scuole imbattersi in un rifiuto degli studenti stranieri a parlare
dei loro vissuti, della loro cultura di provenienza. Questo atteggiamento è sintetizzato molto bene da
quella che è stata chiamata la «formula di Hans Jonas», filosofo e sociologo americano, che a
proposito degli emigranti o degli immigranti afferma: «Il nipote vorrà ricordare ciò che suo nonno
voleva dimenticare». Cosa voleva dire con questa frase? Che la prima generazione migrata, spesso
non ha né la voglia né il lusso di difendere la propria cultura, anzi spesso si mimetizza, cercando di
integrarsi. Quando poi la seconda generazione nella società ospitante, ecco che il nipote forse potrà
anche permettersi il lusso di ricordare le proprie origini. Per dire, un Robert De Niro che si vanta di
avere radici italiane, lui sì può farlo, però ci sono volute una o due generazioni! Dunque, non
condanniamo gli altri a essere ciò che vorremmo che fossero.
La difficoltà che hanno gli insegnanti nelle scuole primarie e secondarie oggi è talmente grande, che
non mi sento assolutamente di dare consigli generali o ricette. L'unica cosa che mi sento di dire è
che va salvaguardato il diritto alla scelta di essere quello che si vuole.
Si tratta di uno dei diritti fondamentali: se uno decide di non parlare della sua cultura, deve essere
lasciato libero di farlo. Io non credo che nessuno dimentichi o abbandoni la propria cultura di
origine, ma in certi periodi della nostra vita e in certe situazioni può essere necessario farlo.
Posso citare l'esperienza di un personaggio storico, Leone l'Africano, arabo musulmano andaluso
del 1500, originario di Granada. Cacciato dalla Spagna, musulmano, finisce in Marocco ospitato
dagli ebrei e poi dopo lungo peregrinare arriva alla corte del Re del Mali, che allora era uno dei
regni più potenti d'Africa. Rapito da inviati del Vaticano e portato a Roma, scrive una delle prime
3
storie dell'Africa che univano storia e geografia. Bene, all'inizio della sua relazione, lui afferma:
«Nel mio vagare, rivendico il diritto di elogiare il mio paese natale quando mi conviene, e di
parlarne altrettanto male - sempre se mi conviene - per salvare la vita». La sua vita era la
testimonianza di quante volte si è costretti a giocarsi le carte delle identità, magari non scegliendolo,
ma per necessità.
Le cose che ci uniscono
Domanda. Nell'invito a lasciare che sia l'altro a definirsi, a non ridurlo a rappresentante delle
sua cultura, c'è anche la consapevolezza che l'incontro con lui avviene più facilmente sulla
base delle cose che ci uniscono, più che di quelle che ci vedono diversi?
Risposta. Sì. In California, dove la popolazione ispanofona ha aggiunto il 50%, se non di più, le
associazioni che hanno sempre difeso i diritti degli ispanofoni hanno indetto un sondaggio, per
chiedere se si voleva che nelle scuole lo spagnolo fosse insegnato come prima lingua. Quasi l'80%
ha risposto «no».
Queste le motivazioni: «Io voglio che i miei figli - siccome viviamo negli Stati Uniti - abbiano un
futuro, e se continuano a parlare spagnolo saranno sempre americani di serie B; lo spagnolo glielo
posso insegnare a casa io; che imparino bene l'inglese, così potranno avere la possibilità di far
carriera e di essere dei cittadini considerati alla pari».
Quest'altro esempio mostra come a volte pecchiamo di eccesso di buonismo, e non ci accorgiamo
che poniamo troppo l'accento sulla diversità, che magari riguarda un 10-15% di ciò che ci distingue
dall'altro, e dimentichiamo tutto ciò che ci avvicina.
Anni fa quando c'erano i primi ambulanti marocchini coi tappeti sulle spalle, io abitavo a
Borgaretto, un paese vicino a Torino, e ricordo un anziano, vicino di casa, che aveva comperato un
portacenere da un marocchino. Incontrandolo, gli dico «che bel portacenere!» e lui mi risponde in
piemontese: «L'ho comprato da un marocchino, però era una brava persona». Questo signore
anziano, che aveva come ogni piemontese medio un tasso di razzismo, aveva fatto un'operazione
molto semplice: aveva cominciato a chiacchierare con questo marocchino e gli aveva anche offerto
il caffè, dopo aver comprato il posacenere. Questo anziano in gioventù era dovuto migrare in
Germania e mettendosi a parlare col marocchino si erano trovati a dire: «Che brutto dover star da
soli lontano dalla famiglia…»; avevano cioè scoperto di avere un pezzo di vita in comune. Quindi
che cosa aveva fatto il piemontese? Aveva semplicemente estratto il marocchino dalla categoria dei
marocchini, che per lui non erano brave persone, ma quello sì, perché ne aveva fatto una persona in
carne e ossa, cioè aveva tirato fuori la sua storia.
Allora, a volte, noi nel parlare di «cultura» - e su questo ci vorrebbe il mea culpa degli antropologi le consideriamo come categorie astratte, come assoluti, e così quando parliamo di «stranieri».
La realtà dietro ogni individuo, al di là della cultura di appartenenza, esistono strategie, aspettative,
progetti di vita molto diversi.
Domanda. Da antropologo metti in luce come un individuo non è mai solo la «sua cultura», né
è mai solo «una cultura». Eppure i mass media parlano insistentemente e quotidianamente di
«guerra tra cultura», come se queste fossero dei monoliti. Le culture sembrano oggi
appiccicarsi in maniera indelebile alla pelle delle persone. Tu nel libro ti chiedi: ma in tutta
sincerità chi ha mai visto due culture incontrarsi o scontrarsi? Resta il fatto che lo scontro tra
cultura è l'incubo di questi nostri tempi…
4
Risposta. Sicuramente l'11 settembre ha dato un buon appoggio a chi voleva pensare alla guerra tra
culture. Non è causale che subito dopo l'11 settembre siano rispuntate nelle librerie pile del libro di
Samuel Huntington Lo scontro delle civiltà. Questo libro è diventato un best-seller, scritto nei primi
anni 90 dall'autore, che è uno storico contemporaneo, membro dello staff di consulenza
dell'amministrazione Bush. Huntington nel libro disegnava le future guerre tra civiltà, delineando
uno scenario in cui il mondo era diviso in blocchi. Il suo quadro lascia molto a desiderare, per
esempio per quanto riguarda la contrapposizione da lui disegnata tra mondo arabo-musulmano e
Occidente. Se oggi andiamo a vedere, il 90% abbondante dei paesi di quel blocco è a fianco
dell'Occidente: l'Arabia Saudita, il Pakistan e molti altri. La Cina, disegnata come mondo
comunista, oggi dal punto di vista economico fa concorrenza ai paesi più liberisti, senza contare
che, la Cina, ha grosse sacche musulmane al suo interno, e quindi mostra una situazione molto più
complessa.
Ma il problema è ancora una volta utilizzare queste cose.
Le culture né si incontrano né si scontrano; quando arrivano i barconi o le carrette del mare sulle
nostre coste, non ci sono culture, ci sono donne, uomini, bambini, e sono gente che scappa da
situazioni di fame, guerre, carestie o anche gente che non scappa da niente, ma vuole tentare un
futuro migliore.
Posso fare degli esempi vissuti; per esempio in Africa centrale la televisione di Stato è colonizzata
per il 70-80% dalle Tv delle ex potenze coloniali; ho fatto ricerca più che altro nell'Africa
francofona ma so che non è diverso in altre aree. In questi Paesi (il Mali, Benin, il Senegal) dove il
reddito medio di una famiglia è attorno ai 250 euro l'anno, trasmettono un equivalente del quiz di
Gerry Scotti, dove rispondendo a quattro domande, anche banali, si vincono 50 mila euro. Che
immagine si fa un ragazzo che vede questo alla televisione? Io mi sono sentito dire tante volte: «Se
vengo da voi avrò la macchina, la televisione, il forno, il microonde, il computer…»; e vagli a
spiegare che «no, a te non te lo diamo».
Persone, non culture in senso astratto
Domanda. Questo era successo anche con gli albanesi, che captavano le nostre trasmissioni
televisive e vedevano un paese ricco e sfavillante. Poi una volta sbarcati sulle coste italiane
hanno impattato una realtà ben diversa…
Risposta. E qualcuno avrebbe voluto ripartire subito col gommone. L'immagine dell'Occidente,
dell'Europa oggi, paradossalmente, attraverso i media è molto più conosciuta di un tempo e molta
gente non parte solo perché disperata.
Su questo c'è anche un po' una falsa informazione, nel senso che spesso sento dire: «Sono i più
poveri quelli che migrano».
Posso assicurare che in Africa i più poveri non hanno neanche i soldi per comprare un biglietto
della corriera dalla città alla capitale; chi arriva fin qui quindi è perché comunque ha già un minimo
di disponibilità economica. Magari perché tutta la famiglia ha investito su di lui: «Ti mandiamo e
poi se fai fortuna ci restituisci i soldi». Non tutti quelli che migrano scappano per situazioni
disperate. Ma anche migrare per star meglio è un diritto. Tutti noi cerchiamo di costruirci un futuro
migliore, no?
Ho avuto incontri con donne del quartiere di Porta Palazzo a Torino, in un seminario fatto per
cercare di creare delle cooperative di lavoro; ricordo molte donne nigeriane delusissime e dicevo
loro: «Ma voi tornereste nel vostro paese?». E loro: «Io sì, ma poi i nostri figli cosa fanno là?
5
Restiamo perché forse qui avranno un futuro migliore». Quindi ognuno sceglie delle strategie di
vita, o meglio a volte non le sceglie perché gli sono imposte dalle condizioni; non sempre purtroppo
nella vita possiamo scegliere che cosa essere.
Molto tempo fa in una lunga intervista Elio Toaff, allora rabbino e capo della comunità ebraica
italiana, ripercorreva un po' tutta la sua vita. Il giornalista ad un certo punto gli chiese: «Cosa ha
significato per lei essere ebreo?». Mi ricordo che ci pensò un po' e poi rispose: «In realtà mi sono
sentito per la prima volta davvero ebreo nel '38, quando sono state emanate le leggi razziali; prima
mi ero sempre pensato cittadino italiano di cultura e fede ebraica». A volte non c'è scelta appunto:
lui è stato costretto, nel momento in cui la legge lo privava di diritti, a essere solo l'ebreo, non più il
cittadino italiano, perché quei diritti di cittadino non li aveva più. Sartre diceva che è
l'antisemitismo che ha creato il semita, cioè a volte le condizioni ci costringono a scegliere, anche
giocandoci queste carte culturali
Insistere sull'integrazione culturale?
Domanda. Può esistere secondo te una politica di integrazione interculturale? O forse è più
utile puntare su politiche di integrazione sociale ed economica?
Risposta. Ancora una volta, con un mea culpa dell'antropologia, penso che le politiche di
integrazione, se partono dal punto di vista culturale, rischiano di proporre un po' degli schemi e
degli stereotipi, prima di tutto perché - ripeto - quando parliamo di intercultura, cosa vogliamo dire?
Noi siamo già tutti multiculturali.
Le culture sono tutte bastarde e lo dico nel senso bello della parola, cioè siamo tutti dei gran meticci
culturali. Ricordo di aver letto sul libretto scritto dal fondatore del museo di storia naturale e
antropologia qui a Torino, nel ventennio, quando c'era l'elogio della razza italiana, una frase quasi
commovente: «La razza italiana si è mantenuta pura e fiera nonostante qualche invasione». Voglio
dire: facciamo prima a contare chi non ci ha invaso! Questa è un po' la prospettiva oggi. Siamo già
tutti prodotto di incroci, di interazioni.
C'era un professore di antropologia americano, Ralph Linton, che negli anni '20-'30 iniziava il suo
corso di antropologia in questo modo: partendo dall'ipotesi che più o meno tutti gli americani
pensano che «tutto ciò che è al mondo è americano» chiedeva ai suoi allievi che gesti avessero fatto
al mattino prima di arrivare a lezione. «Cosa hai fatto come primo gesto? Hai scostato il lenzuolo
fatto in cotone, fibra prodotta in India nel VI secolo a.C., hai fatto colazione in una scodella di
ceramica prodotto inventato in Cina, hai preso il thè che ti arriva dall'India oppure il caffè che ti
arriva dall'Abissinia o magari il cacao che proviene dal Messico…». Poi continuava con tutta una
serie di riferimenti simili, concludendo: «Esci e vai a comprare il giornale, paghi con una moneta di
invenzione della Namibia, compri un quotidiano stampato su carta, procedimento inventato in Cina,
stampato con caratteri mobili escogitati in Europa nel 1450, e a seconda delle notizie ringrazi o
bestemmi una divinità medio-orientale di averti fatto americano».
Questa era l'introduzione che Linton era solito fare, ed era un ottimo modo per smontare questa
credenza della cultura pura.
Quindi io penso che l'intercultura si sviluppi nella realtà: se i bambini che oggi crescono nelle classi
cominciano ad avere i compagni di scuola cinesi, senegalesi, maghrebini pian piano iniziano a
relazionarsi e a stare insieme tra culture diverse. Posso fare un esempio anche sulla mia pelle: io
sono del '56; per mio padre chiunque fosse nato un po' più a Sud era «un napoli», come si diceva
qui a Torino? Ecco, io sono andato a scuola con la generazione dei figli dei primi immigrati e
nessuno di noi si è mai posto il problema se il suo compagno fosse un meridionale. Penso che in
6
parte l'integrazione andrebbe molto più portata avanti dal punto di vista economico e sociale, perché
spesso dietro a questi scontri, che chiamiamo di cultura o razzisti, si nascondono competizioni per
le risorse.
Ricordate nei primi anni '90, quando era stata fatta la proposta di fare un centro per accoglienza
immigrati a Mirafiori Sud, quartiere con grandi problemi qui a Torino? La gente del quartiere si era
ribellata, e la sinistra aveva tacciato di razzismo l'episodio. Ma chiediamoci: si trattava davvero di
razzismo, oppure di paura che l'immigrato potesse fare concorrenza all'abitante di Mirafiori Sud
disoccupato? Allora è razzismo o è concorrenza per le risorse? Perché non hanno proposto di farlo
alla Crocetta (quartiere residenziale di Torino, ndr) il centro per gli immigrati per esempio? Ecco mi
sembra che oggi dietro al discorso alle retoriche etnico-culturali si nascondano problematiche che
invece hanno radici di tipo socio-economico.
Dietro i cosiddetti «conflitti culturali»
Domanda. In questi anni di grandi migrazioni la politica ha strumentalizzato le questioni
etniche per coprire le proprie incapacità ad affrontare i problemi dal punto di vista sociale ed
economico. Intendi dire questo?
Risposta. Io penso che la differenza culturale possa anche portare a uno stato di antipatia, di
sofferenza, di tensione, e anche di razzismo verso l'altro. Esiste il razzista «doc», che dice «a me i
negri fan schifo», ma non per questo li va a picchiare. Quand'è che invece questa differenza
culturale, questo attrito si trasforma in competizione, in lotta o in violenza? Quando viene
strumentalizzato da élite di potere o di contropotere.
Posso citare molti casi: ad esempio, nel Sud della Francia, dove Jean-Marie Le Pen del Front
National ha intercettato un malumore nelle fabbriche, dovuto a una crisi economica che ha prodotto
una forte disoccupazione, e ha incanalato tutta questa tensione e questa rabbia nei confronti degli
immigrati («Son loro che ci rubano il lavoro»). E allora un territorio che era una roccaforte nel PCF
diventa del Front National Raciste, ma semplicemente perché si strumentalizza una sofferenza.
La Lega - altro esempio - ha captato un malumore esistente, che altre forze politiche forse non
hanno saputo cogliere, e lo ha convogliato in discorsi più o meno deliranti.
Altro caso ancora: uno dei casi più lampanti, che è persino difficile sintetizzare. Tutti conosciamo i
massacri del Ruanda tra Hutu e Tutsi. L'immagine che spesso è data di questo conflitto è che si tratti
di uno scontro tra due etnie, Hutu e Tutsi appunto. Dovremmo invece chiederci: come mai per
qualche migliaio d'anni queste due etnie hanno sempre convissuto e non si sono mai massacrate?
Forse la risposta è da cercarsi nella politica coloniale belga, che ha creato strumentalmente un'élite
Tutsi a sfavore degli Hutu, inventando una differenza sociale e culturale che prima non esisteva.
Altro caso ancora: ho avuto modo di conoscere proprio a Roma Safija, la donna nigeriana
condannata alla lapidazione, quando le è stata conferita la cittadinanza onoraria, e anche di parlare
con l'avvocato che l'aveva difesa. La Nigeria è islamica dall'anno Mille, soprattutto le regioni del
nord, e la Sharia non è mai stata applicata. Come la mettiamo? Il fatto è che la Nigeria sta tentando
di democratizzarsi un po' e le lobby economiche, sentendosi venire meno il terreno da sotto i piedi,
hanno giocato la carta del fondamentalismo islamico di massa. Di disperati che per un euro vanno a
manifestare per qualunque cosa, in Nigeria ne trovate quanto ne volete! L'avvocato che ha difeso
Safija spiegava che uno degli argomenti grazie al quale aveva vinto la causa era stato dimostrare
che tre quarti dei giudici della corte islamica, che avrebbe dovuto giudicare questa donna, non
conosceva l'arabo. Questo per dire che questa Corte islamica era stata inventata, per dare vita a una
7
messa in scena. Allora anche in questo caso si tratta davvero di un discorso di fondamentalismo
islamico o dietro ci sono ben altre ragioni?
Domanda. Abbiamo ragionato sull'ambiguità delle parole, sul concetto di identità e di cultura.
Secondo te cos'è una cultura oggi? Come la possiamo definire?
Risposta. A volte, neanche dopo 60 ore di corso credo di essere riuscito a definire una cultura.
Come definizione base terrei buona quella classica di Charles Taylor, che si trova sui manuali da
antropologia, secondo cui la cultura è «quell'insieme di regole sociali e di valori religiosi che
vengono trasmessi di generazione in generazione». A questa definizione aggiungerei che tutti noi
ereditiamo una cultura, che cresciamo da qualche parte, condividendo una lingua, una fede
religiosa, un sistema di parentela, un modo di leggere il mondo.
In fondo la cultura cos'è? Una strategia per vivere in questo modo e non si può negare che esistono
differenze sostanziali - per fortuna - tra culture. Quello su cui però oggi dobbiamo riflettere è che il
fatto di avere una cultura e una identità non ci obbliga a essere così monolitici. La nostra identità è
un continuo frutto di negoziato, ed è costitutivamente un'entità relazionale. Come singoli individui,
senza gli altri, non potremmo avere un'identità.
Le tre richieste dei Kanak
Posso utilizzare un aneddoto che spiega meglio di ogni concetto cosa sia l'idea di cultura.
Lo ha raccontato Renzo Piano, il famoso architetto genovese. Questi fu incaricato anni fa da
Mitterrand di un progetto di costruzione in Nuova Caledonia, un'isola dell'Oceania, possedimento
francese con una popolazione a maggioranza Kanak, i quali hanno una forte spinta autonomista,
Mitterrand ha deciso di costruire un Centre Culturel, che è stato dedicato a Jean-Marie Tjibaou,
leader dell'autonomismo Kanak, commissionandolo a Renzo Piano. Sembrano dei grandi gusci
reticolari, l'avrete visto su tutti i cataloghi di Renzo Piano, in genere è l'opera più fotografata.
Renzo Piano nel suo diario racconta l'incontro avuto con gli intellettuali Kanak prima dell'inizio
della progettazione, in cui domanda loro se hanno qualche richiesta da fargli. Gli chiedono tre cose:
la prima, che ricordi l'architettura tradizionale; la seconda, che esprima l'oralità, perché la loro
cultura è orale (e questo Piano l'ha risolto brillantemente con delle assicelle di legno che a seconda
dell'inclinazione del vento producono un rumore che sembra un brusio, un chiacchiericcio di
fondo…); la terza, infine - e la più bella - che sembri una costruzione non finita, perché la cultura è
un cantiere sempre aperto (se voi guardate questa costruzione ci sono infatti delle putrelle e dei
bulloni ancora in evidenza…).
È una delle definizioni più belle che si potessero dare di cultura. All'ingresso di questo centro c'è
una frase tratta proprio da un discorso di Jean-Marie Tjibaou, leader Kanak, che propone un'idea
dinamica di tradizione: il ritorno alla tradizione è un mito; la nostra identità è fatta di memoria e di
oblio; più che nel passato, va cercata nel suo costante divenire.
Ecco, credo che poche frasi potessero sintetizzare meglio questa idea dell'identità e della cultura
come continuo lavoro di costruzione sempre aperto. Oggi noi non siamo ciò che erano gli italiani
cinquanta o cento anni fa, e non siamo quello che sarà l'italiano medio fra cinquant'anni.
Non possiamo cristallizzare le culture; sono sempre stati processi in movimento, continuamente
rimodellate, perché gli individui si sono sempre mossi nel mondo nel corso della storia e le idee
hanno circolato.
A me oggi viene da dire che fa quasi ridere chi paventa o chi auspica o parla di città multietniche,
multuculturali; pensiamo cosa doveva essere la Roma imperiale, o Gerusalemme e Costantinopoli, o
8
Venezia…
È ridicolo pensare che siamo noi i primi multietnici. Pensate cosa dovevano essere quelle città.
Oggi parlare di multiculturalità come pericolo significa veramente strumentalizzare. Voglio dire che
non è mai esistita la separazione tra gli individui e le culture; ci siamo sempre incrociati, incontrati,
mossi nel mondo; e alcune idee passano, altre meno, altre ancora ci penetrano dentro e neanche ce
ne accorgiamo. È un processo normale; ed è sempre stato così nella storia; non è una novità di oggi.
Forse oggi tutto avviene più in fretta, questa è probabilmente la differenza.
Intervista a MARCO AIME a cura di CHIARA CASTIGLIONI e CLAUDIA GALETTO
Questa conversazione nasce all'interno dell'iniziativa culturale «Convivere… Voci in dialogo»,
promossa dalla Regione Piemonte, nell'ambito della Rete regionale di servizi per l'educazione
ambientale, e dalla Città di Torino, e organizzata dal Consorzio Pracatinat, in collaborazione con
l'IRRE Piemonte.
MARCO AIME - docente di antropologia culturale dell'Università di Genova - viaggiatore e
scrittore di saggi e opere narrative - e-mail: [email protected]
Fonte: ANIMAZIONE SOCIALE, anno XXXVII, n. 210, Febbraio 2007
DIREZIONE - Associazione Gruppo Abele - Corso Trapani 95 - 10141 Torino
REDAZIONE: Tel. (011) 3841048 - Fax (011) 3841047
E-mail: [email protected]
Sito Internet: www.gruppoabele.org
9