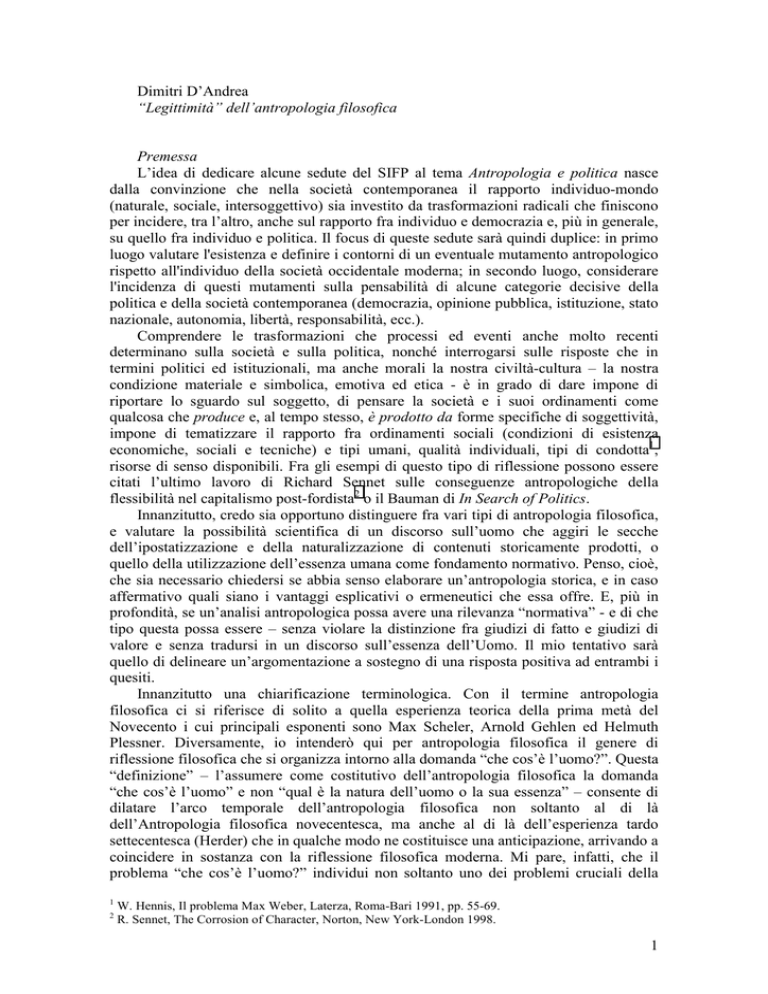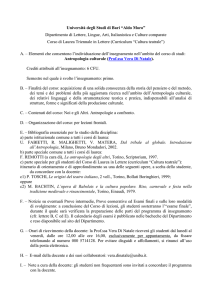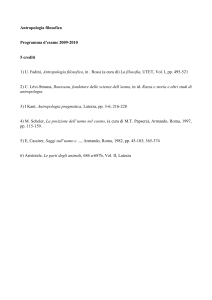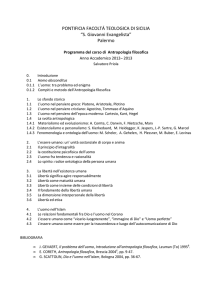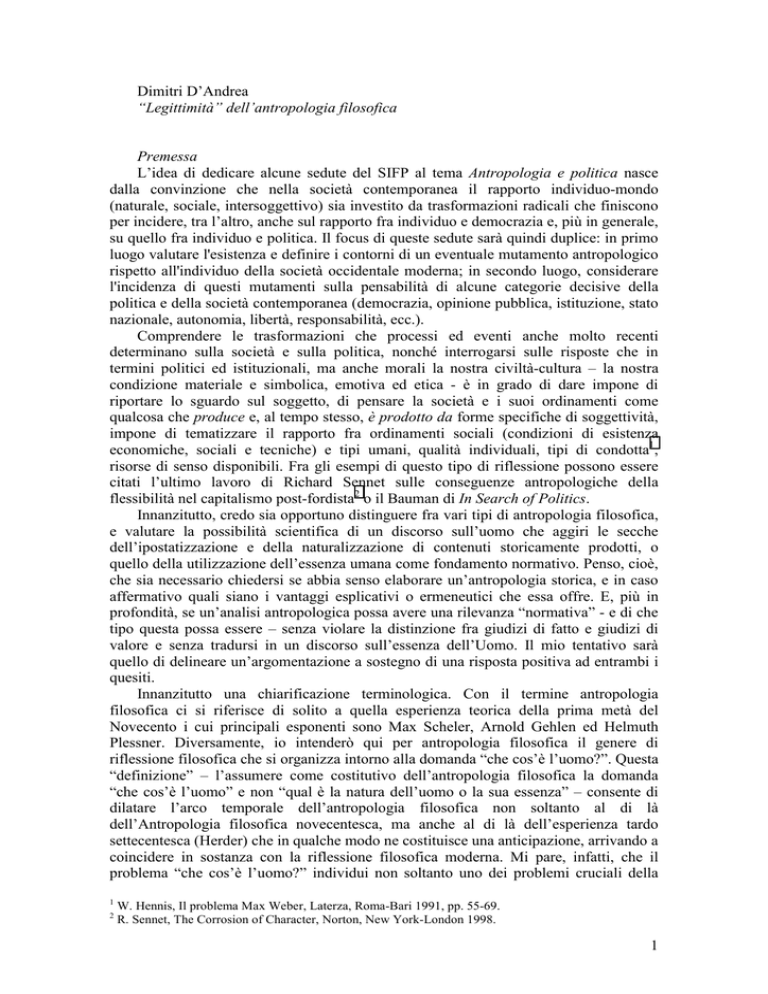
Dimitri D’Andrea
“Legittimità” dell’antropologia filosofica
Premessa
L’idea di dedicare alcune sedute del SIFP al tema Antropologia e politica nasce
dalla convinzione che nella società contemporanea il rapporto individuo-mondo
(naturale, sociale, intersoggettivo) sia investito da trasformazioni radicali che finiscono
per incidere, tra l’altro, anche sul rapporto fra individuo e democrazia e, più in generale,
su quello fra individuo e politica. Il focus di queste sedute sarà quindi duplice: in primo
luogo valutare l'esistenza e definire i contorni di un eventuale mutamento antropologico
rispetto all'individuo della società occidentale moderna; in secondo luogo, considerare
l'incidenza di questi mutamenti sulla pensabilità di alcune categorie decisive della
politica e della società contemporanea (democrazia, opinione pubblica, istituzione, stato
nazionale, autonomia, libertà, responsabilità, ecc.).
Comprendere le trasformazioni che processi ed eventi anche molto recenti
determinano sulla società e sulla politica, nonché interrogarsi sulle risposte che in
termini politici ed istituzionali, ma anche morali la nostra civiltà-cultura – la nostra
condizione materiale e simbolica, emotiva ed etica - è in grado di dare impone di
riportare lo sguardo sul soggetto, di pensare la società e i suoi ordinamenti come
qualcosa che produce e, al tempo stesso, è prodotto da forme specifiche di soggettività,
impone di tematizzare il rapporto fra ordinamenti sociali (condizioni di esistenza
economiche, sociali e tecniche) e tipi umani, qualità individuali, tipi di condotta1,
risorse di senso disponibili. Fra gli esempi di questo tipo di riflessione possono essere
citati l’ultimo lavoro di Richard Sennet sulle conseguenze antropologiche della
flessibilità nel capitalismo post-fordista2 o il Bauman di In Search of Politics.
Innanzitutto, credo sia opportuno distinguere fra vari tipi di antropologia filosofica,
e valutare la possibilità scientifica di un discorso sull’uomo che aggiri le secche
dell’ipostatizzazione e della naturalizzazione di contenuti storicamente prodotti, o
quello della utilizzazione dell’essenza umana come fondamento normativo. Penso, cioè,
che sia necessario chiedersi se abbia senso elaborare un’antropologia storica, e in caso
affermativo quali siano i vantaggi esplicativi o ermeneutici che essa offre. E, più in
profondità, se un’analisi antropologica possa avere una rilevanza “normativa” - e di che
tipo questa possa essere – senza violare la distinzione fra giudizi di fatto e giudizi di
valore e senza tradursi in un discorso sull’essenza dell’Uomo. Il mio tentativo sarà
quello di delineare un’argomentazione a sostegno di una risposta positiva ad entrambi i
quesiti.
Innanzitutto una chiarificazione terminologica. Con il termine antropologia
filosofica ci si riferisce di solito a quella esperienza teorica della prima metà del
Novecento i cui principali esponenti sono Max Scheler, Arnold Gehlen ed Helmuth
Plessner. Diversamente, io intenderò qui per antropologia filosofica il genere di
riflessione filosofica che si organizza intorno alla domanda “che cos’è l’uomo?”. Questa
“definizione” – l’assumere come costitutivo dell’antropologia filosofica la domanda
“che cos’è l’uomo” e non “qual è la natura dell’uomo o la sua essenza” – consente di
dilatare l’arco temporale dell’antropologia filosofica non soltanto al di là
dell’Antropologia filosofica novecentesca, ma anche al di là dell’esperienza tardo
settecentesca (Herder) che in qualche modo ne costituisce una anticipazione, arrivando a
coincidere in sostanza con la riflessione filosofica moderna. Mi pare, infatti, che il
problema “che cos’è l’uomo?” individui non soltanto uno dei problemi cruciali della
1
2
W. Hennis, Il problema Max Weber, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 55-69.
R. Sennet, The Corrosion of Character, Norton, New York-London 1998.
1
filosofia - e della filosofia politica in particolare – moderna, ma che ne costituisca in
qualche modo uno dei tratti peculiari. In particolare mi sembra tipico della filosofia
politica moderna il ricorso ad una riflessione su “che cos’è l’uomo?” in chiave
fondativa. La risposta alla domanda “che cos’è l’uomo?” gioca, infatti, in una gran
quantità di autori anche molto lontani da una prospettiva immediatamente normativa
(Hobbes) il ruolo di passaggio insostituibile dell’argomentazione filosofico-politica,
spesso intervenendo a definire sia l’orizzonte problematico, sia lo spazio di possibilità
del discorso politico.
Prima di discutere la rilevanza e l’attualità di una riflessione antropologica mi
sembra indispensabile introdurre una sommaria fenomenologia che restituisca l’idea
della pluralità e profonda diversità delle antropologie “possibili” e che consenta di
identificare le caratteristiche indispensabili di un possibile discorso antropologico
contemporaneo.
1. Caratteri e percorso dell’antropologia filosofica
L’antropologia moderna nasce come risposta all’ansia tipicamente moderna del
fondamento, all’esigenza di un punto di partenza del ragionamento sulla società e sulla
politica che non rimandi necessariamente ad un sistema metafisico e che consenta di
argomentare intorno alla società. L’antropologia filosofica è il versante disciplinare di
quel venire meno dell’ordine come dato naturale che costituisce il nucleo centrale della
modernità. La domanda “che cos’è l’uomo?” assume rilevanza crescente proprio a
partire dalla mancanza di criteri oggettivi e/o condivisi per stabilire forme e finalità
dell’ordine sociale e politico.
L’antropologia filosofica nasce, quindi, dall’esigenza di rispondere al problema
tipico della modernità (come è possibile l’ordine) e alle sue diverse declinazioni e
modulazioni (ordine sociale, politico e loro relazione in primis). L’idea di fondo che
accomuna tutte le antropologie è che la risposta alla domanda “che cos’è l’uomo”
contribuisca a dare indicazioni non soltanto sul funzionamento della società, ma anche
su che cosa fare per migliorarla. Quasi sempre dimensione e intenti analitici sono parte
integrante di un percorso argomentativo che ha comunque anche uno spessore
normativo. E quasi sempre la modalità con cui dimensione analitica e proposta
normativa si intrecciano è legata al fatto che la riflessione antropologica interviene a
limitare le finalità che è possibile perseguire e gli strumenti a cui è possibile ricorrere
per perseguirle. La riflessione antropologica delimita l’ambito di ciò che posso
“sperare” e dei mezzi che posso efficacemente utilizzare.
Questa configurazione di un’antropologia “empirico”-descrittiva che interviene
nella definizione dei compiti, delle forme e dei mezzi della politica e della società mi
sembra restituisca la generalissima cifra comune di quasi tutte le antropologie lato sensu
politiche della prima modernità (con l’eccezione forse di Locke, almeno secondo certe
interpretazioni): da Hobbes a Rousseau, da Mandeville ad Smith. La dimensione
normativa viene argomentata a partire da una certa antropologia, ma quest’ultima non
ne costituisce il fondamento ontologico. Mi sembra, cioè, estraneo alla fisionomia
dell’antropologia filosofica moderna l’operazione di dedurre la dimensione normativa
direttamente dalla definizione di una natura umana: soltanto l’ontologia scheleriana dei
valori costituisce forse un esempio di deduzione del dover essere dell’uomo
direttamente dal suo concetto o dalla sua essenza. In quasi tutti gli altri casi, il percorso
mi pare più indiretto e caratterizzato dall’intervento dell’antropologia come dimensione
“empirico-fattuale” nella elaborazione di finalità e strategie. Da questo punto di vista
l’antropologia hobbesiana possiede un carattere paradigmatico: non la deduzione di un
2
contenuto normativo da una concezione della natura umana come qualcosa che contiene
in sé delle finalità positive, ma il tentativo di individuare dei comportamenti su cui gli
uomini si possono accordare a partire da una natura che, al di fuori di ogni telos, rende
tutti interessati alla conservazione di sé come primo dei beni. La riflessione
antropologica hobbesiana presenta le caratteristiche-tipo dell’antropologia moderna: una
descrizione della natura umana, della condizione umana come ciò che definisce i
compiti a cui trovare soluzione e delimita l’ambito dei mezzi e delle soluzioni possibili.
Prima di affrontare la questione dei caratteri e dell’utilità di un’antropologia
filosofica contemporanea mi sembra opportuno distinguere i vari tipi di riflessione
antropologica a partire da quattro alternative: la prima fra un’antropologia analitica e
un’antropologia assiologica; la seconda fra un’antropologia positiva e un’antropologia
negativa; la terza fra antropologie della natura umana e antropologie storiche; l’ultima
fra antropologie delle passioni e antropologie del senso o delle immagini del mondo.
L’intento non è ovviamente quello di elaborare una tassonomia completa delle
antropologie, ma semplicemente di mettere in luce delle differenze e delle opposizioni
che poi verranno utilizzate nella parte in cui tenterò di delineare i caratteri di una
antropologia che possa giocare un ruolo nella riflessione filosofica sulla politica e sulla
società.
b. Antropologia positiva - antropologia negativa
Una distinzione chiave fra i vari modelli antropologici è quella fra antropologie
positive ed antropologie negative. Le antropologie positive sono quelle antropologie che
attribuiscono alla natura umana un contenuto determinato, che attribuiscono all’uomo
alcune caratteristiche naturali che ne determinano in positivo alcuni tratti del
comportamento sociale e della relazione con l’ambiente. Quelle negative sono tutte le
antropologie dell’assenza di contenuto della natura umana, che attribuiscono all’uomo
una assenza di definitezza naturale che equivale all’assenza di qualsiasi limite naturale
alle forme in cui gli uomini possono strutturare il loro rapporto con il mondo. È
un’antropologia dell’assenza di un contenuto positivo – nel senso di positum – della
natura umana. È un’antropologia della natura umana come assenza di natura. Nietzsche
è stato il primo a formulare questa posizione: «Poiché l’uomo è più malato, più insicuro,
più mutevole, più indeterminato di qualsiasi altro animale non v’è dubbio - è l’animale
malato: come mai è così? Certo, più di tutti gli altri animali presi insieme, egli ha anche
tentato, innovato, affrontato, sfidato il destino: questo grande sperimentatore di se
stesso, questo inappagato, questo insaziato, che per l’ultima supremazia contende con
animali, natura e deità, questo pur sempre indomabile, eternamente di là da venire che
per l’empito della sua stessa forza non trova più requie, sì che il suo futuro, come uno
sprone, spietatamente gli va frugando nella carne d’ogni presente - come non dovrebbe
essere, un tale ardito e ricco animale, anche il più esposto al pericolo, il più lungamente
e profondamente malato tra tutti gli animali malati»3.
Un’antropologia vuota, un’antropologia da cui non è possibile dedurre in positivo
diritti, doveri, forme sociali e politiche. Un’antropologia negativa che colloca un
vacuum laddove gli altri animali hanno il pieno di una natura che li vincola a forme
definite di rapporto con il mondo. La malattia è appunto l’assenza di quel rapporto
fisso-rigido con l’ambiente che è condizione che determina al contrario la salute
animale.
Di una posizione sostanzialmente analoga G. Anders ha dato una definizione in
termini di antropologia della libertà. «[…] ho visto nell’uomo l’essere che
fondamentalmente non può essere sano e non vuole essere sano, insomma l’essere che
non può essere determinato, l’essere indefinito, che sarebbe un paradosso voler definire.
3
F. Nietzsche, Genealogia della morale, III dissertazione, § 13, p. 103.
3
[…] la libertà dell’uomo come affermazione in positivo del suo non potersi stabilire in
alcun luogo». «L’essenza dell’uomo consiste nel fatto che egli non ha un’essenza»4. È
appena il caso di notare che neppure una siffatta definizione della natura umana ne
rende impraticabile un uso immediatamente assiologico: Scheler fonda in modo
immediato su un’idea molto simile di natura umana la doverosità di una condotta e di un
agire che risponda adeguatamente a ciò che l’uomo è. In maniera sostanzialmente
difforme dal main stream dell’antropologia moderna, qui l’idea di natura viene usata
non come elemento analitico di rilevanza normativa, ma come fondamento ontologico
del valore della libertà.
L’idea di Gehlen dell’uomo come animale carente, indefinito e perciò al tempo
stesso compito a se stesso e costretto ad agire5 è, a mio avviso, solo in parte
riconducibile a questa immagine radicalmente negativa della natura umana.
c. Antropologia storica - antropologia della natura umana. Le antropologie
possono distinguersi inoltre fra le antropologie che pretendono di descrivere la natura
dell’uomo nella sua immutabilità e quelle antropologie che invece si concepiscono
come descrizioni di una tipologia umana storicamente definita e determinata. L’esempio
più ovvio della prima è l’antropologia hobbesiana; un esempio significativo della
seconda è la riflessione di Tocqueville e, per un diverso tipo di antropologia, quella di
Hans Blumenberg.
In un passaggio di La legittimità dell’età moderna H. Blumenberg formula
un’argomentazione che costituisce a mio avviso la più radicale neutralizzazione di
un’antropologia della natura umana. Più precisamente, una neutralizzazione
antropologica dell’antropologia filosofica: «L’autoconservazione è una caratteristica
biologica e, nella misura in cui l’uomo entrò sulla scena del mondo come essere
imperfettamente equipaggiato ed adattato, fin dal principio egli ebbe bisogno dei
sussidi, strumenti e procedimenti tecnici per soddisfare le proprie esigenze elementari.
Ma, riferito a questa natura dell’uomo, lo strumentario dell’autoconservazione rimase
costante per lunghi periodi di tempo ed entro margini di varianti minime. Sembra che,
per lunghi tratti della sua storia, l’uomo abbia considerato la propria situazione nel
mondo non come una situazione di carenza fondamentale e di miseria fisica»6.
Blumenberg non si rifiuta di praticare il livello della natura umana; anzi fa propria
una visione che ricalca nei punti essenziali l’immagine che della natura umana era stata
fornita dall’esperienza dell’antropologia filosofica. L’uomo imperfettamente
equipaggiato ed adattato di cui parla Blumenberg coincide perfettamente con l’uomo di
Gehlen e dell’antropologia filosofica. Su questa immagine del resto si basa gran parte
della riflessione di Blumenberg sul mito. Il mito è appunto quella modalità di relazione
con il mondo tipicamente umana che nasce dall’esigenza di fronteggiare l’assolutismo
della realtà, l’impatto con un mondo nei confronti del quale non si possiedono
meccanismi adattivi. Anche se l’inadattamento non costituisce un dato originario7, esso
è nondimeno l’atto, l’esperienza costitutiva dell’umano, l’elemento che definisce la
fuoriuscita dal preumano e l’ingresso nell’umano.
L’operazione di Blumenberg nei confronti dell’antropologia consiste tuttavia nella
radicale esclusione di rilevanza di questa origine. Ciò che ha dettato la forma della
relazione dell’uomo nei confronti del mondo non è l’oggettività di questa condizione,
ma l’orizzonte che è stato delimitato dalla risposta simbolica, di senso a questa realtà.
4
G. Anders, L’uomo è antiquato, II, Bollati Borignhieri, [1980], Torino 1992, pp. 117-8.
A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, [1940 (1); 1950 (2)]Feltrinelli, Milano
1983, pp. 35-37.
6
H. Blumenberg, La legittimità dell’età moderna, [1966, 1974], Marietti, Genova 1992, p. 144.
5
7
4
L’uomo dis-adattato ha vissuto in uno mondo che percepiva creato e
provvidenzialisticamente ordinato per il suo bene: questa condizione è rimasta celata ai
suoi occhi, e di fatto non ha condizionato per quasi due millenni il suo rapporto con il
mondo. La reazione dell’uomo è stata iper-adattiva, non soltanto ha cancellato la
percezione della inadeguatezza, ma l’ha sostituita con una percezione di centralità e di
ordine finalisticamente governato che è il suo esatto contrario. Quello che allora è
rilevante nello scandire le forme della percezione del mondo e della realtà non è la
natura, l’oggettiva fisionomia del rapporto dell’uomo con il mondo, ma la forma in cui
esso (l’uomo) l’ha organizzato e l’organizza. Quel che conta non è l’antropologia come
descrizione di una oggettività, ma un’esperienza soggettiva degli esseri umani che non
intrattiene un rapporto di verità con quel prius, con quella oggettività. Comprendere, ad
esempio, la modernità significa comprendere l’irrompere di una coscienza del mondo il
cui dato significativo non è l’essere finalmente adeguata alla natura oggettiva e naturale
della condizione umana, ma il fatto di avere una certa fisionomia. Quello che conta è la
configurazione storica e contingente (non necessaria e mutevole) del rapporto dell’uomo
con il mondo e con i propri simili.
L’antropologia della natura umana perde importanza, completamente neutralizzata
nel suo senso e nel suo ruolo dalla predominanza e dalla assoluta centralità di quella
antropologia storica – di quella configurazione storicamente variabile del rapporto
uomo-mondo e uomo-uomo - che non necessariamente deve essere adeguata o fedele a
quella condizione oggettiva ed eterna di cui si occupa l’antropologia della natura
umana.
L’antropologia rilevante per il discorso filosofico sulla società e la politica non è in
primis quella della natura umana, ma quella dell’epoca in cui viviamo, un’antropologia
storica che può esprimere un rapporto con il mondo e con i propri simili all’insegna di
una percezione della realtà che può anche contraddire in modo patente quella che su un
piano meta-epocale possiamo ritenere la situazione oggettiva del rapporto uomo-mondo.
Sul piano del modello antropologico, e malgrado le assonanze quasi letterali con la
posizione di Gehlen, la posizione di Blumenberg sembra così avvicinarsi molto a quella
già ricordata di Anders.
d. Antropologie delle passioni - Antropologie del senso o delle immagini del mondo
Non si tratta di una vera e propria contrapposizione, ma più propriamente di una
differenza che mi sembra possieda una qualche rilevanza. Il punto che mi sembra
rilevante è relativo al fatto che le antropologie del senso o delle immagini del mondo
rendono esplicita la dipendenza, l’interrelazione, l’intreccio della stessa dimensione
emotiva con l’esistenza di un piano di senso che trascende non soltanto la singola
azione ma anche la vita del singolo individuo. Sono le antropologie che inseriscono le
dinamiche emotive che definiscono un tipo di soggettività nel contesto di una
percezione del mondo e del suo senso. Casi paradigmatici di questo tipo di antropologia
sono sia la ricerca weberiana sui tipi di personalità nella loro relazione con gli
ordinamenti del mondo e con le grandi religioni universali, sia la ricerca di Hans
Blumenberg. L’analisi delle passioni e di quella loro concreta fisionomia che
caratterizza un determinato tipo di soggettività non può prescindere dalle domande e
dalle risposte che sono disponibili per quel determinato tipo umano su questioni relative
al senso della vita e del mondo. L’immagine del mondo, della vita e di ciò che sta al di
là della vita individuale sono decisive per comprendere i caratteri di un tipo di
soggettività.
È sicuramente difficile individuare una linea evolutiva della riflessione
antropologica nella modernità. Si possono a mio avviso svolgere soltanto due
considerazioni di carattere negativo. La prima riguarda l’impraticabilità di una
5
descrizione dell’evoluzione dell’antropologia in direzione dell’affermarsi di una
antropologia storica. Se ricorriamo alla coppia antropologia storica – antropologie della
natura umana possiamo facilmente constatare che il Novecento conosce il riaffermarsi
indiscusso dell’antropologia della natura umana: l’esperienza teorica che va sotto il
nome di antropologia filosofica è un’antropologia della natura umana. Il ricorso fecondo
alle scoperte dell’etologia, della fisiologia e della biologia umane e delle scienze
empiriche dell’uomo in genere è finalizzato a restituire un’immagine della natura
dell’uomo come dato oggettivo e suscettibile di essere modificato. È vero: le
implicazioni normative di tale natura sono minime, ma nondimeno si radicano in una
idea della natura dell’uomo. La capacità corrosiva dell’antropologia filosofica
novecentesca nei confronti delle filosofie della storia si basa appunto sulla utilizzazione
della natura dell’uomo come fondamento prosaico di un divenire dell’uomo centrato
sulle istituzioni e caratterizzato dall’attivazione di meccanismi compensativi che non
possono essere completamente rimossi, e la cui parziale rimozione viene comunque
pagata a prezzi altissimi. Questo non vuol dire che manchino nel Novecento
antropologie storiche, ma semplicemente che non è possibile individuare una linea di
evoluzione dell’antropologia segnata dal venire meno di una pretesa di definizione della
natura umana.
La seconda riguarda l’uguale impraticabilità di una caratterizzazione della
trasformazione dell’antropologia lungo l’asse antropologie delle passioni – antropologie
del senso. Nel Novecento si ritrovano in abbondanza esempi di antropologie di ambedue
le specie.
2. Antropologia storica e filosofia politica e sociale
Può la filosofia politica e sociale fare a meno di un’antropologia? La mia risposta è
genericamente negativa. Non può, a mio avviso, fare a meno di un’antropologia storica
in una duplice accezione: analisi della soggettività nella sua configurazione presente;
collocazione di questa realtà in una prospettiva di più lunga durata che consenta di
cogliere tendenze e invarianze (Weber, Blumenberg, Bauman, ecc.). In una prospettiva
generale l’antropologia mi sembra parte integrante di uno sguardo filosofico sulla
politica e la società. Per uno sguardo filosofico sulla politica e la società mi pare
essenziale il riferimento alle strutture profonde dell’individualità contemporanea, alla
peculiare configurazione fra dimensione emotiva, immagini del mondo, risorse di senso,
costituzione psichica. E questo perché soltanto uno sguardo sul soggetto consente di
mettere a fuoco tre aspetti cruciali di ogni riflessione sulla società e la politica: le
conseguenze sugli individui delle forme sociali e delle decisioni politiche; gli spazi di
possibilità che esistono per modificare e “migliorare” le istituzioni politiche e sociali; le
condizioni di efficacia di un discorso normativo. Essenziale per la filosofia sociale è
un’antropologia storica che miri a mettere a fuoco le caratteristiche di lunga durata della
soggettività, il suo orizzonte: antropologia come una sorta di long durée della
soggettività, come luogo delle invarianti epocali e degli orizzonti ultimi che configurano
il soggetto di una determinata fase storica. In questo senso, descrittivo, storicoricostruttivo, consapevole della propria “contingenza” un’antropologia storica è una
parte essenziale della filosofia, un prospettiva essenziale per un interrogarsi sugli
ordinamenti sociali con un respiro propriamente filosofico. Mi pare, cioè, che lo
specifico dello sguardo filosofico sulla società sia il tentativo di cogliere e tematizzare
l’intreccio fra individuo e società, fra forme della soggettività e ordinamenti politici e
sociali. Il riferimento a questa dimensione mi sembra, del resto, inaggirabile anche per
6
qualsiasi proposta normativa che voglia raccogliere la sfida di un confronto con la
soggettività così com’è, che voglia accettare di confrontarsi con l’esistente.
Ma quale antropologia? Non credo che alla filosofia politica e sociale sia
indispensabile una antropologia della natura umana. Credo, invece, che in modo meno
impegnativo e carico di implicazioni e di assunzioni metafisiche sia indispensabile
un’antropologia storica. Un’antropologia che non postula l’esistenza di una natura
umana, ma che si limita a “censire” le forme concrete di “soggettività epocale” e a
ricostruirne le tendenze evolutive. Particolarmente significativo in questo quadro mi
pare il ricorso ad una dimensione comparativa non soltanto in senso diacronico, ma
anche in senso sincronico, nel senso, cioè, di una comparazione fra differenti tipi di
civiltà e fra i diversi tipi di soggettività.
L’approccio antropologico che a me pare più convincente è del tipo di quelle che ho
definito antropologie del senso o delle immagini del mondo: un’antropologia storica in
cui la presenza costitutiva di un riferimento alla dimensione metafisica del senso
consenta di tematizzare tra l’altro anche le conseguenze antropologiche di quella
condizione specificamente contemporanea che è lo sgretolarsi di qualsiasi struttura
sovraindividuale di senso, sia di carattere religioso, sia di filosofia della storia. Il tipo di
antropologia che mi sembra più fecondo per una riflessione filosofica sulla società e la
politica è quella che non prende le passioni come un dato ultimo ma le concepisce come
uno degli elementi che contribuiscono a definire ed è a sua volta definito dalle relazioni
sociali e dalle risorse di senso. L’antropologia analitica che ci interessa è l’assetto di
lunga durata che si stabilisce fra passioni, forme sociali e risorse di senso: si tratta di
una costellazione mutevole e in cui nessuno degli elementi costituisce il fondamento ma
semplicemente un elemento irriducibile della relazione. Antropologia come descrizione
della configurazione epocale della soggettività all’incrocio fra dimensione emotiva,
assetti sociali, risorse di senso (prospettive metafisiche). A quelle antropologie che
fanno entrare in gioco nella descrizione dei tipi di soggettività umana la componente
delle
rappresentazioni
astratte
di
carattere
metafisico,
religioso
o
Geschichtsphilosophisch. Il nostro rapporto anche emotivo con il mondo in aspetti
essenziali della nostra vita ed esperienza sociale mi pare in buona parte plasmato dalle
nostre immagini del mondo e, direi, in tanta parte dalle immagini di un “altro mondo”.
Weber è l’autore che forse più di ogni altro si è spinto sul sentiero di
un’antropologia storica del senso o delle immagini del mondo. L’intera Sociologia della
religione è un affresco di antropologia storica comparativa, la messa a confronto di ciò
che l’uomo è diventato in seguito all’intreccio fra diverse immagini del mondo, interessi
materiali e ideali, ordinamenti sociali. Competizione, lotta, padroneggiamento teorico e
pratico del mondo, l’intreccio fra rifiuto religioso e dominio razionale del mondo non
rappresentano costanti antropologiche che definiscono una ipostatizzata natura umana,
ma una concreta configurazione antropologica diversa e irriducibile a modelli di
soggettività come quelli tipici del mondo cinese o del mondo orientale. L’uomo è un
animale culturale nel senso che il suo rapporto con il mondo è mediato da una
percezione del mondo che è a sua volta il prodotto complesso di un insieme di fattori
che sfugge a qualsiasi determinante monocausale. La Sociologia della religione è il
tentativo di mettere a fuoco i fattori, o meglio il percorso che ha portato a quel
fenomeno assolutamente peculiare che è l’uomo occidentale moderno, ad una
configurazione della soggettività e degli ordinamenti di vita che non ha equivalenti in
altre parti del mondo. Nessuna ontologia, nessuna diversità della natura umana sta alla
base di una diversità che può essere definita, senza esitazione, antropologica, perché
possiede una dimensione temporale e una profondità da configurare una sorta di
seconda natura.
7
Ma proprio perché sganciata da un fondamento ontologico da una diversità nella
natura umana la riflessione di Weber è anche una riflessione sulla condizionatezza di
questa antropologia dell’uomo occidentale moderno e sul rischio che la parabola
evolutiva dell’Occidente moderno stesso metta in discussione non soltanto gli
ordinamenti di vita che hanno fatto la specificità dell’Occidente, ma anche la
soggettività che ha giocato un ruolo decisivo nel produrli. È il tema delle conseguenze
della morte di dio e della minaccia degli “ultimi uomini”. La morte di dio mette in
pericolo la modernità occidentale, espone la soggettività occidentale moderna al rischio
di una mutazione antropologica perché consuma - ha consumato - le risorse di senso che
ne hanno scandito la peculiarità. Il tema della morte di dio ci introduce a quella
dimensione della riflessione antropologica che si confronta appunto con gli esiti del
venir meno della prospettiva ultraterrena e del suo sostituto funzionale le filosofie della
storia.
3. Antropologia filosofica e dimensione normativa
Ma un’antropologia filosofica dell’epoca presente - in grado di declinare struttura
emotiva, ordinamenti sociali e orizzonti di senso - consente anche una operazione
fondamentale per una ricognizione filosofica della società e della politica: individuare
gli spazi di possibilità di un discorso normativo. Nella “migliore” tradizione della teoria
politica e della filosofia sociale moderna la proposta normativa si è sempre configurata
o come risposta ai disagi e alle patologie di una determinata configurazione storica della
soggettività, o come un “dover essere” che nella sua aspirazione a tradursi
effettivamente in istituzioni e ordinamenti politici e sociali finiva necessariamente per
venire a confronto con ciò che l’uomo era diventato. Mi pare che una relazione di
questo tipo fra dimensione normativa e riflessione antropologica conservi intatta tutta la
sua importanza.
Credo, tuttavia, che valga la pena interrogarsi anche su un ulteriore possibile
intreccio fra dimensione normativa e riflessione antropologica: quello che potrebbe
realizzarsi in una definizione normativa di natura umana. Mi chiedo cioè se il rapido
procedere delle scienze della vita, il suo intervenire sempre più in profondità sulla vita
umana non ponga problemi etici e politici per fronteggiare i quali si debba – si sia
costretti – a ricorrere ad un’idea normativa di natura umana, di vita umana, di essere
umano e così via. Le biotecnologie pongono cioè un problema di definizione
dell’umano, il problema di dotarsi di una definizione normativa di che cosa sia l’uomo
proprio a partire da una condizione in cui l’uomo può diventare se non tutto, molto altro
da quello che non soltanto zoologicamente è stato finora.
Problemi analoghi – anche se non esattamente identici - si pongono a partire dalle
conseguenze indesiderate, anche se ormai in gran parte conosciute-previste, della
capacità umana di dominare e sfruttare tecnicamente risorse non rinnovabili del pianeta.
Il rapporto uomo-natura, il rapporto con le altre specie animali e con l’ecosistema è
ormai, anche nelle sue dimensioni più generali, un rapporto decidibile, e decidere come
vogliamo che si configuri rimanda ad un’idea di come vogliamo che l’uomo di domani
sia.
Mi sembra, per concludere, che dagli sviluppi della tecnica ci venga una spinta ad
elaborare una idea normativa di uomo che per l’ampiezza e la profondità del potere
della tecnica sulla natura dell’uomo non possa che essere un’idea normativa di natura
umana.
© Dimitri D’Andrea 2001
8
9