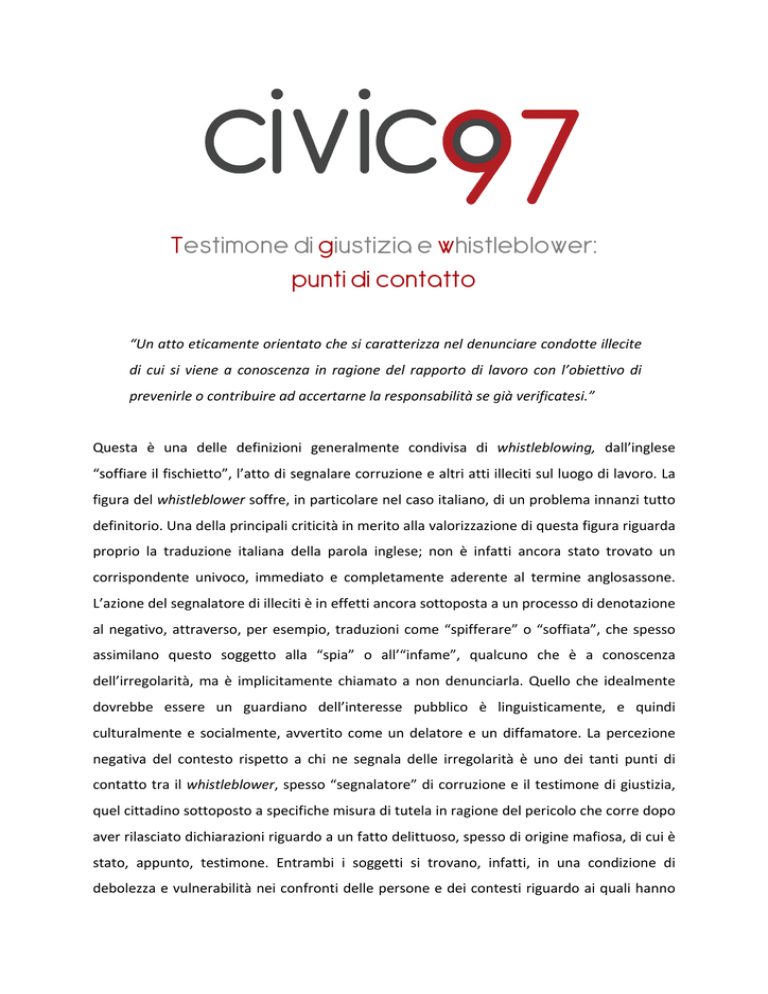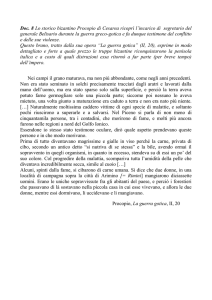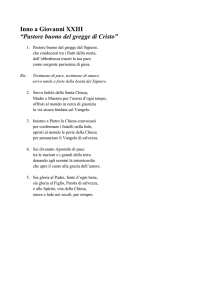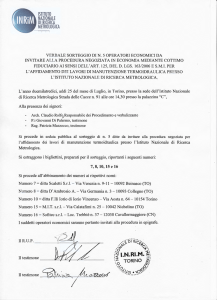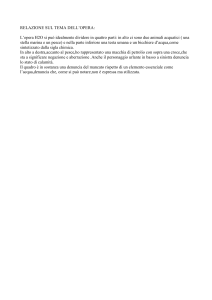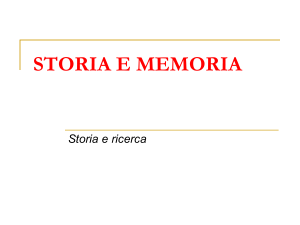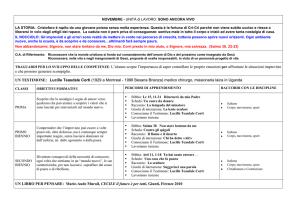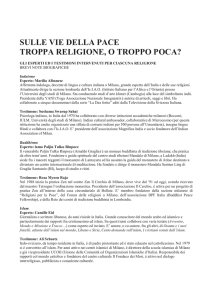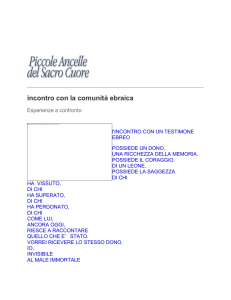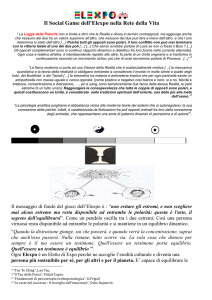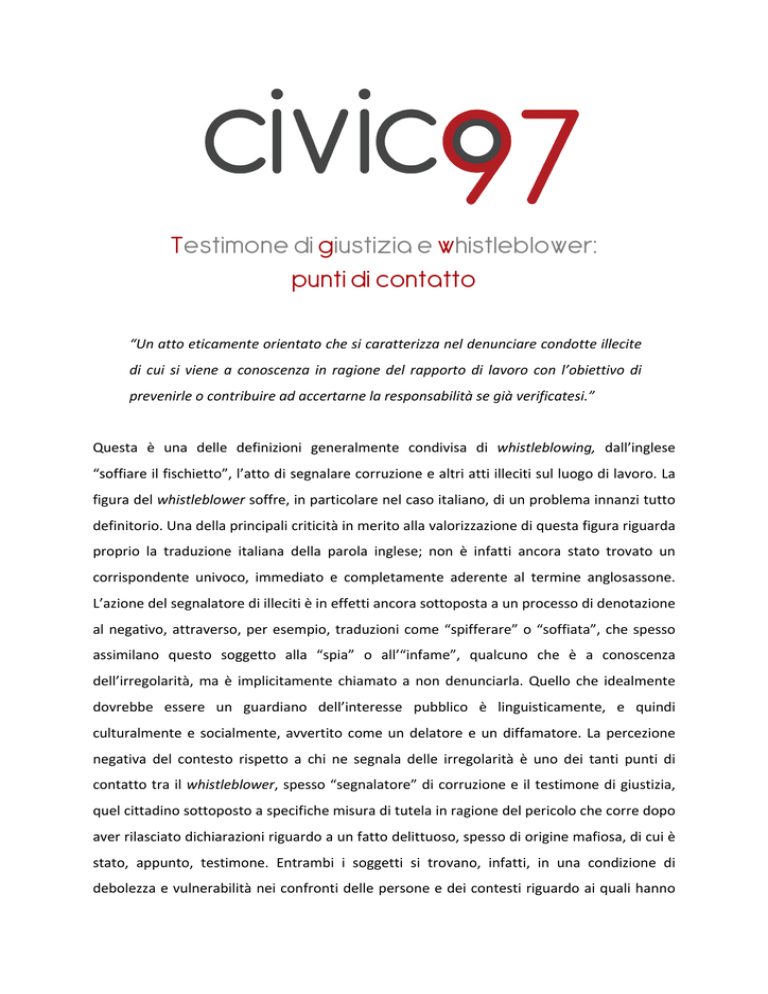
Testimone di giustizia e whistleblower:
punti di contatto
“Un atto eticamente orientato che si caratterizza nel denunciare condotte illecite di cui si viene a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con l’obiettivo di prevenirle o contribuire ad accertarne la responsabilità se già verificatesi.” Questa è una delle definizioni generalmente condivisa di whistleblowing, dall’inglese “soffiare il fischietto”, l’atto di segnalare corruzione e altri atti illeciti sul luogo di lavoro. La figura del whistleblower soffre, in particolare nel caso italiano, di un problema innanzi tutto definitorio. Una della principali criticità in merito alla valorizzazione di questa figura riguarda proprio la traduzione italiana della parola inglese; non è infatti ancora stato trovato un corrispondente univoco, immediato e completamente aderente al termine anglosassone. L’azione del segnalatore di illeciti è in effetti ancora sottoposta a un processo di denotazione al negativo, attraverso, per esempio, traduzioni come “spifferare” o “soffiata”, che spesso assimilano questo soggetto alla “spia” o all’“infame”, qualcuno che è a conoscenza dell’irregolarità, ma è implicitamente chiamato a non denunciarla. Quello che idealmente dovrebbe essere un guardiano dell’interesse pubblico è linguisticamente, e quindi culturalmente e socialmente, avvertito come un delatore e un diffamatore. La percezione negativa del contesto rispetto a chi ne segnala delle irregolarità è uno dei tanti punti di contatto tra il whistleblower, spesso “segnalatore” di corruzione e il testimone di giustizia, quel cittadino sottoposto a specifiche misura di tutela in ragione del pericolo che corre dopo aver rilasciato dichiarazioni riguardo a un fatto delittuoso, spesso di origine mafiosa, di cui è stato, appunto, testimone. Entrambi i soggetti si trovano, infatti, in una condizione di debolezza e vulnerabilità nei confronti delle persone e dei contesti riguardo ai quali hanno reso le loro dichiarazioni. I “soffiatori di fischietto” rischiano ripercussioni a livello innanzi tutto professionale, come, per esempio, essere trasferiti in posizioni prive di prospettive, essere demansionati, subire discriminazioni o trattamenti ingiusti, vedersi negate delle promozioni o essere addirittura licenziati. Proprio in virtù di questi rischi si ritrovano, nel momento in cui vengono a conoscenza dell’illecito, di fronte a un vero e proprio dilemma etico: segnalare, permettendo all’organizzazione di isolare ed eliminare i comportamenti illeciti ma rischiando le eventuali ripercussioni personali e professionali, o non segnalare, tutelandosi ma dando la possibilità a tali comportamenti di perpetrarsi. I potenziali testimoni di giustizia, d’altra parte, si trovano in una simile situazione di conflitto. La decisione della denuncia porta infatti con sé il rischio di serie ritorsioni da parte dei soggetti criminali e il conseguente stravolgimento della propria routine di vita; mentre la decisione di non denunciare equivale, invece, al possibile proseguimento e proliferare delle logiche e delle attività criminali e dell’impunità. Una delle riflessioni più interessanti sulla questione della definizione del whistleblower è stata portata avanti dallo studioso Abraham Mansbach, che chiama in causa il concetto di pharresia, vocabolo di origine greca che si riferisce all’atto pratico di “dire il vero” senza temerne le potenziali ripercussioni e conseguenze negative. Il parresiasta dell’antica Grecia era colui che con coraggio e senza paura affrontava il potere attraverso un discorso di verità, il messaggero che a rischio della propria vita portava la notizia di una battaglia persa, il politico che evidenziava una verità scomoda a rischio di perdere il proprio consenso, i consiglieri dei re ellenici che erano chiamati a ispirarsi a questo principio per moderarne il potere e guidarli nelle decisioni. L’odierno “soffiatore di fischietto” ricoprirebbe quindi il ruolo di parresiasta contemporaneo, riuscendo a mettere in discussione il sistema di potere verso cui quell’atto di verità è rivolto, con l’obiettivo di svelarne le contraddizioni, le falsità, le irregolarità. La pratica del whistleblowing, definita da Mansbach anche come “discorso senza paura”, è così in grado di rafforzare e contemporaneamente mettere in discussione i princìpi fondanti della democrazia quali la libertà e l’uguaglianza tra gli individui. L’atto di verità della segnalazione rappresenta infatti un’azione di estrema libertà e affermazione della propria individualità, ma al contempo un comportamento che mira a mantenere in buono stato la cosa pubblica, garantendo l’interesse dell’intera collettività. Questa riflessione potrebbe facilmente essere applicata anche al ruolo del testimone di giustizia che allo stesso modo propone un atto estremo di verità a rischio della propria vita. Prendendo la parola e denunciando, il testimone riafferma se stesso, i suoi diritti e doveri di cittadino onesto. Allo stesso tempo, però, mettendo in luce l’illegalità ed esponendosi al rischio, rende un servizio alla collettività permettendo che un determinato reato venga perseguito e che il principio di legalità venga riaffermato. Il testimone, quindi, una sorta di whistleblower del proprio contesto sociale, “libera” potenzialmente l’intera società dalla pratica criminale. L’atto di parola del testimone di mafia, in particolare, assume anche un’ulteriore valenza di tipo culturale rompendo i presupposti di omertà, silenzio e “non detto” su cui le organizzazioni criminali di questo tipo fondano la loro sopravvivenza. Le riflessioni di Mansbach presentano anche uno specifico focus sul tema dell’identità e sul suo rapporto con la scelta di segnalazione del whistleblower. Secondo lo studioso, infatti, ci sarebbe proprio il discorso sull’identità alla base della pratica della segnalazione. Decidere di denunciare le pratiche irregolari della propria organizzazione rappresenta un’azione di dissenso e “disidentificazione” rispetto ad essa. D’altra parte, però, proprio da fonti esterne di identità il whistleblower può trarre il coraggio per la decisione della denuncia. La possibilità di riconoscersi in altri gruppi o contesti rispetto a quelli legati alla dimensione lavorativa (che possono riferirsi a varie sfere, quali sport, politica, religione, attività sociali di altro genere, etc.) costituisce per il segnalante una sorta di “serbatoio” di identità dove trovare il coraggio di rischiare mettendo in discussione quella lavorativa. Questo approccio è particolarmente interessante se si prendono in esame i testimoni di giustizia, che sono spesso chiamati a mettere in discussione tutte le loro “fonti” di identità: il lavoro è spesso abbandonato, le imprese che hanno fondato e costruito falliscono, la famiglia è divisa e i parenti abbandonati (oltre al fatto che spesso gli stessi parenti non riconoscono né accettano la scelta di denuncia), le relazioni sociali sono interrotte. Inoltre, proprio come accade ai whistleblower, la loro identità diventa il primo obiettivo di chi intende vendicarsi. Anche il testimone, infatti, è spesso oggetto di discredito e di tentativi di danneggiamento della reputazione da parte di chi è stato oggetto di denuncia, ma ancora più significativamente da parte del contesto o sistema in cui essa è avvenuta e che si è verosimilmente sentito messo in discussione. Per questi motivi l’azione portata avanti dalle due figure oggetto di analisi può essere ridefinita anche in un’ottica di “resistenza”. In entrambe le situazioni, infatti, chi fa dichiarazioni riguardo illegalità o atti irregolari deve sostenerne le conseguenze nel tempo e resistere al contesto che li ha prodotti. Questo discorso è particolarmente calzante se vengono presi in considerazione i contesti mafiosi, dove il gruppo di potenziali testimoni dell’illecito è spesso rappresentato da una collettività silenziosa e spaventata, sorretta nella sua scelta di tacere da una sorta di “tradizione” di omertà che ha origini più o meno lontane nel tempo. Proprio per questo, la scelta del testimone di giustizia di denunciare l’illegalità, di cui spesso è prima vittima, è talvolta anche un atto di estrema resistenza, se non di portata rivoluzionaria, in un contesto di “testimoni inerti”. Paradossalmente una parte del senso delle azioni di testimonianza e della segnalazione viene così a risiedere proprio nella loro singolarità rispetto alle scelte comuni degli altri individui. Per questo approfondirne le sfumature potrebbe contribuire a tracciare un profilo di ciò che sono e dovrebbero essere il testimone e il segnalatore, in una “normalizzazione” e in un riconoscimento completo dell’atto di denuncia, in modo che essa possa esprimere a pieno quel valore, anche sociale, che il gesto porta con sé. In questo modo si renderebbe più semplice creare un sistema di “accompagnamento” e di costruzione collettiva della testimonianza nelle sue varie fasi, in modo che non diventi più un atto di coraggio e di sfida a un sistema, ma l’azione normale di ogni cittadino responsabile. Inoltre, un contesto culturale e sociale dove l’atto di “non farsi i fatti propri” fosse visto come contributo essenziale alla crescita e al buon andamento della comunità renderebbe più facile riconsegnare i denuncianti alla propria normalità di cittadini e di persone.