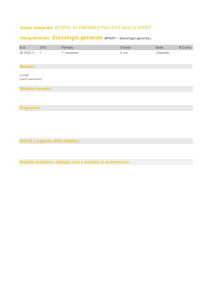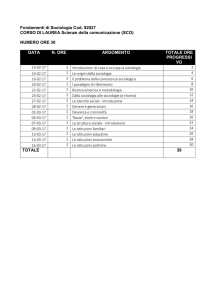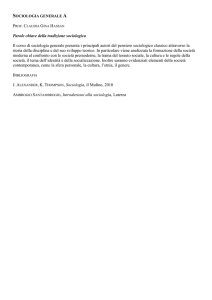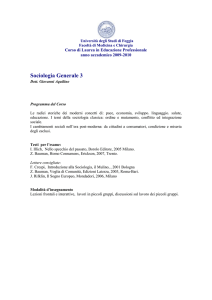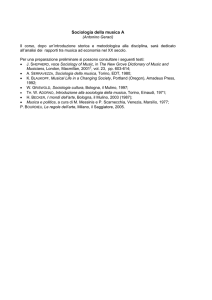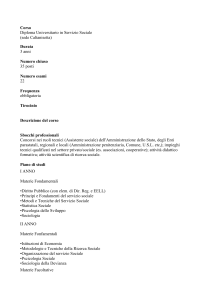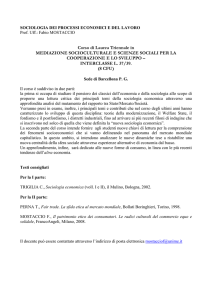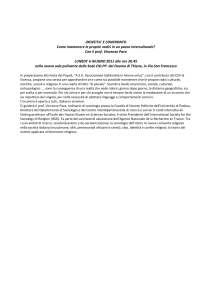N e w s l e t t e r
Gennaio 2006, Anno 3, Numero 1
Sociologia e Ricerca Sociale
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
Ricerca Sociale
R i c e r c a
4
S o c i a l e
In questo numero, lo spazio ormai consueto dedicato alle storie intellettuali dei e delle
docenti della nostra Facoltà è occupato dal professor Giuseppe Bonazzi, docente di Sociologia
delle Organizzazioni e Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali.
Intervista a Giuseppe Bonazzi
di Giulia Cavaletto
D: Professor Bonazzi, potrebbe illustrarmi la sua storia
“intellettuale”? Com’è nato il suo interesse per la sociologia, e come è arrivato a essere docente di sociologia
delle organizzazioni?
R: Premesso che proprio su come diventai sociologo, e in
particolare sociologo dell’organizzazione ho scritto una mia
autobiografia che uscirà tra pochi mesi dal Mulino, posso dire
che il modo in cui lo sono diventato è stato abbastanza
fortuito. Io sono arrivato alla carriera accademica dopo diversi
anni passati lontano dall’Università. Dopo la mia laurea (in
Filosofia con Abbagnano) per molti anni non ho più frequentato l’Università, lavoravo all’IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali), dove facevo ricerche di natura velatamente
sociologica, ho anche passato un anno negli Stati Uniti ad
approfondire le mie conoscenze soprattutto in metodologia
della ricerca, ma non avevo intenzioni universitarie. Fu solo di
fronte alla povertà, ai limiti intellettuali che vedevo all’IRES,
che negli anni sessanta mi sono detto «devo assolutamente
uscire di qua». Avevo già pubblicato il mio libro Alienazione e
anomia nella grande industria, dove riportavo i risultati delle
mie interviste a operai Fiat e di altre quattro fabbriche torinesi
sulla loro coscienza di classe. Questo libro uscì nel 1964 e poi
scrissi altre cose, così che nel 1968 potei prendere la libera
docenza. Nel 1969 si aperse la Facoltà di Scienze Politiche,
staccatasi da Legge, e Barbano mi offerse la scelta: «puoi
insegnare sociologia del lavoro, dell’industria, oppure
dell’organizzazione. Scegli tu». Io scelsi sociologia dell’organizzazione perché già allora intuivo che era la materia con
maggiori potenzialità scientifiche, dato che l’organizzazione
poteva essere del lavoro, della fabbrica, come delle Forze
Armate, della Chiesa e così via. Il concetto di organizzazione
mi consentiva uno spettro di significati, di potenzialità
euristiche molto più ampio che non “sociologia del lavoro” o
“sociologia industriale”. Evidentemente avevo già allora un
interesse lavoristico, diciamo, che però ho sviluppato in senso
organizzativo.
repubblicano storico alla La Malfa. Poi sono divenuto
progressivamente di sinistra e mi iscrissi al partito socialista.
La mia iscrizione al partito socialista però non ha avuto alcuna
influenza diretta sulla mia carriera. Io rimasi iscritto solo alcuni
anni, poi quando arrivai all’Università già non ero più iscritto,
anche perché il PSI aveva già avuto una scissione e io non mi
ero più riconosciuto né da una parte né dall’altra. Diciamo che
sono sempre stato di sinistra ma indipendente, mai più iscritto
a nessun partito. È evidente però che avevo una posizione di
parte, filo-operaia, per un certo periodo mi sono dichiarato
marxista, sebbene molto sui generis, poi il marxismo l’ho
abbandonato come dottrina conclusa in sé stessa e semmai
oggi, se dovessi definirmi, mi definirei weberiano.
D: Oltre all’esigenza di cambiare luogo di lavoro,
uscendo dall’IRES, c’è stato qualche evento particolare
che l’ha portata ad accostarsi alla sociologia nella
forma che pratica oggi? Penso per esempio alle vicende
delle lotte operaie…
R: Io ero di sinistra, mi sono accostato al mondo della sinistra
nell’ultimo anno dell’università, prima ero su posizioni sempre
rigorosamente laiche ma centriste, diciamo di stampo
D: Ecco, lei in quanto esperto di organizzazioni e
studioso della vita di fabbrica, come ha visto e quale
interpretazione ha dato, soprattutto nella realtà di
Torino, del passaggio da un sistema fordista a post
fordista soprattutto per come si è andato configurando
negli anni più recenti nella nostra città?
R: Torino è una città emblematica sotto questo aspetto,
perché ha portato alle estreme conseguenze l’esperienza
D: Nel suo percorso all’interno della sociologia
dell’organizzazione, la sua attenzione è stata catturata
prevalentemente dalle dinamiche di organizzazione del
lavoro, la vita di fabbrica, oppure ha avuto innamoramenti intellettuali anche per altre branche della
sociologia?
R: Prevalentemente per il mondo della fabbrica, su cui sono
tornato più volte. Poi negli anni settanta, nell’epoca di
maggiore sbandamento sociale, di maggiore marasma
soprattutto qui a Torino, di terrorismo, degli attacchi delle
Brigate Rosse, mi allontanai. Non mi interessava più il mondo
della fabbrica, perché si degradava, degenerava rispetto a
quello che io ritenevo dovesse essere. Per un certo periodo
sono stato in Francia, dove mi sono occupato della creazione
politica di capri espiatori, ossia dei processi di colpevolizzazione simbolica. Condussi una ricerca comparata tra Italia e
Francia, da cui poi è uscito preso il Mulino il mio libro Colpa e
potere dove svolgo un’analisi di come soprattutto a livello della
Pubblica Amministrazione erano stati creati dei “capri
espiatori” sia in Italia sia in Francia. Ma quello è stato un
periodo relativamente breve, tra il ’77 e 1980. Poi con l’81-’82
sono tornato ad occuparmi di fabbrica.
Gennaio 2006, Anno 3, Numero 1
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
taylor-fordista. In nessuna altra parte d’Europa si è avuta una
concentrazione così ampia e così monocorde di operai, come è
stata Mirafiori, vi era una concentrazione in termini assoluti
paragonabile soltanto alle fabbriche di Detroit. Quando si
voleva espandere, Fiat andò a scegliersi Rivalta, l’idea che
potesse andare a produrre altrove, come poi è stato per Melfi
o Termini Imerese, è venuta molto ma molto dopo. La visione
fordista coincideva con una visione torinocentrica, con tutti i
vantaggi ma soprattutto con tutti gli svantaggi di una
concentrazione parossistica di operai in questa città. Poi ci fu il
trapasso in un’epoca post-fordista, anche allora si può indicare
un anno simbolico, il 1980, con la lotta dei trentacinque giorni,
con il blocco ai cancelli e la marcia dei Quarantamila. Fu un
trapasso brusco e traumatico in un’epoca che convenzionalmente possiamo definire post-fordista. Quel passaggio non
poteva non esserci, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che
comporta, ci fu una ridefinizione completa non solo del modo
di lavorare, ma anche di organizzare la vita. Post-fordista può
essere considerato non soltanto un modello produttivo, ma
un’intera società…
D: Post-fordista può essere in questo senso parzialmente sovrapponibile, o si interseca, con “globalizzato”?
R: La globalizzazione si interseca con il post-fordismo ma non
è identica. Sono due processi distinti anche se si intrecciano.
Avrebbe potuto esserci anche una globalizzazione fordista.
D: I suoi più recenti interessi di ricerca la vedono
ancora sempre impegnato sul fronte della sociologia
delle organizzazioni applicata al mondo del lavoro,
oppure si sta spostando verso altri ambiti?
R: Mi sto spostando… Io sono spiritualmente “andato in
pensione con la Fiat”, non ho più voglia di occuparmi di
fabbrica, di lavoro. Ma sempre sociologo sono e mi sto
spostando verso tematiche di credenze religiose, cioè, non ha
nulla a che fare con il lavoro precedente se non la continuità
come sociologo.
D: La scelta di questo tema, così diverso dal
precedente, deriva dal fatto che si è trattato di un
interesse che lei già in qualche modo coltivava, ma non
aveva modo di esplicitare nel suo percorso accademico,
oppure è stato un incontro fortuito, oppure ancora è
stato coinvolto in qualche progetto?
R: Non è un incontro fortuito, ho scelto di mia iniziativa e non
sono coinvolto in nessun progetto di gruppo. Posso dire che se
io non avessi fatto il sociologo, tornando indietro mi sarebbe
piaciuto fare (stando dentro l’università e dovendo scegliere
un’altra branca di sapere) lo storico del primo Cristianesimo, il
Cristianesimo primitivo. In particolare mi sarebbe piaciuto
studiare e approfondire tutta la costruzione dogmatica
cristiana e cattolica in particolare. Dato che io non sono un
credente, in una chiave di totale demistificazione, avrei voluto
vedere attraverso quali negoziati, compromessi e strane
avventure del pensiero e della politica si sono definiti e
cristallizzati dei dogmi, in maniera del tutto casuale o magari
N e w s l e t t e r
Sociologia e Ricerca Sociale
5
secondo una logica di potere. La mia è comunque una
posizione fortemente demistificatoria, mi riferisco all’opera
della scuola razionalista tedesca dell’ottocento che ha
demistificato tutto il costrutto del primo cristianesimo. Non
potendo alla mia età diventare uno storico delle religioni, mi
sto occupando dei costrutti mentali, dell’immaginario delle
persone, di nuovo in una chiave che è totalmente differente
dai sociologi della religione più noti, nel senso che non faccio
ricerche quantitative. Io attraverso un’indagine qualitativa di
analisi del discorso voglio vedere le incongruenze, le
approssimazioni, le aporie che le persone hanno nel loro
immaginario religioso.
D: L’approccio qualitativo, che ha adottato in
quest’ultima fase del suo cammino di ricerca, ha anche
contraddistinto l’epoca del lavoro sulla fabbrica o allora
prediligeva tecniche quantitative?
R: Io ho usato tecniche di indagine quantitativa soltanto nella
mia prima ricerca su alienazione e anomia, dove intervistai
quasi soltanto da solo, 230 dipendenti della Fiat e un’ottantina
di altre imprese. Quella è stata l’unica ricerca quantitativa che
ho fatto. Poi ho sempre fatto ricerche qualitative…. no c’è stata
anche Una fabbrica di motori dove io svolsi una ricerca con
questionari, ma anche lì le interviste non le ho fatte io, le ho
fatte fare, mi sembra 200-300 interviste… altrimenti ho
sempre fatto ricerche qualitative, di osservazione, ricerca
etnografica e osservazione di piccoli gruppi.
D: Un’ultima cosa: da una serie di affermazione che lei
ha fatto mi è sembrato di capire che c’è un filo
conduttore
filosofico
che
l’ha
guidata
pur
nell’evoluzione dei suoi interessi. Ritiene che sia stata
effettivamente la sua originaria formazione filosofica a
guidarla, instradarla e mantenere vivo l’interesse per
gli argomenti più recenti? In altre parole, è lì, a suo
avviso, il seme della sua curiosità sociologica?
R: La filosofia ha avuto certamente per me grande importanza,
mi ha aiutato a darmi un’impostazione di fondo. La filosofia e
in particolare il pragmatismo americano in cui mi sono trovato
subito a mio agio, passando dalla filosofia alla sociologia.
Quindi, perché mi sono spostato dalla filosofia alla sociologia?
Perché ad un certo punto avevo l’esigenza di lasciare un
mondo che percepivo come troppo astratto, volevo trovare e
conoscere un mondo sociale più concreto. E infatti dall’Università io sono immediatamente passato al mondo del lavoro.
Appena laureato passai un anno preso l’Ufficio studi del
sindacato - erano gli anni cinquanta - per conoscere proprio il
mondo della fabbrica, gli operai. La filosofia era l’ancoraggio a
un mondo teorico. La sociologia è stato un po’ il punto di
incontro, la congiunzione tra un’esigenza teorica e un’esigenza
empirica, quindi riuscire a elaborare degli schemi di medio
raggio e rendere conto di fenomeni e realtà specifiche.