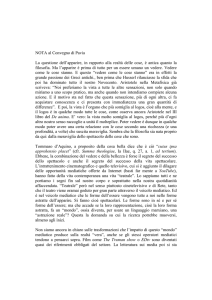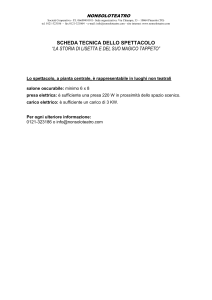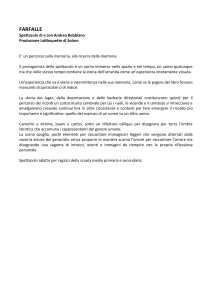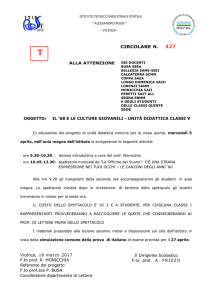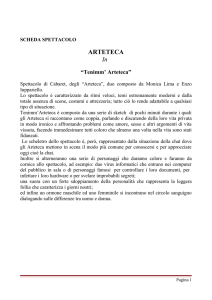LADOMENICA
DOMENICA 24 MARZO 2013
NUMERO 420
DIREPUBBLICA
CULT
All’interno
La copertina
Parlare da soli
perché questo
è diventato il Paese
dei monologhi
STEFANO BARTEZZAGHI
e GIANCARLO BOSETTI
Il libro
Scelte diverse
stesso destino
sbirri e ultrà
uniti dalla rabbia
CARLO BONINI
Straparlando
Luca Ronconi
“Mi piacerebbe
trovare un senso
alla tristezza”
C’era una volta
laVia
ANTONIO GNOLI
Emilia
DISEGNO DI MASSIMO JATOSTI
È talmente dritta che si vede dal satellite
ma percorrerla è impresa quasi impossibile
A 2200 anni dalla sua fondazione
viaggio alla ricerca della strada
FOTO CORBIS
che dà il nome alla regione-guida d’Italia
L’archivio
Guy Debord
e il crollo
del consumismo
CARLO FRECCERO,
FABIO GAMBARO
e DANIELA STRUMIA
L’incontro
Keira Knightley
“Siamo tutti finti
guardate me...”
MARIO SERENELLINI
PAOLO RUMIZ
«S
FRANCESCO GUCCINI
RIMINI - PIACENZA
cusi dov’è l’antica via Emilia?». Rimini. All’ufficio informazioni davanti alla stazione mi
mostrano senza esitare il periplo delle mura.
La strada millenaria che spacca la città come
una mela e taglia dritta dall’arco di Augusto fino a Piacenza, è ignorata. Diavolo, non c’è niente di così rettilineo in tutto il Nord, la vedi
persino dal satellite, ma è come se fosse sparita. Piove, il mare è immobile, il divertimentificio in letargo; in un chilometro conto 17 banche, nove negozi chiusi, centinaia di immigrati e infinite badanti.
Sono i 2200 anni della grande via romana — nel 187 a. C. il console Emilio Lepido la completava per tenere a bada i Galli della pianura — ma la regione ignora il mito fondativo della sua strada maggiore. Salvo un incontro voluto a giugno dalla soprintendenza e dall’editore Mulino in quel di Rimini, in vista c’è poco o nulla. Così vengo
a dare un’occhiata, per dire cosa è diventata la più nobile delle antiche vie d’Italia. E capire perché gli emiliani la dimenticano.
(segue nelle pagine successive)
L
a viaEmilia è un paradosso. È strada e frontiera. Unisce
e separa. Collega Rimini a Piacenza, e divide i paesi che
attraversa, li taglia in due. Per dare un’idea, quando nel
’52 ho cambiato casa a Modena e ho attraversato lo stradone per passare dal lato appenninico a quello Nord sulla pianura,
da quel momento — c’è da non credere — tutte le mie amicizie sono cambiate. Le persone che hanno segnato la mia storia musicale
le ho incontrate sistematicamente oltre la via: Bonvi, quelli dell’Equipe 84, Dodo l’arrangiatore dei Nomadi, eccetera. Gli altri sono
scomparsi. Giuro: mai più visti. Rimasti dall’altra parte.
Forse il lato musicale della via Emilia è quello di pianura. Ancora
oggi. Tra Parma e Modena c’è tutta la fascia del blues. E poi c’è una
quantità di gruppi rock. Una volta ho fatto un giro con Ligabue, che
stava facendo un film, e li ho visti, questi “americani”. È un marchio
rimasto dal Dopoguerra, dalla presenza degli Alleati. In quegli anni
tutto quello che era americano era bello.
(segue nelle pagine successive)
L’opera
Il cane di Bulgakov
diventa musica
più bella da vedere
che da ascoltare
ANGELO FOLETTO
L’arte
Il Museo
del mondo
Lazzaro
secondo Giotto
MELANIA MAZZUCCO
Repubblica Nazionale
LA DOMENICA
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 28
La copertina
C’era una volta
La SS9 non ha conservato nulla
dell’antica strada romana
Da Rimini a Piacenza
tra Tir e centri commerciali
VERSO NORD
“Ferrovia a destra, Appennino a sinistra: almeno
su questo non ti puoi sbagliare”. A destra: l’arco
di Augusto a Rimini, chilometro zero della via Emilia
FOTO DI ALEX
SCILLITANI
diario di viaggio
alla ricerca
della storia perduta
Scusi, dov’è la Via Emilia?
L
PAOLO RUMIZ
(segue dalla copertina)
e sorprese cominciano subito. Chiedo un
bus per Cesena, ma
non si può, si arriva
solo a Savignano, a
trenta chilometri.
Non c’è un Greyhound come sulla
Route 66 transamericana. Per fare
la strada più dritta d’Italia devo cucire coincidenze impossibili. Ho
rimediato una strisciata di orari da
mal di testa; me l’ha data un mago
delle vie traverse di nome Paolo
Merlini. Fino a Piacenza fanno
quindici cambi, fra treno e bus. Dovrò armarmi di pazienza.
Linea 90, autoradio con spot
martellanti, tre badanti rumene,
due senegalesi che gridano al cellulare. Infiniti svincoli, rotonde
fatte apposta per perdersi. Poi confluisco sulla via, e subito qualcosa
si rimette a posto in me, come in un
arabo che trova la Mecca. Rotta a
Nordovest, ferrovia a destra, Appennino a sinistra. C’è anche una
casa cantoniera, rosso pompeiano
d’ordinanza. Spiragli di bella Italia.
A Santa Giustina con la via Emi-
lia ce l’hanno a morte. È pavesata di
lenzuolate ai balconi con scritto
“Basta chiacchiere, circonvallazione subito”, “Traffico+smog,
grazie sindaco”. La via è diventata
Statale 9 fino a Milano, ma non taglia più i paesi: ci gira attorno. E laddove li taglia, diventa un inferno di
Tir. Fabbriche, centri commerciali, wellness, un manifesto che invita a una cena con strip maschile.
Nessuna strada antica d’Europa
somiglia meno di questa a ciò che è
stata.
A Savignano merenda alla piadineria del ponte, con vista sulle
campate romane e il Rubicone. Mi
dicono che il paese pullula di cinesi negli scantinati. Il resto è anziani, e il solito gineceo romagnolo: impiegate, postine in bici, vigilesse a caccia di divieti. «Scusate,
dov’è l’antica via Emilia?» chiedo
alle ultime, e loro indicano perentorie la circonvallazione. Come a
Rimini.
Linea 95 per Cesena, vetri sporchi da non veder fuori. Ipermercati, rotonda dedicata all’imperatore
del liscio Secondo Casadei. Nella
turrita Cesena patria di due papi mi
raccatta Angela Arcozzi, una mora
che odia le autostrade e mi porta in
auto a Forlì. Piove forte, immense
rotonde attorno a Forum Popili,
l’attuale Forlimpopoli, patria di
cuochi e briganti, Pellegrino Artusi
e il Passator Cortese svaligiatore di
teatri.
Forlì,fascistissimo vialone d’accesso con mega-statua della vittoria. Ora la tabella oraria mi consiglia un pezzo in treno, in fondo anche la ferrovia segue la via come
un’ombra, mai più distante di duecento metri. Arriva un regionale
per Imola, surriscaldato e chiacchierone, in ritardo di quaranta
minuti. Edgardo, pensionato stazza Obelix, brontola che la
CASA GUCCINI
Paolo Rumiz e Francesco Guccini
a Pavana, in casa dell’artista
Romagna ti infligge un rompiballe
al secolo. Ieri Mussolini, oggi il riminese Moretti, rottamatore di Fs.
«Scusi dov’è l’antica via Emilia?», richiedo nella pulitissima
Imola. Un tipo con valigia ventiquattr’ore mi indica la parallela. A
confonderlo forse c’è il viale della
stazione, che si chiama via Appia.
L’incrocio col vero Decumano è
una meraviglia in pietra e mattoni,
ma tutto è sigillato in una teca pedonale con negozi alla moda.
Il bus Tpr 101 per Bolognafa cinquanta fermate in 33 chilometri,
roba da crisi di nervi. Al capolinea
un bambino grasso, una donna
con un sacchetto di pesci rossi, la
solita badante e un africano ben
vestito; poi si parte verso la capitale dei Boi in un balletto di saliscendi alle portiere. Donne, di
tutte le età. La via è massacrata
dalla sua stessa geniale funzionalità trasportistica. Imola centro commerciale, Toscanella,
Dozza, Osteria Grande: nessuna
fermata che ricordi le legioni.
Mucchi di neve sporca, frutteti
spogli e l’eterna domanda: chissà dove finisce la Romagna e comincia l’Emilia? Mah.
Alle porte di Bologna già annot-
ta. Rotaie, negozi, argini, fabbriche, canali, fari nelle pozzanghere.
A bordo si discute di Grillo e del
Mago Gargamella (Bersani) mentre la radio gracchia di Balotelli se
gioca o non gioca e due ragazze in
hijab digitano freneticamente sul
telefonino. Nemmeno l’Emilia,
terra di vie dritte, sa più dove andare. Al capolinea, fuggi-fuggi nella
pioggia, poi camminata solitaria
lungo il cardo di via Galliera solo
per chiacchierare con la russa al
bancone di “Kalinka”, posto di
vodke e caviali.
Afferro brandelli di mito solo
con Gianni Brizzi, il prof di storia
romana più annibalico che ci sia.
Tra verdure padellate e un lambrusco, ecco venir fuori che fu il grande spavento punico a convincere
Roma ad attrezzare quella strada
per tenere buoni i Galli con una fascia-cuscinetto che non fosse solo
militare. Una via capace di essere
anche spazio di colonizzazione,
mercato, e al tempo stesso un confine, l’antenato di tutti i Limes. La
cena finisce con una panna cotta e
un anatema: «Questa è la prima
frontiera dell’Italia romana. E in
Emilia non lo capiscono».
Come è vuota Bologna la notte;
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 29
(segue dalla copertina)
I
n bicicletta da ragazzini noi si frenava all’americana. Funzionava così: balzavi agile dal
sellino e stringevi la ruota posteriore fra le cosce. Io me li ricordo gli Americani quando passarono la Linea Gotica. Ricordo il gusto della Coca Cola e la forma di quelle bottiglie verdine. Noi ragazzi si stava sempre con loro. E loro sparavano una cannonata
ogni tanto, tranquilli come se andassero in ufficio.
La mia via Emilia è stata dunque soprattutto frontiera. Non era
il Far West in sé, ma la linea oltre la
quale c’era il Far West, specialmente sul lato appenninico. Lì per
noi c’era la prateria. Si rubava l’uva, si giocava ai cowboy, si andava
a morosare di nascosto. C’era, mi
FRANCESCO GUCCINI
ricordo, il campo di un signor Magnavacca, il quale per tenerci lontani aveva messo un cartello con la scritta “terreno
avvelenato”. Sapevamo benissimo che non era vero, e la proibizione aumentava il godimento della scorribanda. Era in quei campi, a primavera, che si svegliava il profumo
dell’erba, e quel profumo mi accendeva la nostalgia del mulino del nonno, a Pavana
sul monte. Una volta, per dire “andiamo a Modena”, bastava abitare a un chilometro
dal centro. Io potevo dirlo, perché tra casa mia e il cuore della città c’erano pezzi di campagna. La Millemiglia tagliava un mondo ancora antico: verso Castelfranco c’era un
La nostra frontiera
prima del Far West
posto chiamato Cavazzona, e tutti andavano lì a vederli passare, i concorrenti, con la
Gazzetta dello Sport in mano. Il grido era: “È passato Nuvolari alla Cavazzona”. Oggi
per dire “vado a Modena” devi abitare per lo meno a Piacenza, perché tra le città e i paesi non c’è più campagna. Specialmente tra Bologna e Reggio non hai che case e capannoni, un’infinita metropoli lineare.
Ogni tanto mi piace immaginare com’erano le nostre città al tempo dei Romani. Le
vedo come dei Fort Apache, con intorno i Celti cattivi come puzzole. E credo che, per
collegare tra loro quelle città con la via Emilia, i legionari non abbiano inventato nulla
e si siano limitati a usare piste già battute dai nostri antenati. Ma hanno lasciato al mondo un grande nome: “strata”. Che è una delle pochissime parole latine passate alla lingua inglese. “Street”, stessa radice di “strada”. L’antico basolato romano l’ho visto, nella pancia di Bologna, anni fa. L’avevano trovato scavando un sottopassaggio all’altezza di via Ugo Bassi e via Rizzoli. Quando aprirono la galleria al pubblico, i resti della via
Emilia furono alla portata di tutti. Divenne un posto frequentatissimo: accanto alle
vecchie pietre c’era un negozio di dischi, si tenevano riunioni politiche. Poi divenne
pian piano un ricettacolo di perdigiorno, e il Comune ha finito per tombare il passaggio. I monumenti, le chiese, i ponti. Erano quelle le nostre pietre miliari. E quando scrivevo con Lucio Dalla la canzone Aemilia, era a quella misura dello spazio che mi riferivo. Lo stesso per Piccola città. Fino agli anni Sessanta, la domenica vedevo passare
sciami di ciclisti. Non andavano mica ad allenarsi, come oggi. Andavano a ballare, a
trovar la morosa, al cinema. E tornavano di notte perché non c’era pericolo. Io ci sono
andato in bici, una volta, da Modena a Bologna. Madonna, non si arrivava mai.
(Testo raccolto a Pavana da Paolo Rumiz)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GLI ULTIMI FRUTTETI
“Frutteti spogli e l’eterna domanda: dove
finisce la Romagna e comincia l’Emilia?”
LA BRUCIATA
“Una volta qui c’era il West, oggi signorine,
russe o africane, a prezzi popolari”
IL VIDEO
Su Repubblica.it
Rumiz e Guccini
raccontano
come è cambiata
la via Emilia
nel video
di Alex Scillitani
I NEGOZI CHIUSI
“Rimini è semideserta
In un chilometro conto
diciassette banche
e nove negozi chiusi”
LE PRATERIE
“Fari nella pioggia, luminarie
e qualche varco di prateria
Ma la regione Emilia esiste
davvero o è solo un’idea?”
sento l’eco dei miei passi tra le Torri e il Nettuno. Tutto, mi dicono, è
risucchiato dai centri commerciali. È incredibile: questa è l’unica regione al mondo che prende il nome
da una strada, ma a quella strada
non dedica una sola iscrizione turistica visibile. Nulla che proclami:
qui sono passate le legioni, qui abita la nostra identità. Ma come fai a
sapere dove vai, se non sai da dove
vieni?
In auto per Modena con l’amico
Alex Scillitani. Insegne trasparenti:
Gelateria Delirius, Più compri e più
risparmi, Affittasi capannoni,
Compro oro. Tra Borgo Panigale e
Casalecchio densità mai vista di
seminude con ombrello, tacchi alti e iPod. Il consumo di suolo è terrificante, non c’è più spazio per la
campagna. L’antico è disprezzato,
lasciato morire. Ogni tanto un segnale dal mondo di ieri: un grandioso rudere in mattoni, una late-
rale di nome “Via del cantastorie”.
Castelfranco è il primo paese
senza tangenziale, la SS9 lo attraversa tra i portici come ai tempi
della Millemiglia. Altrove ti deviano spietatamente, come a Modena, dove appena la strada si fa bella ti sparano sulla rotonda Maserati. L’unico modo di fare la via romana integrale sarebbe la bici, che
però negli anni del Sol dell’Avvenire è stata bollata come retaggio della miseria, col risultato che oggi
sull’Emilia ti arrotano se te la fai sul
sellino.
Alla “Bruciata”,oltre lo svincolo
di Modena Nord, una volta c’era il
West; oggi hai le signorine da marciapiede, russe o africane, a prezzi
popolari. Puoi fartene una dopo
una cena in pizzeria o un giro all’ipermercato. Poco prima, al ponte
sul Panaro, c’erano i ruderi della
discoteca Mac2, rugginosa base
spaziale dimenticata. Poi fari nella
pioggia, luminarie, e qualche varco di prateria. Ma la regione Emilia
esiste davvero o è solo un’idea?
A Reggio il sindaco, noto per le
“panchine parlanti” (fortunatamente guaste) e una mirabile rotonda attorno a una chiesa, ha pensato di ritombare un pezzo della via
I CUOCHI E I BRIGANTI
“Piove, immense rotonde
attorno a Forum Popili,
patria di cuochi e briganti”
romana originale, in nome della
modernità. In città la vivono come
striscio, non come asse di collegamento. E se ti ostini a usarla come
tale, ti dicono che la via è sbarrata.
I bus non entrano nel granducato
di Parma. Si va solo fino alla frontiera, come ai tempi delle dogane
pre-unitarie.
La linea 2 verso il granducato è
un bus urbano con posti in piedi.
Coerente, in una via che è solo città
lineare. E via, per rotonde megalitiche, in mezzo a cartelli di Vendesi e Affittasi. A Villa Cella c’è un venerabile cimelio, un cinema aperto, poi ti taglia la strada un funebre
sovrappasso pedonale inaugurato
con ascensore per disabili, e mai
entrato in esercizio. Sembra Sicilia, ma è Emilia. Poi di nuovo campagna, monti innevati in lontananza, pavoni, oche, anatre.
Arrivo a Sant’Ilario in
un bus vuoto, in un capolinea vuoto, in un quartiere vuoto. Piove anche
nel chiosco d’attesa e non c’è nessuna coincidenza. Dopo le otto del
mattino più niente collega il Reggiano al Parmense. Resta solo il
treno, ma per arrivare alla stazione
sono due chilometri a piedi. C’è solo l’autostop per passare l’Enza,
gonfio e marrone, e con il ponte
una nuova parata di adescatrici
automunite, e una rete di sterrati
per il mestiere.
Da un capo all’altro di Parma,la
via di Emilio Lepido svela la sua
storia ospedaliera. Lazzaretti, ricoveri per pellegrini, vecchi manicomi, la meraviglia di un ospedale rinascimentale. «Tutti segni — mi
dice al bar l’assessore grillino Laura Maria Ferraris — di una rilettura
non solo verdiana della città». Ma è
dura risalire la china dopo anni di
sfascio e ruberie. Col disastro Parmalat è scoppiata la crisi, il commercio va male anche in centro.
Chiara Cabassi, bibliotecaria, mi
porta sotto il ponte di mezzo, nell’antro che contiene le campate del
suo predecessore romano. Oggi il
sottopasso è terra di nessuno, ieri
era pieno di negozi. E via di nuovo
tra capannoni in disuso come balene spiaggiate.
Ponte sul Taro, grandioso, con
statue di donna; poi la bellissima
Fidenza disertata dai suoi stessi
abitanti. La gente va al “Fidenza
Village”, preferisce l’antico finto
all’antico vero. I Tir non danno requie. «Con la crisi, i camionisti risparmiano sulle autostrade. Rovoleto e Pontenure sono annichilite
dai passaggi», lamenta Mauro Nicoli, ufficio urbanistico di Fiorenzuola. «Ma la catastrofe vera è che
la via non è più sentita come tale.
Solo dall’aereo la percepisci come
segno del territorio».
Ultimo caffè al bar Mocambo,
ex balera sulla ferrovia, poi via in
treno fino al paracarro finale: Piacenza, 197° miglio romano, piantata sull’ultimo guado del Po. Per
fare tutta la strada dovrei continuare fino al dazio milanese di Porta Romana, ma sono sazio di badanti, Tir, belle-di-giorno, serrande abbassate e centri commerciali.
Non ho trovato il mito; non so dove vada la regione-guida d’Italia.
Piove troppo, Cristo santo, e ho pure le scarpe fradice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Repubblica Nazionale
LA DOMENICA
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 30
L’attualità
Legge e ordine
Cantati dalla grande letteratura russa
e ridotti da Stalin ad attrazione circense,
i guerrieri del Don sono stati
rimessi da Putin in prima linea
Contro chiunque minacci l’integrità
del suo Impero. Ma anche contro
gli ubriaconi moscoviti
Belli e spietati
i cosacchi
sono tornati
NICOLA LOMBARDOZZI
P
MOSCA
er la Fede, per la Patria e per lo Zar.
Tutto rigorosamente in quest’ordine. L’antico motto dei cosacchi dice
più di ogni altra cosa su queste figure leggendarie uscite improvvisamente dai libri
di storia e dal folklore delle guide turistiche per
attraversare con passo fiero e sguardo cattivo le
strade delle città russe. I colbacchi, le fruste, le
cartuccere dorate intarsiate sui lunghi cappotti
rossi, vengono dopo. Giusto per dare un tocco di
solennità e di mistero a un revival studiato a tavolino con l’ambizioso scopo di «riportare legge
e ordine nel Paese».
E fa uno strano effetto, a metà tra il minaccioso e il patetico, vederli aggirarsi nelle ore notturne, come ronde di quartiere in uniforme storica,
pronti a dare una lezione a qualche ubriaco un
po’ troppo sguaiato o a segnalare rabbiosamente alla polizia eventuali «comportamenti immorali» sui marciapiedi di periferia.
Ma sono solo distorsioni metropolitane. Come vedere un cowboy a Manhattan o un samurai tra i grattacieli di Tokyo. In altri scenari più
consoni al mito, lungo le valli meridionali del
Volga o sulle sponde del sempre placido Don, i
cosacchi sono invece tornati davvero. Marziali e
spavaldi nelle loro nuove accademie, centri di
addestramento, scuole religioso-militari pro-
tette, benedette, e gestite dal Patriarca ortodosso in persona. Qui le divise colorate, i pantaloni
blu dalle bande rosse che un tempo indicavano
l’esenzione dalle tasse, le cariche a cavallo lungo
le steppe sconfinate, evocano senza equivoci le
gesta di Taras Bulba e degli altri eroi cantati dal
fior fiore della grande letteratura russa. Una rivincita, dopo anni di depressione e oblio, per un
popolo guerriero e ribelle che ancora ripete di riconoscere solo due autorità: “Il cavallo sotto di
noi e il Signore sopra di noi”.
Non è proprio una garanzia di fedeltà assoluta allo Stato come constatarono nei secoli molti
zar, preoccupati dalla turbolenta e intermittente obbedienza dei loro migliori cavalieri. Ma per
Vladimir Putin, ansioso di “bonificare” le difficili aree del Caucaso islamico e separatista, va
benissimo così. Laggiù, dove la pressione dell’Islam e il boom demografico delle popolazioni
ostili al potere di Mosca minacciano l’integrità
dell’Impero, una difesa organizzata e anche un
po’ ottusa della Cristianità, come quella offerta
dai valorosi cosacchi, serve perfettamente allo
scopo.
Putin ci conta. Finora li aveva usati solo nella
guerra vera, durante l’invasione del territorio
georgiano nel 2009, inviando battaglioni cosacchi in Ossetia e Abkhazia del Sud. Adesso gli servono a incutere timore agli integralisti islamici di
Cecenia, Daghestan e Kabardino Balkaria e, magari, anche ai giovani piccolo borghesi delle
grandi città che da qualche tempo hanno preso
l’abitudine di inscenare grandi manifestazioni
di piazza contro il potere.
Loro lo fanno con lo stesso impegno con cui
gli antenati proteggevano i confini meridionali
del territorio degli zar dalle orde tartare. Con devozione totale alla Madonna del Don loro protettrice e con una lista di nemici che mette i brividi: musulmani, ebrei, atei e sobillatori dell’ordine costituito.
Ed è con questo spirito e con questi motti che
si formano i giovanissimi allievi delle nuove
scuole di cadetti, o delle palestre cristiane che
sorgono a ritmi impressionanti da Volgograd
(già Stalingrado) alle città sul fiume Terek. Dove,
come promette ai genitori uno slogan molto diffuso, “si forgiano i cosacchi del XXI secolo”. Che
cercheranno di somigliare il più possibile ai loro
progenitori comparsi intorno al Milleduecento,
bellicosi e invincibili, nella steppa dell’Europa
dell’Est tra Ucraina e Russia del Sud. E che i loro
nemici tartari definivano kazakche vuol dire “libero avventuriero”. Cavallerizzi di abilità tuttora ineguagliata, spirito libero e lunghe sciabole
usate su chiunque senza alcuna pietà. Prima alleati dei prìncipi locali, poi insubordinati servitori degli z ar, divennero celebri per il loro democratico sistema interno di potere e per le loro feroci rivolte contro ogni prevaricazione. Combattenti impulsivi e disordinati, durante la campagna napoleonica di Russia fecero impazzire
gli schemi di un teorico della guerra come il generale von Clausewitz che militava sotto le inse-
gne del Cremlino. Troppo prussiano per capire
il selvaggio spirito russo dei cosacchi, von Clausewitz li bollò come dilettanti anarchici pur dovendo ammettere che solo loro, con le loro incursioni temerarie al limite della follia, erano riusciti a fiaccare la potenza delle armate francesi.
Irascibili e imprevedibili. La leggenda vuole
che la presa del Palazzo d’Inverno, che nel 1917
segnò la conquista del potere dei bolscevichi, fu
facilitata da una loro impuntatura. Si rifiutarono sdegnati di cooperare con un corpo volontario femminile alla protezione della residenza
degli zar, lasciandola praticamente indifesa. In
ogni caso, poco dopo ritornarono dalla parte
dell’imperatore schierandosi con la Guardia
Bianca nella guerra civile che seguì all’avvento
del comunismo. A potere stabilizzato la reazione dei nuovi padroni del Cremlino fu spietata: i
cosacchi furono deportati, sterminati, e in gran
parte costretti a fuggire all’estero in quella che
Stalin battezzò come una “campagna di decosacchizzazionedel Paese”. E siccome la fede cristiana viene prima di ogni cosa, migliaia di
guerrieri cosacchi si arruolarono nelle fila naziste nel 1941 partecipando all’invasione dell’Urss con il proposito di “restituirla a Dio”. Cavalcarono in senso contrario le proprie steppe
ostentando, durante il giorno, una svastica sulla divisa e, al tramonto, le icone sacre nascoste
nei loro zaini da combattimento. Il disastro e
l’ulteriore massacro di uomini donne e bambini che ne seguì sembravano aver messo fine a
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 31
ACCADEMIA
Giovani reclute
dell’Accademia cosacca
di Novocherkassk
E su questa striscia fertile viveva da tempo immemorabile
una popolazione di sangue russo, bella ricca e pugnace, che professava
la fede dei vecchi credenti ed era conosciuta col nome di cosacchi
Lev Tolstoj “I cosacchi”
ARTI MARZIALI
Alcuni cadetti si addestrano sui monti del Caucaso. A destra, un prete ortodosso benedice un nuovo comandante regionale
Ma i cosacchi del Jaìk che dovevano salvaguardare
la tranquillità e la sicurezza di quel paese da qualche tempo
erano essi stessi per il governo sudditi irrequieti e pericolosi
Aleksandr Pushkin “La figlia del capitano”
BRINDISI
FOTO LUZ PHOTO AGENCY S.R.L.
Cosacchi pronti a brindare e (a destra) a ballare per festeggiare l’anniversario della fine della Seconda guerra mondiale
un mito durato più di nove secoli.
Costretti in vere e proprie riserve indiane nelle province più urbanizzate del Caucaso, i superstiti dei cosacchi sono stati per anni un richiamo per turisti cui mostravano la loro abilità,
nelle celebri danze o nell’ammaestramento dei
cavalli, in malinconici spettacoli organizzati
dalle agenzie di viaggio statali.
Non essendo una etnia vera e propria, ma solo la condivisione di un modo di essere, si sono
mimetizzati con il resto della popolazione cominciando lentamente a perdere abitudini e riti
di un tempo.
A rivitalizzarli ci ha pensato il primo presidente del periodo post sovietico Boris Eltsin con
un decreto che li riabilitava e li considerava “vittime della repressione sovietica”. Ma chi ha deciso di riportarli agli antichi fasti è stato Vladimir
Putin, vedendo in loro reincarnazione di antichi
valori che dovrebbero aiutarlo a difendersi da
separatismi e contestazioni. Un lavoro metodico, cominciato con il reintegro nell’esercito, il finanziamento di istituzioni locali, l’intervento
spirituale ed economico della Chiesa e l’autorizzazione all’esercizio delle ronde urbane. E i
cosacchi sono dunque tornati. Belli, scenografici e sicuri della loro forza. Inquietanti per molti. A seconda di come si vuole leggere l’ambigua
definizione del grande scrittore Isaak Babel, fucilato per ordine di Stalin: «Delle bestie con dei
princìpi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il cosacco di Baklanov getta indietro la testa, come un buon cavallo
che ode uno squillo di tromba, e battendo il pugno nodoso
sul tavolo, sussurra: “Fuori le baionette! Sguainate le sciabole!”
Mikhail Sholokhov “Il placido Don”
UNIFORMI
Un giovanissimo cadetto ritira l’uniforme invernale prima di iniziare il corso. Qui sopra, un “Terek” appena eletto dai suoi compagni d’armi
Nella steppa sconfinata / a 40 sotto zero / se ne infischiano del gelo /
i cosacchi dello Zar / Col colbacco e gli stivali / camminando tutti
in fila / con la neve a mezza gamba / vanno verso il fiume Don
“Popov” Zecchino d’oro 1967
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
LA DOMENICA
■ 32
L’archivio
Avanguardie
“Sono il più famoso degli uomini oscuri” diceva di sé
Ora un’affascinante mostra parigina ricca
di manifesti “situazionisti”, schede, video e appunti
inediti riaccende i riflettori sull’eclettico intellettuale francese
Che prima del ’68 aveva già capito quale fosse il nemico
da combattere. E intuito come sarebbe andata a finire dopo
Debord
contro
tutti
La spettacolare guerra
alla società dello spettacolo
FABIO GAMBARO
«T
PARIGI
utta la vita delle società in cui regnano le condizioni moderne
della produzione s’annuncia
come un’immensa accumulazione di spettacoli». Inizia così il più celebre dei libri di
Guy Debord, La società dello spettacolo, arrivato nelle librerie francesi nel novembre del 1967 e poi tradotto infinite volte in tutto il mondo. Discusso, chiosato, detestato o adulato è considerato ancora oggi uno dei testi
che meglio interpretano la condizione contemporanea. Duecentoventuno tesi che si presentano come una
teoria critica dell’alienazione dominante, denunciando senza mezzi termini lo spettacolo come condizione
onnipresente della società capitalistica. «Lo spettacolo
non è un insieme d’immagini, ma un rapporto sociale
tra le persone mediato dalle immagini», scrive colui che
all’epoca era l’instancabile artefice dell’Internazionale
Situazionista. Lo spettacolo governa le nostre esistenze, s’interpone tra noi e gli altri, recuperando oltretutto
ogni forma di contestazione che tenti di rimetterlo in discussione. Di conseguenza, la sua critica — che per Debord era la condizione necessaria per provare a immaginare una vita emancipata dall’ideologia del consumo
— non può che prendere le forme di una guerra fatta
d’intelligenza, movimento e strategia. Esattamente come quel Jeu de la Guerre che l’atipico intellettuale francese inventò nel 1956 e poi continuò a elaborare negli
anni successivi con la volontà di «riprodurre la dialettica di tutti i conflitti». Un gioco della guerra che è al contempo «sintesi strategica della sua opera e metafora della lotta contro lo spettacolo delle merci», spiega Laurence Le Bras che, insieme a Emmanuel Guy, ha curato
l’ampia e affascinante mostra intitolata “Guy Debord,
un art de la guerre” (alla Bibliothèque nationale de France dal 27 marzo al 13 luglio).
Proprio quel gioco — che «mira innanzitutto a rompere le linee di comunicazione del nemico» — è stato
scelto dai curatori come filo conduttore di un percorso
che, oltre a ribadire l’attualità di Debord in tempi in cui
lo spettacolo è più che mai un principio strutturante
della realtà, ricostruisce in dettaglio la poliedrica personalità di un autodidatta — nato il 28 dicembre 1931 e
morto suicida il 30 novembre 1994 — che fu al contempo poeta, saggista, cineasta, artista, filosofo, sociologo e
militante politico. Anche se — come ricorda Bruno Racine, il presidente della BnF che per Gallimard firma la
prefazione del bel catalogo della mostra — l’autore di
Critique de la séparation preferiva considerasi «uno
stratega, un arrabbiato e un teorico».
La quasi totalità dei documenti esposti provengono
dagli archivi privati di Debord, acquisiti dalla Biblioteca nazionale nel febbraio del 2011 per 2,7 milioni di euro, e impedendo così che finissero all’università di Yale.
Grazie al vastissimo materiale lasciato dal teorico del situazionismo (manoscritti, lettere, appunti, schede, fotografie, ritagli, volantini), i due curatori hanno costruito un ricco percorso che propone anche diversi quadri
e documenti audiovisivi, al cui centro figurano seicento delle oltre millequattrocento schede di lettura vergate dall’intellettuale francese. Per Laurence Le Bras
«questo è il vero e proprio cuore pulsante della riflessione di Debord», che per tutta la vita ha incessantemente
annotato pensieri e citazioni in una sorta di dialogo permanente con gli autori che prima di lui avevano cercato di comprendere il mondo. «Per saper scrivere occorre aver letto. E per saper leggere occorre saper vivere»,
scrive Debord, che in una delle schede annota una frase di Carl von Clausewitz che pare scritta per lui: «In qualunque modo io possa immaginare la relazione tra me
e resto del mondo, la mia strada passerà sempre attraverso un campo di battaglia».
Quando pubblicò il suo libro più famoso, l’autore della Società dello spettacolo aveva già una lunga carriera di
agitatore alle spalle, dentro e fuori i movimenti dell’avanguardia artistico-politica degli anni ’50 e ’60. Aveva
per esempio partecipato al movimento lettrista d’Isidore Isou e Gabriel Pomerand, realizzando nel 1952 un
film intitolato Hurlement en faveur de Sade. In seguito,
convinto che fosse necessario uscire dal semplice rituale dello scandalo artistico, crea Potlatch, un bollettino
politico-culturale che per molti versi anticipa le tematiche dell’Internazionale Situazionista. Questa nascerà
ufficialmente nel luglio del 1957 in un paesino dell’entroterra ligure, Cosio d’Arroscia (tra i fondatori c’erano
anche gli italiani Giuseppe Pinot-Gallizio, Piero Simondo, Walter Olmo ed Elena Verrone), sulla base di un testo intitolato Rapporto sulla costruzione delle situazioni. «Noi pensiamo innanzitutto che occorra cambiare il
mondo. Vogliamo il cambiamento per liberare la società e la vita in cui ci sentiamo imprigionati», si leggeva
nella prima pagina del documento, che poi precisava:
«La nostra idea centrale è la costruzione di situazioni,
vale a dire la costruzione concreta di atmosfere momentanee della vita, e la loro trasformazione in una qualità passionale superiore».
Negli anni successivi, il percorso di Debord, che tra i
suoi autori preferiti menziona Dante, Machiavelli e Petrarca, seguirà quello del movimento situazionista, la
cui avventura s’intreccia con le lotte politiche di quegli
anni, specie nel Maggio ’68 cui fornirà, oltre a spiazzanti modalità di comunicazione, alcuni delle parole d’ordine più efficaci e diffuse. Tra una battaglia e l’altra,
mentre nelle riunioni dell’Internazionale Situazionista
si succedono scomuniche ed espulsioni (fino alla dissoluzione ufficiale nel 1972), l’intellettuale militante
continua a fare film sperimentali come La société du
spectaclee In girum imus nocte et consumimur igni. E intanto pubblica alcuni testi più autobiografici, tra cui
Panégyrique e Cette mauvaise réputation. Proprio in
uno scritto inedito degli ultimi anni, si definisce «il più
famoso degli uomini oscuri». Una definizione perfettamente illustrata dalla mostra parigina, che restituisce
tutta la complessità di quel «teatro delle operazioni» immaginato da Debord. Per il quale «la miglior cosa che
possa capitare a un’avanguardia è di aver fatto il proprio
tempo, nel pieno senso del termine». E per l’autore della Società dello spettacolo è sicuramente vero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 33
Il consumismo è morto
benvenuti a Gomorra
CARLO FRECCERO e DANIELA STRUMIA
ella sua opera più famosa, La società dello spettacolo(di cui curammo la prefazione all’edizione italiana nel 1997), Debord descrive il consumismo che ci siamo appena lasciati alle
spalle. Per Debord lo spettacolo «è il cattivo sogno della società incatenata». Ne consegue
che «svegliarsi da quest’incubo è il primo compito che si assegnano i situazionisti».
Oggi che questo evento si è realizzato, che lo spettacolo è andato in frantumi e abbiamo bruscamente riacquistato il contatto con la realtà, l’impressione che ne traiamo non è di liberazione,
quanto piuttosto di disperazione e rimpianto. Cypher, il traditore di Matrix, non chiede in cambio
del suo tradimento dei benefici economici: vuole solamente regredire allo stato di incoscienza che
caratterizzava la sua vita prima di assumere la fatale pillola rossa, che l’ha liberato dalle accoglienti illusioni di Matrix per scagliarlo brutalmente nei sotterranei della vita vera, dove si combatte in trincea contro il male, ma a costo di
rinunciare a ogni piacere. Conoscere la verità non significa necessariamente schierarsi dalla parte giusta.
Marx come ispiratore di rivolta ha avuto un compito
tutto sommato più facile di Debord. Marx aveva come oggetto di studio la prima rivoluzione industriale, e la sua
analisi era intrisa di sudore, sfruttamento e dolore. Il consumismo invece non viene percepito come sofferenza,
ma come godimento condiviso, redistribuzione del benessere. Se quindi Marx ha buon gioco a connotare di significati negativi il concetto di alienazione, Debord, che è
una sorta di Marx del consumismo, prova maggiori difficoltà a farci odiare la contemplazione, che è l’anello di
congiunzione tra alienazione e spettacolo. Anche la contemplazione è passività, ma una passività che non nasce
dall’impotenza bensì dall’ammirazione. Si contempla la
Madonna, si contempla il sacro, si contempla lo spettacolo. Lo spettacolo, inteso come consumismo, ha rappresentato nel nostro recente passato una sorta di sacralità.
Se dunque lo spettacolo è morto non è perché l’abbiamo combattuto, ma perché le leggi economiche hanno
preso un’altra strada. Alla fine degli anni Settanta nacque
il capitalismo finanziario. Il valore non scaturisce più dal
lavoro, dalla produzione e dal consumo. Nasce dal mercato, dalla libera contrattazione dei valori azionari. Spazzato via il mondo della produzione reale, lavoro e consumi diventano superflui. Le luci dello spettacolo si spengono ad una ad una e il mondo sembra tornato a uno scenario da prima rivoluzione industriale.
Finito il consumismo, cosa può dunque insegnarci oggi Debord? In realtà sembra che le sue risorse profetiche si
rivelino inesauribili. Nel 1988 scrisse I commentari sulla
società dello spettacolo che descrivono lucidamente non
la società di allora, ma la realtà di oggi. Ne La società dello
spettacolo Debord identificava due forme di spettacolo,
legate a due diverse forme di regime politico: lo spettacolo concentrato, proprio delle società totalitarie e dittatoriali, e lo spettacolo diffuso, proprio delle democrazie occidentali dominate dal consumismo. Nei Commentariintroduce il concetto di spettacolo integrato, che ha molte
caratteristiche in comune con lo spettacolo concentrato,
dove «il centro direttivo è ormai diventato occulto». Qui la
Mafia non rappresenta più un residuo arcaico del passato, ma il modello economico vincente: «nell’epoca dello
spettacolo integrato, essa appare di fatto come il modello
di tutte le imprese commerciali avanzate».
Ancora una volta Debord descrive dal passato il nostro
presente. Pensiamo al concetto di spettacolo integrato,
miscela di stato tollerante e autoritario, come anticipazione del capitalismo autoritario contemporaneo. E pensiamo all’idea di Mafia come modello di tutte le imprese
future. Incomprensibile nel momento in cui viene scritta,
quella definizione anticipa in maniera sorprendente
un’opera come Gomorra: la delinquenza non è corruzione, deviazione, ma la matrice stessa della produzione capitalistica.
FOTO ® BNF, DPT. MANUSCRIPTS, FONDS GUY DEBORD
N
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IMMAGINI
FOTO ® BNF, DPT. MANUSCRITS, FONDS GUY DEBORD
Qui sopra La società dello spettacolo in un’edizione francese del 1971
Dall’alto: 1954, da sinistra a destra Gil Wolman, Mohamed Dahou,
Guy Debord e Ivan Chtcheglov davanti alla galleria Double Doute
(Doppio Dubbio) a Parigi. Una scheda del dossier Filosofia, sociologia;
un manoscritto del ’78 (In girum imus nocte et consumimur igni, uno dei suoi film);
tre volantini, di cui quello arancione invita all’apertura del bar La Méthode:
“Se stasera dopo le dieci non avete intenzione di rileggere Schopenhauer”
DOCUMENTI
Nella pagina
di sinistra Guy Debord
a Cannes nel 1950
e dall’alto: un numero
dell’Internationale situationniste,
scheda dal dossier “Marxismo”
e un fotomontaggio. Qui a destra
tre manifesti del Maggio ’68, mentre a sinistra
uno dei cinque esemplari del “Gioco della guerra”
costruito da Debord nel 1978. Qui sopra “The Naked City” (1957)
Tutti materiali esposti nella mostra parigina “Guy Debord, un art de la guerre”
alla Biblioteca nazionale di Francia dal 27 marzo al 13 luglio
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
LA DOMENICA
■ 34
Spettacoli
Allegro con brio
La Biblioteca Marciana conserva spartiti
originali incisi ora per la prima volta
E documenti preziosi
anche per ricostruire la vita
dissoluta degli artisti di corte
Musicae sesso nellaVenezia del ’700
GIUSEPPE VIDETTI
«Q
VENEZIA
uella bassa e gialla è la casa
di Elton John», esclama Andrea Bacchetti scrutando la
Giudecca dalla Piazzetta
San Marco. Poi, brandendo gli spartiti di Baldassarre Galuppi e Benedetto Marcello: «Questi erano come lui: le pop star del Settecento veneziano». Il giovane pianista genovese è magro, nervoso, un furetto al servizio della musica; tanto comico nel suo scattante virtuosismo da finire nello show di Chiambretti. Sono cinque anni, dal
2007, che il maestro periodicamente si rintana
nella rivale repubblica marinara in cerca di tesori da riproporre nella collana La Tastiera Italiana,
che cura con lo storico Mario Marcarini: un progetto di recupero, restauro e prima edizione discografica di preziosissimi manoscritti in collaborazione con la Biblioteca nazionale Marciana
di Venezia. I volumi già pubblicati — dedicati ai
compositori Cherubini, Galuppi, Marcello e
Scarlatti — hanno avuto risonanza internazionale. Negli spazi monumentali progettati dal Sansovino, Bacchetti si muove come a casa. È questa
la struttura che custodisce i suoi “vangeli”, manoscritti originali di uno dei patrimoni musicali
più importanti del mondo, riccamente decorati e
rilegati in marocchino rosso. Ce ne sono di
perduti, ritrovati e restaurati di fresco che
stanno scatenando la curiosità di musicisti e melomani.
«Erano i tempi in cui ricchezza faceva
rima con bellezza», sospira Franco Rossi, vicedirettore del conservatorio Benedetto Marcello e docente di storia della
musica. Le vicende della Marciana sono
una favola che oggi non avrebbe lieto fine.
È il 1468: il cardinale greco Bessarione fa
dono dei suoi mille codici latini e greci
alla Repubblica di Venezia. Per
ospitare il prezioso carico, lo Stato Veneto affida a Jacopo Sansovino la costruzione davanti al Palazzo Ducale di
un grandioso edificio di
stile classico. La sala di
lettura viene decorata
da Tintoretto e Veronese; nell’antisala, ornata da un dipinto di
Tiziano, trova posto il
Museo Statuario della Repubblica. Uno
scrigno per tutte le
arti; un’allegoria
del Veronese è
dedicata alla
RESTAURATI
Un musicista
inciso da Filippo Bonanni
Qui accanto il Libro I (1752)
di Domenico Scarlatti
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 35
Domenico Scarlatti
Benedetto Marcello
Baldassarre Galuppi
Antonio Soler
Luigi Cherubini
1685-1757
1686-1739
1706-1785
1729-1783
1760-1842
Nella Biblioteca
San Marco vi erano
i manoscritti
di alcune sonate
Resta anche la fitta
corrispondenza
con Farinelli
Sono molte le fonti
manoscritte
dell’artista,
cui è dedicato
il Conservatorio,
conservate
in Biblioteca
Le otto sonate
per tastiera
pubblicate
su disco nel 2008
sono solo parte
dei suoi documenti
tenuti alla Marciana
Conosciuto anche
come Padre Soler,
l’allievo di Scarlatti
è ritenuto l’autore
di molti manoscritti
conservati
nella Biblioteca
La Marciana
custodisce
gli spartiti
delle Sei sonate
per cimbalo op.1
del compositore
fiorentino
musica (popolare e colta): donne che cantano e
suonano il liuto e la lira da gamba sotto gli occhi
compiaciuti del dio Pan. «Uno dei luoghi più belli del mondo della cultura dal valore simbolico
enorme, in un secolo che sta perdendo l’uso della memoria», ammonisce il professor Rossi. Se
oggi un ipotetico Bessarione facesse una donazione in libri dal contenuto filosofico metterebbe
in imbarazzo le istituzioni che non saprebbero
come e dove sistemarli. Tesori negletti che non
arriverebbero ai posteri. Sorte anche peggiore
toccherebbe a quegli spartiti musicali di tre secoli fa che il buon governo della Serenissima teneva
in altissima considerazione.
La sala di lettura della Marciana, cui si accede
dalla scala allegorica del Sansovino raramente
aperta al pubblico che simboleggia la musica come forma di ascensione collettiva verso il cielo,
assomiglia al salone delle feste di un palazzo reale con i magnifici affacci su Piazza San Marco. In
mostra anche il primo cahier de musique di cui si
sia a conoscenza, codice riccamente miniato in
oro zecchino appartenuto alla signora Maria Venier. Contiene le sonate autografe che i musicisti
invitati a palazzo dedicarono alla nobildonna:
uno scorcio inedito della Venezia di primo Settecento. Quanti anni aveva la Venier? Che rapporti
intratteneva con i protagonisti della musica dell’epoca? Raccoglieva autografi dei suoi idoli come oggi le groupie quelli delle rockstar? «Non abbiamo molte informazioni su di lei», precisa il
professor Rossi. «Sappiamo solo che La Fenice,
alla fine del Settecento, fu edificata nel giro di un
anno su un fondo di proprietà dei Venier. Una legge sul lusso sanciva che la città di Venezia dovesse avere non più di sette teatri. Lo Stato dovette fare una deroga ai nobili affinché ce ne fosse un ottavo, la Fenice appunto. I ricchi dell’epoca investivano sugli artisti. Esiste copia di un contratto
tra il compositore e un nobile veneziano con delle clausole sorprendenti: 1) il maestro ha diritto al
compenso anche nei giorni di malattia 2) verrà retribuito anche quando sarà chiamato a tenere
concerti fuori città o in altri stati».
Personaggio di spicco del teatro musicale ita-
liano, nato nell’isola di Burano nel 1706, Galuppi
(morì a 79 anni e fu padre di 15 figli), dal 1762 maestro di cappella nella Basilica di San Marco, fu star
a livello europeo. I Pisani, una delle famiglie più
facoltose di Venezia, lo adottarono. Alla Marciana è conservata una delle due copie (l’altra è a Parigi) di una cantata, Venere al Tempio, scritta per
il matrimonio di un Pisani. «Sappiamo che le celebrazioni si tennero nel salone delle feste dell’attuale Conservatorio, gli eredi hanno ceduto il palazzo nei primi del Novecento», precisa Rossi.
«Questo per ribadire che anche allora i ricchi
spendevano in maniera dissennata, ma per le cose belle. E uno dei lussi che non si facevano mancare era avere per casa degli artisti. L’educazione
musicale dei figli era seguita con attenzione, come dimostrano alcune lettere appartenute alla
potente famiglia Querini».
Ne sa più il professore su Galuppi di quanto noi
su Michael Jackson. Prodezze sessuali che fanno
impallidire Bowie e Jagger. «Intrighi con la Venier? È possibile. Attraverso Cento Anni, il ro-
LA BIBLIOTECA
L’interno
della Biblioteca
Marciana
di Venezia
In alto, alcuni
spartiti originali
lì conservati
manzo storico di Giuseppe Rovani (1818-1874),
uno scrittore della Scapigliatura milanese, scopriamo che Galuppi non era esattamente l’artista
virtuoso che voleva sembrare. C’era del torbido
nel suo ingaggio fiorentino alla corte di Gian Gastone de’ Medici». Ben noto per la sua condotta libertina ai limiti dell’hard core, il granduca si beava del virtuosismo del Galuppi. Non solo. «Aveva
saputo che il suo clavicembalista preferito era superdotato, lo volle vicino per motivi palesemente sessuali», precisa Rossi. «In un documento
conservato a Firenze — diciamo pure un diario a
luci rosse — la sua prestanza fisica è descritta con
dovizia di particolari. Che l’ultimo rampollo dei
Medici fosse un sodomita era risaputo anche fuori dal Granducato di Toscana, tanto che il padre di
Domenico Scarlatti si adoperò in ogni modo affinché la permanenza del figlio a Firenze non durasse più di qualche giorno. Anche Caterina II di
Russia, rinomata per i suoi appetiti sessuali, era
ben informata sulle dotazioni di Galuppi. Il soggiorno di Baldassarre a San Pietroburgo fu lungo
e chiacchierato. Quando il figlio di Caterina venne a Venezia, poco prima della morte del compositore, gli consegnò un dono prezioso: “Da parte
di mia madre, che non vi dimentica”, gli disse. Era
il frutto della loro relazione? I comportamenti
sessuali, anche borderline, erano molto tollerati
dalla società dell’epoca. Ben oltre le prodezze di
Casanova dovette spingersi Lorenzo Da Ponte, il
librettista delle Nozze di Figaro, per essere bandito (il 17 dicembre 1779) dalla Repubblica di Venezia per quindici anni».
È purissima e malinconica l’aria per clavicembalo del Galuppi che il maestro Bacchetti fa risuonare sotto le preziose volte della Marciana, tra
i tesori musicali esposti a una generazione distratta. «Qui dentro c’è il fondo più importante
appartenuto ai reali di Spagna e Portogallo dal
Quattrocento fino all’Ottocento. Materiali che ci
mettono in contatto con la Storia», conclude Rossi. Vuol dire che saremmo dei mostri se facessimo
scempio di tanta bellezza. E non s’arrivi a dire che
ogni generazione ha la Venier che si merita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Chiedi alla polvere e ti risponderà
ANDREA BACCHETTI
uandomi hanno parlato della riscoperta di partiture inedite di autori del Settecento, tratte da manoscritti autentici, mi sono entusiasmato. L’emozione
di leggere un testo originale così come scritto dal compositore è impagabile.
È bello andare dentro le note, percepire il pensiero dell’autore, interpretarlo per trovare la frase che lui avrebbe voluto scrivere e che rispecchia la sua ispirazione. In poche parole: vivere l’autenticità di quanto voleva lasciare ai posteri.
È una sorta di rompicapo che ti consente di ascoltare (riscrivendo) la melodia, anche nei dettagli. Devi tornare indietro negli anni, entrare nel momento storico, nello stato emozionale e caratteriale dell’autore, nel suo modo di vivere e di concepire la musica. Una ricerca senza fine che ti pone dubbi, ma
anche sensazioni incontaminate che sulle partiture stampate non troverai mai. O
meglio: sono già state risolte e interpretate da altri, e ciò toglie il piacere della sco-
Q
perta, perché nell’esecuzione non parti da un pensiero che hai sviluppato tu, originale, ma da una scrittura già tradotta. L’inusuale decifrazione delle chiavi antiche
per noi pianisti è pratica ormai dimenticata, avendo sempre le partiture in chiavi
moderne. L’immergersi nella “polvere dei secoli” delle biblioteche europee, nella
vita e nella storia di istituzioni centenarie che con il loro lavoro paziente e appassionato ci permettono ancora oggi di disporre di questo materiale unico al mondo,
ci trasmette adesso e per sempre pagine di vita vissuta, di gioia e di dolore di uomini che hanno lasciato il segno nella storia dell’umanità. La sintesi di questo lavorare nel tempo è l’acquisire in te stesso la consapevolezza che per crescere non
bisogna mai smettere di cercare, non c’è un punto di arrivo. Più cerchi, più trovi, più cercheresti: un “crescendo in continuo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
LA DOMENICA
■ 36
Next
In fila per 3.0
IL SITO
Tablet e Lim erano soltanto il primo passo
Per adeguare insegnamento e apprendimento
ai tempi di Internet si comincia dall’architettura
delle vecchie aule. Ecco come. E dove
Per conoscere come sarà
la classe del futuro
si può visitare il sito
dell’Indire, l’Istituto
di documentazione,
innovazione e ricerca
educativa del Miur
(Ministero dell’istruzione
università e ricerca)
I BANCHI DEL FUTURO
5
4
LE CARATTERISTICHE
COOPERATIVE LEARNING
La lezione non è più
frontale, per questo
l’insegnante non siede
in cattedra
Ogni studente, dotato
di computer, potrà
intervenire per arricchire
i temi e gli argomenti
trattati di volta in volta
ROSARIA AMATO
a cattedra è scomparsa e la lavagna
pure, anche quella in versione multimediale: sono le quattro pareti a far da
schermo al proiettore del computer.
Quanto all’aula, è diventata “a geometria variabile”: i banchi non sono
più rettangoli allineati a due a due, bensì trapezi
che si compongono e scompongono a seconda
delle esigenze formando delle “isole”. Gli argomenti vengono affrontati in versione multimediale, l’insegnante suggerisce e modera, i ragazzi intervengono utilizzando il loro tablet. Il tema non è
banalmente “la lezione”: quella il professore ha
provveduto a postarla per tempo, e i ragazzi l’hanno ascoltata attentamente su video, a casa. Quello
che si fa in classe è altro: si approfondisce, si affrontano i problemi legati a quell’argomento, si
fanno collegamenti con esperienze ed esperimenti di altre classi, della stessa scuola, ma non necessariamente perché potrebbe trattarsi anche di
scuole che si trovano all’altro capo della terra.
L
In alcuni paesi, e persino in Italia,
la scuola 3.0 si sta già sperimentando
Rivoluzionerà il sistema attuale
di apprendimento a partire dall’aula
Ci saranno:
1. debate, e non lezioni
2. didattica multidirezionale
3. isole, e non più singoli banchi
4. pareti vive, al posto delle lavagne
5. cooperative learning
PARETI VIVE
Su ciascuna
delle quattro pareti
dell’aula vengono
proiettati con il pc
immagini e testi utilizzati
dall’insegnante
mediante il suo
tablet per presentare
un argomento (o anche
un quadro)
Senza cattedra né lavagne
sarà così la nuova scuola
Tutto questo è la scuola 3.0: troppo presto per
parlarne, visto che in Italia la 2.0 è ancora in fase di
sperimentazione e quella tradizionale cade a pezzi? Può darsi. Però, anche se suona sarcastica fantascienza alle orecchie dei tanti genitori che oggi
devono provvedere di tasca propria alla carta igienica per i bagni, esistono già scuole italiane che
stanno avviando la sperimentazione dell’aula a
geometria variabile. Mentre le classi 2.0 sono ormai
in una fase matura, e l’esperienza si va allargando.
«Non si tratta solo di introdurre nuove tecnologie nelle scuole — dice Giovanni Biondi, capo dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali del
ministero dell’Istruzione e presidente dell’European Schoolnet — dobbiamo creare una situazione di attrattività della scuola per le nuove generazioni. Abbiamo una generazione digitale che
apprende a casa attraverso la multimedialità e le
tecnologie interattive: quando questi ragazzi arrivano a scuola, trovano un ambiente dove sono
soggetti passivi, sono invitati solo ad ascoltare, a
prendere appunti, e gli unici linguaggi che possono utilizzare sono quello scritto e quello orale.
Mentre la scuola ha l’obiettivo di coinvolgere e far
appassionare gli studenti: l’ha sempre avuto, e
adesso ancora di più, ora che le nuove tecnologie
offrono l’opportunità di superare lo schema sto-
rico-narrativo tradizionale».
La rivoluzione è già cominciata nelle scuole ed è
partita quando i computer sono usciti dal “laboratorio informatico” per entrare in classe, e diventare protagonisti delle lezioni. Fino ad allora, certo,
professori particolarmente avveduti erano riusciti
già a far apprezzare materie magari meno digeribili: «Entrare in un quadro di Tiziano e poterne apprezzare i particolari in 3D non è come vedere la foto sul vecchio manuale», dice Biondi. L’arrivo del
computer nelle classi, e meglio ancora della Lim, la
lavagna multimediale interattiva, ha dato poi inizio alla rivoluzione vera e propria. Una rivoluzione
che adesso sta arrivando a mettere in discussione
persino la tradizionale architettura scolastica, che
non si presta più alle esigenze di quella che sarà la
scuola di domani. «Io utilizzo la Lim per la geometria ormai da cinque anni — dice Tiziana Napolitano, insegnante di matematica e scienze alla scuola
media di via dei Consoli a Roma — perché mi permette di spaziare: la lezione diventa aperta, ognuno interagisce, dà il proprio contributo».
«Gli insegnanti — spiega Daniele Checchi, pro-
I PROGETTI
ITEC
Montelupo fiorentino
Book in progress
Uno per uno
Innovative Technologies
for an Engaging Classroom:
progetto europeo di “classe
del futuro” avviato in mille classi
di dodici paesi
All’istituto comprensivo Baccio
da Montelupo (Firenze)
gli studenti delle medie
usano regolarmente computer,
tablet, Lim e libri digitali
Il liceo Majorana di Brindisi
è capofila di un progetto
che affianca i libri di testo
a una “sintesi vocale”. I docenti
usano la Lim e le videolezioni
All’istituto tecnico Pacioli
di Crema c’è un computer
per ogni studente
e si sperimenta anche l’aula 3.0
a geometria variabile
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 37
1
DEBATE
Tra l’ardesia e il web
Non più interventi disorganici:
tutto si svolgerà secondo
regole precise apprese
mediante il “debate”,
una sorta di ars oratoria
ai tempi del computer,
già conosciuta e codificata
nel mondo anglosassone
MARCO LODOLI
ome sarà la nuova scuola ormai sembra abbastanza chiaro, almeno nelle intenzioni,
nelle aspettative, nelle speranze: un luogo dinamico dove lo studente partecipa e interagisce con
l’insegnante presente in classe e con le mille sollecitazione che gli arrivano tramite il tablet, la lavagna
multimediale, l’infinito oceano di Internet. Sta per
finire la vecchia lezione frontale, quella con il prof in
cattedra che per un’ora spiega Leopardi o l’ablativo,
che si volta solo per tracciare con il gessetto parole
sghembe sulla lavagna d’ardesia, la lezione che soddisfa l’insegnante ma a volte deprime gli alunni, che
stanno lì, immobili, inerti, spesso distratti. In Europa questo tipo di insegnamento è superato, e chi ancora si attarda nei suoi comizi culturali viene visto
male, come un rottame vanitoso di un tempo tramontato. Insomma, la nuova pedagogia detta regole precise: bisogna che la scuola sia un luogo di dibattito e partecipazione, non banchi da scaldare. Le
nuove tecnologie sono pronte
per trasformare una vecchia aula in un centro di
C
raccolta ed elaborazione di dati.
Ma c’è ancora un problema da superare, almeno
qui in Italia. I nostri ragazzi intendono la Rete come
uno spazio ludico: scaricano giochetti, accoppano
zombie, chattano con gli amici, guardano filmetti
dell’orrore, qualche porno, si fanno matte risate navigando tra le follie catalogate su YouTube, ascoltano e scambiano musica, se la spassano. Internet è
una giostra infinita che allarga il suo cerchio e i suoi
cavallini virtuali fino agli orizzonti più lontani, dove c’è sempre qualcosa che farà divertire. Ora bisogna cambiare atteggiamento, far capire ai ragazzi
che la Rete offre occasioni di approfondimento, biblioteche e pinacoteche smisurate, un incredibile
allargamento della conoscenza: non si tratta di scaricare la ricerca premendo un tasto e stampando
quattro fogli da consegnare a quel babbeo del professore. Ma di trasformare il Paese dei Balocchi in
una scuola diversa, più vicina ai ragazzi ma non per
questo meno complessa. Insomma: si tratta pur
sempre di studiare.
‘‘
Entrare in un quadro
di Tiziano
e poterne apprezzare
i particolari in 3D
non è come
vederne la foto
sul vecchio Argan
Giovanni Biondi
capo dipartimento Miur
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
LE ISOLE
Via cattedra e banchi
singoli o a coppia
Gli studenti si siedono
in banchi a forma
di trapezio, che uniti
formano “isole”
smontabili a seconda
delle esigenze
2
DIDATTICA
Diventa
multidirezionale:
gli input non vengono
sempre e solo
dagli insegnanti
La classe riceve stimoli
esterni, che poi però
ciascuno restituisce
agli altri rielaborati
sotto altre forme
fessore di economia politica all’Università di Milano, tra i coordinatori del rapporto “Progetto Cl@ssi 2.0” — dicono
che le nuove tecnologie livellano il terreno di partenza degli studenti, agendo come un elemento di
innovazione che ridisegna i rapporti all’insegna
della classe, permettendo di superare la tradizionale distinzione tra “bravi” e “scarsi”. Molti fanno
notare come sia più facile diversificare l’insegnamento e le richieste, e che la varietà delle risorse
permette di arrivare a tutte le intelligenze. La seconda osservazione è che l’insegnante perde di
centralità come unica fonte di autorità, diventando piuttosto un “facilitatore”, una guida esperta».
Ecco perché gli esperimenti che già fanno intravedere la scuola dei prossimi anni non prevedono più
aule con la cattedra: «Stiamo progettando l’aula
3.0, a geometria variabile — annuncia Giuseppe
Strada, preside dell’Itc Pacioli di Crema — con le
pareti “vive”, le postazioni mobili per gli studenti,
l’insegnante che gira con il suo tablet, sedendosi in
qualunque posto ritenga opportuno. Prevediamo
che verrà utilizzata a turno da tutti gli insegnanti,
School of one
A New York, offre programmi
differenti per ogni studente
Alcuni lavorano in gruppi, altri
da soli, altri col tutor. Non esiste
l’aula, solo grandi isole
che avranno modo così di sviluppare la
didattica multidirezionale: non è detto
che gli stimoli debbano arrivare necessariamente
dal professore, lo studente diventa protagonista
della lezione, ma al tempo stesso viene molto valorizzato il lavoro di gruppo. È un sistema che migliora molto i livelli di apprendimento, fino al 25 per
cento in più, come emerge dagli studi del Mit». Il
Massachusetts Institute of Technology di Boston
sta infatti collaborando con l’Itc Pacioli e con un
gruppo di altre scuole italiane per valorizzare nuovi modelli di didattica: «Abbiamo mandato una
trentina di nostri studenti in alcune scuole — illustra Serenella Sferza, milanese, docente del Mit —
per sperimentare corsi di materie scientifiche cosiddetti custom-tailored, tagliati su misura. Si trat-
IL DISEGNO
Ecco come sarà
l’aula 3.0
Aboliti cattedra
e banchi
Per l’insegnante
un posto
al centro
della stanza;
gli studenti
si sistemano
a gruppi
in banchi
che creano
delle “isole”
Alle pareti sono
proiettati testi
e immagini
con il computer
ta di un metodo applicativo che mira al problem
solving, la ricerca di una soluzione, piuttosto che allo sviluppo di un programma attraverso delle lezioni. Quelle ci sono ancora, ma costituiscono un
momento preliminare: si guardano sul computer,
a casa, prima di arrivare a scuola, ogni studente lo
fa con i tempi che ritiene più appropriati».
Tuttavia le sperimentazioni permetteranno di
arrivare a una scuola nuova, innovativa, solo se saranno il più possibile estese, diffuse e condivise: la
raccomandazione per l’Italia arriva dall’Ocse. All’inizio di marzo due esperti dell’organizzazione,
Stéphan Vincent-Lancrin e Francesco Avvisati,
hanno presentato al Miur uno studio sul piano nazionale per la scuola digitale. In sintesi, l’indicazione è una sola: uscire dalle riserve indiane della sperimentazione, rendere tutte le scuole 2.0 (dotandole di banda larga) eventualmente anche adottando strumentazioni più economiche della lavagna multimediale («basta un computer con un
proiettore»), mettere in Rete i risultati e infine condividere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Modello rovesciato
Alla Clintondale High School
del Michigan i ragazzi a casa
o mentre sono in giro guardano
sullo smartphone i video delle
lezioni; in classe fanno i compiti
Repubblica Nazionale
LA DOMENICA
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 38
I sapori
Di moda
Tra qualità
accertate
e leggende
metropolitane
per la primavera 2013
va molto
l’antico Egitto
Il marchio
Kamut è un marchio
registrato e non il nome
del grano, che si chiama
khorasan e può essere coltivato
ovunque (ma non si
può chiamare Kamut, nome utilizzabile
solo dai produttori americani)
Sotto, Kamut e verdure saltate in padella
LICIA GRANELLO
l potere della parola. Kamut, per
esempio. Odore di spezie e paesi
lontani, civiltà antiche e saperi ritrovati, la Mezzaluna Fertile, culla
della civiltà agricola, e i primissimi
semi trasformati in cibo. Non potevano scegliere nome migliore, i membri
della famiglia Quinn, quando nel 1990 depositarono il marchio di un cereale, il khorasan — Triticum Turgidum sottospecie
Turanicum, in linguaggio botanico — coltivato nell’America del nord. Quasi un
quarto di secolo più tardi, il vero nome del
grano khorasan è sconosciuto ai più, sostituito dal marchio (registrato con tanto di
®), che identifica il cereale più acclamato
e modaiolo di inizio millennio, d’obbligo
nei menù piegati alle esigenze della remise
en forme primaverile.
La storia dell’alimentazione è una successione ondivaga di improvvise accelerazioni e frenate repentine, innamoramenti
fulminanti e oblii inspiegabili. Nel corso
dei secoli, patate e carni arrosto, zucchero
e tartufi, vino e caffè sono passati dalla polvere all’altare e viceversa a seconda di luoghi, costi, ceti sociali. Il grano khorosan
non si è sottratto alla maledizione dei cibi
misconosciuti, se è vero che dopo essere
arrivato in America nel dopoguerra grazie
al regalo di un viaggiatore di ritorno dall’Egitto, il progetto della sua coltivazione è fallito miseramente per ben due volte. Solo
alla fine degli anni Ottanta la diffidenza nei
confronti dei chicchi rustici e giganti arrivati dall’antico Egitto — in realtà il Khorasan è una regione dell’Iran — ha lasciato
posto al primo serio tentativo di produzione. Le rese si sono rivelate buone, la pianta
robusta, il gusto — una volta ottenuta la farina e impastati i primi pani — piacevole.
Da quel momento, la popolarità del khorasan ribattezzato Kamut ha avuto un incremento esponenziale, tra qualità accertate e leggende metropolitane, dal ritrovamento all’interno delle piramidi all’assenza di glutine (che invece è ben presente). In
compenso, l’analisi nutrizionale evidenzia ricchezza in minerali — magnesio, zinco e selenio su tutti — e un’eccellente quota di proteine, lipidi e acidi grassi insaturi
(buoni). In più, il khorasan Kamut è in tutto simile a quello di migliaia di anni fa: nessun miglioramento genetico, nessuna
manipolazione, nessuna coltivazione intensiva a indebolirne la tempra.
Uno status di rustico incontaminato
che facilita la coltivazione organica (obbligatoria, nel disciplinare di produzione),
senza pesticidi né forzature. Alcuni virtuosi mulini piemontesi lo impreziosiscono
ulteriormente, macinandolo a pietra. Il
guaio è che il Kamut sembra amare solo i
campi di Alberta e Montana. In più solo
quello nordamericano può essere chiamato Kamut, fattori che stridono pesantemente con il concetto di chilometri zero
ipotizzato per il domani dell’agricoltura a
basso impatto economico (costo del trasporto) ed ecologico. Comunque, se la fascinazione del grano dei Faraoni ha colpito anche voi, il libro di Antonella Scialdone
— Kamut, 60 ricette per conoscerlo e utilizzarlo al meglio, Calderini Edizioni — soddisferà tutti i vostri quesiti cerealicoli. Altrimenti, comprate un pacco di farina integrale made in Italy macinata a pietra e
dedicatevi alla panificazione d’antàn. Con
buona pace dei Faraoni.
I
Kamut
®
Il grano dei Faraoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Repubblica Nazionale
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 39
Gli indirizzi
DOVE DORMIRE
DOVE MANGIARE
DOVE COMPRARE
CORTE GONDINA
Via Roma 100
La Morra
Tel. 0173-509781
Camera doppia da 110 euro, colazione inclusa
OSTERIA DA GEMMA
Via Marconi 6
Roddino
Tel. 0173-794252
Chiuso lunedì e martedì, menù da 25 euro
MULINO MARINO
Via Caduti per la Patria 43
Cossano Belbo
Tel. 0141-88129
AGRITURISMO IL CORTILE
Via S. Croce 17, Diano d’Alba
Tel. 0173-69595
camera doppia da 75 euro, colazione inclusa
L’OSTERIA DEL VIGNAIOLO
Regione Santa Maria 12, La Morra
Tel. 0173-50335
Chiuso mercoledì e giovedì, menù da 32 euro
MULINO SOBRINO
(con camere)
Via Roma 108
La Morra
Tel. 0173-50118
AMALIA CASCINA IN LANGA
Località Sant’Anna 85
Monforte d’Alba
Tel. 0173-789013
Camera doppia da 90 euro, colazione inclusa
LA TORRE
Via dell’Ospedale 2
Cherasco
Tel. 0172-488458
Chiuso lunedì, menù da 30 euro
IL FORNO
DEL BUON PANE
Borgo Corini 3
Roddino
Tel. 0173-794088
I PIATTI
Spaghetti
Ciambella
Drink
Zuppa
Pane
Pastifici artigiani e grandi
marchi propongono
la pasta dal lieve gusto
nocciolato che ben si accorda
con sughi di verdure
e condimenti freschi
Fragrante e burrosa, la farina
si declina in cento lievitati
differenti — croissant
compresi — regalando
allo stesso tempo
consistenza e sofficità
Acqua, olio di semi
di girasole e cartamo,
più un pizzico di sale marino
(che esalta la nota dolce)
per la ricetta della bevanda
alternativa al latte
Chicchi ammollati per tutta
la notte (integrali) o lavorati
per accelerarne i tempi
di cottura (perlati)
Si preparano in brodo
di verdure, o con legumi
Struttura consistente,
morbidezza, profumo, sapore
caratteristico e lunga durata
sono frutto di impasti
che rendono al meglio
con il lievito naturale
A tavola
In principio fu la rucola
MARINO NIOLA
puntano improvvisamente come dei pop up da
mangiare e si installano di prepotenza nel nostro
immaginario gastronomico. La moda è così anche per i cibi. Capricciosa e mutevole. Fatta di innamoramenti virali che spesso durano una stagione. O
diventano un tormentone. Come la rucola. Esplosa
negli anni Ottanta è finita dappertutto, dalle tagliate
alle orecchiette. Anche quella del ciliegino è stata
un’ubriacatura collettiva. Piccolo e tondo come un
pacman ha cannibalizzato uno a uno gli altri pomodori. Impazzando in tutte le salse, quasi sempre a sproposito. Come i gamberetti con il mais d’ordinanza.
Che negli anni dei Duran Duran e degli Spandau non
facevano prigionieri.
E adesso tocca al Kamut, un cereale pseudo-egizio
che sembra inventato da Ken Follet. E non è finita perché l’America Precolombiana, dopo averci angustiato
ILLUSTRAZIONE DI CARLO STANGA
S
con la profezia Maya, ci infesta anche con la Quinoa. Un
cereale gluten free. Che si è già guadagnato la fama di
salvavita per i celiaci. E di talismano per quelli che celiaci non sono, ma si comportano come se lo fossero. E
il farro che in Italia si era quasi estinto — e qualche ragione ci sarà pure stata — oggi diventa il simbolo dell’abbondanza frugale, di un’idea di cucina che sta tra il
pauperismo francescano e l’agriturismo dello spirito.
Insomma la moda è sempre moda, ma se una volta i
cibi cult erano indicatori di ricchezza, simboli di abbondanza, surplus di golosità (come tartufi, caviale,
petto d’oca, fois gras) oggi va alla grande il toccasana vegetale, il parafarmaco da mangiare. Un po’ esotico, un
po’ choosy. L’ideale per la tavola nutriceutica. Che fa
cortocircuitare etica e dietetica, ascetismo e salutismo.
È la conversione savonaroliana di una società che trasforma il sovrappeso in una colpa, l’invecchiamento in
reato. E lo sfizio in vizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GLI ALTRI CEREALI
Segale
Farro
Mais
Grano saraceno Quinoa
Gusto intenso, poche proteine
e glutine per la farina nera
che ama il freddo
Grazie all’ottima capacità
di assorbire acqua,
i pani riescono umidi e duraturi
Tre tipologie — spelta,
dicocco e monococco
(a basso contenuto di glutine)
— per il grano rustico
e dolce, antesignano
del moderno grano tenero
Il giallo re dei cereali
latinoamericani — detto
anche granoturco
o meliga — si usa a 360 gradi,
dai biscotti ai biocarburanti
È privo di glutine
Crêpes, pizzoccheri — tipica
pasta valtellinese — e polenta
taragna (con formaggi)
per il simil-cereale proteico
e senza glutine,
di colore grigiastro
Tre colori — giallo, rosso
e nero — per il non-cereale
senza glutine coltivato
sulle Ande, ricco di proteine,
grassi insaturi, vitamine
e oligoelementi
LA RICETTA
Ingredienti per 6 persone
Mattia Spadone e il gemello Alessio,
in sala, sono figli d’arte: i genitori
Marcello e Bruna sono i loro tutori
a “La Bandiera” di Civitella
Casanova, Pescara, dove trionfa
l’impronta del territorio, come
nella ricetta per i lettori di Repubblica
100 g. di zucca gialla
100 g. di fagioli
100 g. di carote
50 g. di sedano
50 g. di porri
50 g. di scalogni
100 g. di pomodorini tipo pendolino
100 g. di funghi
100 g. di farina di Kamut
200 g. di farina di grano tenero
pecorino stagionato,
rosmarino, erba cipollina, pepe, peperoncino,
aglio, qualche foglia di basilico
Mescolare le farine sul tavolo, facendo cadere delle goccioline
d’acqua con le dita e setacciare (i piccoli grumi d’acqua
e farina che si formano resteranno sul setaccio)
Ripetere l’operazione più volte, per raggiungere la quantità
di granetti voluta
Tagliare a dadini le verdure, unire i fagioli ammollati
e cuocere un’ora a partire da acqua fredda,
schiumando a bollitura
Fare un soffritto con porro e scalogno, aggiungere pomodori,
peperoncino, basilico e pepe, poi unire ai fagioli
e continuare la cottura della zuppa almeno venti minuti
In ultimo, far scendere nella pentola i granetti e cucinare per cinque
minuti. Servire con un’abbondante grattugiata di pecorino,
erba cipollina tritata e un filo d’extravergine
✃
Granetti di Kamut con fagioli tondino e finferli
Repubblica Nazionale
LA DOMENICA
DOMENICA 24 MARZO 2013
■ 40
L’incontro
Smascherate
Figlia d’arte, a tre anni voleva
un agente. Lo ha avuto a sei, e a sedici
ha smesso di studiare: “La mia scuola
è stata il cinema”. Da “Sognando
Beckham” a “Pirati dei Caraibi”,
ora nei panni di Anna
Karenina, la star inglese
si guarda allo specchio:
“Noi attori non siamo
che ombre, solo finzione
e trucco. Per esempio
prendete me: nella realtà
sono piatta come un’asse
e ho anche l’acne
Delusione terribile, vero?”
Keira Knightley
na risata, per cominciare. Ridere, spiega, è la
sua prima autodifesa,
un’arma preventiva
contro le domande insidiose: «Ho imparato a sorridere quando devo riflettere e a ridere per salvarmi dal confronto
diretto: funziona altrettanto bene al cinema che negli incontri». Via, allora, a
risate e sorrisi: su uno dei volti più incantevoli del cinema d’oggi, faccia di
languida scolaretta sempre all’erta,
adusa all’affabile ma discreta distanza
del tè delle cinque da brava inglese di
buona famiglia. Keira Knightley, ventotto anni tra due giorni: si sentirà più
matura? «Sono cresciuta molto in fretta, mi pare d’essere adulta già da tempo:
è da tanto che affronto da sola le mie responsabilità e, da sola, decido. La mia
fortuna è stata di avere genitori formidabili, che hanno saputo consigliarmi
senza mai impormi nulla. Mio padre,
Will Knightley, è un veterano del teatro.
Mia madre, Sharman Macdonald, attrice, ora scrive commedie. All’inizio hanno fatto di tutto per scoraggiarmi, poi
hanno capito che ero troppo determinata. Mi hanno entrambi aiutata, fin da
piccola, ma hanno sempre aspettato
che fossi io a volere. Il mio primo provino, il mio primo spettacolo, il mio primo film, sono io ad averli decisi: fin da
‘‘
Anna Karenina di Joe Wright o, adesso,
Jack Ryan, spy-story di Kenneth Branagh, li ho presi come una sfida al mio intelletto: non è troppo arduo sfidarmi intellettualmente... Se fossi più femminile, lavorerei di più con il cuore. Ma la ricerca mi ha sempre incantata. Prima di
A Dangerous Method di David Cronenberg ho trascorso sei mesi a leggermi
l’impossibile su psicoanalisi e Sabina
Spielrein. Certo, non dico di aver capito
tutto. Sa, ho lasciato la scuola a sedici
anni e non ho goduto d’altra formazione didattica che dell’approfondimento, dovuto a questo o quel film, delle
materie più diverse. Questa è stata la
mia scuola».
Mai una ricreazione? Matrimonio, figli? «Io sposata, mamma? Neanche per
sogno. Mia madre m’ha fatto promettere di rifletterci su: niente colpi di testa.
L’arte della seduzione
non è il mio forte
Del resto voi uomini
vi sentite disarmati
se una ragazza
vi ride in faccia
quando cominciate
a prendervi sul serio
FOTO DI MATT SAYLES/INVISION/AP
U
PARIGI
quando avevo dieci anni».
Davanti a un kir royal sul Boulevard
Saint Germain, nello storico Café Flore,
naturalmente il suo preferito a Parigi,
rivestita di Chanel (di cui è da sette anni
l’intrigante testimonial), trucco e profumo inclusi, l’attrice britannica esibisce la spumeggiante sicurezza d’una
manager in erba: «Da una quindicina
d’anni giro film e da una decina ne assicuro la promozione. Potrei considerarmi una vecchia professionista dello
show business». Anche perché ci si è
messa fin da piccina: «Già a tre anni avevo deciso di diventare attrice. Una banalità devastante, vero?». Leggenda
vuole che proprio così piccina avesse
preteso un agente: «Mi pareva naturale, dato che sia mio padre che mia madre ne avevano uno. Sono riusciti a convincermi ad aspettare un po’: ho firmato il primo contratto con un agente a sei
anni. Ecco che tipo di moccioso si trovavano tra i piedi». Come mai questa
vocazione divorante? «Tutta colpa dell’ambiente casalingo, che si popolava a
ciclo continuo di attori, autori, registi:
in gran parte politicamente engagés.
Non capivo nulla delle loro discussioni,
ma bevevo una a una le loro parole. Sono cresciuta con l’idea che l’arte può
cambiare il mondo. Quegli ospiti sono
stati i miei eroi d’infanzia, Superman e
Batman che razzolavano per casa. Ho
scelto la loro professione perché, semplicemente, volevo emularli». Con film
come Sognando Beckham, che l’ha lanciata, o i primi tre Pirati dei Caraibi?
«Sono stata presa in giro dagli amici prima delle riprese di Beckham («che ci fai
in un film sul calcio?») e prima e dopo i
tre Pirati («sei diventata una nuova attrazione di Disneyland?»). Ma mi sono
divertita un mondo. Con I pirati dei Caraibi ho cominciato a diciassette anni e
ho smesso a ventuno, non avevo mai visto tante persone e tanta effervescenza
su un set. E poi girare scene d’azione così fisiche è stato un regalo per me che sono un maschiaccio mancato». Maschiaccio? «Anche nel modo di vestire,
à la garçonne, d’accordo, magari un po’
chic. Fino ai quattordici anni non ho indossato gonne: le odiavo. Al contrario
delle camicie da uomo. Insopportabilmente snob, vero? In più, sono molto
analitica. I film più recenti, da Seta di
François Girard (dal vostro Baricco) a
Non lasciarmi di Mark Romanek, ad
Alla mia età voglio prima di tutto approfittare delle opportunità del lavoro.
Non mi vedo attrice tutta la vita. Forse
ancora una decina d’anni, e stop. Verrà
il momento della famiglia». Da un po’ è
però assediata da un certo James Righton, musicista dei Klaxons e suo tenace
fidanzato: «Ma come suona romantica
questa insinuazione, espressa in un inglese con accento italiano», scoppia a
ridere. «Ci sentiamo più che appagati
come semplici fidanzati: al punto che
potremmo rimanerlo per sempre — altra risata — chi lo sa?». Le sfugge che oggi è l’agognata fidanzata d’infiniti spasimanti in coda, dai diciotto ai sessantotto anni? «L’arte della seduzione non
è mai stata il mio forte: potrei farmi corteggiare per un’ora senza rendermene
conto. Un disastro. Mi attraggono gli incontri, gli scambi d’idee. Mi annoiano
solo i tipi pesanti, ma li liquido alla svelta con una sonora risata. Voi uomini vi
sentite disarmati se una ragazza vi ride
in faccia quando vi prendete sul serio».
La seduzione per finzione è per lei un
giochetto più semplice? Come in The
Hole, con il nudo integrale a quindici
anni o nello spot Chanel, ora censurato,
perché — questo il goffo verdetto —
«sotto il vestito fa intuire la nudità»? «Le
scene erotiche sono sempre le più facili per me. Sono europea e non ho problemi con la nudità, se è funzionale o se
mi fa ridere. Trovo anzi che sia liberatorio spogliarsi. Una donna può usare il
corpo come arma per accrescere il suo
potere davanti a un uomo». Può bastare il décolleté, uno di quelli abissali di
Anna Karenina: «Merce contraffatta:
sono piatta come un’asse! E così distruggo di colpo il fantasma di molti ragazzi», ride di cuore. «È per me una delizia guardarmi su grande schermo con
un seno rigoglioso, e senza nemmeno
lo sforzo d’un intervento di chirurgia
estetica: solo un paio di sfumature.
Ogni mattina, un’amica truccatrice disegnava ombre tra i miei seni per dare
l’illusione d’un petto generoso. Provi a
immaginare: una mezz’ora al giorno
intenta a farmi disegnare i seni da una
donna... Un bell’incentivo ai fantasmi
erotici maschili, no?». E truccarsi, le
piace? «Oggi ho quintali di trucco in faccia, per via dell’acne… ormai so come
neutralizzare i foruncoli. Ma le proibisco di guardarmi troppo da vicino».
Il successo la stuzzica? «Sì e no. Avere
un’intera équipe sul set ogni giorno agli
ordini del tuo look è quasi un sogno di
ragazzina: come essere una perenne
principessa, con tutti quei boccoli finti
d’eroina ottocentesca appiccicati in testa. Ma il mio mestiere non è di farmi riconoscere dall’immagine o dal cognome. Desidero essere un’attrice e spero,
un giorno, d’arrivare al livello di Judi
Dench, la mia partner in Orgoglio e pregiudizio. Il solo osservarla durante le riprese è stato per me un corso di recitazione». Come vive gli obblighi dello star
system? «Ho raggiunto la celebrità giovanissima. A lungo mi ha creato confusione e anche un bel po’ di spavento.
Non mi sentivo all’altezza. Ne traevo
conferma dalle cattiverie che periodicamente ho subìto dai cosiddetti fan,
accaniti sul “difetto” d’una supposta
anoressia: il che faceva imbestialire mia
madre, mentre a me, ogni volta che sentivo la parola dieta, veniva una gran voglia di cioccolata. La gente diventa crudele se ti vede occupare un posto dove
è convinta che tu non debba stare: quasi fossi una pubblicità e non una persona. Shakespeare lo diceva del genere
umano: per me gli attori sono ombre.
Non esistono. Interpretano personaggi immaginari. Il trucco è la loro identità, gli abiti sono di qualcun altro. Finzioni, talora immortali, ma finzioni.
Perciò quando la gente ci vede come
siamo, nella realtà, rimane terribilmente delusa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
‘‘
MARIO SERENELLINI
Repubblica Nazionale