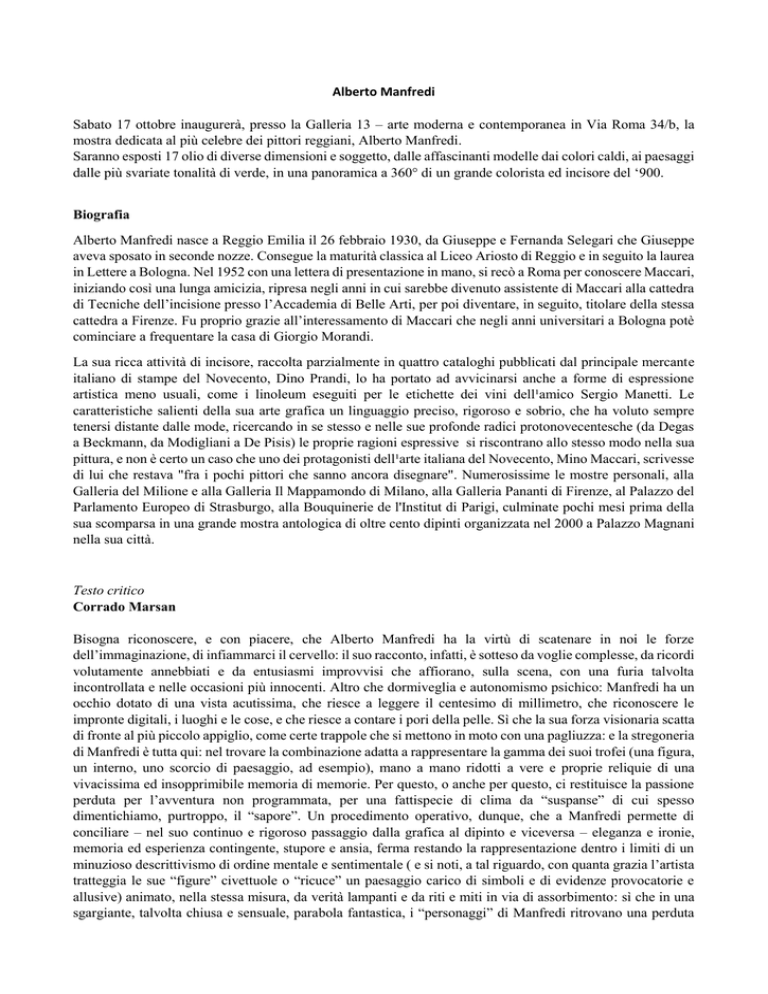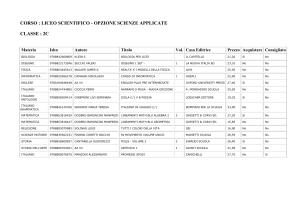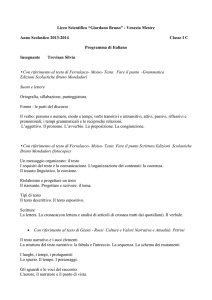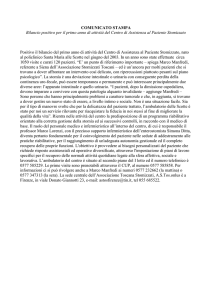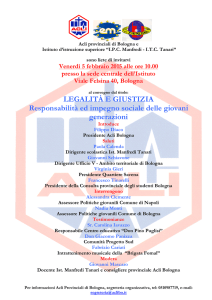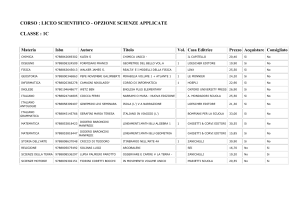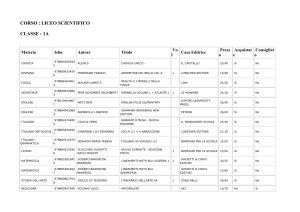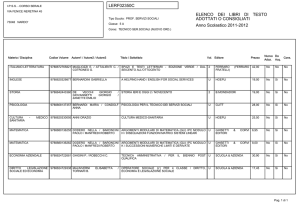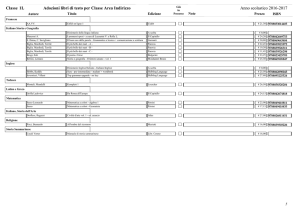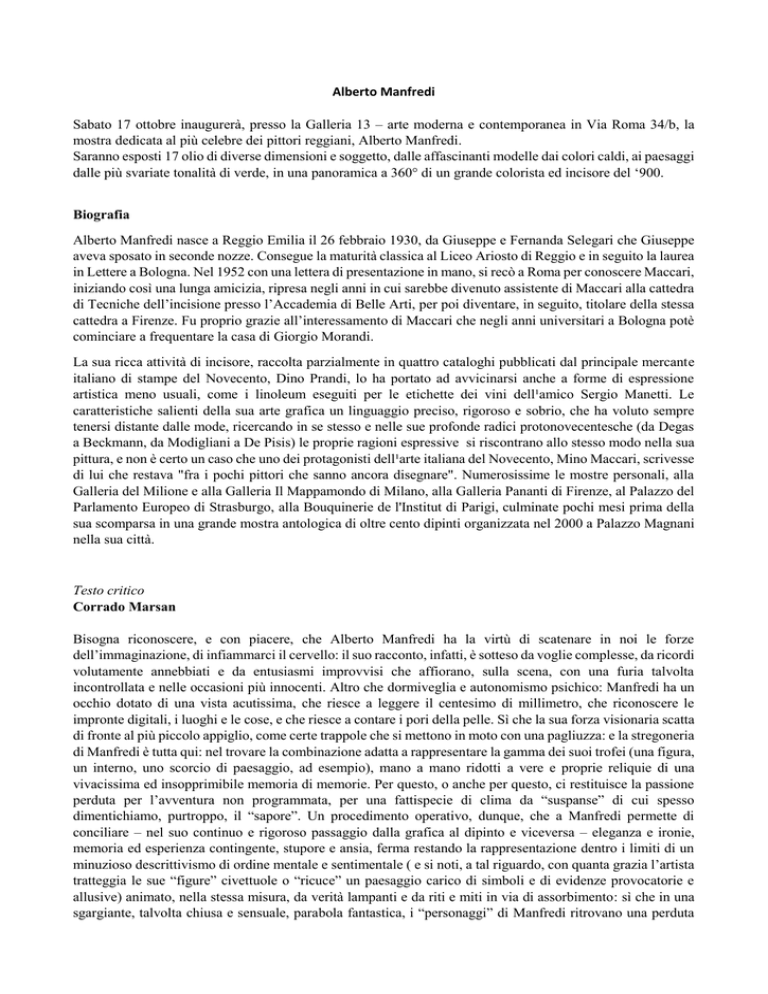
Alberto Manfredi
Sabato 17 ottobre inaugurerà, presso la Galleria 13 – arte moderna e contemporanea in Via Roma 34/b, la
mostra dedicata al più celebre dei pittori reggiani, Alberto Manfredi.
Saranno esposti 17 olio di diverse dimensioni e soggetto, dalle affascinanti modelle dai colori caldi, ai paesaggi
dalle più svariate tonalità di verde, in una panoramica a 360° di un grande colorista ed incisore del ‘900.
Biografia
Alberto Manfredi nasce a Reggio Emilia il 26 febbraio 1930, da Giuseppe e Fernanda Selegari che Giuseppe
aveva sposato in seconde nozze. Consegue la maturità classica al Liceo Ariosto di Reggio e in seguito la laurea
in Lettere a Bologna. Nel 1952 con una lettera di presentazione in mano, si recò a Roma per conoscere Maccari,
iniziando così una lunga amicizia, ripresa negli anni in cui sarebbe divenuto assistente di Maccari alla cattedra
di Tecniche dell’incisione presso l’Accademia di Belle Arti, per poi diventare, in seguito, titolare della stessa
cattedra a Firenze. Fu proprio grazie all’interessamento di Maccari che negli anni universitari a Bologna potè
cominciare a frequentare la casa di Giorgio Morandi.
La sua ricca attività di incisore, raccolta parzialmente in quattro cataloghi pubblicati dal principale mercante
italiano di stampe del Novecento, Dino Prandi, lo ha portato ad avvicinarsi anche a forme di espressione
artistica meno usuali, come i linoleum eseguiti per le etichette dei vini dell¹amico Sergio Manetti. Le
caratteristiche salienti della sua arte grafica un linguaggio preciso, rigoroso e sobrio, che ha voluto sempre
tenersi distante dalle mode, ricercando in se stesso e nelle sue profonde radici protonovecentesche (da Degas
a Beckmann, da Modigliani a De Pisis) le proprie ragioni espressive si riscontrano allo stesso modo nella sua
pittura, e non è certo un caso che uno dei protagonisti dell¹arte italiana del Novecento, Mino Maccari, scrivesse
di lui che restava "fra i pochi pittori che sanno ancora disegnare". Numerosissime le mostre personali, alla
Galleria del Milione e alla Galleria Il Mappamondo di Milano, alla Galleria Pananti di Firenze, al Palazzo del
Parlamento Europeo di Strasburgo, alla Bouquinerie de l'Institut di Parigi, culminate pochi mesi prima della
sua scomparsa in una grande mostra antologica di oltre cento dipinti organizzata nel 2000 a Palazzo Magnani
nella sua città.
Testo critico
Corrado Marsan
Bisogna riconoscere, e con piacere, che Alberto Manfredi ha la virtù di scatenare in noi le forze
dell’immaginazione, di infiammarci il cervello: il suo racconto, infatti, è sotteso da voglie complesse, da ricordi
volutamente annebbiati e da entusiasmi improvvisi che affiorano, sulla scena, con una furia talvolta
incontrollata e nelle occasioni più innocenti. Altro che dormiveglia e autonomismo psichico: Manfredi ha un
occhio dotato di una vista acutissima, che riesce a leggere il centesimo di millimetro, che riconoscere le
impronte digitali, i luoghi e le cose, e che riesce a contare i pori della pelle. Sì che la sua forza visionaria scatta
di fronte al più piccolo appiglio, come certe trappole che si mettono in moto con una pagliuzza: e la stregoneria
di Manfredi è tutta qui: nel trovare la combinazione adatta a rappresentare la gamma dei suoi trofei (una figura,
un interno, uno scorcio di paesaggio, ad esempio), mano a mano ridotti a vere e proprie reliquie di una
vivacissima ed insopprimibile memoria di memorie. Per questo, o anche per questo, ci restituisce la passione
perduta per l’avventura non programmata, per una fattispecie di clima da “suspanse” di cui spesso
dimentichiamo, purtroppo, il “sapore”. Un procedimento operativo, dunque, che a Manfredi permette di
conciliare – nel suo continuo e rigoroso passaggio dalla grafica al dipinto e viceversa – eleganza e ironie,
memoria ed esperienza contingente, stupore e ansia, ferma restando la rappresentazione dentro i limiti di un
minuzioso descrittivismo di ordine mentale e sentimentale ( e si noti, a tal riguardo, con quanta grazia l’artista
tratteggia le sue “figure” civettuole o “ricuce” un paesaggio carico di simboli e di evidenze provocatorie e
allusive) animato, nella stessa misura, da verità lampanti e da riti e miti in via di assorbimento: sì che in una
sgargiante, talvolta chiusa e sensuale, parabola fantastica, i “personaggi” di Manfredi ritrovano una perduta
serenità, una momentanea forza di sorridere; ma è sollievo di breve durata che, subito, i “volti” si gonfiano e
si fanno duri denunciando apertamente e puntualmente, le tante e sottili ambiguità di un’abbacinante epoca di
inquietudini e di crisi, anche di disperata solitudine e di inaccettabile rinuncia alla libertà.
E se c’è un indicazione precisa da dedurre dal lavoro più recente di Manfredi è proprio la cautela, addirittura
la sfiducia in certi calcoli accomodanti e fondamentalmente compromessi, nell’uso delle cifre e dei “segnali
alfabetici” al posto di precisi nessi logici e sintattici che si rifanno, diciamo così nelle loro sotterranee
metamorfosi, alla ruvida coscienza di ciò che è necessario: non a caso, infatti Manfredi vive e agisce, ancora,
in un labirinto popolato di tutte quelle cose e di tutti quei fatti che, giornalmente, ci aggrediscono e ci
coinvolgono da ogni parte. Di qui, infine, una cronaca lirica e morale che non lascia nulla d’intentato e che si
arricchisce, di sequenza in sequenza, di sollecitazioni e di sempre nuove e civilissime “possibilità esplorative”:
tanto che nei paesaggi più significativi dell’artista – nei suoi scatti e nelle sue “smagliature” controllate da un
colore ora trasparente, ora denso ed appena sfrangiato, e più spesso ridotto a un solo e inconfondibile gioco di
piani monocromi, sottesi da un segno continuato e rivelatore – possiamo cogliere la presenza di uno spazio
interno ( e a questo punto il colore-segno diventa, come non potrebbe essere diversamente, segno-scrittura: o,
ancora, una sorta di ideogramma dilatato sulla superficie della tela) nel quale figure di Manfredi galleggiano
intrecciate, ciascuna presa dai propri pensieri, dalle proprie nostalgie, dai propri slanci e non di rado sconvolte,
tutto sommato, da un oscuro presentimento. Quasi un elegia o, meglio, lo squillo vesperino di una tromba che
strozza, di acuto in acuto, le ultime note di un impareggiabile e frainteso “sentimento del tempo”.
“La Nazione”, Firenze, 1969
Orfeo Tamburi
Se è facile leggere nel pensiero o nella scrittura per chi è dotato, è altrettanto facile e forse meglio, leggere in
un quadro ed in un disegno la vera natura di chi gli ha concepiti. Le confessioni di un artista sono nelle sue
opere. Il caso di Albero Manfredi non è semplice come potrebbe sembrare a prima vista, poiché, a parer mio,
c’è un Manfredi disegnatore e un Manfredi pittore, che competono fra di loro. E se il primo è chiaro, nitido,
essenziale, il secondo è più chiuso e complesso, nonostante le apparenze.
Il disegnatore è ironico, leggero. Il pittore è grave.
Ma io non so più se qualcuno lo ha scritto, o invece sono io che lo ha sempre pensato, che una pittura sta alla
prosa come un disegno sta alla poesia. E poiché i quadri e i disegni si leggono come poesie, è chiaro che una
castità mentale guida la mano di Alberto Manfredi perfino nelle parti più intime delle sue modelle, stupite di
ritrovarsi nude, le sue donne, le sue giovani donne in camicia quando mettono in mostra quelle loro rotondità
con candore, ma anche con un pizzico di ironia che non guasta, che anzi dà maggior sapore.
Ma c’è modo e modo di rappresentare un nudo, che può diventare vano, sentimentale e sporco, o naturale
come un frutto e un oggetto. E in Manfredi c’è la gioia della carne, dei sensi e non la miseria del nudo con
tutte le sue imperfezioni.
Un quadretto con un piccolo nudo allungato, di colore marrone un po’ terroso, lo incontro ogni giorno sui
muri della mia casa.
È Bonadea, la sua modella prediletta.
Questo per dire che mi interesso all’arte di Alberto Manfredi già da qualche anno. Ma a dire la verità è uno dei
suoi “abbaini” che avrei voluto scambiare con una delle mie telette, quegli abbaini che fino a qualche anno fa
egli ci mostrava aperti sui suoi cieli inesistenti.
Manfredi è un grafico anche quando dipinge, ecco perché la sua pittura è quasi monocroma, monocolore perché
non ha bisogno di colore.
Alberto Manfredi, Prato, 1969
Sandro Parmigiani
…Il colore, nei dipinti ad olio di Manfredi, non è mai qualcosa di cui essere soggiogati, o magari da brandire
per catturare una subitanea, non si sa quanto duratura, emozione; è invece, insieme, strumento al servizio al
servizio del disegno, per scavare ancora di più dentro la sontuosità delle forme, e amaro sguardo di verità sul
mondo, con quei toni d’argilla, la materia da cui tutto ha origine e a cui tutto torna.
Come in Sironi, in Manfredi non c’è naufragio delle forme nel colore, ma emergere delle forme dal colore,
mai gridato, ma tanto intensamente macerato che l’umore, il fiele del mondo sembrano esservisi impregnati
dentro.
E’ vero che Manfredi ha una mano scolta, felice, e uno sguardo beffardo, divertito. Non sta solo qui, tuttavia,
l’intima verità della sua poetica; ci sono altre facce, nascoste, da cogliere. L’artista non ama certo lavorare
davanti a qualcuno; ciò che allora posso testimoniare sono i momenti in cui Manfredi traccia qualche disegno
sul frontespizio di un catalogo. La facilità e la sicurezza con cui muove la mano, senza mai staccarla punta
della matita dal foglio, fanno quasi pensare ad una gestualità immediata, che venga dall’inconscio. Invece,
basta cogliere lo sguardo con cui segue il segno per sentire, quasi fisicamente, il controllo estremo, il rigore e
il bisogno assoluti di creare e mantenere, nella rappresentazione, una certa struttura dell’immagine.
Nei dipinti c’è questa estenuazione della vita in un’armonia di toni, questo senso desolato e amaro del fluire
del tempo. Impetuosa scorre in Manfredi la vena irriverente e individualista, pronta a denunciare le volgarità,
i moralismi, le ipocrisie, ma mai ci sono in lui lo scherno, il furore di Grosz, ma piuttosto amore e disincanto,
nostalgia di momenti e di illusioni perdute, quando le forme, i toni e le emozioni di uno sguardo si incontrano
e si fondono.
Svelare l’anima dentro le forme, Reggio Emilia, 1996