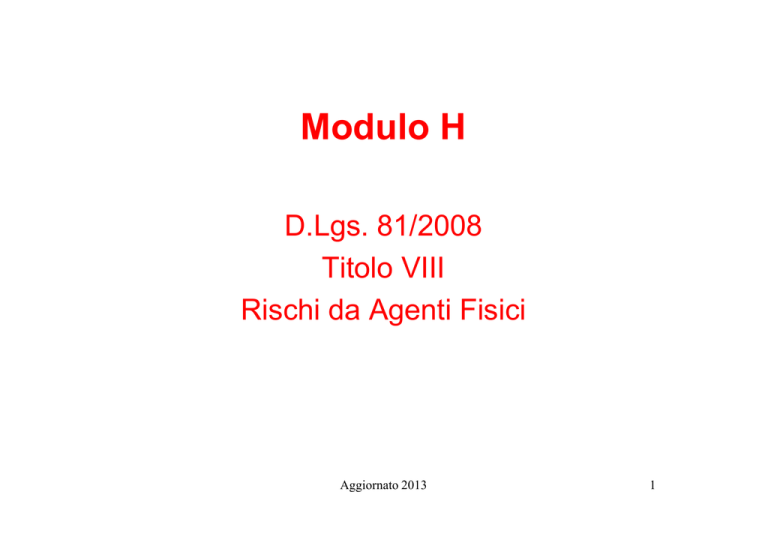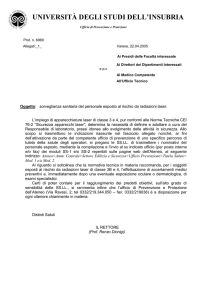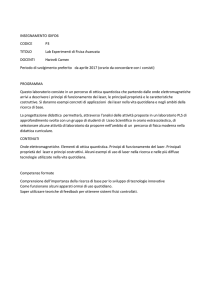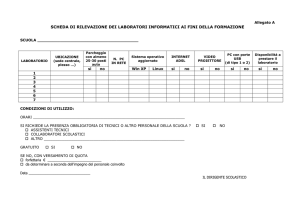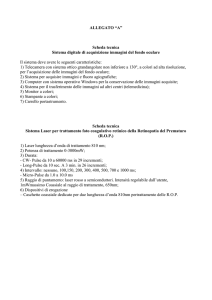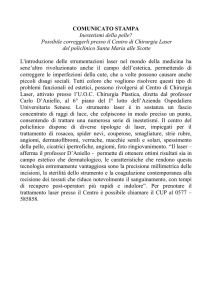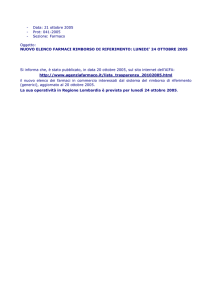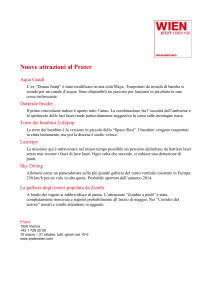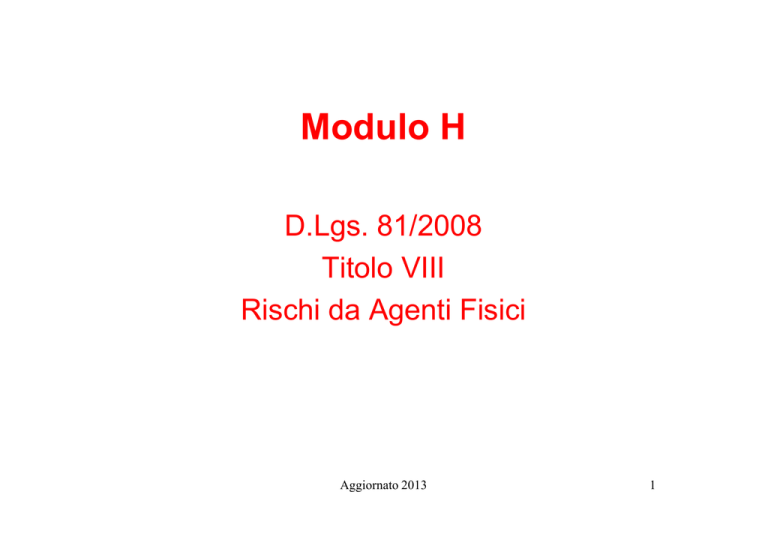
Modulo H
D.Lgs. 81/2008
Titolo VIII
Rischi da Agenti Fisici
Aggiornato 2013
1
Modulo H
- Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro.
-Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici.
- Impatto ambientale dei Campi
elettromagnetici.
-Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
- Cenni di Radioprotezione
Aggiornato 2013
2
D.LGS. 81/2008
TITOLO VIII: AGENTI FISICI
Per agenti fisici si intendono il rumore,
gli ultrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i
campi elettromagnetici, le radiazioni
ottiche, il microclima e le atmosfere
iperbariche che possono comportare
rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Aggiornato 2013
3
D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII
Capo II: Protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro
Aggiornato 2013
4
Esposizione al RUMORE – Introduzione
La Percezione sonora
La percezione sonora è dovuta dall’emissione di energia sonora da
parte di una sorgente che investe il ricettore (orecchio umano).
trasferimento
energia sonora
SORGENTE
RICETTORE
L’energia sonora si propaga dalla sorgente al ricettore attraverso delle
successive espansioni e compressioni dell’aria, le quali provocano una
continua variazione della pressione ambientale, a cui si da il nome di
PRESSIONE SONORA
Aggiornato 2013
5
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA
E’ una delle grandezze fondamentali del fenomeno sonoro
Lp= 10 lg (p2/prif.2)
Pressione sonora
(Pa)
espresso in DECIBEL (dB)
Pressione di riferimento
20 x 10-6 Pa
Il valore della pressione sonora al quadrato è proporzionale
all’energia trasportata dall’onda sonora nell’unità di tempo
- La misura della pressione sonora (e quindi indirettamente del livello)
avviene attraverso uno strumento denominato FONOMETRO
Aggiornato 2013
6
CURVE ISOFONICHE
-Il sistema uditivo dell’uomo è in grado di trasformare in sensazione
sonora solo perturbazioni caratterizzate da valori della frequenza tra
20 Hz e 16000 Hz; inoltre occorre che il livello di pressione sonora
del segnale superi un determinato valore di soglia, variabile con la
frequenza.
Tale fenomeno è ben visibile dalla figura seguente delle curve
isofoniche, ciascuna caratterizzata dalla stessa sensazione sonora.
E’ EVIDENTE CHE LA SENSIBILITA’ DELL’ORECCHIO UMANO E’ MOLTO
MAGGIORE ALLE ALTE FREQUENZE, CON UN PICCO MASSIMO dai
1.000 ai 4.000 Hz, CHE SONO, NON A CASO, LE FREQUENZE DEL
“PARLATO”.
Aggiornato 2013
7
energia
AUDIOGRAMMA NORMALE – CURVE ISOFONICHE
Lp
Soglia di udibilità
frequenza
Aggiornato 2013
8
CURVE di PONDERAZIONE
Dal momento che si è appena visto dall’audiogramma normale che la
sensazione sonora, a parità di livello di pressione sonora e quindi di
energia emessa dalla sorgente, è variabile con la frequenza
sono state inserite nel fonometro delle curve di ponderazione che
alterano la risposta in frequenza dello strumento in modo da avere in
uscita dal fonometro un dato oggettivo, che riproduca la sensazione
sonora.
- Sono definite quattro curve di ponderazione, denominate A, B, C e D,
normalizzate in campo internazionale, come da figura seguente.
Aggiornato 2013
9
I valori di livello sonoro ottenuti misurando la pressione sonora con tali curve di
ponderazione in frequenza, sono ancora espressi rispettivamente in
PIU’ COMUNE
dB(A)
dB(B)
dB(C)
Aggiornato 2013
dB(D)
10
EFFETTI DEL RUMORE di tipo UDITIVO
- L’esposizione a rumore può produrre una diminuzione delle
capacità uditive a causa delle lesioni distruttive irreversibili subite
dalle cellule ciliate dell’organo del Corti. Inizialmente le cellule lese
sono quelle preposte alla percezione dei segnali di 4000-6000 Hz.
Successivamente il deficit uditivo si aggrava gradualmente alle
frequenze inferiori - 2000 e poi 1000, 500 Hz – che sono quelle più
importanti del parlato.
- Un innalzamento della soglia di udibilità rispetto al valore medio
evidenzia una perdita di capacità uditiva
Aggiornato 2013
11
Effetti EXTRAUDITIVI:
Le conseguenze del rumore non si limitano al campo uditivo, ma il
rumore può produrre effetti (denominati extra-uditivi) su:
Sistema cardiocircolatorio
Funzione respiratoria (rallentamento della frequenza e
aumento della profondità del respiro)
Sistema gastro-enterico
Funzione visiva
Sistema endocrino
Effetti di tipo neuropsichico (tra cui disturbi della
concentrazione, riduzione del rendimento)
Aggiornato 2013
12
Titolo VIII del D. lgs 81/08 AGENTI FISICI
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro
Limiti di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco:
Esposizione giornaliera
al rumore
Lex (dB)
Esposizione giornaliera
alla pressione acustica di
picco
Ppeak (Pa)
Valori limite di esposizione
87dB (A)
200 Pa
(140 dB(C)) riferito a
20µPa);
Valori superiori di azione
85 dB (A)
140 Pa
(137 dB(C)) riferito a
20µPa);
Valori inferiori di azione
80 dB (A)
112 Pa
(135 dB(C)) riferito a
20µPa);
Aggiornato 2013
13
Titolo VIII del D. lgs 81/08 AGENTI FISICI
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro
Quali obblighi incombono sul datore di lavoro se i limiti della precedente
tabella vengono superati?
-Nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione
(80dB) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale dell'udito.
-Se viene superato il valore superiore di azione (85dB), il datore di lavoro
elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative
volte a ridurre l’esposizione al rumore.
- Laddove venga superato il valore superiore di azione (85dB), il datore di
lavoro deve apporre segnali indicativi e delimitare l’accesso alle aree
coinvolte.
-Non deve essere superato il valore limite di azione (87dB).
Aggiornato 2013
14
MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE
Gli interventi di riduzione del rischio da attuare possono essere
di tre tipi, secondo una scala decrescente di priorità:
Interventi:
1. Alla fonte
(es. utilizzo di macchinari silenziosi)
2. Sul percorso di propagazione
(es. utilizzando barriere di insonorizzazione)
3. Sul lavoratore esposto
(es. utilizzando Disposizione di Protezione Individuale)
Aggiornato 2013
P
R
I
O
R
I
T
À
15
MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE
DPI
1.
2.
3.
4.
Cuffie
Inserti auricolari
Archetti
Personalizzati
- Inconveniente: riducono l’intelligibilità delle comunicazioni verbali
(in particolare nel caso di soggetti ipoacusici) e la percezione dei
segnali di allarme o di rumore indicativo di cattivo funzionamento
delle macchine, favorendo quindi il verificarsi di infortuni.
- La riduzione del rumore non va spinta oltre determinati livelli
Aggiornato 2013
16
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e
formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a
eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore,
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione;
Aggiornato 2013
17
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore insieme a
una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare
sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore
Aggiornato 2013
18
D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII
Capo IV – Protezione dei lavoratori dai
rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Aggiornato 2013
19
INTRODUZIONE
Cos’è un campo elettromagnetico?
IL CAMPO ELETTROMAGNETICO È DATO DALLA
PRESENZA CONTEMPORANEA DI CAMPI ELETTRICI
E MAGNETICI, TRA LORO CONNESSI, IN UNA CERTA
REGIONE DI SPAZIO
UN CAMPO ELETTROMAGNETICO E’ UNA
REGIONE DELLO SPAZIO IN CUI SI MANIFESTANO
FENOMENI ASSOCIATI A GRANDEZZE ELETTRICHE
Aggiornato 2013
20
UN'ONDA ELETTROMAGNETICA È COSTITUITA DA CAMPI
ELETTRICI E MAGNETICI CHE SI PROPAGANO NELLO SPAZIO
TRASPORTANDO UNA CERTA QUANTITÀ DI ENERGIA
Aggiornato 2013
21
SPETTRO ELETTROMAGNETICO
Aggiornato 2013
22
L’ INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI:
non è permanente ed è sufficiente “spegnere” la sorgente
di campo elettromagnetico per eliminare immediatamente il
problema, senza la necessità di tempi lunghi o di opere di
bonifica per ripristinare le condizioni originarie.
Aggiornato 2013
23
EFFETTI dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sul
CORPO UMANO
Il principale risultato degli studi e ricerche effettuati, riguarda la
conferma di effetti biologici in caso di “esposizioni acute, a livelli
che non si riscontrano nelle vita quotidiana”
Ai normali
livelli di esposizione
studi epidemiologici hanno evidenziato una
correlazione tra i campi magnetici a bassa
frequenza ed un aumento di alcune forme di
leucemia infantile.
finora nessuna evidenza per le alte
frequenze
Aggiornato 2013
24
SORGENTI
ALTE FREQUENZE
BASSE FREQUENZE
Sistemi di trasmissione
e radiodiffusione
-Elettrodotti
-Cabine di trasformazione
(antenne per i segnali
radio-televisivi,
Stazioni radio base-SRB
per i segnali per telefonia
cellulare)
-Impianti industriali
-Elettrodomestici
(tipicamente 50 Hz)
(Banda tra 80 MHz e 1,9 GHz)
Aggiornato 2013
25
D.Lgs. 81/2008 Esposizione ad elettromagnetismo
Definizioni art. 207
Campo elettromagnetico:
Campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o
pari a 300 GHz;
Valore limite di esposizione e Valori di azione: sono valori
tabellati.
Il datore di lavoro deve misurare i livelli di esposizione reali, e
verificare che i limiti non vengano superati e intervenire con
misure di protezione in caso di necessità
Aggiornato 2013
26
A titolo informativo si riportano le seguenti tabelle
Valori limite di esposizione
Aggiornato 2013
27
Valori di azione
Aggiornato 2013
28
La COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA o ECM
(Electro Magnetic Compatibility)
si occupa della convivenza degli apparati e dei sistemi elettrici ed
elettronici con l’ambiente elettromagnetico che li ospita.
La EMC riguarda due diversi aspetti:
1. EMISSIONI: l´apparato, o sistema, durante il suo
funzionamento, non deve emettere segnali elettromagnetici di
entità tale da inquinare l´ambiente elettromagnetico
circostante oltre limiti ben definiti.
2. IMMUNITA’: l´apparato, o sistema, deve poter funzionare
correttamente anche quando si trova in un ambiente
elettromagnetico inquinato da disturbi di entità definita.
Aggiornato 2013
29
Misure di prevenzione e protezione – Art. 210
a) Attuare altri metodi di lavoro implicanti minore esposizione
(riduzione del rischio);
b) scegliere attrezzature che emettano campi elettromagnetici
di intensità inferiore;
c) impiegare misure tecniche per ridurre l’emissione
(schermature o meccanismi di protezione);
d) pianificare le manutenzioni delle attrezzature, dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
e) progettare la struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) limitare la durata e l’intensità di esposizione;
g) disporre di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) apporre specifica segnaletica nei luoghi di lavoro in cui
possano essere superati i valori di azione;
i) evitare l’esposizione dei lavoratori al di sopra dei valori limite
di esposizione.
Aggiornato 2013
30
D.Lgs 81/2008
Titolo VIII
Capo V
Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
Per quanto riguarda il presente Capo V
viene approfondita la sola parte
relativa alla esposizione dei lavoratori
ai LASER
Aggiornato 2013
31
Definizioni art. 214
LASER (amplificazione di luce mediante
emissione
stimolata
di
radiazione):
qualsiasi dispositivo al quale si possa far
produrre o amplificare le radiazioni
elettromagnetiche
nella
gamma
di
lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche,
soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata.
Aggiornato 2013
32
Introduzione - LASER
Light Amplificated by Stimulated Emission of
Radiation
Amplificazione di luce tramite emissione stimolata di
radiazione
La radiazione elettromagnetica porta con sé una certa energia che
può essere scambiata con la materia solo in quantità elementari
discrete, chiamate quanti di radiazioni o fotoni.
E = hν
Aggiornato 2013
33
Campi di utilizzo dei laser
• Lavorazione di materiali (es. foratura, taglio, saldatura,
trattamenti termici);
• misure industriali, civili e ambientali ( es. misuratori di
diametro di fili, rugosimetri, lettori laser, puntatori);
• telecomunicazioni a fibre ottiche (es. sorgenti laser per la
trasmissione ed elaborazione dati);
• applicazioni mediche (es. oftalmologia,chirurgia
endoscopica);
• applicazione in laboratori di ricerca (es. interazioni
radiazione materia)
Aggiornato 2013
34
Caratteristiche del laser
•
•
•
•
Basso grado di coerenza
Bassa potenza
Bassa direzionalità
Bassa monocromaticità
•
•
•
•
Monocromatica
Altamente coerente
Strettamente direzionale
Strettamente focalizzata
Aggiornato 2013
35
Principali tipi di laser
• Laser allo stato solido
(cristalli o semiconduttori Nd-YAG);
• Laser a liquidi;
• Laser a gas
(ulteriormente suddivisi in laser ad atomi neutri,
laser a ioni, laser molecolari es CO2 e laser ad
eccimeri)
Aggiornato 2013
36
Norme tecniche di riferimento
CEI 76
Guida per l’utilizzazione di apparati laser
CEI EN 60825-1
(CEI 76-2)
Sicurezza
degli
apparati
laser.
Parte
1:
Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e
guida per l’utilizzo
CEI EN 60825-4
(CEI 76-5)
Sicurezza degli apparati laser. Parte 4: Barriere per
laser
CEI 76-6
Sicurezza degli apparati laser. Parte 8: Guida all’uso
degli apparati laser in medicina
Aggiornato 2013
37
Esposizione Massima Permessa EMP
I valori di EMP sono i massimi livelli di esposizione
laser a cui l’occhio o la pelle possono essere
esposti senza subire danni a breve o a lungo
termine. Il valore di EPM dipende da numerosi
parametri, quali la lunghezza d’onda, la durata
dell’impulso il tempo di esposizione, il diametro del
fascio ecc…
Aggiornato 2013
38
LEA limite di emissione accessibile
La grande varietà di laser, delle applicazioni e dei modi di
impiego, rendono indispensabile, ai fini della sicurezza, il
loro raggruppamento in classi entro le quali sia applicabile
un criterio comune di limite di pericolosità in relazione alla
lunghezza d’onda, al contenuto energetico del fascio e
alla durata temporale dell’emissione laser.
LEA descrive il livello massimo di radiazione assegnato a
ciascuna classe di rischio. La valutazione del livello di
radiazione emergente consente la collocazione di un
apparecchio nella opportuna classe di rischio.
Aggiornato 2013
39
Classificazione apparecchi laser
Classe 1 laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento
ragionevolmente prevedibili, compreso l’impiego con strumenti ottici per
visione diretta del fascio.
Classe 1M: laser che emettono radiazioni nell’intervallo di lunghezza
d’onda tra 302.5nm e 4000nm, che sono sicuri nelle condizioni di
funzionamento ragionevolmente prevedibili, ma che possono essere
pericolosi se l’utilizzatore impiega ottiche all’interno del fascio.
Classe 2: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di
lunghezza d’onda tra 400nm e 700nm, in cui la protezione dell’occhio è
normalmente assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso
palpebrale. Questa reazione può essere prevista per fornire una
protezione adeguata nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente
prevedibili, compreso l’impiego con strumenti ottici per visione diretta del
fascio.
Aggiornato 2013
40
Classificazione apparecchi laser
Classe 2M: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di
lunghezza d’onda tra 400nm e 700nm, in cui la protezione dell’occhio è
normalmente assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso
palpebrale. Tuttavia l’osservazione dell’emissione può risultare
pericolosa se , all’interno del fascio, l’utilizzatore impiega ottiche( lenti di
ingrandimento,binoculari, ecc…).
Classe 3R: laser che emettono nell’intervallo di lunghezza d’onda tra
302,5 nm e 106 nm, in cui la visione del fascio è potenzialmente
pericolosa, ma il rischio è inferiore ai laser di classe 3B.
Classe 3B: laser normalmente pericolosi in caso di visione diretta del
fascio. Le riflessioni diffuse sono normalmente sicure.
Aggiornato 2013
41
Classificazione apparecchi laser
Classe 4: laser in grado di produrre anche
riflessioni diffuse pericolose. Possono
causare lesioni alla pelle e potrebbero anche
costituire un pericolo di incendio. Il loro uso
richiede estrema cautela.
Aggiornato 2013
42
Valutazione del rischio
Normativa di riferimento CEI EN 60825-1:2003
Nelle installazioni in cui sono in funzione apparecchi laser di
classe 3B o Classe 4 dovrebbe essere designato un addetto
alla sicurezza laser.
L’addetto deve saper:
• classificare i laser
• calcolare la distanza nominale di rischio oculare DNRO
• saper calcolare la densità ottica richiesta e scegliere il
protettore oculare idoneo
• saper redigere procedure operative
• conoscere la normativa vigente
Aggiornato 2013
43
Misure di sicurezza
Uso del connettore di blocco a distanza: il connettore di
blocco a distanza dei laser di classe 3B e classe 4
dovrebbe essere collegato ad un blocco di scollegamento
principale di emergenza, o a dispositivi di blocco dei locali
o delle porte o degli infissi.
Comando a chiave: i sistemi laser appartenenti alle classi
3B e 4, quando non vengono impiegati, dovrebbero essere
protetti da un uso non autorizzato rimuovendo la chiave
dal comando.
Aggiornato 2013
44
Misure di sicurezza
Dispositivo di arresto del fascio o attenuatore:
l’esposizione involontaria di un osservatore alla radiazione
di un apparecchio laser di classe 3B o 4
essere
prevenuta impiegando un dispositivo di arresto o un
attenuatore del fascio.
Traiettorie del fascio: il fascio di ogni apparecchio laser…
dovrebbe essere terminato con materiale diffondente o con
materiali assorbenti. Le traiettorie esposte dovrebbero
passare quando possibile al disopra o al disotto del livello
degli occhi…e dovrebbero, quando possibile, essere al
chiuso.
Aggiornato 2013
45
Misure di sicurezza
Segnali di avvertimento:
Sugli accessi alle aree o agli involucri di protezione che
contengono apparecchi Laser di classe 3B o 4 dovrebbero
essere affissi segnali di avvertimento.
Aggiornato 2013
46
Misure di sicurezza
Riflessioni speculari: si dovrebbe prestare attenzione ad
impedire la riflessione speculare accidentale di radiazioni
dagli apparecchi laser di classe 3R, 3B e 4.
Specchi, lenti e divisori di fascio dovrebbero essere fissati
rigidamente e, durante l’emissione di laser, dovrebbero
essere soggetti solo a movimenti controllati ( evitare
utilizzo di anelli, orologi e bracciali)
Protezione degli occhi: nelle aree di pericolo in cui sono
impiegati apparecchi Laser di classe 3R che emettono
energia con lunghezza d’onda esterna all’intervallo da 400 a
700 nm, di classe 3B e di classe 4 si dovrebbe impiegare
una adeguata protezione per
gli occhi prevista per
lunghezze d’onda specifiche.
Aggiornato 2013
47
Protettori oculari
Le protezioni oculari dovrebbero essere:
• Comode da indossare
• Fornire ampia visuale
• Essere aderenti pur garantendo ampia ventilazione
• Fornire adeguata densità ottica
Aggiornato 2013
48
Misure di sicurezza
Indumenti protettivi: quando il personale può
essere esposto a livelli di radiazione che superino
l’EMP per la pelle devono essere previsti adeguati
indumenti. I laser di classe 4, in modo particolare,
rappresentano un potenziale pericolo di incendio e
gli indumenti protettivi indossati dovrebbero essere
in adeguato materiale ignifugo o termoresistente.
Aggiornato 2013
49
Misure di sicurezza
Addestramento: il funzionamento degli apparecchi laser può
rappresentare un pericolo non solo per l’utilizzatore ma anche per altre
persone poste a distanza considerevole. A causa di tale potenziale
pericolo, al controllo di questi sistemi deve essere posto solo personale
che abbia ricevuto un adeguato livello di addestramento.
L’addestramento dovrebbe includere, ma non essere limitato a:
• la familiarizzazione con le procedure di funzionamento del sistema
• il corretto utilizzo delle procedure di controllo del pericolo, dei segnali di
avvertimento, ecc
• la necessità di protezione personale
• gli effetti biologici del laser sugli occhi e sulla pelle
Aggiornato 2013
50
Rischi connessi all’utilizzo dei laser
Contaminazione atmosferica
a) i materiali bersaglio vaporizzati e i prodotti di reazione
dovuti alle operazioni di taglio, foratura e saldatura con il
laser. Questi materiali possono comprendere amianto
monossido di carbonio, anidride carbonica, ozono,
piombo, mercurio, e altri metalli e materiali biologici
b) i gas provenienti dai sistemi laser a scarica gassosa o dai
prodotti di reazione innescati dai laser, quali bromo, cloro,
acido cianidrico.
c) i gas e vapori di refrigeranti criogenici
d) i gas di assistenza per le interazioni laser-bersaglio come
l’ossigeno
Aggiornato 2013
51
Considerazioni di tipo biofisico
Effetti delle radiazioni laser sui tessuti biologici
Effetti termici
La maggior parte dei danni causati da laser sono dovuti al
riscaldamento del tessuto o dei tessuti assorbenti.
Questo danno termico è generalmente limitato ad una zona
ristretta che si estende ai lati della regione che assorbe
energia ed è centrata sul fascio di radiazione.
Le cellule all’interno di questa zona mostrano le
caratteristiche della bruciatura ed il tessuto risulta
danneggiato principalmente per la denaturazione delle
proteine.
Aggiornato 2013
52
Considerazioni di tipo biofisico
Effetti fotochimici
Questo processo è generato dall’assorbimento di una data
energia luminosa.
Tuttavia, invece di rilasciare energia, la specie chimica
subisce una reazione chimica particolare dovuta al suo stato
eccitato.
Per via di questo meccanismo alcuni tessuti biologici quali la
pelle, il cristallino dell’occhio e in particolare la retina possono
manifestare cambiamenti irreversibili provocati da una
esposizione prolungata a livelli moderati di una radiazione
ultravioletta e di luce con breve lunghezza d’onda.
Aggiornato 2013
53
Cenni di radioprotezione
Aggiornato 2013
54
Le radiazioni elettromagnetiche
“ Trasferimento di energia da un punto dello
spazio ad un altro senza che vi sia movimento
di corpi macroscopici e senza il supporto di un
mezzo materiale.”
c
E = h*
Aggiornato 2013
λ
55
Radiazioni ionizzanti
Si definiscono ionizzanti tutte le radiazioni,
corpuscolari ed elettromagnetiche, dotate di
energia superiore ai normali potenziali di
ionizzazione atomici e molecolari dei tessuti
biologici.
Radiazioni:
• corpuscolari particelle α e β
• elettromagnetiche raggi x e γ
I normali processi chimici all’interno delle cellule del
corpo umano possono risultare perturbati con
conseguenti danni cellulari (effetti somatici o genetici)
Aggiornato 2013
56
Radioattività naturale e
artificiale
Origine Naturale:
Raggi cosmici
e radionuclidi presenti nella crosta
terrestre o Radon
Origine Artificiale:
Radio farmaci
Radioterapia
Radiodiagnostica
Ricerca
Aggiornato 2013
57
Le sorgenti
Macchine radiogene: sorgenti di radiazioni alimentate
(elettricamente) quali tubi a raggi x ed acceleratori di
particelle
Materiali radioattivi: si dividono in sorgenti sigillate e sorgenti
non sigillate
In merito alla radioprotezione si deve sottolineare che le
macchine radiogene emettono solo quando sono
funzionamento mentre i radioisotopi emettono sempre.
Aggiornato 2013
58
in
I Radionuclidi
La radioattività è un fenomeno fisico che
coinvolge gli atomi di taluni isotopi i quali
hanno la caratteristica di emettere radiazioni in
seguito a trasformazione spontanea dei loro
nuclei.
Es . Uranio 238-235-233
Potassio 40
Trizio
Aggiornato 2013
59
Misura dell’esposizione
I rischio derivato dalla esposizione a radiazioni ionizzanti
è legato a diversi fattori:
- energia della radiazione
- tipo di esposizione (esterna o interna radiotossicità)
- sensibilità dell’organo bersaglio
Dosimetri personali
Aggiornato 2013
60
Grandezze utilizzate in radioprotezione
Dose assorbita
Dose equivalente
Dose efficace
Dose assorbita
Energia media depositata dalla radiazione
in un elemento di volume di massa unitaria.
D= dE/dm
Si misura in Gray (Gy) oppure in rad:
1Gy=100 rad
1 Gy = 1 J Kg-1
Aggiornato 2013
61
Dose Equivalente
Oltre a considerare l’energia depositata tiene conto
anche della diversa radio -tossicità delle radiazioni.
Si ottiene moltiplicando la dose assorbita per un
fattore di ponderazione che dipende dal tipo di
radiazione:
HT,R=wR*DT,R
wR=1 fotoni, ed elettroni
wR=20 per le particelle alfa
Unità di misura Sievert (Sv ) o il rem: 1Sv=100 rem
H= Dose equivalente espressa in Sievert quantità di
energia assorbita da parte
dell’organo irradiato
Aggiornato 2013
62
Dose efficace
Tiene conto della diversa radiosensibilità dei tessuti.
Si ottiene moltiplicando la dose equivalente per un fattore
di ponderazione che dipende dall’organo o tessuto.
E = ΣTwT*HT
– wT = 0. 20 gonadi
– wT= 0.01 ossa e pelle
Unità di misura Sievert (Sv ) o il rem: 1Sv=100 rem
La dose efficace è la grandezza di riferimento per la
valutazione degli effetti biologici di natura stocastica
ovverosia induzioni di tumori e danni genetici.
Aggiornato 2013
63
Organi sensibili
Il cristallino
Le gonadi
Il midollo osseo
Tiroide
Aggiornato 2013
64
La radioprotezione
Aggiornato 2013
65
Particelle α Elevata densità di ionizzazione
schermabili da un foglio di carta o 10 cm di aria molto
energetiche quindi estremamente pericolose in caso
di contaminazione interna
Particelle ß maggiore capacità di penetrazione 4 m
aria e 4 mm acqua ma minore energia bisogna fare
attenzione ai raggi X prodotti per frenamento
Particelle x e γ elevata capacità di penetrazione per
schermarle si devono utilizzare materiali ad elevato
numero atomico e densità es piombo o tungsteno
Aggiornato 2013
66
Fattori di radioprotezione
Il tempo: un contatto limitato nel tempo con la sorgente
radioattiva costituisce un semplice sistema di riduzione
del rischio
La distanza: l’intensità di un campo di radiazioni
diminuisce allontanandosi dalla sorgente
La schermatura: quando non è possibile per necessità
operative diminuire il tempo o aumentare la distanza si
ricorre la schermatura ovvero si interpone tra l’operatore e
la sorgente una barriera
Aggiornato 2013
67
Datore di lavoro
RSPP
DLgs 241/00
E
Successive modifiche e integrazioni
Medico Autorizzato
Esperto qualificato
Aggiornato 2013
68
Esperto qualificato
Persona che possiede le cognizioni e
l’addestramento necessari sia
per effettuare
misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di
carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia
per assicurare il corretto funzionamento dei
dispositivi di protezione sia per fornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a
garantire la sorveglianza fisica della protezione
dei lavoratori e della popolazione.
Aggiornato 2013
69
Medico autorizzato
Medico responsabile della sorveglianza
medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono
riconosciute secondo le procedure e le
modalità stabilite dalla legge
Aggiornato 2013
70
Classificazione ambienti di lavoro
•Zona controllata : ogni area di lavoro nella quale vi è la
possibilità di superare il limite di dose di 6 mSv/anno
• Zona sorvegliata : ogni area nella quale vi è la
possibilità di superare la dose per le persone del
pubblico fissata in 1 mSv/anno,ovviamente oltre il fondo
ambientale
Area di lavoro
Intervallo dose
Zona controllata
6-20 mSv/anno
Zona sorvegliata
1-6 mSv/anno
Aggiornato 2013
71
Classificazione ambienti di lavoro
Le zone sorvegliate e controllate devono essere segnalate
utilizzandola segnaletica definita dalle norme in maniera ben
visibile.
L’accesso alle zone controllate deve essere regolamentato
dall’esperto qualificato.
Materiali radioattivi o radiazioni ionizzanti
Aggiornato 2013
72
Segnaletica
Aggiornato 2013
73
Rifiuti radioattivi
Vanno raccolti in bidoni con caratteristiche tecniche
definite suddivisi:
Solidi
Liquidi
Vials
Per singolo isotopo
E conferiti a smaltitori autorizzati
Aggiornato 2013
74
Classificazione dei lavoratori
La classificazione è compito dell’esperto qualificato.
I lavoratori esposti si dividono in due categorie: A, B.
• Lavoratori di categoria A: lavoratori suscettibili di una
esposizione globale annua uguale a 6 mSv/ anno , con
un limite di 100 mSv in 5 anni consecutivi e con la
condizione che non venga superato il limite di 20 mSv in
un anno solare
• Lavoratori di categoria B: lavoratori suscettibili di una
esposizione globale annua compresa tra 1 e 6 mSv.
Aggiornato 2013
75
I compiti dei lavoratori
a) Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai
suoi incaricati ai fini della protezione individuale e collettiva
della sicurezza
b) Usare secondo le specifiche indicazioni i dispositivi di
sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica
c) Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei
mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica
d) Non rimuovere ne modificare senza averne l’autorizzazione i
dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza
e) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza o che possono compromettere la
protezione e la sicurezza
f) Sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi della normativa
vigente
Aggiornato 2014
76