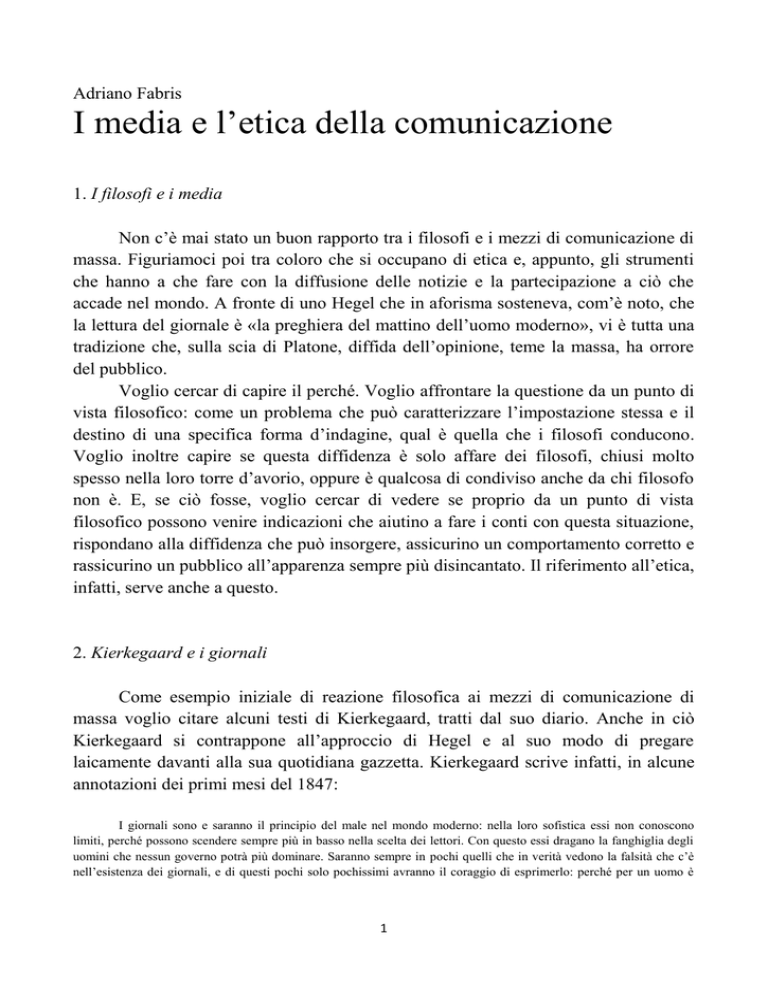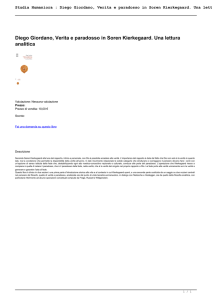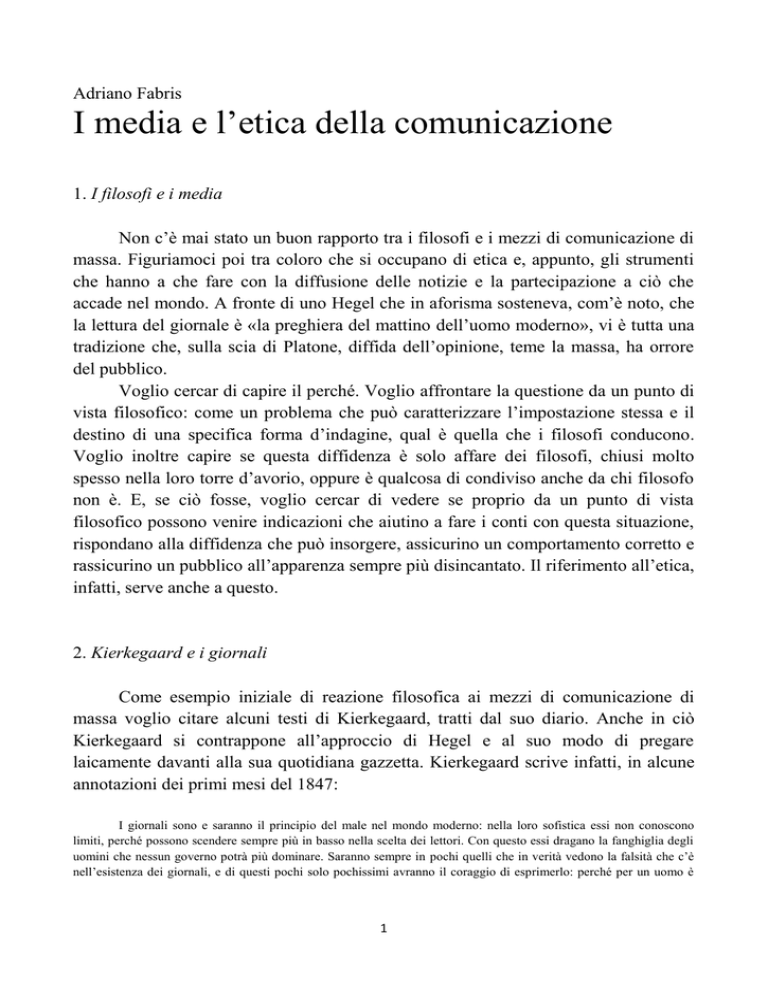
Adriano Fabris
I media e l’etica della comunicazione
1. I filosofi e i media
Non c’è mai stato un buon rapporto tra i filosofi e i mezzi di comunicazione di
massa. Figuriamoci poi tra coloro che si occupano di etica e, appunto, gli strumenti
che hanno a che fare con la diffusione delle notizie e la partecipazione a ciò che
accade nel mondo. A fronte di uno Hegel che in aforisma sosteneva, com’è noto, che
la lettura del giornale è «la preghiera del mattino dell’uomo moderno», vi è tutta una
tradizione che, sulla scia di Platone, diffida dell’opinione, teme la massa, ha orrore
del pubblico.
Voglio cercar di capire il perché. Voglio affrontare la questione da un punto di
vista filosofico: come un problema che può caratterizzare l’impostazione stessa e il
destino di una specifica forma d’indagine, qual è quella che i filosofi conducono.
Voglio inoltre capire se questa diffidenza è solo affare dei filosofi, chiusi molto
spesso nella loro torre d’avorio, oppure è qualcosa di condiviso anche da chi filosofo
non è. E, se ciò fosse, voglio cercar di vedere se proprio da un punto di vista
filosofico possono venire indicazioni che aiutino a fare i conti con questa situazione,
rispondano alla diffidenza che può insorgere, assicurino un comportamento corretto e
rassicurino un pubblico all’apparenza sempre più disincantato. Il riferimento all’etica,
infatti, serve anche a questo.
2. Kierkegaard e i giornali
Come esempio iniziale di reazione filosofica ai mezzi di comunicazione di
massa voglio citare alcuni testi di Kierkegaard, tratti dal suo diario. Anche in ciò
Kierkegaard si contrappone all’approccio di Hegel e al suo modo di pregare
laicamente davanti alla sua quotidiana gazzetta. Kierkegaard scrive infatti, in alcune
annotazioni dei primi mesi del 1847:
I giornali sono e saranno il principio del male nel mondo moderno: nella loro sofistica essi non conoscono
limiti, perché possono scendere sempre più in basso nella scelta dei lettori. Con questo essi dragano la fanghiglia degli
uomini che nessun governo potrà più dominare. Saranno sempre in pochi quelli che in verità vedono la falsità che c’è
nell’esistenza dei giornali, e di questi pochi solo pochissimi avranno il coraggio di esprimerlo: perché per un uomo è
1
addirittura un martirio il rompere con la maggioranza e la diffusione, che poi lo perseguiterà e lo maltratterà senza
1
posa .
È chiaro che qui, ancora una volta, Kierkegaard ha in mente Socrate: il “suo”
Socrate: il singolo che è stato vittima della «Folla». Questo è un primo aspetto del
rigetto da parte di Kierkegaard dei giornali come mezzi di comunicazione di massa.
Essi «sono e saranno il principio del male nel mondo moderno» perché sono «per la
Folla». E la «Folla» è in Kierkegaard «propriamente il bersaglio polemico», come
dice in un'altra nota del diario. Lo ha infatti imparato, di nuovo, da Socrate2: la
«Folla» è «ignorante».
In relazione a questa situazione che cosa fa allora il giornale? Afferma ancora
Kierkegaard:
Esso comunica tutto ciò che comunica (l’oggetto è indifferente: politica, critica, ecc.), come se fosse la Folla, la
3
pluralità a saperlo. Per questo i giornali sono il sofisma più funesto che sia mai apparso .
Qui emerge un altro punto della critica di Kierkegaard ai mezzi di
comunicazione di massa. Il fatto che essi parlino alla massa mette in questione
proprio la loro capacità di dire la verità. Non è qualcosa di occasionale: è la struttura
stessa dei giornali a impedire che essi possano dire la verità. Continua infatti
Kierkegaard:
Ci si lamenta perché qualche volta appare qualche articolo falso: – ahimè, che inezia! No, è l’intera forma di
questa comunicazione nella sua essenza che è falsa. Nell’antichità si lusingava la folla in modo puramente materiale per
4
via di denaro e di panem et circensem…: ma la stampa ha spiritualmente adulato la classe media .
E dunque, continua il filosofi danese: «Il governo non può proibire la parola ch’è un
dono di Dio; ma potrebbe proibire i giornali, perché sono un mezzo di comunicazione
troppo enorme»5. Si tratta di un mezzo enorme per il potere che esso ha. Ma, appunto
perciò, il pericolo che i giornali ci fanno correre è altrettanto enorme. Esso consiste
nel fatto di non poter garantire la verità di quanto essi affermano. E ciò accade
perché, per la loro struttura di mezzi di comunicazione di massa, i giornali stessi
fanno dipendere la verità dalle opinioni della «Folla». Conclude allora Kierkegaard:
1
S. Kierkegaard, Diario 1847-1848, 4, Terza edizione riveduta e aumentata, a cura di C. Fabro, Morcelliana, Brescia
1980 p. 46.
2
Ivi, p. 14.
3
Ivi, p. 45.
4
Ibidem.
5
Ivi, p. 46.
2
Se il criterio della verità fosse il fato di essere alla portata dei più, la verità sarebbe eo ipso tradita poiché i più
abbisognano di un lungo tempo di formazione per riuscire a capire cos’è la verità. Ne segue che quel che i più riescono
a capire è eo ipso una filastrocca. Perciò si può dire: ciò che i più subito e senz’altro possono capire è, distrattamente,
chiacchiera e filastrocca. Di qui l’altra conseguenza: ciò che i più riescono a sapere può essere filastrocca, ma può
essere anche la verità. La verità si trova sempre e soltanto nella minoranza, ma non ne segue che la minoranza sia
6
sempre nella verità .
3. I media e la verità
Fin qui ho riportato ciò che dice Kierkegaard. Si tratta di un Kierkegaard molto
platonico, peraltro. E figuriamoci che cosa sarebbe accaduto se egli fosse vissuto
oggi: nell’epoca in cui mezzi di comunicazione di massa non sono più soltanto i
giornali, ma sono la televisione e tutto ciò che viene veicolato dalla rete. Figuriamoci
che cosa avrebbe pensato della nostra epoca, nella quale non c’è più semplicemente
la “Folla”, ma c’è, appunto, la “massa”: la dimensione di quei “tutti e nessuno” che
viene analizzata da Elias Canetti nel suo Massa e potere, e che è suscettibile di essere
manipolata, anche sul piano delle decisioni politiche che in un regime democratico
sono di sua competenza, attraverso forme comunicative sempre più sofisticate7.
E tuttavia Kierkegaard, nonostante una concezione fin troppo aristocratica del
comunicare, ha ragione almeno su di un punto. Ha ragione nel mettere in evidenza il
nesso problematico tra dimensione pubblica della massa, sua espressione e
validazione, e problema della verità. È certo una questione che riguarda ogni
democrazia. È il tema che aveva motivato, dopo la morte di Socrate, l’intera indagine
di Platone. È un tema, soprattutto, di filosofia della comunicazione.
Esso però dev’essere oggi ripreso in forme nuove. Perché oggi il contesto non è
più quello di una sfera pubblica limitata e controllata, e alla quale solo pochi
potevano avere accesso, come accadeva per la democrazia ateniese. Al contrario: i
mezzi di comunicazione di massa hanno allargato a dismisura la possibilità di accesso
e di partecipazione, senza però allargare in maniera analoga le competenze. Lo
squilibrio tra informazione e competenze è ciò che Kierkegaard, anche, segnalava.
Ma oggi non è più neppure l’epoca di Kierkegaard. Non solo perché, come
dicevo, altri sono gli strumenti di comunicazione di massa presenti e imperanti, non
solo perché essi rendono possibile forme diversificate di partecipazione, più o meno
reale, più o meno virtuale. Ma perché la “classe media”, alla quale Kierkegaard si
riferiva, oggi sostanzialmente si sta estinguendo, almeno in Occidente, e la
comunicazione di massa assume una funzione livellante verso il basso: voláno di una
6
7
Ivi, p. 47.
Cfr. E. Canetti, Massa e potere (1960), trad. it. di F. Jesi, Adelphi, Milano 1981.
3
polarizzazione tra una élite sempre più ristretta e ben poco intellettuale, e la massa,
appunto, il popolo. E poi perché – questo è il vero problema filosofico – la verità può
oggi essere costruita e manipolata in una misura sconosciuta nel passato.
Questo è dunque il problema che può interessare prima una filosofia della
comunicazione e poi un’etica che si occupi criticamente e che metta sotto giudizio i
processi comunicativi. È un problema urgente perché, nella situazione attuale di
overdose comunicativa, cresce il disagio nei confronti della scomparsa della verità.
Cresce pure in coloro che vengono solitamente classificati come “massa”. Vediamo
di capire il perché.
4. Il fondamento della fiducia
La comunicazione si basa sulla fiducia. Questo è un aspetto basilare del suo
funzionamento. Chi ascolta, chi legge, ha infatti una disposizione a credere a quello
che gli si dice. S’affida, primariamente, a ciò che gli viene comunicato8.
Chi parla si presenta immediatamente come credibile e dev’essere in grado di
esibire, a richiesta, le credenziali di questa sua credibilità. Anche quando inganna,
anche quando insulta. Anzi: l’inganno e l’insulto giungono a segno solo se si ritiene
che chi li esprime sia appunto – almeno un poco – credibile. E una tale credibilità può
essere esibita in varie forme: rinviando alla verifica di quel che uno dice; facendo
riferimento a chi può supportare la sua opinione; garantendo addirittura egli stesso, in
prima persona, la veridicità di ciò che dice.
Chi ascolta, dal canto suo, si aspetta che quanto gli viene comunicato gli sia
detto in maniera tutto sommato «leale, corretta e veritiera», come si legge in alcuni
codici deontologici. Anche se, nella realtà, il significato di queste parole è mantenuto
abbastanza nel vago. Intendiamoci: chi ascolta sa che non tutto quello che gli viene
detto è degno di fiducia. Ma sa anche che senza un’apertura preliminare di credito
non si ha comunicazione. In altre parole: sui contenuti che mi vengono trasmessi e
sulle intenzioni dell’interlocutore io posso essere ingannato. E dunque,
concretamente, possono realizzarsi forme non cooperative d’interazione
comunicativa. Ma tali modalità avvengono unicamente entro lo sfondo di un’intesa
possibile e comunque ricercata. Solo se si presuppone questo sfondo, infatti, si può
8
Ho sviluppato più approfonditamente questo tema nel mio Fiducia e verità, La Compagnia della Stampa, Roccafranca
(BS) 2014.
4
ingannare l’interlocutore, fargli del male con le parole che gli si rivolgono, fargli
capire che non c’è interesse né per quello che dice né per lui9.
Emerge dunque uno specifico carattere che contraddistingue il discorso
quotidiano: ciò che, anche, è chiamato “conversazione”. Alla base di essa, infatti, si
trova una volontà tacita di accordo. Vi è l’intenzione di accordarsi sul significato
delle parole usate, sul modo in cui ciò che viene detto dev’essere compreso, su ciò
che l’altro vuole che io intenda, sulla stessa volontà d’intendersi.
Ma non c’è solo questo. C’è anche un’aspettativa ben precisa di verità alla base
di questa fiducia. Comunicando, cioè, mi aspetto non solo che l’altro sia disposto, in
qualche modo, ad accordarsi con me – secondo quel principio etico della solidarietà
che Karl-Otto Apel pone, insieme ai criteri della giustizia e della co-responsabilità,
alla base della sua ricostruzione trascendentalpragmatica della «comunità illimitata
della comunicazione»10 –, ma soprattutto che abbia intenzione di accordarsi con me
sulle cose. In altre parole, non c’è unicamente l’idea di una costruzione comunitaria
dell’opinione condivisa, a cui siamo tutti disposti a partecipare più o meno
attivamente. C’è anche l’aspettativa che tale opinione esprima situazioni ben precise
e trovi riscontro in esse. Su ciò si basa appunto l’aspetto apofantico del linguaggio.
L’alternativa fra i due approcci, fra i due modi di stabilire e consolidare la
fiducia a partire da due modalità di costruire la comunità della comunicazione, è
quella che si apre fra Gorgia e Socrate, ad esempio nel dialogo platonico che prende
il nome dal celebre sofista. Gorgia ritiene che basti l’accordo tra i parlanti per
realizzare l’intesa: dal momento che – stando almeno a quanto ci viene riportato da
Sesto Empirico – egli parte dall’assunto metafisico per cui «nulla esiste; se anche
esistesse non sarebbe conoscibile; se anche fosse conoscibile non sarebbe
comunicabile». Tutto si gioca allora nel rapporto tra gli interlocutori: un rapporto che
Gorgia interpreta immediatamente come un rapporto di forza.
Dal canto suo Socrate, il Socrate platonico, muove dall’idea che solo il
riferimento a qualcosa di terzo, d’indipendente, di precedente ai due o più
interlocutori è in grado di garantire il loro accordo: che è anzitutto un accordo sulle
cose e poi, sulla base di esso, un accordo fra le persone. E tutto lo sforzo di Platone
per giustificare tale soluzione mira a mostrare come in realtà c’è un mondo che esiste
davvero, al di là del mondo sensibile, ed esso può essere conosciuto e comunicato
nella sua verità.
Si veda invece, per un’elaborazione della «tesi anti-cooperativistica» in comunicazione, il saggio di C. Castelfranchi,
«Ma non dica idiozie!» Per un modello delle interazioni verbali al di là della conversazione, in F. Orletti (a cura di),
Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione verbale, Carocci, Roma 2000, pp. 143-70.
10
Cfr. ad esempio K.-O. Apel, Etica della comunicazione, Jaca Book, Milano 1992.
9
5
5. Comunità e verità
Così, certamente, si cerca di dar ragione della fiducia che anima le relazioni
interumane. Anche se – privilegiando in maniera unilaterale la soluzione di Gorgia
piuttosto che quella di Platone, cioè l’accordo condiviso oppure imposto nel gioco
comunicativo, invece l’intenzione che questo accordo sia raggiunto a partire da come
stanno le cose – vengono corsi dei rischi ben precisi. Il rischio della soluzione di
Gorgia è quello che contraddistingue ciò che Aristotele chiamerà la «cattiva
retorica»: vale a dire la subordinazione della verità all’efficacia del discorso. Il
rischio della proposta di Platone è quello di privilegiare unicamente il carattere
semantico del linguaggio: mettendo di conseguenza al centro dell’indagine l’idea di
verità come corrispondenza e trascurando altri aspetti dell’espressione e altre forme
di verità. Il risultato è la disattenzione, che ha predominato in filosofia per lunghi
secoli, nei confronti di altri modi dell’esperienza umana e di altri aspetti del
comunicare: come ad esempio l’aspetto pragmatico.
Ecco perché, fra l’altro, la filosofia è stata incapace di confrontarsi davvero con
lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa e con la nascita dell’opinione
pubblica. A eccezione di Habermas, che ha dedicato all’argomento un ponderoso
volume11, questa forma di comunicazione è stata appiattita sulla retorica e come tale,
ripetendo il gesto di Platone, si è finito per lo più per condannarla. Velleitariamente.
E invece ciò che i mezzi di comunicazione di massa, proprio nella capillare
diffusione dell’oggi, mostrano sono due cose importanti: da un lato, che il bisogno di
fiducia, pur nell’epoca del disincanto, torna sempre a riproporsi; dall’altro, che è
necessario tenere assieme, per creare e mantenere questa fiducia, sia l’aspetto della
costruzione condivisa dei contenuti, sia il riferimento a uno stato di cose. La
comunità comunicativa si basa anzitutto su queste due esigenze. In sintesi:
sull’esigenza di una condivisione della verità, e dunque su di una costruzione
comunitaria di essa; e sull’accordo comune riguardo a ciò che s’impone come vero.
Due, insomma, sono gli aspetti da sottolineare con forza. Da un lato, il fatto
che l’evidenza senza condivisione è insensata. Dall’altro, l’idea che la condivisione,
per suo conto, non basta a produrre la verità.
6. La mediazione dei media
Il problema è dunque quello della mediazione fra questi due livelli – la
costruzione condivisa del senso e la verifica secondo un riferimento analogo – e fra le
11
Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari 1971.
6
esigenze che a essi si ricollegano. Tale problema, riguarda non solo la filosofia della
comunicazione (com’è il caso specifico del problema della verità), ma concerne
soprattutto l’etica: l’etica della comunicazione, appunto. Si tratta di un problema che
è urgente affrontare: proprio perché oggi questa mediazione si verifica in maniera
molto spesso indipendente da noi. Essa viene compiuta, con movenze tecnologiche,
appunto dai media.
I media – lo dice la parola stessa – sono infatti organi di mediazione. Mediano
tra soggetti comunicativi ponendosi come frammezzi, come intermediari necessari
affinché la comunicazione avvenga, oppure risulti opportunamente potenziata. È ciò
che accade con la parola scritta, con il testo (quella scrittura che, guarda caso, aveva
suscitato il rigetto ironico di Platone nel Fedro); è ciò che si verifica con la televisione (la quale media il potere di rapportarsi immediatamente alle evidenze che è
proprio della vista, garantendo la possibilità di guardare lontano); è ciò che si realizza
nel modo per ora più pervasivo attraverso la rete.
Mi piacerebbe analizzare qui le varie forme di mediazione che sono proprie dei
diversi media: il modo in cui esercitano la loro funzione, ciascuno secondo il
dispositivo suo proprio, e i criteri secondo cui contribuiscono a costruire la verità.
Non posso, naturalmente, farlo in questa sede12. Debbo dunque limitarmi a un solo
aspetto. Scelgo perciò, in omaggio a Kierkegaard, la mediazione che è propria dei
giornali: quella che si compie attraverso la trasmissione di notizie e di informazioni.
Una cosa però la debbo dire in generale, nella misura in cui essa vale per tutti i
media. Il fatto che viviamo nell’età della comunicazione significa anzitutto e
soprattutto che la maggior parte di ciò che sperimentiamo – tendenzialmente tutto, nel
mondo virtuale – è appunto mediato da questi strumenti. Se Benjamin parlava di una
perdita dell’esperienza nella nostra epoca di riproducibilità tecnica, tale perdita
riguardava in effetti soprattutto l’esperienza immediata. Ma se questa forma di
esperienza va perduta, ciò che si guadagna è comunque un’estensione, su altri
versanti, della nostra capacità di fare esperienza. A che prezzo? Al prezzo di doverci
affidare non più a interlocutori, ma a strumenti. Al prezzo di avere fiducia nelle
macchine. Al prezzo di essere chiamati – questo è un peso che si fa sempre più grave
– a governare la mediazione.
Il più delle volte non ce ne accorgiamo. L’analfabetismo comunicativo che
caratterizza il nostro tempo riguarda il fatto che consideriamo tutto – anche ciò che ci
viene mediato dai media – come qualcosa di immediato. Sentiamo dire ancora, e
sempre di più: «L’ho visto in televisione»; «L’ho letto su Wikipedia»; «L’ho trovato
su Google». Ciò che sta dietro a questi risultati, e che è tutt’altro che immediato,
finiamo spesso per trascurarlo. Ci fidiamo, e basta. A volte non possiamo farne a
12
Una trattazione più ampia e articolata si trova nel mio Etica della comunicazione, Carocci, Roma 2014.
7
meno. Spesso non siamo in grado di verificare, perché risulterebbe troppo complesso.
La realtà, forse, è scomparsa: come insinua Baudrillard13. La mediazione dei media si
è interposta tra noi e la realtà, e ce la nasconde.
Non sentiamo il bisogno così, se non raramente, di domandarci che cosa ci sta
sotto. A meno che non succeda qualcosa per cui l’ordine delle cose non ci si rivela in
tutta la sua durezza. E allora nascono specifiche domande: le domande dell’etica della
comunicazione.
7. Etica dei mezzi d’informazione
Al giornalista, sia esso della carta stampata o scriva online, viene chiesto di
dire la verità. Ma questo non basta. Gli si chiede di essere obiettivo. Ma in tal modo
gli si domanda qualcosa d’impossibile.
Il giornalista, infatti, non può essere obiettivo. Le cose che vede e su cui scrive
egli le vede e le scrive all’interno di una determinata ottica: quell’ottica che è sua,
inevitabilmente sua. Egli interpreta il mondo, non già lo rispecchia. Non fornisce
mere informazioni, ma, appunto, comunica. Comunica anche qualcosa di sé:
comunica anche la sua prospettiva sul reale. Non può fare altrimenti. Anzi: egli è
tanto più bravo in quanto, con questa sua interpretazione, dà a tutti l’occasione di
vedere i fatti in modo nuovo, ampio, articolato. Il buon giornalista non ci dà solo fatti,
meri fatti, ma anche e soprattutto prospettive sul reale: idee. Il buon giornalista è
sempre, implicitamente, un commentatore.
Tutto ciò è ben noto, certo. Ciò che si chiede al giornalista è di garantire un
accesso corretto alla verità. Ecco perché si vuole che sia obiettivo. Ma allora bisogna
intendersi sulla parola. “Obiettività” non può essere considerato sinonimo di
“neutralità”. È questo, peraltro, ciò che intende la stampa americana quando parla di
objectivity e ne fa un valore: allude al fatto che il giornalista compie nel modo
migliore il proprio lavoro quando ha fedelmente registrato i vari punti di vista su di
un argomento.
Ora: ben sappiamo quanto un tale comportamento sia importante e
deontologicamente corretto. Si tratta però solo di un punto di partenza, perché, come
abbiamo detto, è impossibile non far trasparire la propria ottica. Comprendiamo
dunque il motivo per cui alcune associazioni di categoria in Europa evitano
esplicitamente il richiamo, nei loro codici, ad un’“obiettività” intesa in questo
significato. Ma comprendiamo soprattutto perché negli stessi Stati Uniti si tende da
13
Si vedano i suoi testi raccolti in La scomparsa della realtà, a cura di A. Zuliani, Lupetti, Milano 2009.
8
qualche tempo a privilegiare, rispetto all’objectivity, un’altra categoria: quella di
fairness ovvero di “equità”.
Non si tratta certo di un elemento nuovo. Al principio della fairness si appella
addirittura, nel 1702, l’editoriale di presentazione del primo quotidiano, il «Daily
Courant»14. “Equità” significa assumere un comportamento in cui la particolare
interpretazione adottata è volta non già a far prevalere una parte o a convincere della
giustezza di una tesi, bensì a favorire il dialogo pubblico, il libero dibattito riguardo a
quei fatti sui quali verte l’attività d’informazione. “Equità”, insomma, significa
promozione delle opportunità proprie e altrui: nel nostro caso, delle opportunità di
essere informato e d’informare.
Nell’epoca complessa in cui viviamo, tuttavia, anche queste generali
indicazioni di comportamento non bastano15. Da un lato, perché c’è il rischio che la
rinuncia alla ricerca dell’obiettività finisca per trasformarsi in un alibi per eventuali
comportamenti deontologicamente e moralmente scorretti; dall’altro, perché resta il
problema di motivare adeguatamente la scelta di un atteggiamento di correttezza e di
equità nell’esercizio della propria professione. Ad esempio: se l’obiettività, come
rispecchiamento avalutativo e neutrale dei fatti, è un mito, allora sembra giustificato
tralasciare il reperimento diretto delle fonti, accontentandosi solo delle notizie di
agenzia (di quelle poche agenzie private alle quali si deve il filtro iniziale delle
informazioni). Inoltre si rischia di eliminare il criterio stesso della “verità”: il criterio,
cioè, per il quale i fatti debbono comunque essere rispettati, pur nell’interpretazione
che di essi è inevitabile dare. E allora, rinunciando a ciò, si finisce nel migliore dei
casi per essere rinviati alla coscienza, alla correttezza, all’onestà, alla responsabilità
del singolo giornalista. Secondo l’ormai famosa frase di Hubert Beuve-Mery, il
fondatore di «Le Monde»: «L’obiettività non esiste, ma l’onestà sì».
Questo, però, è ancora troppo poco. Guai, certo, se il giornalista non è onesto e
corretto: ma non basta. Perché non si può scaricare sulla sua buona fede né il compito
di dire il vero, né la motivazione a farlo. Non si può confondere la “verità” (nel senso
del rispetto di come stanno le cose, certamente viste dalla prospettiva del giornalista
che ne scrive) con la “veridicità”. Quest’ultima emerge infatti come un’ulteriore
garanzia, come la possibilità di riacquistare fiducia pur nel mondo mediato delle
comunicazioni di massa: quella fiducia che, come abbiamo visto sopra, è condizione
essenziale di ogni relazione comunicativa.
Che cos’è la veridicità? Anche questo fenomeno riguarda un rapporto di
corrispondenza: ma non fra ciò che dico e ciò che è, bensì fra ciò che dico e ciò che
Cfr. sull’argomento G. Gozzini, Storia del giornalismo, Bruno Mondadori, Milano 2000 e, con taglio polemico, A.
Papuzzi, Il manuale del giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, Donzelli, Roma 1996.
15
Ce lo ricorda C. Sorrentino nel suo volume Il giornalismo. Cos’è e come funziona, Carocci, Roma 2002.
14
9
penso, e di cui sono convinto. Si tratta di una caratteristica che riguarda le persone,
non le cose. E che sta alla base della loro credibilità.
Come fare a garantirla? Non certo con riferimento alla deontologia
professionale. La deontologia è certamente utile per indicare ciò che è corretto e ciò
che non lo è nell’esercizio di una professione: nel nostro caso di quella giornalistica.
Ma non serve a garantire il rispetto delle regole. Bisogna trovare un’altra
motivazione, specificamente etica. Essa può provenire dall’assunzione della
responsabilità specifica che è propria dell’agire del giornalista e della sua
professione, nonché da quelle regole condivise e da quei principî che sono in grado di
dare orientamento alla sua attività. Solo così si può dire non solo che il suo pezzo è
fatto bene, perché efficace e ben scritto, ma che, attraverso di esso, è fatta buona
informazione.
Da che cosa deriva questo senso di responsabilità? Dalla consapevolezza che
solo agendo in questo modo può essere salvaguardata quella fiducia che in generale –
lo ribadisco ancora – è alla base della comunicazione e, nello specifico, rende
possibile lo svolgimento della professione giornalistica. Siamo dunque in grado, ora,
di vedere concretamente, a partire da una motivazione etica e dall’idea di un impegno
in prima persona per la veridicità, in che modo è bene contemperare – nel caso di
studio che sto analizzando: quello della professione giornalistica – fiducia e verità. E
magari, in tal modo, recuperare anche agli occhi della filosofia, al di là di giudizi
come quelli di Kierkegaard, ruolo e valore per i mezzi di comunicazione di massa.
8. Comunità e verità
Il tema della fiducia, dunque, è condizione fondamentale per far sì che vi sia
reale coesione all’interno di una comunità. Ma la fiducia non si può ottenere
solamente attraverso la persuasione. In questo caso si rinuncerebbe troppo facilmente
al rispetto della verità. E la necessità di una coesione comunitaria, a cui pure ad
esempio l’attività giornalistica sarebbe funzionale, sarebbe contrapposta al principio
del dire la verità.
Si tratta di un esito da evitare. Ciò va ribadito tanto più in una fase storica
come quella in cui stiamo vivendo, nella quale spesso la libertà d’informazione, in
vaie parti del mondo, è limitata per motivi più o meno ideologicamente connessi al
principio della ragion di Stato. Ma questo non è affatto ammissibile. Né
politicamente, né eticamente.
Certo: abbiamo visto che una pura e semplice obiettività non esiste. E che
dunque il rispetto dei fatti è bensì qualcosa che viene richiesto, ma più come esigenza
10
che come risultato da raggiungere. Si tratta di un’esigenza che, per il suo nesso
intimo con l’equità, va inquadrata in una più ampia prospettiva di fiducia e di
coesione sociale: che rimanda, cioè, alla costruzione e al consolidamento di una
comunità. Ma tutto ciò non può essere ottenuto con il ricorso a una propaganda
ideologica, pena la perdita dell’aggancio alla realtà e, alla fine, anche della fiducia in
chi media le notizie. L’informazione, nonostante tutto, non è fiction.
Di nuovo, allora: non si può avere comunanza senza rispetto dei fatti. Fin
troppi, certo, sono stati i casi in cui ciò non è avvenuto. Il Novecento sta a
dimostrarlo, proprio con il suo abuso a fini politici dei mezzi di comunicazione di
massa. Ma le vicende del passato – e anche del presente – attestano che la tensione
verso l’obiettività riemerge, a prescindere dal fatto che ogni ideologia tenta di
sopprimerla. Si ripropone, magari, nella forma di un’ideologia contrapposta o, più in
generale, nei modi di un ricorrente desiderio di correttezza, di verità, di onestà, di
apertura ad altre esperienze. Su cui, pure, può nuovamente innestarsi la propaganda.
Ma un’istanza di verità rimane, nonostante tutto, irriducibile.
Proprio così, allora, s’impone quell’esigenza critica che non è solo contro la
realtà, ma è soprattutto al servizio dell’elaborazione di nuove prospettive su di essa.
Proprio così il giornalista si trasforma in garante della mediazione nell’uso del
proprio strumento comunicativo. Proprio in tal modo si pone al servizio della verità e
dà prova di veridicità, meritandosi la fiducia del suo lettore. Agendo eticamente,
dunque, non solo agisce bene, ma fa bene il proprio mestiere. E contribuisce a
costruire e a consolidare la propria comunità. Lo stesso Kierkegaard, alla fine, ne
sarebbe soddisfatto.
11