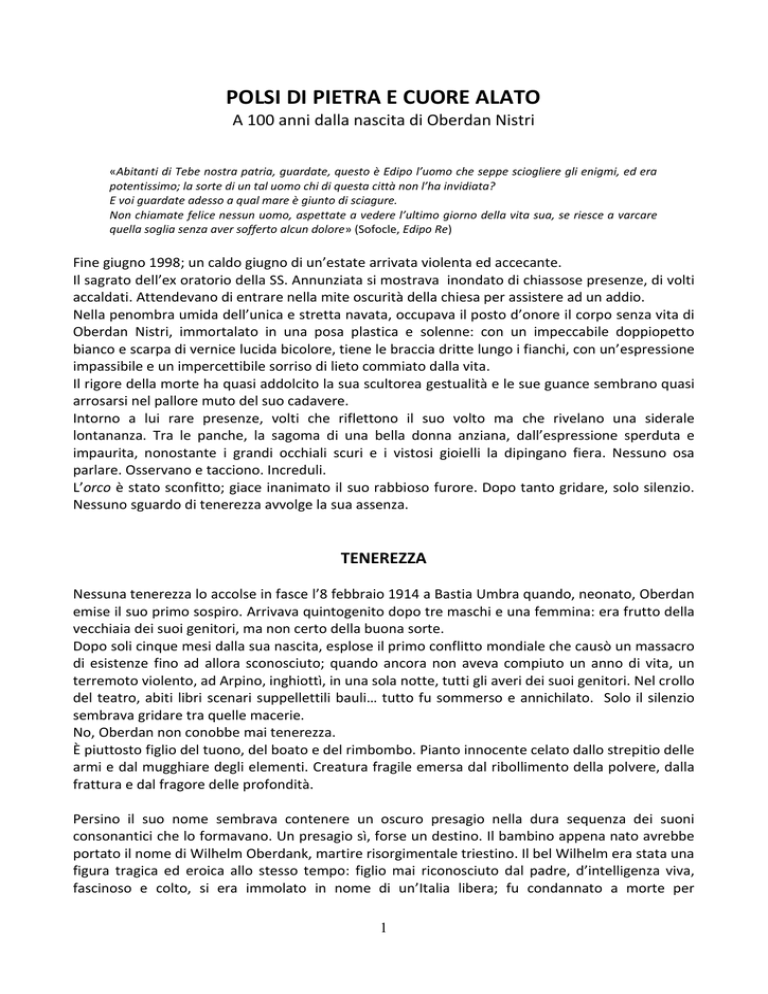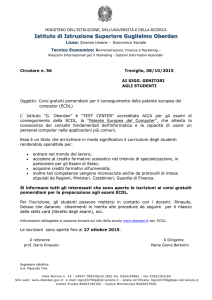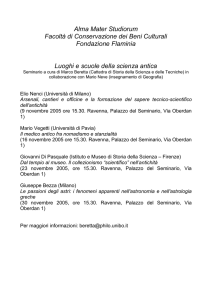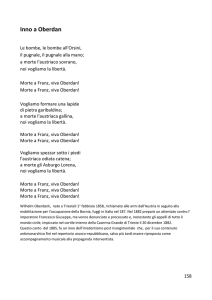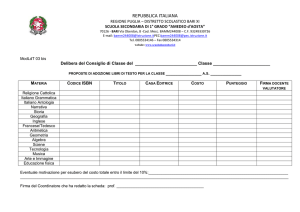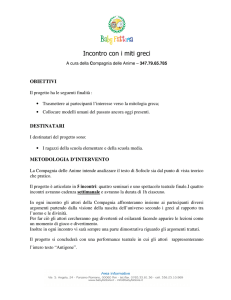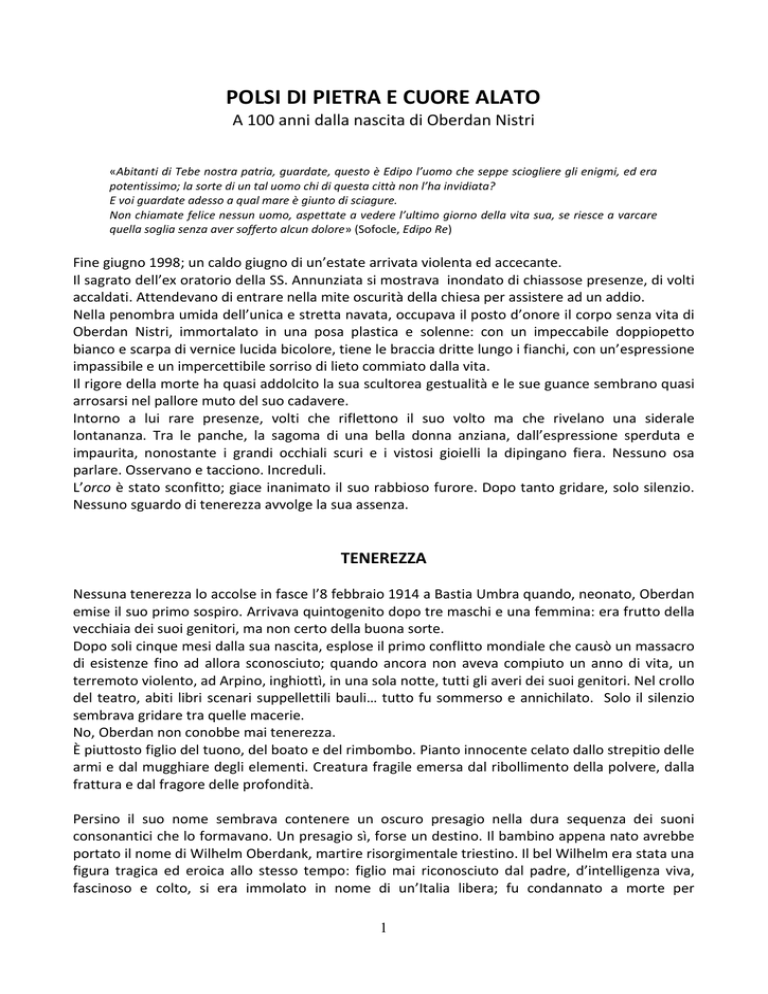
POLSI DI PIETRA E CUORE ALATO
A 100 anni dalla nascita di Oberdan Nistri
«Abitanti di Tebe nostra patria, guardate, questo è Edipo l’uomo che seppe sciogliere gli enigmi, ed era
potentissimo; la sorte di un tal uomo chi di questa città non l’ha invidiata?
E voi guardate adesso a qual mare è giunto di sciagure.
Non chiamate felice nessun uomo, aspettate a vedere l’ultimo giorno della vita sua, se riesce a varcare
quella soglia senza aver sofferto alcun dolore» (Sofocle, Edipo Re)
Fine giugno 1998; un caldo giugno di un’estate arrivata violenta ed accecante.
Il sagrato dell’ex oratorio della SS. Annunziata si mostrava inondato di chiassose presenze, di volti
accaldati. Attendevano di entrare nella mite oscurità della chiesa per assistere ad un addio.
Nella penombra umida dell’unica e stretta navata, occupava il posto d’onore il corpo senza vita di
Oberdan Nistri, immortalato in una posa plastica e solenne: con un impeccabile doppiopetto
bianco e scarpa di vernice lucida bicolore, tiene le braccia dritte lungo i fianchi, con un’espressione
impassibile e un impercettibile sorriso di lieto commiato dalla vita.
Il rigore della morte ha quasi addolcito la sua scultorea gestualità e le sue guance sembrano quasi
arrosarsi nel pallore muto del suo cadavere.
Intorno a lui rare presenze, volti che riflettono il suo volto ma che rivelano una siderale
lontananza. Tra le panche, la sagoma di una bella donna anziana, dall’espressione sperduta e
impaurita, nonostante i grandi occhiali scuri e i vistosi gioielli la dipingano fiera. Nessuno osa
parlare. Osservano e tacciono. Increduli.
L’orco è stato sconfitto; giace inanimato il suo rabbioso furore. Dopo tanto gridare, solo silenzio.
Nessuno sguardo di tenerezza avvolge la sua assenza.
TENEREZZA
Nessuna tenerezza lo accolse in fasce l’8 febbraio 1914 a Bastia Umbra quando, neonato, Oberdan
emise il suo primo sospiro. Arrivava quintogenito dopo tre maschi e una femmina: era frutto della
vecchiaia dei suoi genitori, ma non certo della buona sorte.
Dopo soli cinque mesi dalla sua nascita, esplose il primo conflitto mondiale che causò un massacro
di esistenze fino ad allora sconosciuto; quando ancora non aveva compiuto un anno di vita, un
terremoto violento, ad Arpino, inghiottì, in una sola notte, tutti gli averi dei suoi genitori. Nel crollo
del teatro, abiti libri scenari suppellettili bauli… tutto fu sommerso e annichilato. Solo il silenzio
sembrava gridare tra quelle macerie.
No, Oberdan non conobbe mai tenerezza.
È piuttosto figlio del tuono, del boato e del rimbombo. Pianto innocente celato dallo strepitio delle
armi e dal mugghiare degli elementi. Creatura fragile emersa dal ribollimento della polvere, dalla
frattura e dal fragore delle profondità.
Persino il suo nome sembrava contenere un oscuro presagio nella dura sequenza dei suoni
consonantici che lo formavano. Un presagio sì, forse un destino. Il bambino appena nato avrebbe
portato il nome di Wilhelm Oberdank, martire risorgimentale triestino. Il bel Wilhelm era stata una
figura tragica ed eroica allo stesso tempo: figlio mai riconosciuto dal padre, d’intelligenza viva,
fascinoso e colto, si era immolato in nome di un’Italia libera; fu condannato a morte per
1
impiccagione a soli 24 anni con l’accusa di alto tradimento, diserzione in tempo di pace, resistenza
violenta all'arresto e tentata cospirazione alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe.
Oberdan: sequenza di suoni cupi, pentagramma di un funesto avvenire. Nome alquanto strano per
un neonato!
Se si esclude una morte prematura, anche il destino del nostro piccolo Oberdan era già stabilito
ben prima della sua nascita, anzi forse ancor prima di quella dei suoi stessi genitori: egli sarebbe
stato attore di prosa.
È infatti un autentico “figlio d’arte”: appartiene alla seconda generazione della gens Nistri. Suo
padre, Arturo, era un homo novus delle scene e, come tale, mai del tutto inglobato
nell’aristocrazia dei comici; sua madre, Giuseppina Cresseri, era invece un’autentica blasonata,
discendente da una lunga dinastia artistica (i Feoli e i Cola), osannata per tutto l’Ottocento dai
pubblici dei più importanti teatri d’Italia.
Ancora all’inizio del Novecento, infatti, attori lo si nasceva, non lo si diveniva: era il sangue che ti
scorreva nelle vene a costringerti a solcare le scene, quasi come quella stessa misteriosa forza che
ci imprime addosso ̶ e in modo indelebile ̶ i lineamenti del volto, il colore degli occhi, dei capelli,
la struttura ossea e la massa muscolare.
Chi nasceva nell’anti-mondo dei comici, vi sarebbe rimasto impastoiato per tutta la vita, anche
qualora avesse percepito questa sua appartenenza con rifiuto e vergogna.
Come ogni rampollo dell’oligarchia attorica, Oberdan Nistri si è trovato catapultato sul
palcoscenico ancor prima dell’età della ragione, a rivestire le parti ingenue (immagine 2). E, come
ogni figlio d’arte, ha seguito i suoi genitori di paese in paese, di compagnia in compagnia, senza
sosta.
L’unico momento in cui quest’eterna traversata sembrò per un breve tempo arrestarsi fu nel
febbraio-maggio 1915, quattro mesi nei quali la compagnia Nistri soggiornò a Manciano, paese del
grossetano, forse per riprendersi dallo sfacelo del terremoto. Nessuno di loro, all’epoca, avrebbe
certo immaginato che quel borgo, quasi inesistente persino sulle carte geografiche, avrebbe
invece segnato la storia di tutta la loro famiglia.
Ma ben presto il nomadismo fece risentire il suo richiamo: nel 1917 Arturo Nistri fu scritturato con
Ermete Novelli, Giuseppina Cresseri con compagnie minori. Nel 1918 la troviamo invece prima
attrice nella compagnia delle Sorelle Croce, al fianco di Elettra Croce-Cordiviola.
Liguria, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia… anno dopo anno, mese dopo
mese, Oberdan vaga per l’Italia e non conosce casa né scuola né amici… Conosce solo i teatri e gli
attori, gli attori e i teatri.
Eppure, verso l’età di 8-9 anni, la sua presenza all’interno della compagnia paterna sembra di
colpo scomparire. Forse per necessità economiche, forse per assicurargli quel minimo d’istruzione
divenuta indispensabile, o forse per l’indole eccessivamente indomita di Oberdan, i suoi genitori
decisero di concedergli il “privilegio” di essere educato in una specie di riformatorio di Firenze
gestito da religiosi. E così, ancora bambino, fu sbalzato fuori dalla propria famiglia, sbattuto
lontano da ogni suo affetto, ripudiato da tutti i membri del suo clan.
Lo strappo per lui dovette essere lacerante: l’anarchia dei girovaghi era distante anni luce
dall’austerità spietata di quel luogo; i ritmi vorticosi dei teatranti, cedevano qui il passo a ore che
procedevano lente e monotone, scandite severamente da campanelli e campane.
Lunghi pomeriggi di solitudine.
2
Oberdan percepì fin da subito questa sua condizione come un qualcosa di disumano, dove la
crudeltà e la grettezza sentimentale erano il vero e unico “pane quotidiano” tante volte invocato
nelle preghiere. Quel luogo lo segnò indelebilmente e gli impresse una diffidenza ostile e un’irosa
misantropia verso qualunque essere umano.
Eppure in quest’inferno, in cui tutto gli sarà negato e tolto, in quelle infinite ore di isolamento
forzato, Oberdan avrà il privilegio (davvero sconosciuto ai figli d’arte, non solo digiuni ma, il più
delle volte, affamati di sapere) di studiare la storia, l’arte, la letteratura; di leggere romanzi e
poemi. Impara cosa sia il Bello e desidera sperimentarlo. Tra le centinaia di versi
obbligatoriamente imparati a memoria, il giovane Nistri, dall’animo malinconico, fisserà per
sempre quelli così drammatici, e profeticamente autobiografici, che chiudono il V libro dell’Eneide:
«Troppo al sereno, e troppo a la bonaccia credesti, Palinuro. Or ne l'arena
dal mar gittato in qualche strano lito ignudo e sconosciuto giacerai, né chi
t'onori avrai, né chi ti copra».
Ma ecco che dopo otto lunghi anni di violenze subite, e forse anche inflitte, all’età di diciassette
anni, Oberdan decise di scappare dal “carcere” fiorentino e di far ritorno (siamo nel 1931) nella
compagnia paterna che era prevalentemente formata dai membri della famiglia: sua madre era
prima attrice, la sorella di sua madre (Pia Cresseri) seconda donna, suo padre amministratore e i
suoi due fratelli (Marino e Manlio) primi attori o attor giovani a seconda dell’occorrenza. Mila,
infine, l’ultima nata, era amata e vezzeggiata da tutti, in un clima di tenerezza del tutto
sconosciuto a quella gente tanto dura da risultare talvolta crudele.
L’arrivo di Oberdan in compagnia non fu salutato con entusiasmo: gli occhi mefistofelici del padre,
con quel suo sorriso sarcastico e un ghigno spietato, non si posarono su di lui con amorevolezza,
ma quasi con fastidio e disgusto. Tuttavia egli non rappresentava più una bocca da sfamare, anzi
era piuttosto un attore in meno da pagare.
A giocare poi a suo favore, un aspetto fisico davvero inconfondibile (immagine 3). Come tutti i
Nistri, e come il suo omonimo Wilhelm Oberdank, è alto e biondo, ma di un biondo così chiaro da
richiamare quasi i tratti germanici (cosa piuttosto eccezionale in un’Italia dominata dal tipo
mediterraneo, piccolo di statura e moro). I suoi occhi sono di un azzurro trasparente: due fessure
penetranti ma impenetrabili, che esprimono un non so che di gelido, una lontananza quasi
metafisica. Di contro, la fierezza del suo portamento è paragonabile alla forza del Capaneo
dantesco, gonfio d’ira e di superbo orgoglio nonostante l’eterno supplizio a cui sia stato
condannato.
Oberdan Nistri ha una bellezza moderna, raffinata e massiccia allo stesso tempo: è un Burt
Lancaster ante litteram, con l’eleganza di Rudy Valentino (immagine 8). È il tipico guascone,
istrionico in ogni suo gesto, portatore di una passionalità così incandescente da poterlo assimilare
alla personificazione stessa di ogni moto del cuore; eppure a tratti appare ieratico, come avesse il
mondo a gran dispitto e non venisse toccato dalla prosaicità della realtà circostante.
Per ribadire, in ogni luogo e ad ogni sguardo, la sua appartenenza alla casta eletta dei comici,
indossa abiti bianchi, giacche avvitate e pantaloni alla cavallerizzo e calza stivali in cuoio alti fino al
ginocchio (immagine 4). Passa ore di fronte allo specchio a costruire e rifinire questa sua atipica
figura.
Un tratto, questo della vanità, che sembra essere misteriosamente passato attraverso il sangue:
due suoi illustri antenati, Antonio Feoli e Carlo Cola, erano stati conosciuti dall’intero mondo
teatrale per un vero e proprio culto monoteistico dell’ego e della propria bella figura, elegante e
curata.
3
Madre natura, anche in questo caso, aveva stabilito, forse ben prima di ogni sua scelta, quale
sarebbe stato il suo destino: Oberdan – che lo voglia o meno – non potrà essere null’altro che
primo attore.
Eppure, tornato nella compagnia paterna, egli non poté esprimere nell’immediato questo suo
innato protagonismo: se sua madre infatti era l’insostituibile prima donna di ogni serata, primo
attore incontrastato era suo fratello Manlio, consacrato a tal ruolo dalla “regina madre” e quindi
non spodestabile (immagine 5).
Come in ogni società che si rispetti infatti, micro o macro che sia, anche nel mondo dei comici
esisteva, parallelamente alla crescita anagrafica, un vero e proprio cursus honorum rigido e
inflessibile, scandito tappa dopo tappa da un rito di passaggio. Ma ce n’era uno, tra questi riti, che
rivestiva un’importanza fondamentale perché, non solo consacrava “adulto” nell’arte, ma era per
di più irreversibile: era il passaggio al ruolo di primo attore.
Solo tale investitura avrebbe concesso all’artista il privilegio del proprio nome scritto in grande sui
manifesti, la devozione del pubblico che ogni sera accorre ad ammirarlo e a tributargli il suo
affettuoso applauso. Questa incoronazione però, come è facile intuire, non poteva certo essere
accordata a tutti: chi ne fosse rimasto escluso o accettava di rivestire ruoli eternamente subalterni
e cadetti, oppure si vedeva costretto ad abbandonare il suo clan per andare a formare una propria
compagnia, nella quale poter giocare la parte del leader e ricevere così il meritato premio.
Negli anni subito successivi al suo ritorno (1931-37), Oberdan non sembrava però avere nessuna
intenzione di metter su una propria formazione; anzi pareva accettare di buon grado i ruoli da
coprotagonista a fianco del fratello Manlio.
È questo in fondo il periodo della sua formazione artistica, nel quale ogni giorno osserva e impara,
ascolta e imita, sbaglia e corregge i propri errori. In questo lasso di tempo, memorizza migliaia di
battute, legge centinaia di copioni, interpreta decine di personaggi. Manlio è il suo mentore e sua
madre Giuseppina è la stella polare che gli indica la rotta.
Dall’uno e dall’altra apprende le più delicate sfumature della voce, le impennate declamatorie, il
ghigno meschino e la risata magnanima, la nobile postura del sovrano e l’infido strisciare del servo.
Osservandoli, comprende quale sia la formula del loro fascino, quali gli elementi segreti del loro
magnetismo.
Ma soprattutto, nella mitezza accogliente del fratello, Oberdan cerca la tenerezza che gli è
sconosciuta, quella stessa tenerezza che lui implora ogni sera da sua madre, l’opulenta
Giuseppina. Quando può recitare con lei la parte di Roberto ne La Nemica, si lascia accarezzare
dalla sue affettuose parole d’amore e, sulla scena, sprofonda la testa tra i suoi grandi seni caldi. È
solo in quei momenti, nei quali nessuno è se stesso, che egli si sente per pochi attimi nuovamente
amato. Oberdan dunque non ha fretta di andarsene; anzi indugia. Stranamente, non scalpita.
Dopo anni, finalmente, si sente figlio e fratello di qualcuno. E così attende e rimanda il proprio
volo.
LUSSURIA
Come se però un occhio onnisciente sorvegliasse sopra i destini degli uomini e li conducesse per
sentieri a loro sconosciuti, nel 1937, questo suo volo venne di colpo accelerato da un fatto
imprevedibile quanto accidentale.
4
Suo fratello Raoul, da anni lontano dalla compagnia e stabilitosi a Manciano, paese d’origine di sua
moglie, decise d’un tratto di rientrare in arte insieme alla giovanissima e affascinante Elena, da cui
nel frattempo aveva avuto due figlie (Neda e Silva).
Quella che nella mente dei due giovani sposi sembrava presentarsi come la soluzione a tanti dei
loro problemi, si rivelò invece essere la più perniciosa delle scelte.
Forse già il nome della ragazza avrebbe dovuto far presagire le sciagure che, da lì a poco,
sarebbero seguite.
Il sangue nefasto dei Nistri, che aveva avuto principio da un legame incestuoso, da lì a poco
avrebbe contaminato nuove generazioni, in un ordito di colpe ataviche che dai padri ricadono sui
figli e da quest’ultimi si diramano, poi, verso tutte le generazioni future.
Oberdan ed Elena non si erano mai conosciuti prima d’allora: come nella più prototipica delle
trame romanzesche, il loro incontro era stato ritardato dall’esilio coatto di Oberdan a Firenze. Per
dieci anni, Elena non aveva neppure sospettato l’esistenza del bel cognato e mai avrebbe potuto
immaginare che quello sconosciuto le avrebbe sconvolto l’esistenza.
Ma ora che si ritrova spaesata in una nuova vita e in quell’insolita famiglia, a farle compagnia trova
sempre e solo lui, il biondo e ruvido Oberdan.
Oberdan è diverso dagli altri: la gran parte del tempo la vive isolato, a leggere o a dormire.
Quando, durante il giorno, tutti gli uomini della troupe sono sprofondati nei bar fumosi e
maleodoranti dei paesi, a giocare a carte o a biliardo, lui preferisce un’anacoretica solitudine. Non
ama gli umori della folla, né i passatempi della massa, né tanto meno il chiacchiericcio vano degli
uomini.
Ma anche Elena è per lui un animale grazioso e benigno, una creatura accogliente e curiosa,
perché del tutto incapace di porre un confine tra ciò che prova e ciò che manifesta. Elena gli
appare quasi come quella levatrice che, sola, avrebbe potuto ridare vita a quel “bambino” che mai
nessuno in fondo aveva partorito.
E così, passati non più che pochi mesi dall’arrivo di Elena in compagnia, quasi fosse vittima di un
ingannevole gioco di specchi tra realtà e finzione, Oberdan si innamorò della fascinosa cognata
(immagine 6).
Una nuova tragedia stava per avere inizio: una tragedia che vedrà due fratelli odiarsi con una
ferocia mai sopita; bambini che si chiameranno “fratelli” e insieme “cugini”; zii che rivestiranno il
ruolo di padri e padri considerati poco più che lontani parenti. Tutte le trame più torbide del mito
greco sembreranno rinnovarsi nella famiglia Nistri: dalla guerra fratricida di Eteocle e Polinice, ai
confusi legami tra Edipo e i suoi figli, fino all’odiosa figura di Creonte, zio e tiranno, e a quella,
decisamente più sbiadita, del defraudato Menelao.
Ma gli dèi non lasciano mai impunita una colpa e il castigo raggiunse fulmineo il novello Paolo e la
novella Francesca. Oberdan ed Elena vennero ben presto cacciati dalle loro rispettive famiglie e si
ritrovarono di colpo senza più una patria né una casa, in balìa di un destino imprevedibile, e simili
in tutto e per tutto a quei soldati reduci da Ilio, costretti ad errare senza meta per la bizzarra
volontà dei numi.
I due si misero immediatamente alla ricerca di una compagnia nella quale andare scritturati, pronti
ad imbattersi in mostri e sirene, maghe ed incantesimi, naufraghi e terre beate…
Oberdan, scappando, portò via con sé tutto ciò che per un attore era indispensabile: una
calzamaglia e un paio di scarpe vecchie. Niente più. Altro non gli sarebbe stato richiesto; altro non
5
avrebbe potuto permettersi. Ma con sé portava via la propria felicità: quella ragazza mora e dagli
occhi color smeraldo che, prima e sola, gli aveva insegnato la follia dell’amore.
La ricerca della compagnia non fu sull’immediato cosa semplice: si era già in pieno anno comico e il
casellario dei ruoli era già tutto riempito.
Ma la sorte sembrò invece divenire d’un tratto propizia ai due fuggiaschi: anche se solo per
qualche mese (1937), ebbero l’onore di essere accolti come generici nella “paradisiaca” compagnia
del Cavalier Emmanuel Palmi, con prima attrice sua moglie, Bianca D’Origlia, definita con evidente
ammirazione e sagace ironia «la Duse del teatro d’appendice, la Pavlova del teatro parrocchiale, la
Wanda Osiris dei convitti per suore».
Per gli attori dell’epoca, approdare sulle rive della D’Origlia-Palmi rappresentava una vera e
propria “scalata sociale”.
Gli anni 1938-39 videro ancora i due cognati-amanti in fuga dalle loro famiglie e scritturati nella
compagnia diretta dall’attore – e inguaribile casanova - Oreste Cordiviola, figlio della celebre
Elettra Croce, vecchia conoscenza dei Nistri.
Con il Cordiviola, Oberdan batterà i piccoli centri del Nord Italia e in particolare del Piemonte,
dell’Emilia e della Lombardia. Ma la gelosia spinse ben presto Oberdan a lasciare anche il
Cordiviola: non poteva più sopportare quella presenza maschile, fascinosa e senza scrupoli, che
sembrava insidiare quella ragazza per la quale lui aveva sacrificato ogni altro affetto.
Eppure neanche l’amore che Oberdan nutriva per Elena riuscì a sopire, nel suo animo tumultuoso
e talvolta dissoluto, il desiderio di godere di giovani attrici e attricette. Quel ragazzo eremita e
solitario si dimostrò presto un seduttore così folle da fuggire all’inseguimento di ogni illusione e di
ogni promessa di piacere. Ed Elena, la pazza Elena che aveva osato compiere l’atto più criminoso,
lo insegue per ogni dove, ebbra di rabbia e di passione, per ricondurlo ogni volta, un po’
ammansito, a sé e al suo cuore di amante, moglie e madre.
Ma dopo ogni fuga, ogni volta che lei si ritrova sola, lontano da casa, tra nomadi, senza poter
contare su nulla e nessuno, anche il suo amore sembra lentamente, e impercettibilmente,
raffreddarsi ed essiccarsi.
IRACONDIA
«Volevo diventare un pifferaio
stregare il mondo ed ogni sua creatura,
crescere spighe di grano a gennaio,
sfidar la morte senza aver paura »
(Claudio Baglioni, Acqua dalla luna)
Dopo anni di disperazione e fame, l’Italia sembrò finalmente uscire dal baratro in cui era stata
gettata: la fine della guerra aprì per tutti speranze nuove e liberò energie rimaste finora
inespresse.
Oberdan ed Elena, nel 1946, dopo aver vagato attraverso tante compagnie (Verdirosi, De Rosa,
quella del fratello Manlio), decisero di affrontare una nuova esperienza: quella del cinema
E così, per un anno intero, si trasferirono nella Capitale per toccare con mano che cosa fosse
quella tanto decantata Cinecittà che, da lì a pochi anni, avrebbe conteso a Hollywood il primato
della cinematografia mondiale.
Oberdan sembrava possedere davvero tutti i requisiti per poter sfondare: padroneggiava il
mestiere dell’attore come solo chi lo ha succhiato dal seno materno può padroneggiarlo; aveva
6
un’innata eleganza nel portamento, una dizione perfetta, oltre che una bellezza così atipica da
“bucare lo schermo”.
Ma contro di lui, purtroppo, giocava un temperamento troppo irascibile, a tratti altezzoso, che non
gli permetteva in nessun caso di scendere a compromessi, né di confondersi con le folle
scalmanate che, all’epoca, si accalcavano ai cancelli di Cinecittà per tentare, senza alcun talento, la
fortuna. Oberdan, da quella promiscuità, si sentì immediatamente ferito, umiliato, forse
addirittura offeso nella sua dignità di figlio d’arte.
L’ambiente del cinema gli si rivelò fin da subito come un mondo dove l’arte viene continuamente
spodestata dall’astuzia, dall’intrigo e dalla facile disponibilità ad ogni sorta di compromesso.
Vedeva di continuo passargli avanti persone prive di ogni qualità, pronte a millantare doti
inesistenti. Egli, al contrario, ha come una pudica riluttanza ad ostentare le proprie virtù, abituato
com’è a muoversi tra gente che ha avuto modo di apprezzare l’arte di sua madre, di sua nonna e di
tutta la sua schiatta. Il cinema richiedeva duttilità, trasformismo, remissività ai voleri del registapadrone; i suoi ritmi erano veloci, talvolta fulminei: gli interpreti venivano reclutati in pochi istanti,
da sguardi rapidi e spesso distratti e, in quel breve lasso di tempo, bisognava essere disposti a
giocarsi il tutto per tutto.
Oberdan al contrario ha un’indole monolitica, incapace di piegarsi agli ordini e refrattaria alla vita
in società. È autarchico prima ancora che anarchico. Un’inamovibile durissima roccia.
E così, tra insulti lanciati contro registi e produttori, liti furibonde ingaggiate ad ogni provino, dopo
aver mandato in malora tecnici, macchinisti, fotografi e reclutatori di comparse, esclusa una
“particina” in un film con Rossano Brazzi, l’anno romano fu per Oberdan una clamorosa disfatta.
Eppure l’abbandono di quel progetto e il ritorno alle tavole del palcoscenico, non rappresentò per
lui in alcun modo una sconfitta, quanto piuttosto un vero e proprio ritorno all’Eden perduto, un
recupero di sé e della propria dignità. Oberdan rinunciò senza rimpianti a guardare ad un futuro
forse luminoso, per volgersi con orgoglio al passato, a quel mondo ormai anacronistico che era il
“teatro di giro”.
Immediatamente però, proprio come Ercole al bivio, si trovò di nuovo posto di fronte un altro
angoscioso dubbio, quello che da sempre aveva tormentato i suoi predecessori.
Per un verso, avrebbe potuto battere una carriera redditizia da attore scritturato, regolarmente
stipendiato, in tournée nei grandi teatri italiani, al seguito di artisti rinomati. Si sarebbe però
dovuto rassegnare ad essere null’altro che uno sbiadito utilité che, perennemente, vede il proprio
nome oscurato da quello altisonante dei primi attori ed è costretto a leggere sul proprio conto –
nelle recensioni teatrali – niente più che un laconico bene gli altri.
Per altro verso, gli si delineava di fronte una vita intessuta forse di fatica e di stenti, fors’anche di
squallide camere d’affitto e di trattorie scalcinate, ma ogni sera impreziosita dal proprio nome
scritto in grande sul cartellone, osannato da un pubblico che sarebbe accorso ad ammirare lui solo
e la sua arte e a tributare il proprio applauso esclusivamente all’esimio artista Oberdan Nistri. Ma
è proprio in quell’applauso che lui crede sia racchiuso il senso di tutto il suo esistere.
Posto di fronte a tale bivio, Oberdan aveva l’enorme vantaggio di poter guardare al proprio
retroterra famigliare e di rintracciare, proprio lì, la risposta al proprio amletico dilemma: un secolo
prima, il suo più illustre antenato, Carlo Cola, primo attor giovane a fianco delle più fulgide stelle
del teatro italiano di fine Ottocento (da Virginia Marini a Giovanni Emanuel, da Alamanno Morelli
alla Reiter), con un colpo di coda aveva rinunciato a quella gloriosa carriera per vivere l’incanto di
essere lui, e lui soltanto, il Cavalier Carlo Cola, il primo luminoso astro che compare in cielo sul far
della sera. E la medesima scelta l’aveva poi ripetuta sua madre Giuseppina, orgogliosa, fino alla
7
fine dei suoi giorni, del titolo ineguagliabile di prima donna, fosse anche nei teatrini del
Dopolavoro ferroviario.
Nel sangue dei Nistri, dei Cresseri, dei Cola, dei Feoli scorreva l’inesauribile bisogno di non vedere
altro che il riflesso del proprio volto, del proprio “sé” che diviene ̶ nella stanza degli specchi
chiamata palcoscenico ̶ l’universo intero.
Quell’io-mondo che ha condotto i Feoli, i Cola, i Cresseri e i Nistri ad essere da sempre e per
sempre banditi, con irosa superbia, dal mondo dei nessuno.
SUPERBIA
Nel 1948, a San Vincenzo, Oberdan Nistri compì dunque la grande svolta della propria carriera e
imboccò la strada che, in quegli stessi anni, stavano perseguendo la maggior parte dei comici
girovaghi:
decise
di
allestire
un
Carro
di
Tespi
(cfr
Mauro
Ballerini
http://www.canino.info/inserti/antropologia/tespi/)
La compagnia che il Nistri andò formando sarebbe stata di stampo capocomicale: gli attori
avrebbero ricevuto una paga giornaliera, indipendentemente dagli incassi.
Nonostante l’evidente rischiosità economica della scelta, Oberdan ne colse immediatamente
l’aspetto positivo: solo una compagnia capocomicale avrebbe potuto infliggere un colpo mortale al
cuore stesso della guitteria, origine di quel teatro fatto di trucco impreciso, parrucche spettinate,
abiti tarlati, arredamento rimediato e, peggio ancora, di una recitazione strascicata e
declamatoria, enfatica e meccanica. Per tutti gli attori dell’epoca il termine guitto era un’accusa
che rasentava l’oltraggio (cfr. Mauro Ballerini http://www.canino.info/inserti/antropologia/guitti/)
Il divampare di questa contagiosa epidemia, il Nistri l’avrebbe evitato solo assumendosi l’oneroso
ruolo di capocomico, il gravoso privilegio di essere lui il “Papa-re” del suo piccolo impero.
Avrebbe deciso, da solo, senza alcun bisogno di consultare nessuno, le piazze, le scenografie, gli
abiti, gli orari e la durata delle prove. Nella sua compagnia non sarebbero state tollerate
improvvisazioni di nessun genere, né oggetti o vestiario trasandati. Nessun attore sarebbe potuto
salire in scena senza aver affrontato lunghe ore di prove giornaliere e il suo aspetto avrebbe
dovuto essere curato in ogni minimo dettaglio.
Da “capocomico-regista” avrebbe potuto scegliere gli attori secondo criteri rigorosi, cacciarli se
fossero stati impreparati e minacciarli (di toglier loro la paga) se li avesse giudicati di poca volontà.
Nella sua compagnia non ci sarebbe stato spazio per i cani danesi (espressione tipicamente
teatrale per esprimere un pessimo attore).
Eccettuati lui (primo attore assoluto), Elena (prima donna) e Neda (prima attrice giovane),
entrarono a far parte della nuova formazione artisti di antica e onorevole tradizione: da una parte
Jole (seconda donna), Carlo (generico) e Luciano (attor giovane) D’Antoni, ultimi discendenti di una
dinastia affermata fin dai primi dell’Ottocento; dall’altra, Sante (padre nobile), Emilio (primo attor
giovane) e Raffaello Marchesini, anch’essi appartenenti ad una stirpe di comici addirittura
settecentesca; ed infine Tina Croce-Carani (madre nobile), sorella della celebre Elettra e, come lei,
erede dei Croce.
Che la scelta degli attori, da parte del Nistri, fosse stata avveduta, ce lo comprova il fatto che due
dei suoi attori giovani, Luciano D’Antoni ed Emilio Marchesini, ebbero poi una carriera lunga e
ricca di successi, avendo il primo lavorato per più di trent’anni con il Teatro Stabile di Trieste e il
secondo al fianco della Proclemer e di Albertazzi, nel ciclo shakespeariano.
8
Ma oltre che sulla selezione degli attori, in veste di “capocomico-direttore artistico”, Oberdan
avrebbe avuto carta bianca sulla scelta del repertorio: grazie ai suoi studi e alle sue letture,
Oberdan provava un certo disagio di fronte a tutte quelle produzioni di grande successo popolare
ma disdicevoli dal punto di vista artistico. Nella sua compagnia avrebbe cercato di selezionare
opere con un robusto impianto intellettuale ed emotivo, nelle quali non solo la perizia dell’attore
venisse messa alla prova, ma venisse anche stimolata la sensibilità estetica del pubblico.
Il repertorio da lui scelto era variegato e sempre dignitoso. Una parte di esso derivava dal
repertorio storico del grande teatro all’italiana, rimasto immutato nei decenni e ricevuto da lui in
eredità dai suoi genitori, nonni e bisnonni. Pia de’ Tolomei, Il Fornaretto di Venezia, La morte civile,
Il Padrone delle Ferriere, Tosca… erano opere conosciute e amate dal pubblico che attendeva, di
volta in volta, di vederle riproposte per poter giudicare la valentia dei nuovi interpreti messi a
confronto con i precedenti. Un’altra parte del repertorio era invece novecentesca: Niccodemi (de
La Nemica, Scampolo, La Maestrina) e D’Annunzio (de La fiaccola sotto il moggio, Francesca da
Rimini, La figlia di Jorio) le due colonne portanti.
Ma era soprattutto nei drammi basati sul protagonista maschile che il Nistri riusciva a dare il
meglio di sé: si andava dall’Otello al Conte di Montecristo, dal Cardinale de’ Medici a La Cena delle
Beffe, dal Beffardo a Papà Lebonnard…
A Oberdan, però, tutto questo non bastava: voleva visitare anche opere innovative, non tanto
basate sull’intreccio, quanto piuttosto sulla psicologia dei personaggi. Ecco che, in questo suo
progetto di rinnovamento, introdusse due opere piuttosto recenti e assai complesse quali Nozze di
sangue (opera di Garcia Lorca pubblicata a Madrid nel 1933 e arrivata in Italia solo nel 1939) e
L’urlo (di Alessandro De Stefani e F. Ferruccio Cerio, del 1943).
La prima, intessuta di mito e lirica, s’incentrava sulla forza ancestrale del sangue e sullo sgomento
muto che si prova di fronte all’odio che essa produce; la seconda era un dramma intriso di
psicanalisi, sdoppiamento della personalità e schizofrenia. Due opere raffinate, capaci di
affrontare temi inusuali, piuttosto insolite tra i comici itineranti, ma che il Nistri non avrebbe mai
escluso dal proprio repertorio, neppure se questa scelta gli fosse costata un minor incasso e un più
tiepido consenso.
Nel profondo di se stesso, vale la pena ripeterlo, egli è fermamente convinto che, prima ancora di
assecondare il gusto del pubblico, un buon capocomico debba tentare di educarlo quel gusto.
Oberdan Nistri ha infatti una concezione “primordiale” del teatro, che non ammette ostacoli alla
comunicazione tra un attore e il suo pubblico. Crede che non abbia nessuna rilevanza il luogo in cui
ci si trova a recitare: l’arte drammatica possiede una forza così dirompente da superare ogni tipo
di barriera e penetrare all’interno di ogni coscienza. Ad un attore non serve un edificio teatrale:
basta una sedia, un piccolo spazio rialzato e la magia del teatro risorge tutt’intera. Il Nistri non
disprezza nessun pubblico, fosse anche il più sprovveduto, ma al contrario, come se si trovasse
sempre di fronte ad un Gran Giurì Drammatico, in ogni sua messa in scena infonde tutta l’energia
utile a dar voce all’inesprimibile tensione verso la Bellezza.
Nel suo inarrestabile viaggio, il Carro del Nistri sembrava navigare a gonfie vele attraverso la fine
degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta. Mai un forno (termine tecnico che indica la sala
deserta), mai una contestazione; la biglietteria faceva bene (nel gergo teatrale fare bene non vuol
dire null’altro che guadagnare) e l’incasso era tale da permettere il rinnovamento di scenografie e
costumi, oltre che il pagamento della retta mensile di due figli in collegio (e questa sì che era una
straordinaria eccezione per gli attori dell’epoca).
9
Il pubblico sembrava amare la “Compagnia dei Grandi Spettacoli”, ma in modo particolare ama il
primo attore: è Oberdan il demiurgo di ogni serata, il mago che incanta le platee; lui il mattatore,
l’istrione, l’equilibrista sulle intangibili corde della poesia.
Ha una voce calda, capace di penetrare nelle caverne del petto per poi prorompere come una
fragorosa cascata di suoni sordi e gutturali: nel Volo di Icaro di Gabriele D’Annunzio, esulta di
fronte al sogno del folle volo, grida il dolore del padre che assiste impotente alla caduta
precipitosa del figlio, dopo averlo disperatamente chiamato nell’immensità del cielo. La sua voce è
un uragano che scuote fin dalle fondamenta l’animo di chi l’ascolta; come l’onda dannunziana
palpita, sale, si gonfia, s’incurva, rotola, galoppa, intoppa e poi sempre più irrefrenabile «sciacqua,
sciaborda, scroscia, schiocca, schianta, romba, ride, canta, accorda, discorda, tutte accoglie e
fonde le dissonanze acute nelle sue volute profonde, libera e bella, numerosa e folle, possente e
molle, creatura viva.»
Ma questa “creatura viva” che è la sua voce, quando vuole, sa emettere pure note lievi e
carezzevoli, imbevute di una dolente malinconia, di un flebile sogno d’infanzia: a sentirlo
declamare L’aquilone di Giovanni Pascoli – e in particolar modo gli ultimi versi – t’afferra un nodo
alla gola per l’esilità dei suoni che riesce ad emettere, così contrari al suo titanismo wagneriano.
Il suo volto richiama una scultura espressionista (immagine 1), con fonde trapanature,
contrassegnato da un drammatico effetto chiaroscurale: quando digrigna i denti, gli occhi gli si
inabissano dentro le orbite, quasi ne fossero risucchiati; quando invece li spalanca in un gesto di
incontenibile ferocia, la fronte si corruga e s’increspa così tanto da renderlo quasi una maschera
greca (immagine 11).
La sua bocca talvolta assume un’espressione di diabolica perfidia, che si manifesta in
un’impercettibile smorfia a metà strada tra un palese compiacimento verso la propria superiorità
e un altrettanto evidente disgusto verso l’umanità tutta. Nel suo naso dritto ma prepotente, è
impresso lo spirto guerrier ch’entro gli rugge.
Sul palco si muove con impetuosa destrezza (immagine 7): guizza, corre, si getta a terra e poi si
scaglia contro il suo nemico, con il quale ingaggia una lotta a coltello; tanta è la foga dello slancio
che sembra quasi voler attorcigliare il corpo dell’avversario dopo che lo ha afferrato. Altre volte
invece ha un procedere grave, solenne, che da solo riempie l’intero spazio scenico. Svetta austero
sulle altre figure come un titano sovrasta sulle povere creature mortali.
Le sue braccia disegnano larghe gestualità, tipiche del Prontuario delle pose sceniche ottocentesco.
Nell’atto di accusa o di minaccia, il suo braccio si tende con plastica irruenza, vigoroso come quello
di una marmorea scultura ellenistica (immagine 10). Nel ricevere la più funesta delle notizie, il suo
busto si piega tra contrazioni e spasmi sul fianco sinistro dopo aver portato, con enfatica solennità,
l’avambraccio opposto sulla fronte in segno di straziante tormento e indicibile sciagura.
Quando incarna la gelosia di Otello, non pone limiti alla propria passionalità e così rischia di
uccidere sul serio le sue sventurate compagne di scena: con una veemenza a metà strada tra l’arte
e la follia, afferra il collo di Desdemona e, con i suoi pesanti bracciali di bronzo, lo stringe fino a
strozzarla (immagine 9).
Neda, la figliastra, con il viso cianotico e gli occhi sgranati, quasi ogni sera, emetteva l’ultimo fiato
per implorarlo: “Smettetela! Così mi ammazzate.” Ma lui, non potendo accettare
l’inverosimiglianza di una scena, non mollava la sua presa prima di aver pronunciato l’ultima
battuta. Talvolta colpiva Elena, sua compagna di scena, con la spada, ferendola; talaltra,
inscenando La sepolta viva, la scaraventava a testa in giù in una cisterna; nel migliore dei casi,
costringeva Elena-Tosca a gettarsi realmente dal palcoscenico per rendere più credibile il suo
suicidio.
10
Caninamente latra contro chiunque fra i suoi attori commetta, anche solo involontariamente, un
errore d’entrata o una gaffe di scena; contro di lui è pronto a scatenare tutta la sua furia: sempre
fingendo di recitare, lo prende a pugni o a calci di fronte al pubblico, che resta ammaliato da
questa sua interpretazione così superba da far sembrare reale anche la finzione.
Ma da questa sua indole furente non restano immuni neppure gli spettatori: il Nistri non tollera
schiamazzi o risate inopportune in platea e se, per caso, qualche malcapitato si fosse permesso tali
scorrettezze, senza troppe cautele, lui avrebbe smesso di recitare e iniziato a lanciare offese – ma
anche oggetti – verso quel pubblico zotico e vil. Se la rabbia poi non fosse proprio riuscita a
sbollirgli, poteva addirittura scendere dal palcoscenico e andarsene, interrompendo lo spettacolo
a metà.
Chiunque lo conosca, individua in lui un’evidente traccia di follia.
Oberdan non vive la vita vera, ma una vita immaginifica, in cui tutto è solo teatro e recitazione.
I lunghi pomeriggi in attesa dell’apertura del sipario, li trascorre a truccarsi, seminudo, qualunque
sia la condizione climatica. E durante questo interminabile rito, in cui la figlia è costretta a
reggergli lo specchio senza il minimo tremolio, lui prende a narrare, con la sua voce stentorea,
avventure, incontri e scontri della sua vita che, di volta in volta, quasi per magia, si allungano, si
complicano, cambiano di continuo rotta ed epilogo. Dovendo improvvisare storie inesistenti, per
paura di cadere in contraddizione ma volendo ciononostante lasciare stupefatti i propri ascoltatori
in un crescendo di colpi di scena, Oberdan intercala ogni frase con un “è vero!” al fine di prender
tempo e poter inserire nel suo interminabile poema nuove scene e personaggi. E così il povero
uditore, che ben sa dove il racconto abbia avuto inizio ma non ha la minima idea di dove poi possa
andare a finire, istante dopo istante, vede il romanzo che fuoriesce dalle labbra di Oberdan
accrescersi, dilatarsi, salire, montare, lievitare, gonfiarsi, inturgidirsi, fino a che il suo stesso
narratore ne perde il capo e, tra un “è vero!” e l’altro che si fanno sempre più fitti e martellanti,
dimentica il filo della storia che, però, promette di riprendere il giorno successivo.
Per Oberdan tutto è narrazione… tutto è copione, canovaccio.
Sceso dal palcoscenico, la sua figura diviene pallida, quasi evanescente. Oberdan, il gigantesco
Oberdan, nella vita vera, appare quasi un inetto, un goffo personaggio buono a nulla.
Convinto che le mani di un artista non possano in alcun caso sporcarsi con il vile denaro e che un
sacerdote della scena, come è lui, non possa certo curarsi dell’amministrazione o del reperimento
delle piazze, ha del tutto demandato ad Elena tali vergognosi compiti. Lui non sa niente di SIAE,
borderaux, contributi, occupazione del suolo pubblico, registri di cassa… rifiuta di imparare ogni
cosa che non sia palcoscenico. E non sembra neppure darsene pensiero: per lui vivere è recitare e
recitare è vivere. Null’altro.
Neppure gli affetti rientrano tra i suoi interessi. Se per un solo giorno avesse dovuto smettere di
fumare, avrebbe tolto i figli dal collegio: questo è quanto ripete e minaccia di continuo. Oberdan, il
non-amato, sembra a sua volta incapace di amare. Con la figliastra Neda e con il piccolo Mauro è
un padre violento, talvolta spietato. Per qualunque sciocchezza, li prende a calci e pugni, li
mortifica, calpestandone la dignità. Forse, nella sua testa, sono solo comparse di un copione di cui
lui solo conosce l’esistenza… ma questo loro non possono saperlo e, tacitamente, lo disprezzano.
Elena stessa, l’amata Elena, cade sempre più spesso vittima dei suoi attacchi imprevedibili di
rabbia cieca: anche lei, per un nonnulla, viene malmenata, offesa, umiliata… nella vita come sulla
scena. E se per tutti gli altri questo fa un’enorme differenza, nella vita chimerica che Oberdan si è
costruito, tale distinzione è assurda e incomprensibile.
Eppure a poco a poco, forse senza accorgersene, egli rimane sempre più solo, isolato sul suo
palcoscenico sempre più deserto.
11
MIOPIA
La “Compagnia dei Grandi Spettacoli” non solo passa indenne attraverso i primi anni Cinquanta,
ma addirittura sembra promettere un futuro ancora ricco di successi.
Di questo gradimento, si trova traccia persino nella stampa locale, solitamente piuttosto parca nel
tessere elogi alla compagnie itineranti. Per quanto riguarda invece la formazione del Nistri, è
disposta a vantarne non solo il fine gusto artistico, ma anche la cura per la messa in scena e i
costumi, cosa questa che, come abbiamo già avuto modo di dire, era solitamente trascurata dalle
compagnie secondarie.
«L’attrezzato Teatro Carro di Tespi diretto con fine senso artistico dal noto attore
drammatico Oberdan Nistri, continua ad ottenere il più lusinghiero, meritato successo.
Negli interessanti e importanti lavori eseguiti, è stata notata una perfetta interpretazione
da parte di tutti gli attori, principalmente del direttore Nistri, nonché una ammirevole
messa in scena e massima ed elegante proprietà negli abbigliamenti e costumi» (Il
Messaggero dell’Umbria, 29 agosto 1954)
Lo stesso quotidiano riferisce anche del consenso dimostratogli dal pubblico per le buone scelte di
repertorio:
«Le continue, interessanti rappresentazioni drammatiche che vengono date nel Teatro
Carro di Tespi diretto con fine gusto artistico da Oberdan Nistri, sono sempre affollate di
pubblico il quale, con vivi applausi, dimostra il suo compiacimento verso tutti gli attori.
Questo ben affiatato complesso si tratterrà tra noi per qualche giorno ancora e sono in
programma le esecuzioni di altri moderni e gustevoli lavori» (Il Messaggero dell’Umbria, 3
settembre 1954)
Ed infine, rimarcando la buona fama del Nistri e del suo Carro, vi leggiamo:
«Un manifesto murale ci annuncia l’imminente debutto a Gualdo della “Compagnia dei
Grandi Spettacoli” diretta da O. Nistri. Siamo certi che di fronte all’ottima fama che
precede il “Carro” Gualdo saprà ancora una volta manifestare il suo gusto per l’arte
drammatica e per i bravi artisti che la compongono» (Il Messaggero dell’Umbria, 16
settembre 1954)
Tutto, insomma, sembrerebbe andare nel migliore dei modi: il Nistri sembrerebbe aver ottenuto
quello che considerava indispensabile per onorare degnamente se stesso e l’arte teatrale.
Eppure… eppure, intorno a lui qualcosa stava cambiando in modo così repentino e irreversibile, da
non dargli neppure il tempo di trovare un antidoto né una cura.
Il cinema aveva spodestato già in molti settori, e da molti anni, i vecchi teatranti. Aveva tolto loro il
monopolio delle dirompenti passioni, degli intrighi insolubili, del pianto e della facile commozione,
così come la risata liberatoria e farsesca oppure la magia di venire traspostati in luoghi e tempi
remoti.
Ciononostante, per anni, il teatro aveva resistito con un’energia incredibile all’impatto del cinema,
senza mai lasciarsi soppiantare.
Ma negli anni Cinquanta, in Italia, accadde un qualcosa di completamente nuovo a livello sociale e
culturale; fu un terremoto senza precedenti quello che stava per colpire e devastare il mondo dei
comici girovaghi e tale catastrofe si chiamava televisione.
Il nuovo centro di ritrovo, adesso, non è più la sala teatrale o cinematografica, ma è il bar che
possiede l’unico apparecchio televisivo del paese. Il giovedì sera persino la compagnia smette di
12
recitare per vedere Lascia o Raddoppia. I giornali locali, a poco a poco, tralasciano di riferire
dell’arrivo e del successo dei teatranti, presi come sono a magnificare le tante soubrette
dell’ultima stagione televisiva che, con la loro presenza, onorano feste e sagre locali. Le stelline
della TV, personaggi di fama nazionale, vengono osannate nei paesi e riscuotono un consenso
unanime. In quella scatola magica, chiamata televisione, chiunque vi entri diviene per incanto
immediatamente un divo: l’Italia intera attende di vedere sul piccolo schermo il personaggio locale
che avrà l’onore di una manciata di secondi di gloria. È il mondo contemporaneo che sta nascendo,
con i suoi meccanismi pubblicitari e la spettacolarizzazione di ogni sfera dell’esistenza. Un mondo
che cambia con ritmi convulsi e che ogni giorno si rivela diverso e imprevedibile.
In opposizione a questa rivoluzione, troviamo il mondo dei teatranti, caratterizzato dalla lentezza
tipica del mondo antico, da quell’incapacità a rinnovarsi e a riciclarsi in tempi brevi propria di tutti
gli antichi regimi. Ed è forse in tale immobilismo che si annida la debolezza del Nistri e di tutti i
suoi compagni d’arte.
Un ristagno che talvolta sfiorava l’impaludamento: il loro vivere alla giornata, convinti che quel che
era stato per secoli sarebbe continuato a essere per i secoli venturi, immutato ed immutabile, è
stata la loro vera grande colpa. Gli attori girovaghi, nella loro miopia, non hanno saputo
comprendere che un’epoca era definitivamente conclusa e che un certo tipo di repertorio e di
tradizioni (farsa finale, uso del suggeritore, rigidità dei ruoli…) sarebbe divenuto, da lì a poco
tempo, oltre che superato, addirittura ridicolo. Presi com’erano dal dover “mettere insieme il
pranzo con la cena”, non si accorsero di essere ormai esclusi dalla nuova società nascente, fondata
essenzialmente sulla produzione e circolazione di denaro. I comici dell’arte, poveri e austeri sui
loro Carri, erano come un pezzo di Medioevo catapultato nella contemporaneità. Il loro vivere
“per l’arte”, prima ancora che per il guadagno derivante dall’arte, li rendeva, sì, personaggi
romantici, ma inoppugnabilmente anacronistici e destinati a scomparire, proprio come quegli
imponenti mobili dei palazzi padronali considerati in breve tempo inutili e troppo voluminosi per le
nuove case concepite comode e fruibili.
I vecchi attori furono messi alle strette: da una parte, il teatro novecentesco li snobbava come
ruderi superati e fuori dal tempo; il cinema usurpava loro il dominio delle passioni e dei sentimenti
e lo stars system quell’alone di misterioso fascino e seduzione che da sempre li aveva
caratterizzati; dall’altra parte, la neonata televisione svuotava le platee, per riempire i bar e
modificare per sempre il modo di pensare e vivere dell’intero pianeta.
Per loro fu davvero la fine, la morte, l’abisso.
ACCIDIA
«Non ti conosce il dorso della pietra,
né il raso nero dove ti distruggi.
Non ti conosce il tuo ricordo muto
perché sei morto per sempre»
(Garcia Lorca, Lamento per Ignacio Sanchez)
La gran parte dei Carri di Tespi cadrà sotto il peso degli anni, sotto la furia delle intemperie, della
pioggia e del vento.
Quello del Nistri, nel 1957, venne venduto per poche lire come legna da ardere.
Allo stesso modo, senza rimpianti, e dimostrando ancora una volta una scriteriata miopia,
verranno gettati e distrutti abiti di scena, suppellettili, centinaia di copioni, fotografie, locandine.
Intere pagine della nostra storia vennero condannata a scomparire.
13
Gli attori sembrarono incapaci di farsi custodi persino della loro propria memoria, abituati come
erano a rinascere ogni sera, ad ogni spettacolo, e costretti a non accumulare mai pesi superflui,
troppo ingombranti per chi doveva contenere tutto se stesso, e tutta la propria storia, dentro un
baule-armadio.
Con risentimento verso il pubblico e un senso di rabbiosa sconfitta, i vecchi attori sentirono il
bisogno di dare un colpo di spugna sull’intera loro vicenda umana ed artistica.
Dal 1957 al 1959, Oberdan cercherà, ma sempre con minor convinzione, di andare scritturato
presso altre compagnie; ma il suo fin troppo noto “brutto carattere” non gli permetterà mai più di
rientrare nel giro.
Contro la sua dignità d’artista, si vedrà addirittura costretto, per motivi economici, a riciclarsi nelle
vesti di mago o di fachiro, come prestigiatore o indovino. A ingenui pubblici creduloni, annuncerà
di volta in volta “allagamenti della sala” e ogni tipo di sortilegi e predizioni. Ma questo prostituirsi
lo svilisce, causandogli insofferenza e disagio: la dignità non può mai esser venduta. A nessun
prezzo. Per nessun motivo.
Ecco allora che Oberdan decise, suo malgrado, di fermarsi e di far proprio un luogo e una casa:
Manciano, quel paese che lo aveva accolto a un anno di vita, che a suo fratello Raul aveva regalato
una famiglia e a lui il solo vero amore della sua vita, divenne ora il suo ultimo porto.
Da Goldoni in avanti, nessuno della sua gente aveva mai posseduto una casa né potuto vantare un
paese d’appartenenza. Eppure quella che a noi, oggi, potrebbe forse sembrare una rinascita,
rappresentò invece per lui una Messa di requiem, la pietra tombale su tutto ciò che da sempre lo
aveva identificato.
Oberdan, che a quest’epoca è poco più di un quarantenne, ancora bello e vigoroso, inizia invece a
percepirsi come un pezzo inutile tagliato fuori dall’esistenza, quasi come un aborto tragicamente
cosciente di non esistere più. A lui, come a molti dei suoi compagni d’arte, sarebbe stato richiesto
di reinventarsi daccapo, quasi come se la vita precedente non fosse stata altro che un sogno o un
incubo.
Ma lui proprio non riuscì a rassegnarsi al pensiero che non solo la sua carriera fosse finita, ma
l’intero mondo che lo aveva generato, cresciuto ed allevato, fosse scomparso nel nulla e… per
sempre.
Non poté accettare l’idea che non ci sarebbe mai più stato, in nessun luogo, un Carro di guitti
pronti a “metter su banco”. Tra sé andava ripetendo, quasi come un monito inconsapevolmente
accolto, quei versi imparati tanti anni prima nelle ore della sua adolescenza:
«Troppo al sereno, e troppo a la bonaccia credesti, Palinuro. Or ne l'arena
dal mar gittato in qualche strano lito ignudo e sconosciuto giacerai, né chi
t'onori avrai, né chi ti copra».
Una nebbia fitta scese sulla sua vita e ne ingrigì i singoli giorni. Come impaludato in un mondo
d’ombre, perse a poco a poco il senso del vivere.
Talvolta poi, all’interno della sfera opaca nella quale si era volontariamente rinchiuso, eremita nel
deserto della routine, penetravano echi lontane, frammenti di notizie circa la sorte dei suoi tre
fratelli. Loro avevano osato continuare a battere la strada dell’arte, ma il loro destino non era
certamente meno tragico del suo: Mila si era ridotta a recitare nei matinée di fronte a scolaresche
che deridono lei e il suo vetusto repertorio; Marino, ormai essiccato nella sua magrezza, si era
addirittura venduto ai fotoromanzi di Grand Hôtel; e Manlio – quell’ideale a cui Oberdan per tutta
la sua giovinezza aveva guardato con tacita devozione – era invece a Roma a “fingere” di recitare
insieme al cavalier Palmi che, ottuagenario, si ostinava a impersonare la parte di Romeo nel
14
teatrino umido e maleodorante di Borgo Santo Spirito, noto a tutta la Capitale per il suo
inesauribile serbatoio di patetiche e lacrimevoli vite di Santi e Martiri.
Oberdan, guardando alle sorti dei suoi tre fratelli, sentiva inasprirsi la rabbia e la sconfitta. Per se
stesso forse non provava nemmeno più rimpianti, ma quelle immagini desolanti gli creavano un
cupo sgomento verso un mondo ormai marcescente e decomposto.
Rispecchia se stesso nelle loro sconfitte.
Eppure, irriducibile, Oberdan decise di continuare a recitare, nel suo privato, la parte del primo
attore: abito bianco in ogni occasione, eleganza impeccabile nelle movenze e timbro di voce
perennemente baritonale. Nel suo immaginario palcoscenico, nessuno avrebbe osato deriderlo.
Apparentemente mai sconfitto, si rassegnò ad essere null’altro che la maschera di se stesso, una
maschera però così vera da coincidere, in tutto e per tutto, con il suo vero volto, con la sua più
genuina essenza.
A chi fosse stato estraneo a tanta complessità, il Nistri poteva apparire pososo e artefatto. Era
assolutamente autentico in quella sua camminata impostata, nella rigidità della sua schiena dritta,
oppure quando, seduto al bar del paese, poneva due dita sotto il mento e sembrava quasi
attendere il ritratto di un pittore. Per lui, innaturali, erano piuttosto gli atti quotidiani, i gesti
scontati, la banalità del vivere. Innaturale era la vita vera.
A guardarlo attentamente, mostrava un impercettibile ghigno verso le bassezze degli uomini e una
fiera rabbia contro la meschinità del teatrino mondano, fatto di frasi fatte, di sorrisi impostati e di
lacrime finte.
Oberdan, nonostante il suo perenne travestimento, è di una disperata autenticità: considera la
parola come la rivelazione più sincera dell’animo umano e ne rifiuta ogni mistificazione. Non si
concede una sola minima espressione che non sia pienamente conforme al suo pensiero.
Se ne sta volentieri in disparte, con il suo repertorio di pose e atteggiamenti, per non venir mai
confuso con quei “piccoli bricconi” che vivono per ingannare sé e gli altri, inconsapevolmente
contraffatti, ingenuamente alterati, furbescamente ipocriti.
Strascicata così per quattro lunghi decenni, tra le monotone vie di un minuscolo paese, si è
protratta la storia del Nistri: una storia ormai sbiadita, senza più odore né sapore.
Un impalpabile soffio di un inconsistente alito di vento.
Poi una crudele malattia gli ha sottratto, in breve tempo, persino la memoria e il movimento e la
dignità: aggrappato maldestramente ad altri, si è ridotto ad essere un vecchietto smemorato, dai
movimenti stentati e dalla parola che incespica tra i denti. Nei rari momenti di lucidità, invoca la
morte, ma con voce fioca e irriconoscibile.
Fine giugno 1998; un caldo giugno di un’estate arrivata violenta ed accecante.
Nell’umida penombra della SS. Annunziata, Oberdan è ancora lì, immobile.
Lo sarà ormai per lunghissimo tempo, finché di lui non resterà che pulvis, cinis… nihil.
Non c’è mano che si posi teneramente sul suo volto, non un volto che si contragga per il dolore
della perdita. Pochi osano addirittura avvicinarlo: temono forse che il gran cagnaccio possa
risvegliarsi. Nessuna pietà li muove verso di lui.
Giace solo, sprofondato in quella stessa solitudine che forse lo aveva accompagnato dal suo primo
vagito. Non vi è per lui sguardo di madre né sorriso di donna; non vi è il calore di un abbraccio. Tra
le panche, in lontananza, la sagoma di una bella donna anziana che, nascosti i suoi occhi color
smeraldo dietro grandi occhiali scuri, smarrita non riesce a piangere.
Solitudine immensa.
Il figlio del tuono, del boato e del rimbombo, emerso dal ribollimento della polvere, dalla frattura e
dal fragore delle profondità «ormai dorme senza fine./ Ormai i muschi e le erbe/ aprono con dita
15
sicure/ il fiore del suo teschio./E già viene cantando il suo sangue:/vacillando senz’anima nella
nebbia»
Tuttavia sorride: la vita non potrà più infierire sopra di lui.
Solo una carezza di madre, che ancora tarda ad arrivare, gli fa temere di esser vissuto davvero
troppo a lungo.
«O morto giovinetto,
anch'io presto verrò sotto le zolle
là dove dormi placido e soletto...
Meglio venirci ansante, roseo, molle
di sudor, come dopo una gioconda
corsa di gara per salire un colle!
Meglio venirci con la testa bionda,
che poi che fredda giacque sul guanciale,
ti pettinò co' bei capelli a onda
tua madre... adagio, per non farti male.»
16