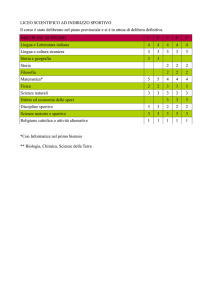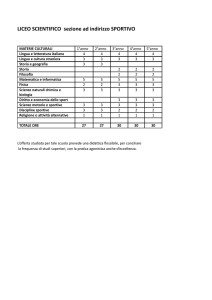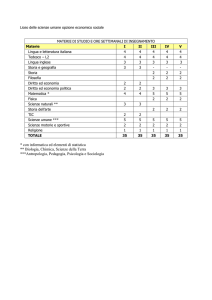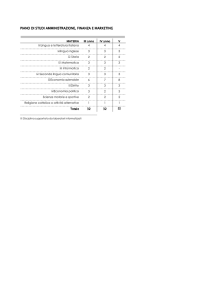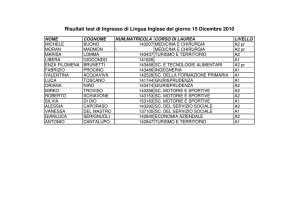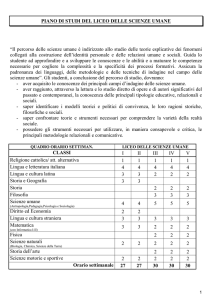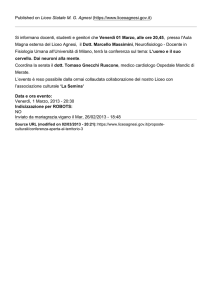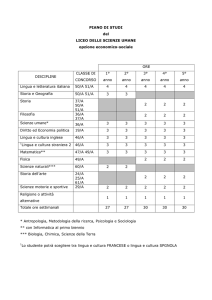Programmazione Finale per classe
1 di 47
Classe 4A LICEO
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Indirizzo
Anno scolastico 2014/2015
1. Programmazione svolta
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
2 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa ROSSIN MARIA ELISABETTA
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
Il livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari è nel complesso buono: gli alunni, ciascuno secondo la
sensibilità e attitudini personali, sono nelle condizioni di analizzare, nelle prove orali e scritte, testi letterari
pertinenti agli autori e ai periodi studiati, evidenziando le peculiarità tematiche e stilistiche, stabilendo
collegamenti fra autori e testi diversi, operando connessioni interdisciplinari fra storia letteraria e altre
discipline. Tutti sono in grado di rielaborare i contenuti in modo logico ed organico e di svolgere un’analisi
adeguata per rilevanza di contenuti, forma espressiva e per apporto critico originale e personale: i livelli di
competenza raggiunti sono stati misurati sull’intera scala decimale.
Conoscenze
Gli alunni hanno acquisito una visione fondamentalmente completa dei fenomeni letterari propri dell’età
rinascimentale, del Barocco, dell’Illuminismo e dell’età preromantica e neoclassica; sanno individuare i
movimenti fondamentali e le personalità di maggior rilievo anche attraverso l’esperienza sui testi.
Competenze
Gli alunni sono in grado di stabilire connessioni intra-disciplinari tra i diversi momenti della storia letteraria
oggetto di studio; tra gli autori e i movimenti analizzati; con altre discipline, attraverso coordinate temporali e
tematiche.
Capacità
Gli alunni sanno rielaborare i contenuti in modo logico-consequenziale, facendo uso di strumenti espressivi
adeguati. Sono in grado di condurre un’analisi del testo sia sul piano dei contenuti che su quello stilistico,
evidenziando i più evidenti legami e le principali differenze fra vari autori e movimenti. Conoscono le
strutture caratterizzanti l’analisi del testo ed il saggio breve.
1.1 Conoscenze
1.2 Competenze e capacita
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
TRIMESTRE ( inizio attività didattiche – 23 Dicembre)
L’età del Rinascimento: le strutture politiche, economiche e sociali, i centri di produzione e diffusione
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
3 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
della cultura; i gruppi intellettuali ed il pubblico; i generi letterari
Il rapporto con la Classicità: imitazione ed emulazione; il Canone letterario
Baldassarre Castiglione: la lingua cortigiana e il perfetto cortigiano. Letture antologizzate da “Il
cortegiano”
Ludovico Ariosto: formazione culturale ed il rapporto con il potere. La corte estense
Le Satire: presentazione dell’opera e confronto con i modelli (Orazio e Giovenale). Lettura e
commento della Satira I; riflessione su alcuni passaggi della Satira II e III
Ariosto, dalle Rime, "Oscuro, secreto e fidel porto", analisi e commento
L’epica cavalleresca tra 1400 e 1500: miti e valori
Matteo Mattia Boiardo: biografia e produzione letteraria. Valori cavallereschi e umanistici
nell’Innamorato; lettura, analisi, commento del Proemio; lettura e commento del "duello di Orlando e
Agricane", I, XVIII, 34-36, 39-48
L’Orlando furioso: l’inchiesta fallimentare (quete) ed il movimento circolare;
le tecniche narrative dell’ entrelacement e della digressione
Lettura, analisi, commento del Proemio (cfr. con Boiardo); Canto I; Angelica e Medoro; Canto XIX,
ottave 33-36; Canto XXIII, ottave 102-136; la follia di Orlando
Riflessione sul fantastico e sulla magia nei poemi epici cavallereschi
La letteratura nell’Età della Controriforma; il nuovo profilo dell’intellettuale
Tasso: il contesto, la vita
Tasso, Aminta. Lettura e commento dell’ Atto I, scena II, vv. 472-516; vv. 534-61 (il coro)
Dalla Gerusalemme Liberata alla Gerusalemme Conquistata; lettura, analisi, commento de: il
Proemio; "La maga Armida" IV, 29-36; V, 64-70; "Il giardino di Armida"
Il pensiero politico nel Cinquecento: teoria e prassi politica
Niccolò Machiavelli: biografia e opere. Tra Repubblica e Principato
Machiavelli e Cicerone: affinità e divergenze nel pensiero politico
Riflessioni sulla verità effettuale, la fortuna e le virtù dell’uomo politico (lettura integrale de “Il
Principe”)
Analisi e commento della "Lettera al Vettori del 10 Dicembre 1513"
PENTAMESTRE (7 Gennaio – conclusione anno scolastico)
L’Età del Barocco e della scienza nuova: quadro socio-politico-economico
Il Seicento: generi e finalità della Letteratura. Il ruolo del letterato
La lirica barocca: Marino, i Marinisti; l’antipetrarchismo
Lettura, analisi, commento di: Ciro di Pers, “Orologio da rote”; Marino, “Donna che cuce”; “Onde
dorate”; marinisti: analisi e commento di "Bella schiava"; "Per i pidocchi della sua donna"
Quadro storico, politico, sociale ed economico dell’Europa nel 1700
Il Settecento e la letteratura: intellettuali e pubblico in Italia
L’Arcadia: le dispute estetiche e letterarie
L’Europa e l’Illuminismo; caratteri distintivi dell’ Italia (L’Illuminismo a Napoli e l’Illuminismo
lombardo)
Riflessione sul mito del buon selvaggio (assolutismo e relativismo culturale)
L’Illuminismo milanese. L’Accademia dei Pugni, I Verri ed il Caffè
C.Beccaria, “Dei delitti e delle pene”: lettura critica dell’Introduzione e cap. XVI (tortura e pena di
morte)
Il secolo del teatro: le caratteristiche del teatro barocco in Europa
Moliere: la comedie italienne. Dalla commedia dell’arte alla commedia di carattere
La commedia dell’arte (breve excursus sulla storia del teatro)
Goldoni ed il "cauto illuminismo"
La riforma del teatro: Carlo Goldoni (Mondo e Teatro)
Letture antologizzate da “La Locandiera”
Giuseppe Parini: biografia e produzione letteraria
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
4 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Parini, le Odi: confronto con i modelli. Il progressismo moderato di Parini, Lettura, analisi, commento
de “La salubrità dell’aria”
Parini: presentazione de "Il Giorno". Il Precettor d’amabil rito; il "giovar dilettando"
Da “Il Giorno”: lettura, analisi, commento di “Alla Moda”, introduzione; “Il Mattino I, 1-36”; “Il
risveglio del giovin Signore”; “La vergine cuccia”
L’Età napoleonica: quadro storico
I caratteri del Neoclassicismo. Gli scavi archeologici, la definizione di Bello del Winckelmann.
Il Preromanticismo europeo. La poesia cimiteriale inglese. La sehnsucht
Titanismo e vittimismo
Ugo Foscolo: contesto e formazione culturale. La nuova figura dell’intellettuale e la sua crisi
Lettura, analisi e commento di “Autoritratto”; "A Zacinto"; "In morte del fratello Giovanni"
Presentazione del romanzo epistolare “Le ultime lettere di Jacopo Ortis (di cui la lettura integrale
durante il periodo estivo)
Il programma relativo all’età napoleonica sarà completato l’anno prossimo e soggetto a verifica nella
prima parte del primo periodo
Divina Commedia,
l’Inferno, lettura, analisi, commento del Canto XIII; Canto XXVI; Canto XXXIII; Canto XXXIV
il Purgatorio: riflessione su alcuni nodi tematici. Lettura, analisi e commento del Canto I
Laboratorio di scrittura: attività congiunta al progetto “Il Quotidiano in classe”
-
L’analisi del testo in prosa e poesia. L’apparato retorico
Il saggio breve
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
Per l’insegnamento della lingua e della letteratura italiana si sono adottate strategie e percorsi volti a
rafforzare la padronanza del mezzo linguistico ed una conoscenza sufficientemente articolata del panorama
storico-letterario ed artistico. A tal fine si è ricorso ad essenziali ed insostituibili letture di testi di grandi
autori, tali da suscitare interesse ad ulteriori approfondimenti. Si è manifestata la necessità di perseguire,
secondo precise linee programmatiche (per es., il “laboratorio di scrittura”), obiettivi di consolidamento e
avanzamento nel campo delle competenze scrittorie e delle conoscenze linguistiche e letterarie generali.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
La lezione frontale si è resa criterio metodologico imprescindibile a causa della resistenza di una parte della
classe alla partecipazione fattiva durante la lezione. Si è cercato di arricchire il dialogo educativo facendo
riferimenti alle conoscenze apprese in Filosofia, Storia, Storia dell’Arte e in Letteratura inglese, stimolando
collegamenti interdisciplinari. Sono state svolte letture ed analisi guidate dei testi in prosa e poesia con la
relativa contestualizzazione e commento.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO/ INTEGRAZIONE
Il recupero delle carenze, il sostegno e l’integrazione sono state svolte sempre in orario curriculare con
interventi mirati (esercitazioni in classe, assegnazione e correzione di compiti suppletivi, approfondimenti
individuali, ripasso, ecc…). L’intento perseguito è stato porre gli allievi in condizione di organizzare i tempi e
definire le strategie dello studio individuale con maggior profitto; di curare l’esposizione orale; di svolgere le
prove scritte, nelle diverse tipologie, con maggior sicurezza; di porre attenzione alla forma e alla correttezza
dello scritto, incrementando il personale vocabolario e bagaglio di conoscenze anche attraverso la lettura
integrale di una scelta di romanzi.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
5 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
4. OBIETTIVI MINIMI
LIVELLI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
LIVELLO
BASE
RAGGIUNTO
(voti inferiori alla
Sufficienza )
Motivazione:
NON LIVELLO BASE
(voto 6)
LIVELLO MEDIO
( voti 7- 8 )
LIVELLO avanzato
( voti 9-10)
Lo studente svolge compiti Lo studente svolge compiti e Lo studente svolge compiti e problemi
semplici in situazioni note risolve problemi complessi in complessi in situazioni anche non note,
mostrando
di
possedere situazioni note, compie scelte mostrando
padronanza
nell’uso
delle
conoscenze ed abilità essenziali consapevoli, mostrando di saper conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
e di saper applicare regole e utilizzare le conoscenze e le abilità sostenere le proprie opinioni e assumere
procedure fondamentali.
acquisite.
autonomamente decisioni consapevoli.
OBIETTIVI MINIMI corrispondenti al livello di sufficienza
saper prendere appunti, sintetizzare e schematizzare
saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per poter poi elaborare un testo scritto
ordinato
conoscere gli aspetti salienti del programma progressivamente svolto ( Autori e testi)
saper collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria
saper presentare problematiche con chiarezza e coerenza, anche se limitatamente agli aspetti più
importanti
operare semplici collegamenti, anche interdisciplinari
analizzare i testi operando un inquadramento essenziale degli argomenti, l’identificazione delle forme
metriche e retoriche fondamentali
produrre testi scritti sufficientemente corretti, coesi e coerenti, che dimostrino la conoscenza ed il
rispetto delle principali caratteristiche della tipologia testuale richiesta
esporre senza errori gravi, utilizzando espressioni, parole-chiave ed il lessico specifico della disciplina
5. MATERIALI DIDATTICI
Sono stati utilizzati libri di testo e fotocopie, appunti dalle lezioni, schemi di riepilogo, articoli di critica
letteraria, il Quotidiano in classe, lezioni in Power Point, la Lim di classe.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate almeno due verifiche scritte per periodo, secondo le tipologie A e B dell’ Esame di
Stato. Le verifiche tradizionali sono state integrate da test di controllo sul materiale studiato. Le prove orali
sono state quanto più frequenti possibile, sia nella forma classica dell’interrogazione frontale che in interventi
dal posto richiesti anche per favorire l’approfondimento personale e la revisione delle conoscenze. E’ stato
valutato anche il lavoro personale svolto a casa, nella forma di elaborati scritti (analisi di testi poetici, tracce
di attualità, saggi); sono stati incoraggiati commenti interpretativi dei brani d’autore letti in classe.
Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto della partecipazione al lavoro didattico, oltre che
dell’impegno e della disponibilità all’apprendimento. Particolare peso è stato assegnato alle conoscenze dei
contenuti, alle competenze specifiche di analisi e rielaborazione personale, alla capacità di gestire
autonomamente un approccio critico e trasversale alle tematiche affrontate. Il voto conclusivo ha tenuto
conto dell’interesse dimostrato per la disciplina e dei progressi fatti rispetto alla situazione iniziale. La
valutazione delle prove scritte si è basata sull’utilizzo di una griglia specifica per le diverse tipologie, definita
e adottata dal Dipartimento di Lettere.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
6 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia LINGUA E CULTURA LATINA
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa ROSSIN MARIA ELISABETTA
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
Conoscenze
Gli alunni hanno acquisito una visione sostanzialmente completa dei fenomeni letterari propri della
produzione dall’età di Cesare all’età augustea, individuando i movimenti fondamentali e le personalità di
maggior rilievo, anche attraverso l’esperienza sui testi.
Competenze
Nel complesso gli alunni sanno rielaborare i contenuti in modo logico e critico, facendo uso di strumenti
espressivi appropriati. Sono in grado di condurre un’analisi del testo sia sul piano dei contenuti che su quello
stilistico, evidenziando i più evidenti legami e le principali differenze fra vari autori e generi, con adeguato
riferimento alla letteratura italiana. Arrivano, guidati, ad una corretta comprensione del testo latino ed ad
un’analisi sufficientemente approfondita degli aspetti grammaticali.
Capacità
Gli alunni sono in grado di stabilire connessioni interdisciplinari tra i diversi momenti della storia letteraria
oggetto di studio e tra gli autori e i movimenti analizzati; in sufficiente autonomia operano collegamenti con
le altre discipline attraverso coordinate temporali e tematiche.
1.1 Conoscenze
1.2 Competenze e capacita
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
TRIMESTRE (Inizio scuola – 23 Dicembre)
Introduzione a Cicerone: quadro storico, politico, culturale
Epicureismo e Stoicismo, caratteri generali ed implicazioni.
Cicerone, la vita e la personalità
Cicerone e l'opposizione alla filosofia epicurea; l’ideologia politica
Riflessione sul ruolo politico del saggio e sulla responsabilità civile dell'uomo di cultura
Come si svolgeva il processo nella Roma di Cicerone; gli interpreti ed i meccanismi.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
7 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Cicerone: scopi dell'oratoria (politico e morale); le caratteristiche dell' orator e l'encyclos paideia
Definizione di retorica e suo esercizio nel De oratore
Le orazioni giudiziarie: gli stili oratori
Le Catilinarie
Le opere filosofiche: la filosofia come forma di impegno; l’eclettismo
Cicerone: le opere politiche - il De republica
Il Somnium Scipionis: traduzione, analisi e commento dell’opera integrale
PENTAMESTRE (7 Gennaio – conclusione attività didattica)
Introduzione a Sallustio; breve excursus sulle caratteristiche della storiografia latina in cfr. con la
tradizione greca ed ellenistica
La scelta della storiografia: la funzione dello storiografo e il ruolo dello storico
La scelta della monografia
La rivoluzione di Catilina: la lettura sallustiana e ciceroniana della congiura
Sallustio, letture: De coniuratione Catilinae, LXI, 4-9 (in Ital.); Historiae I, 11 (in Ital.)
Sallustio, i ritratti fisiognomici; il ritratto di Catilina (De coniuratione Catilinae, V, in latino); il ritratto
di Sempronia (De coniuratione Catilinae, XXV, in latino) ; Fulvia e la scoperta della congiura (De
coniuratione Catilinae, XXIII, in italiano)
Sallustio, il ritratto di Giugurta ed il Bellum Iugurthinum LXXXI, 1-4 (in Ital.)
Introduzione all'età augustea: definizione dei caratteri fondanti attraverso la lettura del monumentoemblema: l'Ara Pacis Gli intellettuali e i luoghi della cultura. Il circolo di Mecenate
Individualità e funzione pubblica della poesia
Orazio: il pensiero filosofico e la poesia della misura
Tra etica e autobiografia: le Satire
Sermones II, 6 (la favola del topo di campagna e di città): commento
Le Odi: perle di saggezza universale: traduzione, analisi e commento di: Odi III, 30 (exegi
monumentum); Ode II, 11 (Carpe diem); Ode I, 9 (Vides ut alta); I, 38 (Odio il fasto persiano); Ode II,
10 (Rectius vives, Licini)
Approfondimento sulla metafora epicurea del mare: Lucrezio, naufragio con spettatore (De rerum
natura, II, in italiano)
Le Epistole: testamento di un uomo e di un poeta
I caratteri della poesia elegiaca latina
Orazio, Odi I, 23, Cloe: Traduzione, analisi e commento
Orazio, traduzione ed analisi di Odi I, 5, Pyrra
Virgilio: la vita, le opere, l’ideologia
La poesia bucolica in Grecia e a Roma
Le Bucoliche e le Georgiche; traduzione, analisi, commento della Bucolica I
Virgilio I Bucolica: raffronti con Pascoli (Myricae) e con Leopardi (teoria della visione e del suono)
Incipit Bucolica IV
L’Eneide: poema epico-mitologico; il poema della romanità; il rapporto con Omero; i temi e i
personaggi (Enea, Didone); trama
Lavoro estivo: lettura dei “Libri di Didone”o Elissade
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
Per l’insegnamento della lingua e della letteratura latina, sono stati attivati strategie e percorsi che hanno
contribuito a rafforzare negli allievi una conoscenza il più possibile articolata del panorama storico-letterario,
ricorrendo soprattutto ad essenziali ed insostituibili letture di testi d’autore, tali da suscitare interesse ad
ulteriori approfondimenti. Si è lavorato al recupero e rafforzamento delle competenze di traduzione
attraverso l’approccio diretto ai testi e l’esercizio in classe guidato dall’insegnante.
L’attività didattica è stata svolta principalmente attraverso lezioni frontali (nel proporre un nuovo autore e
nell’inserirlo all’interno del contesto storico-letterario). I brani d’autore sono stati analizzati in classe
dall’insegnante e commentati da un punto di vista contenutistico-formale. E’ stata invece privilegiata la
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
8 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
lezione dialogata quando l’attività fosse rivolta all’analisi critica dei contenuti. Si è cercato di arricchire il
dialogo educativo facendo riferimenti alle conoscenze apprese in filosofia e storia, in letteratura italiana e
nelle arti figurative, stimolando collegamenti interdisciplinari. Non sono mancate riflessioni e discussioni
argomentate su tematiche attuali emerse dalla lettura dei testi.
Il recupero delle carenze pregresse e in corso, il sostegno e l’integrazione hanno fatto parte integrante della
programmazione curriculare: ogni nuovo argomento è stato proposto in modo tale da affinare competenze,
esercitare abilità, apprendere metodi e strategie, in una sorte di continuo ripasso di ciò che è stato ripreso o
definito.Gli interventi di supporto si sono sempre svolti in orario curriculare; così il ripasso, che ha sempre
coinvolto l’intera classe chiamata a prestare particolare attenzione anche nel corso delle interrogazioni.
4. OBIETTIVI MINIMI
LIVELLI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
( MIUR – certificato delle competenze di base e livelli raggiunti)
LIVELLO BASE NON LIVELLO BASE
RAGGIUNTO
(voto 6)
(voti inferiori alla
Sufficienza )
Motivazione:
LIVELLO MEDIO
( voti 7- 8 )
LIVELLO avanzato
( voti 9-10)
Lo studente svolge compiti Lo studente svolge compiti e Lo studente svolge compiti e problemi complessi in
semplici in situazioni note risolve problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza
mostrando
di
possedere situazioni note, compie scelte nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre
conoscenze ed abilità essenziali e consapevoli, mostrando di saper e sostenere le proprie opinioni e assumere
di saper applicare regole e utilizzare le conoscenze e le autonomamente decisioni consapevoli.
procedure fondamentali.
abilità acquisite.
Obiettivi minimi corrispondenti al livello di sufficienza (Latino)
Si richiede di:
saper prendere appunti
(in preparazione alla Terza Prova) sintetizzare in un numero definito di righe gli argomenti storicoletterari con sufficiente competenza
essere in grado di inquadrare gli Autori ed i testi nel relativo contesto storico e culturale
saper individuare specificità di generi, di correnti, di Autori
saper presentare problematiche con chiarezza e coerenza, anche se limitatamente agli aspetti più
importanti
saper individuare le più evidenti relazioni esistenti fra elementi linguistici e letterari latini ed italiani
essere in grado di operare semplici collegamenti trasversali con altre discipline
saper leggere, tradurre e analizzare i testi originali riproducendo le operazioni svolte in classe
dall’insegnante
riconoscere le principali strutture morfo-sintattiche e lessicali
stabilire semplici relazioni tra le nuove e le precedenti acquisizioni
esporre con accettabile correttezza e proprietà di linguaggio
5. MATERIALI DIDATTICI
Oltre al libro di testo, l’attività didattica si è avvalsa di fotocopie e schede fornite dall’insegnante, estratti di
saggi di critica letteraria; si è cercato di utilizzare la Lim presente in classe per reperire fonti letterarie e
documentarie e proiettare testi su cui svolgere esercitazioni e traduzione.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove scritte si sono articolate secondo tipologie diverse: la traduzione (possibilmente di testi di autore
oggetto dello studio letterario), prove di comprensione e analisi di testi tradotti, questionari sulla storia
letteraria. Sono state proposte verifiche sul modello della tipologia B della terza prova dell’esame di stato.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
9 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Le prove orali hanno verificato la conoscenza di autori e testi, la capacità di analisi e di inquadramento
letterario. Nell’intero periodo sono state eseguite almeno due prove scritte e due orali.
Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto della partecipazione al lavoro didattico, oltre che
dell’impegno e della disponibilità all’apprendimento. Particolare peso è stato assegnato alle conoscenze dei
contenuti, alle competenze specifiche di analisi e rielaborazione personale, alla capacità di gestire
autonomamente un approccio critico e trasversale alle tematiche affrontate. Il voto conclusivo ha tenuto
conto dell’interesse dimostrato per la disciplina e dei progressi fatti rispetto alla situazione iniziale. Hanno
contribuito alla valutazione quali occasioni di verifica personale il riepilogo, richiesto agli alunni all’inizio
della lezione, degli argomenti trattati in precedenza; interventi pertinenti e motivati durante l’attività
didattica; approfondimenti ed iniziative personali inerenti al programma in svolgimento.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
10 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia INGLESE 1 LINGUA
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa MONSUTTI GIULIANA
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
In generale, seppur in misura diversificata, la classe ha raggiunto gli obiettivi sotto elencati:
Rafforzare la capacità di interazione in situazioni di vita quotidiana.
Produrre testi scritti adeguati quanto a morfosintassi e lessico.
Sviluppare l’autonomia e la sicurezza nell’attività di conversazione/lettura/comprensione di testi
prevalentemente letterari e storico-letterari.
Acquisire senso critico e precisione nella composizione di commenti tematici.
Sviluppare la capacità di sintesi nella produzione scritta, rispetto ai limiti di parole o righe assegnate.
Comprendere messaggi anche da materiale audiovisivo di una certa complessità.
Esprimersi in modo lineare, senza interferenza, e fonologicamente corretto su argomenti sia quotidiani
sia storico-letterari.
1.1 Conoscenze
CONOSCENZE
Conoscenza dei contenuti grammaticali e strutturali:
Aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di
più immediato interesse
Padronanza degli argomenti grammaticali affrontati durante il percorso liceale finora compiuto
Lessico letterario/artistico/scientifico specifico
Conoscenza dei seguenti contenuti di letteratura:
Partendo dal presupposto che la lettura del testo letterario deve essere considerata centrale e propedeutica
ad uno studio della letteratura che la collochi nel contesto sociale, culturale e storico, sono stati sviluppati i
tratti generali dei vari generi letterari, scegliendo testi accessibili e linguisticamente rilevanti dal punto di
vista della motivazione, del valore estetico, della rappresentatività del genere (periodo che va dal 1600 al
1800.
1.2 Competenze e capacita
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
11 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Le competenze del 2° biennio integrano e ampliano le finalità del 1° biennio e mirano a potenziare i
seguenti aspetti:
COMPETENZE LINGUISTICHE
1. Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti anche su argomenti inerenti la
sfera di interesse di ciascun indirizzo
2. Produrre testi orali/scritti strutturati e coesi per riferire fatti e descrivere fenomeni e situazioni
3. Sostenere opinioni con le opportune argomentazioni
4. Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto e agli
interlocutori
5. Sviluppare una riflessione sul sistema e sugli usi linguistici volta all’acquisizione di una
consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana
6. Riflettere sulle conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della
trasferibilità ad altre lingue
COMPETENZE CULTURALI
1. Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata con
particolare riferimento all’ambito di interesse di ciascun indirizzo
2. Comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse (con priorità per generi/tematiche
motivanti per lo studente)
3. Analizzare e confrontare testi letterari e produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse
(italiane/straniere)
4. Utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche
5. Utilizzare le nuove tecnologie per approfondire argomenti di studio
CAPACITA’
Comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali;
stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla
situazione di comunicazione;
Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell'indirizzo;
Produzione orale: saper riassumere oralmente un testo letterario, storico, scientifico o di attualità
nelle linee essenziali, facendo uso di connettori; riferire nelle linee essenziali opinioni, informazioni
ecc.; riconoscere autonomamente in contesti orali elementi linguistici nuovi e integrare con essi il
proprio bagaglio di conoscenze linguistiche; saper utilizzare in modo appropriato un lessico specifico
di base e saper fornire sinonimi.
Produrre testi scritti di tipo descrittivo espositivo e argomentativo con chiarezza logica e
precisione lessicale; riassumere nelle linee essenziali testi di varia tipologia;
Riconoscere autonomamente in testi scritti elementi linguistici nuovi e integrare con essi il proprio
bagaglio di conoscenze linguistiche; riconoscere alla lettura un genere letterario e individuarne le
caratteristiche.
Riconoscere i generi testuali, letterari e non, e al loro interno le costanti che li caratterizzano;
Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto socioculturale, in un ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani.
Comprendere e interpretare situazioni legate alla comunicazione quotidiana, identificando
l'apporto degli elementi paralinguistici ed extra-linguistici.
Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio;
Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali;
Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni, sia le identità
specifiche.
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
12 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
Facendo riferimento al testo in adozione ”Millennium” vol 1, di Arturo Cattaneo e Donatella De Flaviis, Ed.
Signorelli Scuola, si sono affrontati in maniera specifica gli argomenti di seguito elencati.
UNIT C
History and society
THE RESTORATION AND THE EIGHTEENTH CENTURY
Culture
The restoration
The Restoration:
The French influence
The Glorious Revolution The rebuilding of London
and the last Stuarts
Science and the Royal Society
The Augustan Age
The first Hanoverian kings: The term “Augustan” Neoclassicism
George I and Parlamentary A Belief in order
monarchy
Rational philosophers
George III and the British
The role of women
Empire
The education of the middle class
The novel and the middle class
The literary scene
Writers and texts
The rise of the novel
Daniel Defoe
The need for realism
Robinson Crusoe:
“Robinson and Friday”
The Myth of the Natural Man
TRIMESTRE
The realistic novel
Utopian fiction
The epistolary novel
The picaresque novel
The sentimental novel
Jonathan Swift
Gulliver’s Travels
“Beloved Horses, Hateful Men”
Features of the novel A Modest Proposal
(p161-1639
+ brano su fotocopia
Laurence Sterne (cenni alla vita)
Tristam Shandy (solo p189-190)
UNIT D THE ROMANTIC AGE
History and Society
Culture
The literary Scene
Writers and Texts
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
13 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
The American Revolution
The new colonies
The Romantic Revolution
Romantic poetry
William Blake
(tutto)
PENTAMESTRE
Romantic themes and conventions
First-generarion
Songs of Innocence and of
Romantics
Experience:
The French Revolution (tutto)
Social unrest
“The Lamb”
The “dark” Romantic hero (cenni al
Economic liberalism
Satana di Milton p127-128)
Second-generation
“The Tyger“
Romantics
cenni ai tratti comuni tra William Wordsworth
The Industrial Revolution
Byron, Shelley e Keats
Consequences
of
the
Industrial Revolution
Humanitarian movements
The
emancipation
of
women
Social reforms
Lyrical Ballads:
“I Wandered Lonely as a Cloud”
+ brano su fotocopia da Preface
to Lyrical Ballads
Samuel Taylor Coleridge
+ brano su fotocopia da
Biographia Literaria
The emancipation of women
The Rime of the Ancient
Mariner:
“It Is an Ancient Mariner....… A
Sadder and a Wiser Man He
Rose the Morrow Morn”
+ part 2 tutta, e brano da part 4
su fotocopia
The Romantic Novel
The novel of manners
Jane Austen
The novel of purpose
Pride and Prejudice: “Hunting
for a Husband”
Letture per le vacanze:
Pride and Prejudice di Jane Austen, ed. Black Cat (Livello B2.2)
e/o in italiano, O. Wilde’s The Picture of Dorian Gray e/o E. Bronte’s Wuthering Heights e/o Orwell’s 1984.
Si consiglia inoltre un ripasso delle strutture grammaticali della lingua dal testo Grammar e Vocabulary Trainer, già in possesso degli alunni, e/o
il testo Get up and Go, First level B2, by Janet Harper, ed Europass
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
Sono state sperimentate le seguenti metodologie per proporre i contenuti disciplinari:
Lezione frontale
Lezione dialogata
Cooperative learning
L’approccio comunicativo e le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato e con pari valenza.
Testi orali e scritti destinati allo sviluppo dell’ascolto e della produzione sono stati inseriti in situazioni
comunicative di progressiva complessità e sono stati scelti in modo da rappresentare diverse tipologie e
tematiche. I discenti sono stati stimolati e sollecitati, sia a livello linguistico (utilizzando strutture
grammaticali e sintattiche diversificate) che cognitivo (avviandoli alla rielaborazione personale), alla ricerca
di soluzioni mediante procedimenti di tipo induttivo e deduttivo. L’approccio al linguaggio letterario ha
previsto lo studio di testi motivanti sviluppando una sequenza di lavoro sul testo del seguente tipo:
1. Breve introduzione al testo/opera;
2. Lettura del testo;
3. Attività sul testo;
4. Commento al testo;
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
14 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
5. Osservazioni generali/di sintesi;
6. Schedatura degli elementi lessico-formali;
7. Reperimento di informazioni biografiche;
8. Collegamento del testo all’autore e al periodo.
MODALITÀ DI RECUPERO
Nel corso dell’anno, gli studenti più deboli sono riusciti a mantenere un profitto globalmente sufficiente,
seguendo i consigli della docente ed applicandosi nello studio domestico.
4. OBIETTIVI MINIMI
ASCOLTO: comprende globalmente testi di varie tipologie al secondo ascolto individuando anche
dettagli rilevanti.
PRODUZIONE ORALE: si esprime con sufficiente organicità utilizzando connettivi, strutture morfosintattiche, lessico e funzioni comunicative pertinenti, pur con errori.
COMPRENSIONE DI UN TESTO SCRITTO (LETTURA): coglie le informazioni principali anche
di argomenti non noti, individuando dettagli rilevanti.
PRODUZIONE SCRITTA: Produce un testo pertinente con una sufficiente rielaborazione personale.
La forma deve essere sostanzialmente corretta, senza grossolani errori di base ed errori semantici.
Tali obiettivi minimi che riguardano le 4 abilità linguistiche andranno riferiti ai contenuti definiti per
ciascuna delle tre lingue straniere trattati rispettivamente nel trimestre e nel pentamestre.
5. MATERIALI DIDATTICI
Nell’organizzazione del lavoro degli studenti in classe si sono utilizzati le seguenti tecniche e strumenti:
La lezione frontale e la lezione dialogata in L2
Regolare assegnazione di esercizi e questionari sulle attività svolte in classe, con controllo dei compiti.
Lavoro in classe individuale, a coppie e in piccoli gruppi.
Il testo in adozione: “MILLENNIUM” volumi 1 di Arturo Cattaneo e Donatella De Flaviis, corredato
di audio CD per la classe e “Grammar and Vocabulary Trainer” di Angela Gallagher e Fausto
Galuzzi; ed. Pearson Longman, corredato di CD-Rom interattivo.
il computer di classe dotato di lettore CD e DVD;
Lavagna LIM
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prova scritta
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
15 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Prova orale
Per verificare la capacità degli studenti di organizzare le abilità acquisite durante una parte significativa
dell’itinerario di apprendimento, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
prove scritte: Test strutturati coerenti con quanto svolto in classe, sia dal punto di vista dei contenuti che
della tipologia degli esercizi. Tali prove verificheranno la comprensione di materiale autentico, la conoscenza
e proprietà lessicale, la capacità di produrre paragrafi e brevi testi su traccia data nonché liberi, la correttezza
grammaticale ed infine la capacità e precisione nel tradurre in italiano e dall’italiano.
Per l’abilità scritta letteraria sono stati somministrati questionari contestuali storico-letterari; comprehension
tests relativi a testi letterari e storici, con commento tematico, stilistico e contestuale; la composizione di
brevi essays.
prove orali: oltre a valutazioni informali sul processo di apprendimento in itinere, nelle prove orali sono state
verificate le seguenti abilità: pronuncia, ritmo, intonazione, competenza comunicativa, comprensione,
proprietà lessicale e fluency nelle varie attività di classe, quali interazione T/S, S/S, S/SS; la lettura; le attività
di “reporting to the class”; esercitazioni varie.
Le prove di verifica sono state corrette, valutate e puntualmente restituite agli studenti ed il profitto
conseguito è stato reso disponibile per le famiglie mediante il registro online.
Le verifiche formative riguardavano sia le abilità di comprensione che quelle di produzione ed erano
organizzate in modo da essere coerenti con l’impostazione metodologica dell’insegnamento.
Le verifiche sommative erano simili alle attività nella fase di insegnamento (prove oggettive e
soggettive concernenti le quattro abilità).
Si sono valutati, attraverso vari tipi di prove, la conoscenza dei contenuti, l’ordine logico, la coerenza,
la capacità di operare collegamenti e confronti, di individuare le idee essenziali e secondarie, la
correttezza ortografica o fonetica, grammaticale e sintattica, la pertinenza tematica e linguistica e
l’originalità.
Naturalmente, seguendo il principio della gradualità e della complessità, le prove orali del secondo
biennio miravano ad una verifica più approfondita e ampia dei livelli di comprensione e di produzione.
Nella valutazione delle prove orali si sono tenuti presenti: conoscenza dei contenuti richiesti, capacità
di comprensione, correttezza nella pronuncia, ritmo e intonazione, comprensibilità del messaggio,
proprietà lessicale.
La produzione e la comprensione scritta sono state orientate organicamente verso testi narrativi,
descrittivi, espositivi e verso l’analisi di testi letterari.
Per le prove scritte si sono considerate: capacità di comprensione del testo, padronanza delle strutture
grammaticali, capacità di produzione (correttezza grammaticale, spelling, punteggiatura), conoscenza
lessicale.
Nell’abilità scritta la produzione doveva raggiungere un livello minimo di accuratezza attorno al 70%.
Essendo il 70% considerato il punteggio corrispondente alla sufficienza, tutte le altre valutazioni della
scala decimale sono derivate da tale soglia ed espresse con voti che vanno da 1 a 10.
Per la valutazione delle conoscenze/abilità si è fatto riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei
Docenti.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
16 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia MATEMATICA
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa FRANCHINI VALERIA
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
1.1 Conoscenze
Calcolo goniometrico
Trigonometria
Numeri complessi
Matrici
Trasformazioni geometriche
Statistica
Calcolo combinatorio
1.2 Competenze e capacita
Competenze
Sviluppare l’utilizzo di metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse
sviluppare l’abitudine a riesaminare criticamente ed a risistemare logicamente le conoscenze
acquisite
saper utilizzare il formalismo matematico relativo a contenuti trattati
saper risolvere un problema con gli strumenti propri della trigonometria con le conoscenze acquisite
saper applicare le proprietà fondamentali del calcolo goniometrico
saper utilizzare il calcolo statistico e combinatorio per risolvere problemi di vario ambito
Capacità
saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche
saper visualizzare graficamente funzioni goniometriche
saper individuare le relazioni tra angoli e lati di un triangolo
saper utilizzare e rappresentare i numeri complessi
saper individuare alcune principali trasformazioni nel piano
saper effettuare un’analisi statistica di dati
saper applicare alcuni elementi e tecniche risolutive del calcolo statisctico e combinatorio
saper utilizzare il calcolo matriciale finalizzato allo studio delle trasformazioni nel piano
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
17 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Trimestre
* Le funzioni goniometriche:
- la circonferenza goniometrica;
- le funzioni seno e coseno;
- la funzione tangente;
- le funzioni secante e cosecante;
- la funzione cotangente;
- le funzioni goniometriche di angoli particolari;
- le funzioni goniometriche inverse;
- le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche.
* Le formule goniometriche:
- gli angoli associati
- le formule di addizione e sottrazione;
- le formule di duplicazione;
- le formule di bisezione;
- le formule parametriche;
- le formule di prostaferesi (no formule di Werner).
* Le equazioni e le disequazioni goniometriche:
- le equazioni goniometriche elementari;
- le equazioni lineari in seno e coseno;
- i sistemi di equazioni goniometriche;
- le disequazioni goniometriche;
- le equazioni goniometriche parametriche.
Pentamestre
* La trigonometria:
- i triangoli rettangoli;
- applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli;
- i triangoli qualunque.
* I numeri complessi:
- il calcolo con i numeri immaginari
- il calcolo con i numeri complessi in forma algebrica;
- la formula trigonometrica di un numero complesso;
- operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica.
* Statistica (l’interpolazione, la regressione, la correlazione):
- interpolazione;
- il metodo dei minimi quadrati;
- la dipendenza, la regressione, la correlazione.
* Le matrici:
- definizione
- confronto tra matrici;
- la matrice trasposta;
- somma e differenza di matrici;
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
18 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
- la moltiplicazione (del tipo kxA)
- la moltiplicazione generale (riga per colonna);
- il determinante.
* Le trasformazioni geometriche:
- trasformare i grafici;
- definizione di isometria;
- traslazione;
- rotazione con centro nell’origine;
- simmetria centrale;
- simmetria assiale.
* Il calcolo combinatorio:
- le disposizioni semplici;
- le disposizioni con ripetizione;
- le permutazioni semplici;
- le permutazioni con ripetizione;
- le combinazioni semplici;
- le combinazioni con ripetizione.
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
La metodologia didattica che ho utilizzato è stata quella di alternare lezioni frontali (per introdurre nuovi
argomenti) a lezioni dialogate, in cui gli studenti sono stati chiamati ad affrontare in prima persona problemi o
applicazioni delle regole appena apprese.
4. OBIETTIVI MINIMI
La Matematica è una disciplina a sviluppo consequenziale e per questo motivo tutti gli argomenti previsti
sono necessari e propedeutici agli argomenti successivi. Inoltre la taratura degli obiettivi minimi riguarda il
livello di difficoltà e di approfondimento degli argomenti.
A seguito di tutto ciò, nelle verifiche di recupero del debito di settembre si farà riferimento al programma
effettivamente svolto dalla classe nel seguente modo:
per il raggiungimento degli obiettivi minimi agli alunni sarà richiesto di saper rispondere a domande, di saper
svolgere quesiti, di saper risolvere esercizi in modo semplificato, sia per quanto concerne l’impostazione di
partenza, sia per lo sviluppo del contenuto della prova. Qualora queste semplici richieste vengano soddisfatte
nella misura di almeno i 2/3, verrà superato il debito con il voto di sufficienza.
5. MATERIALI DIDATTICI
Come materiale didattico è stato utilizzato il libro di testo integrato da appunti.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove di verifica sono state:
interrogazioni orali
prove scritte
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
19 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia FISICA
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa ZERMINI MADDALENA
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
1.1 Conoscenze
1.2 Competenze e capacita
Saper riconoscere il fenomeno, individuare le leggi e i principi che lo governano e saper risolvere
problemi.
Analizzare i concetti fondamentali, le leggi e le teorie che li regolano sapendoli contestualizzare
storicamente.
Osservare un fenomeno, misurare e analizzare le grandezze coinvolte, formulare ipotesi e proporre modelli
o analogie.
Applicare i principi le leggi i teoremi in relazione alle conoscenze acquisite. risolvere problemi con un
formalismo e tecniche di calcolo adeguati.
Saper utilizzare gli strumenti di misura relativi all’esperimento e saper redigere una relazione di laboratorio
Utilizzo di un linguaggio specifico.
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
PRIMO PERIODO.
Libro di testo: L’ Amaldi per i licei scientifici.blu 1
CAPITOLO 11: CAMBIAMENTI DI STATO (da pagina 400 a 413)
1. I PASSAGGI TRA STATI DI AGGREGAZIONE.
2. LA FUSIONE E LA SOLIDIFICAZIONE.
Le leggi della fusione.
Le leggi della solidificazione.
Il calore latente dal punto di vista microscopico.
1. LA VAPORIZZAZIONE E LA CONDENSAZIONE.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
20 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Il raffreddamento per evaporazione.
La condensazione.
I rigassificatori.
1. IL VAPORE SATURO E LA SUA PRESSIONE.
Pressione del vapore saturo ed ebollizione.
1. LA CONDENSAZIONE E LA TEMPERATURA CRITICA.
Gas e vapori.
Il diagramma di fase.
1. LA SUBLIMAZIONE.
CAPITOLO 12: IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA (da pagina 426 a 444)
1. GLI SCAMBI DI ENERGIA.
Un cilindro pieno di gas perfetto.
Caso più generale.
1. L’ ENERGIA INTERNA DI UN SISTEMA FISICO.
Le funzioni di stato.
1. IL PRINCIPIO ZERO DELLA TERMODINAMICA.
2. TRASFORMAZIONI REALI E TRASFORMAZIONI QAUSISTATICHE.
Le trasformazioni quasistatiche.
Trasformazioni quasistatiche particolari.
1. IL LAVORO TERMODINAMICO.
Il lavoro di una trasformazione isòbara.
Il lavoro compiuto in una trasformazione ciclica.
Il lavoro non è una funzione di stato.
1. ENUNCIAZIONE DEL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA.
2. APPLICAZIONE DEL PRIMO PRINCIPIO.
Trasformazioni isocòre.
Trasformazioni isòbare.
Trasformazioni isoterme.
Trasformazioni cicliche.
1. I CALORI SPECIFICI DEL GAS PERFETTO.
2. LE TRASFORMAZIONI ADIABATICHE.
L’equazione delle adiabatiche quasistatiche.
CAPITOLO 13: IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA (da pagina 460 a 482)
1. LE MACCHINE TERMICHE.
Il bilancio energetico di una macchina termica.
Le sorgenti di calore in termodinamica.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
21 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
1. PRIMO ENUNCIATO: LORD KELVIN.
2. SECONDO ENUNCIATO: RUDOLF CLAUSIUS.
Se fosse falso l’enunciato di Clausius…
Se fosse falso l’enunciato di Kelvin…
1. TERZO ENUNCIATO: IL RENDIMENTO.
Il terzo enunciato del secondo principio della termodinamica.
1. TRASFORMAZIONI REVERSIBILI E IRREVERSIBILI.
Le trasformazioni termodinamiche reversibili.
1. IL TEOREMA DI CARNOT.
Enunciato del teorema di Carnot.
1. IL CICLO DI CARNOT.
2. IL RENDIMENTO DELLA MACCHINA DI CARNOT.
3. IL MOTORE DELL’AUTOMOBILE.
Il motore ideale e la trasformazione ciclica.
1. IL FRIGORIFERO.
Il coefficiente di prestazione.
Il funzionamento del frigorifero.
Il condizionatore e la pompa di calore.
CAPITOLO 14: ENTROPIA E DISORDINE (da pagina 500 a 519)
1. LA DISUGUAGLIANZA DI CLAUSIUS.
Enunciato della disuguaglianza di Clausius.
Dimostrazione della disuguaglianza di Clausius.
1. ENTROPIA
Definizione della variazione di entropia.
L’entropia è una grandezza estensiva.
1. L’ENTROPIA DI UN SISTEMA ISOLATO
Le trasformazioni reversibili non variano l’entropia di un sistema isolato.
Le trasformazioni irreversibili aumentano l’entropia di un sistema isolato.
L’entropia dell’Universo.
1. IL QUARTO ENUNCIATO DEL SECONDO PRINCIPIO.
2. STATI MICROSCOPICI E STATI MACROSCOPICI.
Relazione tra microstati e macrostati.
Relazione tra macrostati e microstati.
La molteplicità di un macrostato.
Microstati ordinati e disordinati.
9. IL TERZO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA.
Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu 2
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
22 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
CAPITOLO 15: LE ONDE ELASTICHE(da pagina 538 a 551)
1. LE ONDE.
Onde su corda.
Onde trasversali e longitudinali.
Vari tipi di onde.
1. FRONTI D’ONDA E RAGGI.
I raggi dell’onda.
1. LE ONDE PERIODICHE.
La lunghezza d’onda e l’ampiezza.
Il periodo e la frequenza.
La velocità di propagazione.
1. LE ONDE ARMONICHE.
La legge delle onde armoniche in un punto fissato.
La fase iniziale.
La legge delle onde armoniche in un istante fissato.
1. L’INTERFERENZA.
Il principio di sovrapposizione.
Interferenza di onde.
Interferenza di onde armoniche su una retta.
Lo sfasamento.
1. L’INTERFERENZA DI UN PIANO E NELLO SPAZIO.
Le condizioni per l’interferenza costruttiva e distruttiva.
CAPITOLO 16: IL SUONO (da pagina 564 a 581)
1. LE ONDE SONORE.
Il suono è un’onda longitudinale.
Il suono non si propaga nel vuoto.
La velocità del suono.
1. LE CARATTERISTICHE DEL SUONO.
L’intensità di un’onda sonora.
Il livello di intensità sonora.
Le note e le scale musicali.
1. I LIMITI DI UDIBILITÀ.
Relazione tra frequenza e lunghezza d’onda.
1. L’ECO.
2. LE ONDE STAZIONARIE.
I modi normali di oscillazione.
Le frequenza dei modi normali.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
23 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Sovrapposizione di modi normali.
1. I BATTIMENTI.
L’equazione dei battimenti.
1. L’EFFETTO DOPPLER.
Sorgente ferma e ricevitore in movimento.
Sorgente in movimento e ricevitore fermo.
Applicazione dell’effetto Doppler.
SECONDO PERIODO.
CAPITOLO 17: LE ONDE LUMINOSE(da pagina 594 a 612) + CAPITOLO 14 LA LUCE (L’AMALDI
2.0) (da pagina 334 a 348)
1. ONDE E CORPUSCOLI (con scheda).
L’affermazione del modello ondulatorio.
La luce è sia onda sia corpuscolo.
1.1 I RAGGI DI LUCE.
Le sorgenti di luce.
La propagazione rettilinea della luce.
La velocità della luce.
1.2 LA RIFLESSIONE E LO SPECCHIO PIANO.
Lo specchio piano.
1.3 GLI SPECCHI CURVI.
Specchi sferici di piccola apertura.
Specchi sferici concavi.
Specchi sferici convessi.
1.4 LA RIFRAZIONE.
Le leggi della rifrazione.
1.5 LA RIFLESSIONE TOTALE.
Il prisma
Le fibre ottiche
1.6 LE LENTI.
Le lenti convergenti.
Le lenti divergenti.
1.7 LA MACCHINA FOTOGRAFICA.
1.8 MICROSCOPIO E CANNOCHIALE.
1. L’IRRADIAMENTO E L’INTENSITÀ DI RADIAZIONE.
L’angolo solido.
L’intensità di radiazione.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
24 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
1. LE GRANDEZZE FOTOMETRICHE.
2. L’INTERFERENZA DELLA LUCE.
L’esperimento di Young.
Analisi dell’esperimento di Young.
Espressione goniometrica della formula per l’interferenza.
1. LA DIFFRAZIONE.
La diffrazione delle onde d’acqua e del suono.
1. I COLORI E LA LUNGHEZZA D’ONDA.
La luce e il suono.
1. L’EMISSIONE E L’ASSORBIMENTO DELLA LUCE.
Corpi solidi e liquidi.
Gas.
Spettro solare e stellare.
ESPERIMENTI DI LABORATORIO:
Esperimenti con specchi piani, concavi e convessi.
Le lenti convergenti e divergenti.
CAPITOLO 18: LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB (da pagina 626 a 642).
1. L’ELETTRIZZAZIONE PER STROFINIO.
L’ipotesi di Franklin.
Il modello microscopico.
1. I CONDUTTORI E GLI ISOLANTI.
Il modello microscopico.
L’elettrizzazione per contatto.
1. LA DEFINIZIONE OPERATIVA DELLA CARICA ELETTRICA.
La misura della carica elettrica.
Il coulomb.
Conservazione della carica elettrica.
1. LA LEGGE DI COULOMB.
Direzione e verso della forza.
La costante dielettrica.
Il principio di sovrapposizione.
La forza elettrica e la forza gravitazionale.
1. L’ESPERIMENTO DI COULOMB.
2. LA FORZA DI COULOMB NELLA MATERIA.
La costante dielettrica assoluta.
1. L’ELETTRIZZAZIONE PER INDUZIONE.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
25 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
L’elettroforo di Volta.
La polarizzazione.
ESPERIMENTI DI LABORATORIO:
Esperienze di elettrostatica. La forza di Coulomb con l'esperimento. La costante dielettrica del vuoto e
relativa. Il fenomeno dell'induzione.
CAPITOLO 19: IL CAMPO ELETTRICO(da pagina 656 a 678)
1. IL VETTORE CAMPO ELETTRICO.
Definizione del vettore campo elettrico.
Il calcolo della forza.
1. IL CAMPO ELETTRICO DI UNA CARICA PUNTIFORME.
Campo elettrico di più cariche puntiformi.
1. LE LINEE DEL CAMPO ELETTRICO
Costruzione delle linee di campo.
Il campo di una carica puntiforme.
Il campo di due cariche puntiformi.
1. IL FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE.
Vettore superficie.
1. IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO E IL TEOREMA DI GAUSS.
Teorema di Gauss per il campo elettrico.
Dimostrazione del teorema di Gauss.
1. IL CAMPO ELETTRICO GENERATO DA UNA DISTRIBUZIONE PIANA INFINITA DI CARICA.
2. ALTRI CAMPI ELETTRICI CON PARTICOLARI SIMMETRIE.
3. DIMOSTRAZIONE DELLE FORMULE RELATIVE AI CAMPI ELETTRICI CON PARTICOLARI
SIMMETRIE.
CAPITOLO 20: IL POTENZIALE ELETTRICO (da pagina 694 a 708)
1. L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA.
L’energia potenziale della forza di Coulomb.
Il caso di più cariche puntiformi.
1. IL POTENZIALE ELETTRICO.
La definizione di potenziale elettrico.
La differenza di potenziale elettrico.
Il moto spontaneo delle cariche elettriche.
L’unità di misura del potenziale elettrico.
Il potenziale di una carica puntiforme.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
26 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
1. LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI.
Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di capo e superfici equipotenziali.
1. LA DEDUZIONE DEL CAMPO ELETTRICO DEL POTENZIALE.
2. LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO ELETTROSTATICO.
Definizione di circuitazione di E.
Il significato della circuitazione del campo elettrico.
CAPITOLO 21: FENOMENI DI ELETTROSTATICA (da pagina 722 a 749)
1. LA DISTRIBUZIONE DELLA CARICA NEI CONDUTTORI IN EQULIBRIO ELETTROSTATICO.
La localizzazione della carica.
Il valore della densità superficiale di carica.
1. IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE IN UN CONDUTTORE ALL’EQUILIBRIO.
Il campo elettrico all’interno di un conduttore carico in equilibrio.
Il campo elettrico sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio.
Il potenziale elettrico in un conduttore carico in equilibrio.
Una applicazione del teorema di Gauss.
1. IL PROBLEMA GENERALE DELL’ELETTROSTATICA.
Dimostrazione del teorema di Coulomb.
Potere delle punte e filtri elettrostatici.
La convenzione per lo zero del potenziale.
1. LA CAPACITÀ DI UN CONDUTTORE.
Il potenziale di una sfera carica isolata.
La capacità di una sfera conduttrice isolata.
1. SFERE IN EQUILIBRIO ELETTROSTATICO.
Determinazione delle cariche sulle due sfere.
Densità di carica sulle due sfere.
1. IL CONDENSATORE.
La capacità di un condensatore.
Il campo generato da un condensatore piano.
La capacità di un condensatore piano.
8
9
10
. CONDENSATORI IN SERIE E IN PARALLELO.
. L’ENERGIA IMMAGAZZINATA IN UN CONDENSATORE.
VERSO LE EQUAZIONI DI MAXWELL.
ESPERIMENTI DI LABORATORIO:
Verifica sperimentale della gabbia di Faraday e effetto punta.
CAPITOLO 22: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (da pagina 768 a 789)
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
27 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
1. L’INTENSITÀ DI CORRENTE ELETTRICA.
L’intensità di corrente.
Il verso della corrente.
La corrente continua.
1. I GENERATORI DI TENSIONE E I CIRCUITI ELETTRICI.
I circuiti elettrici.
Collegamento in parallelo e in serie.
1. LA PRIMA LEGGE DI OHM
2. I RESISTORI IN SERIE E IN PARALLELO.
Risoluzione di un circuito.
L’inserimento degli strumenti di misura in un circuito.
1. LE LEGGI DI KIRCHHOFF.
La legge dei nodi.
La legge delle maglie.
1. LA TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Dimostrazione della formula della potenza dissipata.
La conservazione dell’energia nell’effetto Joule.
Il kilowattora.
1. LA FORZA ELETTROMOTRICE.
Il generatore reale di tensione.
ESPERIMENTI DI LABORATORIO: Assemblaggio di un circuito elettrico con relativi voltmetro e
amperometro.
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
Gli argomenti del corso sono stati svolti utilizzando processi induttivi e deduttivi di apprendimento,
accompagnati da un appropriato formalismo matematico e, dove necessario, dal metodo di visualizzazione
grafica delle leggi fisiche trattate. Nello sviluppo dei contenuti sono stati comunque evidenziati tre momenti
interdipendenti:
- l’elaborazione teorica,
- la realizzazione di esperimenti dimostrativi e non,
-l’applicazione dei contenuti acquisiti mediante esercizi e problemi.
Gli strumenti pedagogici sono stati sostanzialmente:
-lezione frontale
-attività di laboratorio.
Non sono stati attivati sportelli help o corsi di recupero però l'insegnante si è sempre resa disponibile a
rispiegare, per chiarimenti o correzione di esercizi non riusciti a casa.
4. OBIETTIVI MINIMI
Conoscere gli argomenti del programma svolto
Saper applicare le leggi, i principi, le formule studiati per la risoluzione di semplici problemi
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
28 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Saper porre attenzione ai procedimenti di misura ed alla definizione delle unità di misura
Capacità di leggere, interpretare e costruire tabelle e grafici
Capacità di esprimersi in un
linguaggio che, pur spontaneo, sia chiaro e preciso e privo di errori
concettuali
Capacità di utilizzare i formalismi e la terminologia specifica disciplinare acquisiti.
5. MATERIALI DIDATTICI
Gli strumenti didattici:
testo in adozione: Amaldi "L’Amaldi per i licei scientifici.blu .”Onde, Campo elettrico e magnetismo" vol.2 e
vol. 1 ed. Zanichelli.
Testo del biennio per l'argomento “la Luce”: L'Amaldi 2.0 “Le misure, l'equilibrio,e il moto “ ed. Zanichelli.
CD-ROM con animazioni.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche orali sono state programmate e vertevano su tutti gli argomenti svolti nei singoli periodi; come
stabilito dal coordinamento di materia, i colloqui individuali sono stati talora integrati e/o sostituiti da prove
strutturate ( quesiti a risposta singola o multipla, trattazioni sintetiche di argomenti, problemi ).
I momenti valutativi sono stati tre nel primo periodo e almeno quattro nel secondo.
Gli aspetti fondamentali per la valutazione sono stati i seguenti:
Conoscenze:
conoscenza di principi, teorie, concetti, teoremi, procedure e tecniche
pertinenza degli argomenti.
risolutive;
Competenze/capacità:
capacità e competenze applicative ( padronanza nelle abilità di calcolo e nell’utilizzo di tecniche
risolutive, organizzazione e scelta delle strategie risolutive)
capacità di analisi ( approfondimento degli argomenti e rielaborazione dei contenuti)
capacità di sintesi ( contestualizzazione degli argomenti, collegamenti disciplinari e interdisciplinari).
Esposizione
utilizzo adeguato di termini, simboli, formalismi specifici;
proprietà lessicali e capacità espressive.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
29 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa MECOCCI LORETTA
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
Chimica
Trimestre
Richiami di nomenclatura IUPAC e tradizionale
Proprietà delle soluzioni
Le reazioni chimiche
L’energia e la spontaneità delle reazioni (termodinamica)
Velocità di reazione
Equilibrio chimico
Acidi e basi – PH
Tamponi ed idrolisi
Ossidoriduzioni
Elettrochimica
Biologia
Introduzione all’istologia: tessuti animali
Sistema scheletrico e muscolare
Apparato cardio-circolatorio
Apparato respiratorio
Apparato nervoso: fisiologia
Apparato digerente
Apparato escetore ( cenni)
Pentamestre
1.1 Conoscenze
Chimica
Trimestre
Richiami di nomenclatura IUPAC e tradizionale
Proprietà delle soluzioni
Le reazioni chimiche
L’energia e la spontaneità delle reazioni (termodinamica)
Velocità di reazione
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
30 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Pentamestre
Equilibrio chimico
Acidi e basi – PH
Tamponi ed idrolisi
Ossidoriduzioni
Elettrochimica
Stato solido della materia: minerali e rocce
Biologia
Introduzione all’istologia: tessuti animali
Sistema scheletrico e muscolare
Apparato cardio-circolatorio
Apparato respiratorio
Apparato nervoso: fisiologia
Apparato digerente
1.2 Competenze e capacita
Competenze:
consolidare l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico
saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze
saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microscopico al macroscopico) e
viceversa
saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale
Capacità Chimica:
Saper identificare, classificare e scrivere le reazioni di formazione dei composto
Saper calcolare la resa di una trasformazione chimica, considerando eventuali fattori limitanti
Saper applicare le leggi delle proprietà colligative della materia
Prevedere la spontaneità di una reazione a partire da valori di delta H e delta S
Saper utilizzare la costante di equilibrio
Calcolare e determinare il pH delle diverse soluzioni
Saper eseguire una titolazione
Saper riconoscere e bilanciare le reazioni di ossidoriduzione
Determinare la forza elettromotrice di una pila
Rappresentare i processi che si verificano agli elettrodi di una cella elettrolitica
Saper riconoscere i tipi di rocce in base alla loro origine
Capacità Biologia:
Acquisire una visione d’insieme dei diversi livelli di organizzazione strutturale del corpo umano
Saper descrivere la struttura e la funzione dei diversi tessuti
Saper riconoscere i caratteri fondamentali di un tessuto mediante osservazione microscopica
Comprendere che le funzioni degli organi sono rese possibili dall’interazione coordinata di tutti i
tessuti
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
31 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Saper definire il concetto di omeostasi e spiegarlo mediante esempi
Saper riconoscere gli eventi che condizionano gli stati di salute dell’organismo, richiamandone i
principi di prevenzione
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
Chimica
Trimestre
Nomi e formule dei composti chimici:
Richiami di nomenclatura IUPAC e tradizionale
Proprietà delle soluzioni:
dissociazione elettrolitica
ionizzazione
proprietà colligative delle soluzioni
Le reazioni chimiche:
classificazione delle reazioni chimiche
stechiometria delle reazioni chimiche
reagente limitante
stechiometria delle reazioni in soluzione : titolazione acido-base
la resa di reazione
Energia e velocità delle reazioni reazioni chimiche:
L’energia e la spontaneità delle reazioni (termodinamica)
Velocità di reazione e relativi fattori da cui dipende
Equilibrio chimico:
legge di azione di massa e costante di equilibrio
reazioni di equilibrio in fase gassosa e eterogenei
quoziente di reazione
principio dell’equilibrio mobile e i relativi effetti di pressione e di temperatura
prodotto di solubilità e effetto dello ione in comune
Pentamestre
Acidi e basi :
acidi e basi secondo Arrehenius,Bronsted-Lowry,Lewis
ionizzazione e prodotto ionico dell’acqua
soluzioni acide,neutre e basiche
calcolo del PH delle soluzioni
forza di acidi e di basi
idrolisi salina
soluzioni tampone
Elettrochimica:
Bilanciamento delle reazioni redox
pile elettriche
potenziale di riduzione
pila di Daniell
forza elettromotrice di una pila
elettrolisi
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
32 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
stato solido della materia: minerali e rocce
Biologia
Organizzazione del corpo umano:
suddivisione del corpo umano e alcune importanti funzioni dell’organismo
tessuti del corpo umano
Sistema scheletrico e muscolare:
anatomia e fisiologia del sistema scheletrico e muscolare
Sistema cardio-vascolare:
anatomia e fisiologia: sangue,cuore e vasi sanguigni
Sistema respiratorio:
funzioni, anatomia e meccanica respiratoria
trasporto e scambio dei gas
controllo della respirazione
Sistema digerente:
masticazione e deglutizione del cibo
stomaco e demolizione del cibo
intestino e ghiandole annesse
assorbimento delle sostanze nutritive e metabolismo
dieta bilanciata
educazione alla salute
Sistema nervoso:
fisiologia del sistema nervoso: propagazione del segnale
comunicazione tra neuroni
Sono state eseguite le seguenti attività laboratoriali:
Le reazioni chimiche: doppio scambio, redox
Titolazione
Studio dello scheletro umano
Studio del Tronco umano
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
Si ritiene fondamentale che l’insegnamento della materia debba essere condotto secondo il procedimento
caratteristico delle scienze sperimentali che prevede di abituare gli alunni a una continua interazione tra
osservazione della realtà, elaborazione teorica e verifica empirica. La lezione frontale è sempre stata volta al
coinvolgimento e alla partecipazione attiva degli allievi. Ogni argomento, per quanto possibile,è stato
affrontato partendo da esperienze pratiche in aula o in laboratorio per favorire un maggiore coinvolgimento
operativo. L’approfondimento di alcuni argomenti è stato fatto attraverso la lettura di articoli pubblicati su
riviste del settore ad integrazione del testo e quando disponibili sono stati utilizzati strumenti audio visivi e di
laboratorio. La dettatura degli appunti e la lettura del libro di testo è stata agevolata dalla organizzazione dei
contenuti in schemi .Il lavoro è stato impostato tenendo conto della preparazione iniziale degli alunni;
eventuali carenze sono state colmate con attività di recupero in itinere.
Il lavoro degli studenti in classe ha previsto:
Partecipazione attiva durante la spiegazione dei diversi argomenti
Compilazione ordinata del quaderno di materia
Uso del libro di testo o di altre fonti di informazione
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
33 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Correzione degli esercizi e dei compiti assegnati
Il lavoro degli studenti a casa è stato mirato al mantenimento e consolidamento di conoscenze, competenze
e abilità acquisite in classe attraverso:
Studio dei contenuti proposti
Sistemazione degli appunti
Svolgimento dei compiti assegnati
Ricerca personale di notizie riguardanti l’argomento trattato
4. OBIETTIVI MINIMI
Obiettivi minimi (Secondo biennio )
Conoscenze essenziali dei contenuti
Capacità di esposizione dei contenuti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina
Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari con riferimento anche a esempi tratti dalla vita
quotidiana
Saper applicare leggi e modelli anche per la risoluzione di problematiche reali
Gli studenti dell’indirizzo Scienze applicate dovranno consolidare le tecniche acquisite nel biennio per
poter progettare semplici attività laboratoriali
CLASSI QUARTE
Chimica (trimestre- pentamestre)
Richiami di nomenclatura IUPAC
Soluzioni, concentrazioni e calcoli stechiometrici
L’energia e la spontaneità delle reazioni (termodinamica)
Velocità di reazione e l’equilibrio chimico
Acidi e basi – pH
Tamponi ed idrolisi
Ossidoriduzioni
Elettrochimica
Stato solido della materia (minerali e rocce)
Biologia (pentamestre)
Ogni docente si riserva di svolgere tra i seguenti apparati quelli che ritiene irrinunciabili a seconda del tempo
a disposizione.
Introduzione all’istologia
Apparato cardio-circolatorio
Apparato respiratorio
Apparato nervoso
Apparato scheletrico e muscolare
Apparato digerente
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
34 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
5. MATERIALI DIDATTICI
Si è utilizzato il libro di testo adottato e altri strumenti di lavoro come:quaderno per appunti,materiale
audiovisivo,sussidi multimediale, laboratorio e lettura di fonti dirette.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le conoscenze sono state verificate, attraverso un congruo numero di prove: almeno due nel primo periodo e
almeno tre nel secondo periodo. Le tipologie di verifica sono state le seguenti:
1 Prove strutturate e semistrutturate valide anche per l’orale
2 Relazioni di laboratorio, elaborati personali, esercizi, problemi
3 Interrogazioni
Per la valutazione delle conoscenze/abilità si è fatto riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei
docenti. Si è tenuto conto del progresso registrato da ogni singolo alunno, dell’uso appropriato del linguaggio
e della capacità di rielaborazione personale, nonché dell’interesse,impegno e partecipazione al dialogo
educativo.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
35 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia DISEGNO E STORIA DELL ARTE
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa CASTELLINI ROBERTA
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
1.1 Conoscenze
Gli allievi conoscono, a vario livello, gli argomenti trattati nell'ambito della Storia dell'Arte, dal Manierismo
al primo Romanticismo; conoscono i metodi di rappresentazione grafica delle proiezioni ortogonali, della
prospettiva accidentale, la teoria delle ombre e la pratica del rilievo architettonico a mano libera, oltre alle
modalità organizzative - operative generali del Disegno geometrico.
1.2 Competenze e capacita
Gli allievi sono in grado rappresentare graficamente in modo accettabile volumi geometrici e semplici
volumi architettonici utilizzando gli strumenti del disegno; sono in grado di comprendere queste forme,
date attraverso le proiezioni ortogonali, e tradurle graficamente in prospettiva accidentale, applicando la
teoria delle ombre a proiezioni ortogonali e assonometrie di solidi semplici. Hanno acquisito, a diversi
livelli, un corretto metodo di lavoro.
Nell’ambito della storia dell’arte gli allievi hanno sviluppato le capacità di analizzare un prodotto artistico
secondo i codici visivo-storici (analisi iconografica) e di relazionare un prodotto artistico ai significati che
esprime nel contesto storico-sociale in cui si colloca (analisi iconologica). Le abilità linguistico–espressive
sono state affinate con l’incremento della terminologia specifica ed un lessico adeguato. Sono in grado di
confrontare secondo uno stesso tema prodotti artistici di autori ed epoche diversi, tra quelli studiati, per
comprendere meglio i rapporti tra segni, contesto e significati.
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
STORIA DELL’ARTE - PRIMO PERIODO
La pittura veneta. Caratteri, contesto, protagonisti.
Giorgione, Pala di Castelfranco, lettura d’opera;
La tempesta , lettura d'opera
I tre filosofi; altri dipinti allegorici.
Tiziano, Amor sacro e Amor profano; L'Assunta dei Frari, lettura d'opera;
confronto con Assunzione della Vergine, Verona
L'evoluzione drammatica dello stile di Tiziano; le due Incoronazioni di spine;
i dipinti della tarda maturità; Apollo e Marsia.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
36 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Tiziano e il ritratto.
Caratteri e contesto del primo Manierismo fiorentino.
La prima fase e Andrea del Sarto, Madonna delle Arpie.
Lettura - confronto Rosso e Pontormo, Deposizioni.
L'arte clementina e la diffusione del Manierismo.
Parmigianino, Autoritratto allo specchio; Madonna dal collo lungo.
La fase piena del Manierismo a Firenze.
Bronzino, Allegoria dell'amore.
I giardini manieristi.
Giulio Romano a Mantova; Palazzo Te, lettura d'opera.
Dal Manierismo alla pittura di Tintoretto e Veronese.
Confronto tra i due maestri veneti.
Veronese, Cena in casa di Levi.
Andrea Palladio. La formazione, i mecenati, l’arte antica.
La Basilica; il rinnovamento della facciata nelle chiese veneziane.
Villa Almerico Capra, lettura d'opera.
I palazzi cittadini a Vicenza e Palazzo Chiericati; le ville venete; Villa Barbaro a Maser e gli affreschi di
Veronese; il Teatro Olimpico.
L'arte della controriforma;caratteri, finalità; il controllo sulle immagini sacre.
Federico Barocci, Madonna del popolo.
Jacopo Barozzi, Chiesa del Gesù, lettura d'opera; confronti con S. Fedele, Milano.
L'Accademia degli Incamminati e l'arte della Controriforma.
Ludovico Carracci, Annunciazione.
L'inizio della pittura di genere.
Annibale Carracci, Mangiafagioli; Volta Galleria Farnese, lettura d’opera.
Confronti con altre opere.
Caravaggio. La formazione, gli esordi; primo periodo romano; Ragazzo morso da ramarro; Canestra di frutta;
Riposo dalla fuga in Egitto; Cappella Contarelli e Vocazione S. Matteo, lettura d'opera.
Morte della Vergine; Vocazione di Saulo; Madonna dei pellegrini.
Caravaggio. Le opere rifiutate; il periodo maltese e siciliano; le ultime opere; David con testa di Golia.
I caravaggeschi.
Il Barocco. Il contesto storico, iIl termine, la funzione dell'arte, la critica.
La città barocca.
G.L. Bernini, Estasi S. Teresa , lettura d'opera.
Il Barocco romano. Opere di Bernini in S. Pietro: Baldacchino, Cattedra S. Pietro, S. Longino, Monumenti
funerari a Urbano VIII e Alessandro VII.
Gli illusionismi prospettici: Scala Regia; Colonnato di Piazza San Pietro.
Le piazze e le fontane barocche.
S. Andrea al Quirinale.
F. Borromini: la personalità, l’opera. Confronto con Bernini.
S. Carlo alle Quattro fontane; S.Ivo alla Sapienza; la Galleria Palazzo Spada e gli illusionismi barocchi.
S. Agnese in Agone; Ristrutturazione Basilica di S. Giovanni in Laterano.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
37 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
La pittura barocca. Pietro da Cortona, Trionfo della Divina Provvidenza, lettura d’opera.
Confronto con gli affreschi di A. Sacchi.
La pittura di quadratura; Andrea Pozzo, Gloria di S.Ignazio; G.B.Gaulli, Trionfo del Nome di Gesù.
La pittura barocca e la pittura del '600.
Rubens; i dipinti per Maria de Medici; I disastri della guerra.
STORIA DELL’ARTE - SECONDO PERIODO
Rembrandt, La ronda di notte e il ritratto di gruppo.
Velasquez, Las meninas.
J. Vermeer; tecnica e soggetti; Allegoria della pittura; Il geografo; altre opere.
Il Rococò: origine, caratteri, diffusione.
La Reggia di Versailles e i giardini.
I palazzi e giardini del periodo Rococò in Europa; Chiesa di S.Carlo a Vienna; Palazzo del Belvedere.
Il tardo barocco a Torino e l'architettura di G.Guarini: Cappella della Santa Sindone; Palazzo Carignano
Filippo Juvarra, Basilica di Superga, lettura d’opera.
Palazzo Madama; Palazzina di Stupinigi.
L. Vanvitelli, Reggia di Caserta.
N. Salvi, Fontana di Trevi.
La pittura del '700: G.B. Tiepolo. Il linguaggio, i temi.
Affreschi della Residenza di Wurzburg.
I generi della pittura; il Vedutismo.
Da Van Wittel a Canaletto a Francesco Guardi; confronto Canaletto, Guardi, Il Molo con la Libreria e la
Chiesa della Salute.
Il Neoclassicismo; il contesto, i principi, i teorici. Mengs e il Parnaso.
J.L.David e l’ideale etico. Giuramento degli Orazi,lettura d'opera. Morte di Marat, lettura d'opera.
La pittura di David nel periodo imperiale; Napoleone valica il Gran San Bernardo; Incoronazione di
Napoleone.
Canova e l'ideale estetico. La formazione, le prime opere romane; Teseo sul Minotauro.
Amore e Psiche, lettura d'opera.
Ebe; Ritratto di Paolina Borghese; altre opere.
L'esecuzione sublime e la tecnica dal bozzetto all’opera finita.
Confronto con Foscolo.
I Monumenti funerari. Monumento a M.C. d'Austria,lettura d'opera. Altri monumenti funerari;
Tempio di Possagno.
L’Architettura neoclassica. Caratteri, diffusione, intenti.
Il Neoclassicismo in Francia; Pantheon.
Gli architetti utopisti: Boullée e Ledoux; Monumento a Isaac Newton; le Saline di Chaux; altre opere.
L’architettura neoclassica in Inghilterra; la villa palladiana e R. Adam, Kedleston Hall.
L’architettura neoclassica in Germania; von Klenze, Walhalla; Schinkel, Altes Museum.
L’architettura neoclassica negli Stati Uniti e in Russia.
L’architttura neoclassica in Italia. Milano, periodo asburgico e periodo napoleonico.
G. Piermarini, Teatro La Scala, lettura d’opera; Villa Reale a Monza;
altri palazzi ed edifici dell’Italia neoclassica.
Roma, la ristrutturazione di Piazza del Popolo e Giardini del Pincio; i Caffè.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
38 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classico e Romantico: confronto concetti fondamentali.
Le inquietudini preromantiche: J.H. Fussli; La disperazione dell’artista davanti alla grandezza…
Il giuramento dei confederati; L'incubo.
Il sogno e la contrapposizione al razionalismo scientifico. F.Goya: la formazione; le incisioni de "I capricci" e
Il sonno della ragione genera mostri; I disastri della guerra; Le fucilazioni del 3 maggio, lettura d’opera; le
pitture nere; Ritratto della famiglia di Carlo IV; La maja e il tema del nudo.
Romanticismo inglese: il visionario e il fantastico di W.Blake; L’Onnipotente; Il vortice degli amanti; Ritratto
di Isaac Newton.
Pittoresco e sublime; l’origine e la definizione dei concetti; i teorici.
J. Constable, Mulino di Flatford, lettura d’opera; altre opere.
J.M.W. Turner . La “prima maniera”; Didone costruisce Cartagine;confronto con C. Lorrain.
Incendio alla Camera dei Lords..., lettura d’opera.
Il romanticismo nordico e la pittura di Friedrich; il contesto e l formazione; Croce in montagna; Abbazia nel
querceto; la simbologia e la natura.
Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare; Le bianche scogliere di Rϋgen; Nebbia sull'Elba; Mare
di ghiaccio; altre opere.
I temi del Romanticismo.
Romanticismo francese.
T.Gericault, l'uomo e la storia; La zattera della Medusa, lettura d’opera.
Confronto sul tema nave-imbarcazione; componenti classiche e realiste; ritratti di alienati; altre opere.
E. Delacroix, La Libertà guida il popolo, lettura d’opera.
DISEGNO - PRIMO PERIODO
Proiezioni prospettiche. La Prospettiva Accidentale. Aspetti teorici e applicazioni pratiche.
Principi, elementi, procedimenti.
Metodo del prolungamento lati e punti di fuga; metodo del taglio dei raggi visuali.
Prospettiva accidentale di figure geometriche piane, solidi , gruppi di solidi, semplici volumi
architettonici.
DISEGNO - SECONDO PERIODO
Rilievo grafico di facciata di edifici religiosi del periodo Cinquecento-Settecento .
Rilievo grafico di facciate di regge e palazzi del periodo Cinquecento-Settecento.
Disegno a mano libera con chiaro-scuro e disegno geometrico.
Teoria delle ombre .
Ombre di punti, segmenti , figure piane e solidi con proiezioni ortogonali.
Ombre di punti, segmenti , figure piane e solidi in assonometria.
Ombre di solidi su altri solidi.
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
Nella classe quarta il DISEGNO è stato proposto con un primo momento di lezione frontale, con presa di
appunti, grafici realizzati con la lavagna LIM e specifiche applicazioni grafiche, schemi su quaderno ed un
secondo momento con esercitazioni grafiche, impostate in classe e concluse a casa.
Gli esercizi grafici prodotti sono stati ritirati, controllati e corretti, poi restituiti agli allievi per dare loro la
possibilità di raccogliere suggerimenti e correzioni. La puntualità e la regolarità dello svolgimento dei
compiti assegnati sono state elemento che ha concorso a definire il profitto.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
39 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
La STORIA DELL’ARTE è stata affiancata al disegno ogni qual volta è stato possibile, utilizzando
quest’ultimo come mezzo di comprensione ed approfondimento nello studio delle diverse opere d’arte. Il
testo è stato la base di partenza del percorso di apprendimento basato sull’immagine proposta
dall’insegnante sul testo stesso, su altri testi, con il costante utilizzo della LIM, con CD di immagini e
presentazioni. L’immagine dell’opera d’arte, scelta tra le più significative, è stata decodificata secondo uno
schema prestabilito basato sugli elementi del linguaggio visivo per abituare gli allievi a lavorare con metodo;
si è quindi proceduto ponendo l’opera in relazione allo spazio-tempo, al contenuto e alla funzione espressi
dalla forma, alla tecnica e alla società, storia, cultura che l’hanno prodotta. Sono stati spesso effettuati
confronti tra periodi-autori-opere diversi per meglio comprenderne le caratteristiche. La presa di appunti e lo
svolgimento di approfondimenti e sintesi scritti e/o scritto-grafici con l’analisi-lettura di singole opere
particolarmente significative, da preparare a casa, hanno costituito fondamentale supporto per lo studio e il
ripasso.
E’ stata utilizzata costantemente la lavagna LIM per sviluppare gli argomenti con approfondimenti, confronti,
collegamenti anche con materiali iconografici non forniti dal testo.
Per il recupero degli insufficienti si sono utilizzate modalità come il recupero curriculare, con revisione
guidata dall'insegnante di esercizi e verifiche, la ripresa di spiegazione degli argomenti, lo studio individuale.
4. OBIETTIVI MINIMI
Classi quarte - obiettivi minimi espressi in competenze
Storia dell’arte
Sapere leggere un’opera d’arte secondo uno schema dato negli elementi fondamentali del linguaggio visivo
ed essere in grado di individuare i contenuti essenziali relativi all’opera stessa e al suo periodo storico; sapere
confrontare opere di autori e periodi diversi cogliendone affinità e differenze.
Disegno
Sapere usare gli strumenti del Disegno geometrico; sapere applicare i procedimenti grafici studiati.
5. MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo:
Ed. La Nuova Italia; Secchi, Valeri, Il nuovo Le forme del Disegno vol. 2
Ed. Bruno Mondadori; IL NUOVO ARTE TRA NOI, vol. 3 e vol. 4
Presentazioni Power point fornite dall’insegnante.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove, grafiche, test scritto, orale, sono state in numero ben superiore al minimo di due, stabilito dal
Coordinamento di materia. Questo ha comportato un grande impegno da parte del docente ma ha reso
possibile valutare in modo più ampio e preciso gli allievi, oltre che fornire uno stimolo maggiore a studio ed
esercizio.
Le VERIFICHE sono consistite in prove oggettive di disegno, con traduzione e sviluppo di grafici, svolte in
orario curriculare alla conclusione di una o più unità didattiche. La valutazione delle prove grafiche è stata
espressa sotto forma di giudizio e voto numerico, come previsto dal Coordinamento di materia; i risultati sono
stati trascritti e mostrati agli allievi entro massimo 15 gg. con le eventuali indicazioni per il miglioramento. I
livelli di prestazione e loro corrispondenza al voto, sono quelli adottati dal Coordinamento di materia, con
voti da 2 a 10.
Per la Storia dell’Arte si sono somministrati test a tipologia mista, sostitutivi dell’orale, per verificare
contemporaneamente, oggettivamente e con identiche richieste tutti gli allievi. Per alcuni casi è stata invece
utilizzata la tradizionale interrogazione orale.
L’ultima verifica è stata proposta con tipologia simile a quella di Terza prova per l’Esame di Stato, per
iniziare ad abituare la classe in vista del prossimo quinto anno.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
40 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa FAINI DANIELA
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
Obiettivi programmatici
Potenziamento fisiologico
Rielaborazione, affinamento ed integrazione degli schemi motori di base
Conoscenza e pratica delle attività sportive
Consolidamento del carattere sviluppo della socialità e del senso civico
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni
Triennio
Acquisizione corporeità
Cultura sportiva come costume di vita
Completo sviluppo corporeo e motorio con affinamento delle capacità e qualità fisiche di funzioni
neuromuscolari.
Approfondimento teorico pratico delle attività sportiva
Arricchimento coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé.
Miglioramento delle qualità fisiche
Miglioramento delle funzioni neuromuscolari
Acquisizione capacità operative e sportive
Tutela salute e prevenzione infortuni
Realizzazione progetti motori autonomi
CONOSCENZE (elenco dei contenuti disciplinari)
1. Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di
salute e il miglioramento dell’efficienza fisica.
2. promozione di uno stile di vita attivo
3. coscienza del valore della corporeità
4. sviluppo delle competenze motorie
5. sviluppo di una immagine corporea positiva
6. educazione all’igiene del corpo come rispetto dello stesso e benessere psicofisico
7. sviluppo della personalità di ogni allievo
8. sviluppo delle competenze sociali
9. Approfondimento all’uso del gioco e dei giochi sia tradizionali che sportivi agonistici.
10. Rinnovare il rapporto uomo-natura - Conoscere alcune attività motorie e sportive in ambiente naturale.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
41 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
11. I principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola e
negli spazi aperti.
12. Mettere in atto, in modo autonomo, comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita.
1.1 Conoscenze
Gli allievi conoscono:
Gli elementi fondamentali della progettazione di un percorso formativo: finalità, gli obiettivi, mezzi e
metodi da utilizzare, alcuni strumenti di misurazione e valutazione, gli aspetti organizzativi.
Le principali pratiche ed esercitazioni che migliorano le qualità fisiche e le capacità motorie.
Concetto di postura e percezione del proprio corpo nel controllo posturale.
Le differenze dinamiche sociali: coppia, gruppo, squadra.
Le caratteristiche specifiche delle attività finalizzate allo sviluppo delle capacità motorie: resistenza
aerobica, mobilità articolare, forza, equilibrio, velocità e precisione.
Significato di motricità finalizzata e motricità espressiva.
La sedentarietà e i suoi rischi.
1.2 Competenze e capacita
Gli allievi sono in grado di:
Riconoscere le modificazioni fisiche e funzionali delle pratiche motorie.
Riconoscere e applicare le diverse capacità motorie elaborando esercitazioni che permettono di
migliorarle.
Utilizzare strumenti di osservazione, monitoraggio, misurazione e valutazione delle principali attività
e durante i giochi di squadra;
Osservare e interpretare criticamente i fenomeni legati al mondo dell’attività motoria, del gioco
ricreativo e sportivo, delle pratiche agonistiche e competitive.
Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute intesa come benessere
dinamico, conferendo il significato e valore personale e sociale della pratica motoria e sportiva.
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
Materia
Giorno
Ora
Docente
Argomento
Classe
4al
liceo scienze motorie
05/06/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : Escursione in ambiente naturale e saluti alla
classe.
4al
liceo scienze motorie 29/05/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Uscita didattica in barca a vela
4al
liceo scienze motorie 22/05/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP Verifica sulla forza e metodi di allenamento.
Core stability: importanza della stabilità del bacino come
prevenzione patologie del rachide.
4al
liceo scienze motorie 08/05/2015
scientifico
e sportive
1^
(1)
FAINI
DANIELA
Lezione : Escursionismo: Val dei Mulini. Cosa è il
trekkin.g
4al
liceo scienze motorie 24/04/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP:Resistenza generale: Test di Cooper non
cronometrato sul lungolago
4al
liceo scienze motorie 17/04/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG: Pallavolo consolidati i fondamentali
individuali e di squadra. Gioco
4al
liceo scienze motorie 10/04/2015
scientifico
e sportive
1^
(1)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP: Allenamento alla resistenza generale:
preparazione al test di Cooper.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
42 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
4al
liceoscienze motorie
05/06/2015
scientifico
e sportive
1^ (2)
FAINI
DANIELA
Lezione : Escursione in ambiente naturale e saluti alla
classe.
4al
liceo scienze motorie 10/04/2015
scientifico
e sportive
2^
(1)
FAINI
DANIELA
Lezione : La forza: da cosa dipende,forza assoluta e
relativa. Tipi di contrazione muscolare.Lavoro sulle
andature dell'atletica.Staffetta 4x100. Tecnica del passaggio
del testimone. Concetto di lavoro di squadra.
4al
liceo scienze motorie 20/03/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG: La corsa e le sue diverse modalità.
Approfondimento sulle tipologie di gare di corsa in atletica:
la corsa a staffetta. Provato il passaggio del testimone.
4al
liceo scienze motorie 13/03/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : Torneo di pallavolo con la classe 4A
4al
liceo scienze motorie 09/03/2015
scientifico
e sportive
1^
(1)
FAINI
DANIELA
Lezione : La coordinazione generale e la Forza: stazioni di
lavoro in circuit training con pesi. Gioco
4al
liceo scienze motorie 06/03/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG Allenamento specifico di pallavolo in vista del
torneo d'Istituto: avviamento motorio tecnico, schemi di
gioco e provata la squadra.
4al
liceo scienze motorie 20/02/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG: Es. di handball e fondamentali ind. della
pallavolo: battuta, alzata e schiacciata. Particolare
attenzione alla tecnica di schiacciata.Gioco
4al
liceo scienze motorie 13/02/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP Core Stability: esercizi di percezione
posturale e lavoro di stabilizzazione del bacino come
prevenzione patologie del rachide.Gioco
4al
liceo scienze motorie 06/02/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG Lavoro a stazioni sui fond. dei giochi sportivi
ed es. specifici per gli addominali. Es.specifici con
tamburello e gioco. Vedi pag. 142-143-144
4al
liceo scienze motorie 30/01/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP Le capacità coordinative con la funicella per
migliorare l'agilità e il senso del ritmo.
4al
liceo scienze motorie 16/01/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP Muscoli agonisti,sinergici, antagonisti. es. di
Core stability e di tonificazione con pesi. Studiare
pag.142-143. Gioco:palla prigioniera con specifici ruoli.
4al
liceo scienze motorie 09/01/2015
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG Percorso di agilità e orientamento nello
spazio. Lavoro a stazioni con piccoli e grandi
attrezzi.Gioco
4al
liceo scienze motorie 19/12/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP Valutazione successione personale con i pesi.
4al
liceo scienze motorie 05/12/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP: Consegnate scheda circuit Training e
riprovata la successione:iniziata la valutazione individuale.
4al
liceo scienze motorie 28/11/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG Pallavolo: consolidamento fondamentali
individuali e allenata la squadra del torneo di
istituto.Consegnata scheda della successione sulla Forza
con pesi.Gioco
4al
liceo scienze motorie 21/11/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP: Come strutturare un circuit training
personalizzato. Successione con i pesi.Gioco
4al
liceo scienze motorie 14/11/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG Pallavolo: passaggi, palleggi a coppie,
squadra uff. in campo, ruolo alzatore, battitore,
schiacciatore. Partita.
4al
liceo scienze motorie 07/11/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP:Successione pesi ed es. specifici di
irrobustimento. Come lavorare in circuito. il circuit
training.
4al
liceo scienze motorie 31/10/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG La Mobilità articolare da che cosa dipende:
es. specifici, muscoli agonisti e antagonisti. Lavoro a
stazioni per il consolidamento dei fondamentali ind.dei
giochi sportivi. Gioco:Tamburello a squadre in mezzo
campo.
4al
liceo scienze motorie 24/10/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP Successione pesi individuale da memorizzare
per la valutazione del primo periodo.
4al
liceo scienze motorie 17/10/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG Palla frisbee: es. sui fondamentali del
passaggio in coppia e gioco. L'arbitro siamo noi!
4al
liceo scienze motorie 10/10/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PP: Successione stretching con musica da
memorizzare.Test motori a stazioni e a tempo
misurati.Ultimate Frisbee.
4al
liceo scienze motorie 03/10/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
Lezione : PG Resistenza generale. Il gioco del frisbee e
regolamento specifico. Gioco: palla frisbee
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
43 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
4al
liceoscienze motorie
05/06/2015
scientifico
e sportive
1^ (2)
FAINI
DANIELA
4al
liceo scienze motorie 26/09/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FAINI
DANIELA
4al
liceo scienze motorie 19/09/2014
scientifico
e sportive
1^
(2)
FABBRI
IRENE
Lezione : Escursione in ambiente naturale e saluti alla
classe.
Lezione : PP Saluti alla classe, presentazione del
programma e della griglia di valutazione. Corsa sul
lungolago in preparazione alla corsa campestre.
Lezione : giochi sportivi
- Corsa Campestre*
-Gara di sci*
- Uscita sulla neve e pala-pattinaggio a Folgaria per tutti
- Torneo di Pallavolo, di calcio a cinque e di Basket di istituto*
- Uscita didattica in barca a vela.
- Partecipazione all’organizzazione della fase regionale di atletica leggera dei G.S.S.
- * con partecipazione ai G.S.S.
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
Le metodologie usate e adattate in base all'argomento sono state:
·Lezioni frontali guidate
·Progettazione partecipata nelle attività di piccolo gruppo.
·Jigsaw (allievo esperto che guida un piccolo gruppo)
·Lavoro di gruppo
Dopo aver valutato il livello degli studenti per quanto riguarda le abilità di base, cioè i prerequisiti motori
attraverso test d’ingresso stabiliti in sede di Dipartimento disciplinare, in seguito alla verifica delle
conoscenze disciplinari, sono state individuate le attività pratiche utili per migliorare tali prerequisiti e le
informazioni teoriche per spiegare le finalità delle proposte e motivare maggiormente il lavoro pratico.
La gradualità è stato il criterio costante dell’insegnamento.
Si è cominciato con un approccio globale al gesto motorio per arrivare ad uno studio più analitico del
movimento esercitando una continua azione di controllo di guida e di correzione attraverso lezioni soprattutto
frontali.
Agli allievi sono sempre state comunicate le proposte di lavoro e gli obiettivi da raggiungere.
Diverse dinamiche di gruppo di conduzione e realizzazione delle pratiche hanno favorito la partecipazione
dell’intero gruppo, in particolare, in riferimento all’intensità e alla durata delle pratiche, si è lavorato in
dinamica individuale, di coppia, di piccolo gruppo favorendo l’iniziativa individuale nelle esercitazioni.
4. OBIETTIVI MINIMI
I livelli si riferiscono al grado conseguito (RISULTATI) e ai processi in atto (PROGRESSI)
Gli obiettivi minimi si considerano conseguiti raggiungendo il livello di sufficienza.
EDUCAZIONE FISICA SCIENZE MOTORIE
PARTECIPAZIONE ATTIVA E IMPEGNO
CONOSCENZE
VOTO
• Partecipare in forma propositiva alle dinamiche di gioco e loro realizzazioneC. Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche
mettendo in atto comportamenti collaborativi con il gruppo e laproprie
delle
attività
squadra.
• DILIGENZAmotorie
D.
NEL LAVORO PROPOSTO
•Conoscenza delle regole nella pratica ludica e
PUNTUALITA',
•sportiva
FREQUENZA,
•
COLLABORAZIONE,
• RISPETTO
DEI MATERIALI
NB: Per favorire
l'inclusione e forme di integrazione si osserverà e valuterà il PROCESSO e
l'ampliamento delle AUTONOMIE OPERATIVE.
DIECI
PARTECIPAZIONE attiva e costruttiva ed IMPEGNO costante eAmpie con riferimenti interdisciplinari, usando
propositivo.
terminologie specifiche e corrette.
NOVE
PARTECIPAZIONE diligente e costante, IMPEGNO attivo.
Approfondite e corrette.
OTTO
PARTECIPAZIONE ed IMPEGNO costanti.
Complete, corrette e sicure.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
44 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
SETTE
PARTECIPAZIONE
costante.
discretamente
SEI
PARTECIPAZIONE non sempre attiva e IMPEGNO poco produttivo.
Essenziali, non complete e imprecise.
CINQUE
PARTECIPAZIONE passiva e IMPEGNO discontinuo.
Parziali, incomplete e non precise.
QUATTRO
PARTECIPAZIONE passiva e IMPEGNO scarso.
Non coerenti e inadeguate.
ACQUISIZIONE DEL GESTO
attiva
e
IMPEGNO
abbastanzaEssenziali complete e precise.
CAPACITA' MOTORIE
VOTO
B. Consolidamento e coordinamento degliA. Potenziamento fisiologico (mobilità
schemi motori di base (abilità motoria e articolare,
forza,
velocità,
motricità espressiva)
•resistenza);
• Saper
Acquisire consapevolezza delle dinamiche applicare gesti e schemi d’azione per
e dei processi fisici e psicologici provocatirisolvere un determinato problema
dai cambiamenti delle funzioni fisiologichemotorio, riproducendo o ideando forme e
conseguenti
all’attivitàprocessi di movimento efficace.
motoria.
•
•
Conoscere e applicare tecniche gestualiPRESTAZIONI
NELLE
PROVE
espressive.
•OGGETTIVE,
RILEVAMENTO
Padroneggiare
molteplici
capacità METRICO (MISURE E TECNICHE
coordinative adattandole alle situazioniESECUTIVE)
RISULTATI
E
richieste della pratica motoria: con l’uso diPROCESSI
(TEST
oggetti, in dinamiche specifiche di gioco. STANDARDIZZATI,
CHECK-LIST,
MONITORAGGI).
DIECI
Efficace, naturale
(cap. di transfert)
NOVE
Finalizzata e spontanea.
OTTO
Corretta in
applicazione.
SETTE
Complessivamente corretta.
DISCRETE
SEI
Parzialmente corretta.
SUFFICIENTI
CINQUE
Non corretta, vari errori esecutivi.
DIFFICOLTOSE
QUATTRO
Non presente.
INCERTE NUMEROSI ERRORI
Non controllata e casuale.
CAOTICHE
CONTROLLATE
e
personalizzata. ECCELLENTI
seguito
TRE
OTTIME
a
costante BUONE
E
POCO
5. MATERIALI DIDATTICI
Per il raggiungimento di alcuni obiettivi si è valutata l’opportunità di utilizzare supporti tecnici quali sintesi
grafiche, MC , accompagnati da materiali didattici come liste, esempi di test metrici, griglie di osservazione,
check-list, presentazioni e testi scritti per l'approfondimento.
I materiali e gli attrezzi della palestra e degli impianti a disposizione sono stati utilizzati per le varie attività
nelle pratiche e nelle attività sportive proposte.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione si sono distinti in tre diversi momenti:
1) Il momento dell’oggettiva misurazione individuale delle variazioni raggiunte rispetto alla base di partenza,
osservazioni, monitoraggio e misurazioni metriche ed edumetriche.
2) La valutazione della comprensione concettuale delle proposte, anche utilizzando produzioni scritte.
3) Il momento della valutazione quadrimestrale espressa con un voto che integra la valutazione del profitto
con giudizio sul grado di applicazione, interesse, continuità e partecipazione all’attività didattica e
conoscenze dei contenuti appresi.
Agli allievi sono stati illustrati gli strumenti di monitoraggio, osservazione e valutazione (prestazioni,
conoscenze, abilità tecniche, comportamenti) e presentata la Scheda di osservazione Periodica utilizzata e
condivisa con i colleghi del coordinamento per materia ed approvata dal Collegio dei Docenti che comprende
l’osservazione e la valutazione delle dinamiche sociali attivate e delle autonomie operative manifeste.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
45 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
In alcuni momenti della didattica alcuni allievi hanno utilizzato i materiali di osservazione e valutazione del
gruppo.
Si è cercato di guidare gli allievi verso una capacità di auto-osservazione critica e auto-valutazione. Agli
allievi provvisti di esonero temporaneo o permanente all’attività pratica si è richiesta una partecipazione
attiva alle lezioni, collaborando, arbitrando o anche approfondendo i contenuti stessi della lezione.
In alcuni momenti si chiesto loro di monitorare e valutare le attività e le dinamiche di gioco in corso.
Garda, 10/06/2015
Firma
Daniela Faini
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
46 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
Classe 4A LICEO
Materia RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE
Anno scolastico 2014/2015
Prof/Prof.essa PACHERA RICCARDO
1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I
SEGUENTI OBIETTIVI
gli studenti hanno saputo :
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;
2. cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del
mondo contemporaneo;
3. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.
1.1 Conoscenze
gli studenti
1. hanno studiato la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero
filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;
2. hanno approfondito, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza,
trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;
3. conoscono, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione
ecologica e sviluppo sostenibile.
1.2 Competenze e capacita
gli alunni
1. sanno confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana,
nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo;
2. sanno descrivere l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che
esso ha prodotto nei vari contesti sociali;
3. hanno operato criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo.
22/06/2015 9.22
Programmazione Finale per classe
47 di 47
https://suite.sogiscuola.com/documenti_web/VRIS017001/documenti/1...
2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPRESSI PER UNITA DIDATTICHE, MODULI, PERCORSI O
ARGOMENTI TRATTATI CON I RISPETTIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE(PROGRAMMA
EFFETTIVAMENTE SVOLTO
E TEMPI DI ATTUAZIONE)
1. Dio e i diversi modi di pensarlo e viverlo
2. La coscienza e tematiche legate ad essa (giustizia e pace, libertà e fraternità)
3. Introduzione all’Etica
4. L’etica cristiana anche in relazione a problematiche morali di attualità
3. METODOLOGIE E EVENTUALI MODALITA DI RECUPERO
In consonanza con la scelta degli obiettivi e dei contenuti, e con attenzione alle capacità logiche e agli
interessi degli studenti, si è fatto uso di:
Lezioni frontali attraverso il libro di testo, liberamente usato, e materiale proposto dal professore,
oppure in riferimento a temi di attualità
Lezioni attraverso materiale audio, video e cartaceo utilizzato come stimolo per suscitare interrogativi
e riflessioni
Lavori di ricerca a carattere individuale e/o di gruppo.
4. OBIETTIVI MINIMI
1-arrichire il proprio lessico religioso riguardo al tema dell'etica;
2-individuare il processo di acquisizione dell'identità, dell'autonomia, della responsabilità come centrali nella
crescita verso la maturità;
3-sensibilizzare ai valori della solidarietà, equità, politica come bene comune, incontro con le diversità
(etniche, religiose, culturali, umane), legalità;
5. MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo
Articoli di giornale/riviste/internet
Materiali video e audio
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
il conseguimento o meno degli obiettivi si è verificato attraverso i seguenti strumenti:
L’attenzione prestata in classe
La partecipazione al dialogo e al confronto educativo in classe
La realizzazione di un lavoro e/o ricerca scritti e/o orali da esporre e presentare poi in classe
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alla Griglia di valutazione concordata nel dipartimento
per materia e approvata dal Collegio Docenti.
22/06/2015 9.22