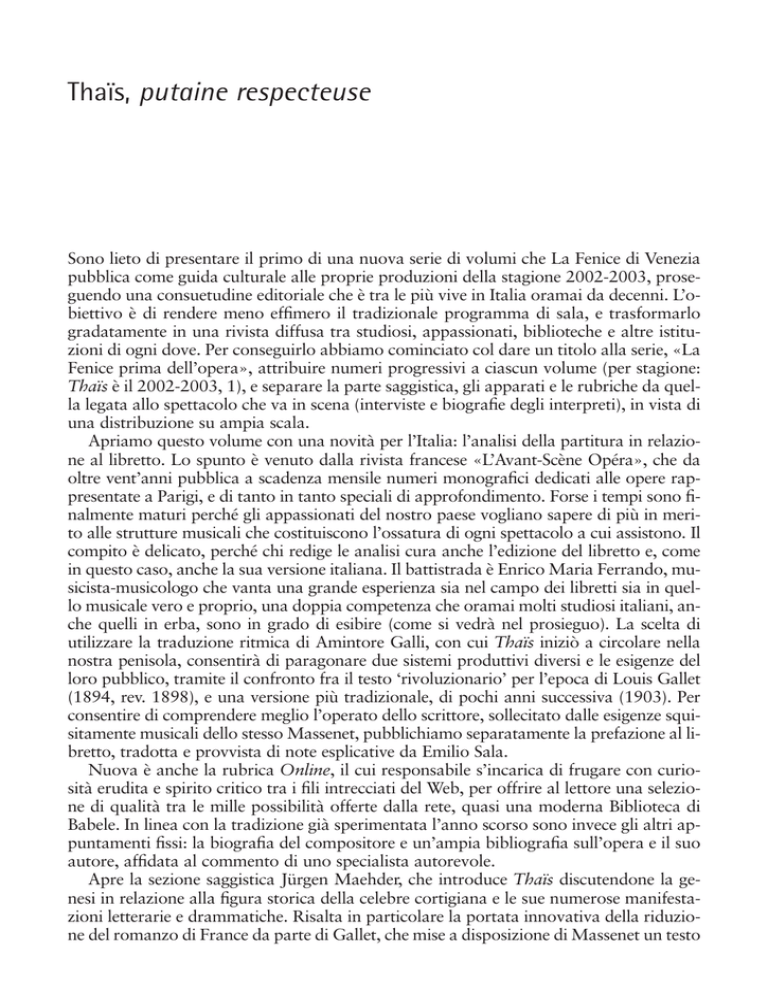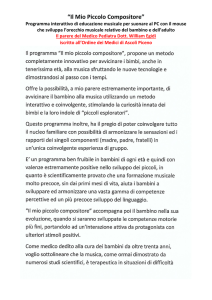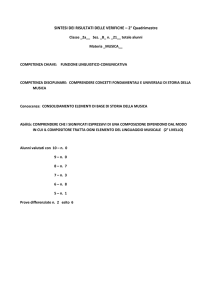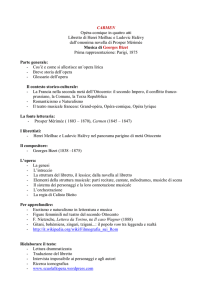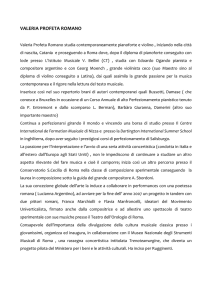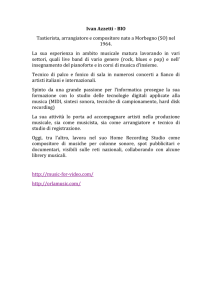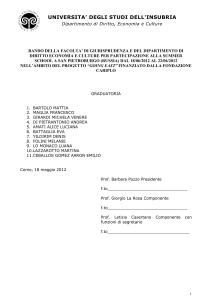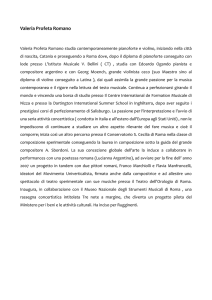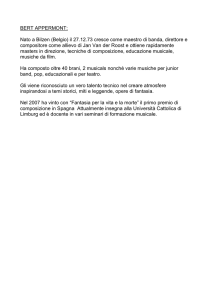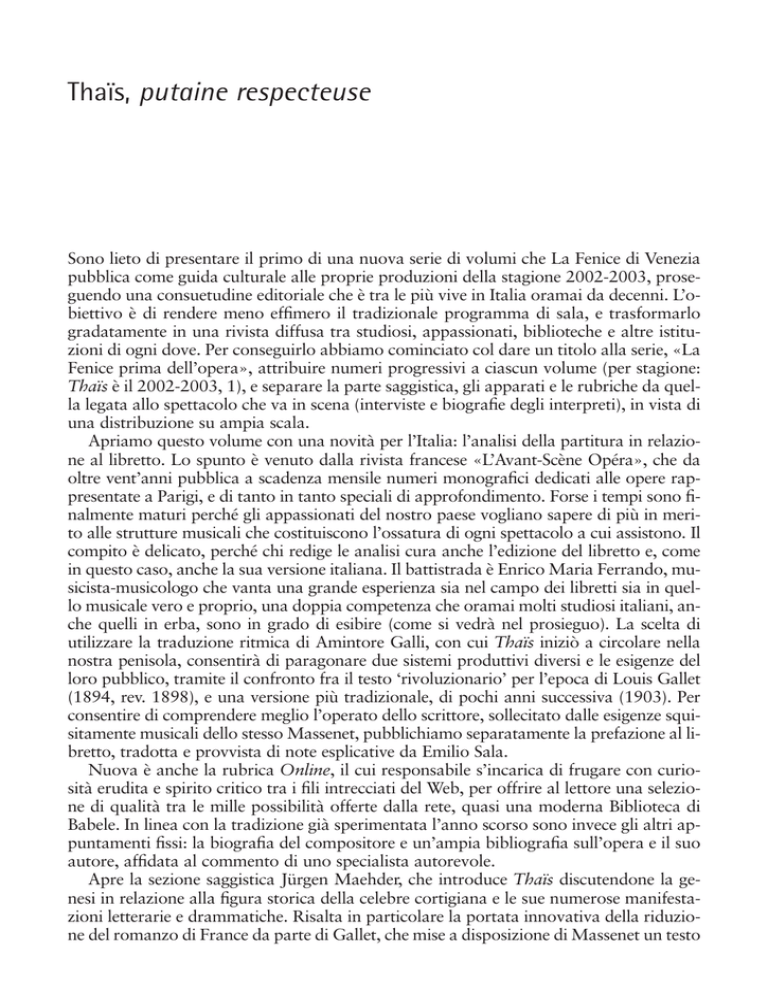
Thaïs, putaine respecteuse
Sono lieto di presentare il primo di una nuova serie di volumi che La Fenice di Venezia
pubblica come guida culturale alle proprie produzioni della stagione 2002-2003, proseguendo una consuetudine editoriale che è tra le più vive in Italia oramai da decenni. L’obiettivo è di rendere meno effimero il tradizionale programma di sala, e trasformarlo
gradatamente in una rivista diffusa tra studiosi, appassionati, biblioteche e altre istituzioni di ogni dove. Per conseguirlo abbiamo cominciato col dare un titolo alla serie, «La
Fenice prima dell’opera», attribuire numeri progressivi a ciascun volume (per stagione:
Thaïs è il 2002-2003, 1), e separare la parte saggistica, gli apparati e le rubriche da quella legata allo spettacolo che va in scena (interviste e biografie degli interpreti), in vista di
una distribuzione su ampia scala.
Apriamo questo volume con una novità per l’Italia: l’analisi della partitura in relazione al libretto. Lo spunto è venuto dalla rivista francese «L’Avant-Scène Opéra», che da
oltre vent’anni pubblica a scadenza mensile numeri monografici dedicati alle opere rappresentate a Parigi, e di tanto in tanto speciali di approfondimento. Forse i tempi sono finalmente maturi perché gli appassionati del nostro paese vogliano sapere di più in merito alle strutture musicali che costituiscono l’ossatura di ogni spettacolo a cui assistono. Il
compito è delicato, perché chi redige le analisi cura anche l’edizione del libretto e, come
in questo caso, anche la sua versione italiana. Il battistrada è Enrico Maria Ferrando, musicista-musicologo che vanta una grande esperienza sia nel campo dei libretti sia in quello musicale vero e proprio, una doppia competenza che oramai molti studiosi italiani, anche quelli in erba, sono in grado di esibire (come si vedrà nel prosieguo). La scelta di
utilizzare la traduzione ritmica di Amintore Galli, con cui Thaïs iniziò a circolare nella
nostra penisola, consentirà di paragonare due sistemi produttivi diversi e le esigenze del
loro pubblico, tramite il confronto fra il testo ‘rivoluzionario’ per l’epoca di Louis Gallet
(1894, rev. 1898), e una versione più tradizionale, di pochi anni successiva (1903). Per
consentire di comprendere meglio l’operato dello scrittore, sollecitato dalle esigenze squisitamente musicali dello stesso Massenet, pubblichiamo separatamente la prefazione al libretto, tradotta e provvista di note esplicative da Emilio Sala.
Nuova è anche la rubrica Online, il cui responsabile s’incarica di frugare con curiosità erudita e spirito critico tra i fili intrecciati del Web, per offrire al lettore una selezione di qualità tra le mille possibilità offerte dalla rete, quasi una moderna Biblioteca di
Babele. In linea con la tradizione già sperimentata l’anno scorso sono invece gli altri appuntamenti fissi: la biografia del compositore e un’ampia bibliografia sull’opera e il suo
autore, affidata al commento di uno specialista autorevole.
Apre la sezione saggistica Jürgen Maehder, che introduce Thaïs discutendone la genesi in relazione alla figura storica della celebre cortigiana e le sue numerose manifestazioni letterarie e drammatiche. Risalta in particolare la portata innovativa della riduzione del romanzo di France da parte di Gallet, che mise a disposizione di Massenet un testo
10
MICHELE GIRARDI
improntato all’inedito principio della «poesia ‘melica’». Adriana Guarnieri allarga l’indagine al contesto estetico dell’Europa di allora e dalla Francia in particolare, dominata dalla voga dell’esotico, collocando Thaïs nell’ambito di quella Décadence che è tratto distintivo delle arti fin-de-siècle. Mercedes Viale Ferrero, invece, prende le mosse da
problemi visivi e scenotecnici per concentrarsi su un tema specifico posto dall’opera: è
possibile rappresentare in modo convincente la ‘santità’ nel teatro musicale?
Credo che tutte le posizioni critiche qui espresse stimoleranno il lettore, come è accaduto a me curando saggi e rubriche: nel mondo d’oggi, in cui tutto torna ciclicamente
d’attualità, anche uno dei perni narrativi di Thaïs, il fanatismo religioso, si ripropone con
enfasi indesiderata. Motore dell’azione, infatti, è un monaco esaltato appartenente alla
setta dei cenobiti, Athaënael, che sconvolge la vita della protagonista, affermata sacerdotessa di Venere in quella ‘mitica’ Alessandria d’Egitto, ricca, còlta e decadente. Preoccupata per la caducità della sua bellezza, l’ammaliatrice si persuade che potrà trovare il vero amore eterno solo tra le braccia di Dio e percorre con avidità, sino alla morte precoce,
una strada lastricata di cilicio e di stenti, lasciandosi alle spalle specchi e alcove.
Permane l’impressione, dopo l’ascolto, che Massenet fosse più interessato, in realtà,
allo scontro fra Sacro e Profano, incarnato da un prete d’aspetto affascinante e da una
putaine respecteuse – la quale è anche una tra più desiderabili e mansuete delle femmes
fatales che popolavano le scene liriche del suo tempo. Il cedimento di Athanaël realizza
lo scioglimento tragico nel finale, quando perde l’oggetto del suo desiderio amoroso più
bruciante e carnale proprio nel momento in cui ha deciso di cedere alla passione. Egli
rinnega con forza la sua fede, inoltre, dopo aver finalmente compreso che non era la missione di pastore d’anime a spingerlo verso Thaïs.
Lo spettatore moderno indovina facilmente l’esito della vicenda: dopotutto, grazie a
Freud, siamo tutti in grado di comprendere il valore di una negazione sin troppo decisa, condita di un’abbondante spruzzata di sadomasochismo (e si veda con quale tenerezza il probo Athanaël, dèdito all’abuso del cilicio, reagisca alla vista dell’esito dei
martìri che lui stesso ha imposto alla futura santa). Ma tant’è: il messaggio dell’eclettico Massenet ha il pregio di essere chiaro, e sostenuto da qualità linguistiche di prim’ordine. Il suo sguardo disincantato di eterno voyeur, che si muove con padronanza tra le
mille trame possibili di mille vicende, non esita a posarsi su un plot che allude, più o meno consapevolmente, a tanti capolavori del passato prossimo. A partire dalla rinuncia a
una vita dorata che apparenta Thaïs a Violetta, cortigiana redenta, e che sfocia nella
consunzione fino all’ultimo istante, in cui entrambe si alzano in piedi, vittime dell’illusione. La lista potrebbe proseguire con la Manon di Puccini, che si trascina morente nel
deserto, ma che prima, da mantenuta di lusso, era stata davanti allo specchio a farsi bella, come la sacerdotessa alessandrina. Con poco sforzo si può persino rammentare quando Des Grieux, protagonista della Manon dello stesso Massenet, si trova finalmente solo (anzi: «seul, seul enfin …») sulle soglie di pronunziare i voti sacerdotali, per poi
soccombere subito dopo alla seduzione della sua eterna compagna e carnèfice.
Ma tutte queste trame, a volte persino lacerti di drammaturgie rimpiante, entrano a
far parte di un gioco ironico di metalinguismi tale da approdare ad esiti drammatici tanto singolari quanto felici, certo fra i più degni di essere considerati dagli studiosi, e celebrati a teatro. Buona lettura, e buon ascolto.
Michele Girardi
La traviata, «Un sogeto dell’epoca»
Il saggio di Mercedes Viale Ferrero, pubblicato nel primo numero di questa serie, a
proposito della cortigiana redenta Taide, si concludeva con una riflessione generosa di
suggestioni, mi pare, anche in questo diverso contesto; per cui vorrei ripartire da lì:
in quale quadro scenico sarà possibile rappresentare la santità? Sorge il dubbio che il quadro più efficace sia la spoglia stanza in cui muore Violetta, cortigiana redenta dall’amore e
non dal pentimento.1
Il dubbio, più che legittimo, fa vedere in controluce una punta d’ironia amara nella
valutazione etica della protagonista: Violetta, spiega Fabrizio Della Seta nel saggio
qui pubblicato, «muore, sì, perché siamo in una tragedia, ma non ci appare affatto
redenta perché non ha nulla da cui redimersi» (p. 73).
Scegliendo La Dame aux camélias Verdi si proponeva, tra l’altro, lo scopo coraggioso di fissare nell’eternità della musica un episodio di attualità, cioè la fine di Marie Duplessis, morta nel 1847 a soli ventitré anni. La mitica Alphonsine Plessis, questo il suo nome vero, era molto in vista nella società parigina e intellettuali e artisti
la circondavano di continue attenzioni. Tra loro figurava il suo biografo-amante
Alexandre Dumas fils, che l’aveva definita come «une des dernières et des seules courtisanes qui eurent du cœur». Le sfide avevano sempre attratto Verdi, il quale appena
due anni prima aveva proposto ai veneziani Rigoletto, da lui stesso collegato idealmente a La traviata in una lettera a De Sanctis del 1° gennaio 1853:
A Venezia faccio la Dame aux Camélias che avrà per titolo, forse, Traviata. Un sogeto dell’epoca. Un altro forse non l’avrebbe fatto per i costumi, pei tempi, e per mille altri goffi
scrupoli [...] Tutti gridavano quando io proposi un gobbo da mettere in scena. Ebbene io
era felice di scrivere il Rigoletto.2
«Un sogeto dell’epoca»: Verdi intendeva rappresentare l’attualità anche nella messa
in scena, per mettere in pieno risalto uno dei temi centrali del nuovo lavoro: la critica
corrosiva alle abitudini ipocrite della società borghese di allora. Poco importa che egli
non sia riuscito a realizzare il suo proposito, sia per la prudenza del librettista Piave (il
quale, per evitare guai con la censura, aveva retrodatato l’azione «A Parigi e sue vicinanze, nel 1700 circa»), sia perché gli artisti del coro, «reclutati di solito fra le rammendatrici, i venditori ambulanti, i bancarellisti», non erano in grado di vestire con
1 MERCEDES VIALE FERRERO, La santità sulle scene teatrali, in Jules Massenet: «Thaïs», «La Fenice prima dell’opera», 2002-2003, 1, pp. 107-120: 120.
2 FRANCO ABBIATI, Giuseppe Verdi, 4 voll., Milano, Ricordi, 1959, II, p. 189.
10
MICHELE GIRARDI
proprietà gli abiti eleganti che indossavano i borghesi.3 Non solo il messaggio conserva la sua efficacia, ma ne risulta amplificata la portata universale: una società ipocrita
abbandona a se stessa una donna, già protagonista di feste, convivi, alcove e quant’altro, solo perché coraggiosamente vive l’amore vero tra le braccia di un coetaneo, causando scompiglio tra le fila di chi vuol solo divertirsi senza mai mettersi in gioco.
Solo il dottor Grenvil rimane al fianco di Violetta, quando tutta Parigi impazza per il
Carnevale, e lei sta spegnendosi in povertà. Nella guida musicale all’opera, Marco Marica mette l’accento sulla solitudine della protagonista e su ciò che l’ha causata, non limitandosi all’analisi di astratte strutture, ma traendo da libretto e partitura considerazioni
più ampie di drammaturgia musicale. Valga un solo esempio: all’inizio del second’atto,
dal suo fulmineo ritratto Alfredo Germont si rivela inequivocabilmente troppo occupato
a «dar sfogo al “giovanile ardore” per comprendere che per una donna come Violetta,
abituata a fare l’amore a pagamento, l’amore vero non ha prezzo» (p. 25).
La solitudine di Violetta primeggia a partire dalla copertina ideata da Marco Riccucci per questo numero, dove la si vede, di spalle rispetto ai convitati, mentre in alto
viene inquadrato il suo doppio, come se di fronte a lei stesse proprio quel «popoloso
deserto che appellano Parigi», ma che in realtà può esistere ovunque, in ogni occasione in cui la società è intrisa di valori falsi e perbenisti. Un esempio felice di come un’interpretazione scenico-registica intelligente (si tratta dello stesso allestimento offerto al
pubblico veneziano in queste recite di dicembre) sappia tradurre visibilmente un risvolto etico connaturato all’opera.
Fabrizio Della Seta apre la sezione saggistica descrivendo, con parole chiare che
hanno il dono della profondità, quel laboratorio drammaturgico-musicale verdiano in
cui è nata La traviata. Oltre a guidare il lettore nel rapporto tra la fonte e l’opera, egli
fa capire, con pochi esempi, quale sia il fine autentico dell’edizione critica. Chi può dirlo meglio di lui, che ha curato la partitura che sentiremo a teatro? Se il quadro rimane quello, molti dettagli sono rifiniti diversamente, ci appaiono colori diversi: il revisore si è quasi trasformato in un restauratore di pitture. Guido Paduano dedica poi la
sua attenzione all’intreccio, scandagliato con raro acume, e alle sue implicazioni, cogliendo fulmineamente sin dall’inizio aporie produttive, come quel «Misterioso altero» che «definisce l’amore nel libretto della Traviata, se pure può chiamarsi definizione ciò che predica l’inconoscibilità dell’oggetto definito» (p. 81). Marco Marica,
infine, concentra a sua volta l’attenzione su pellicole recenti, in particolare Moulin
rouge, mettendole in relazione con La traviata: concludendo che, cambiati i tempi, i
valori autentici hanno perduto gran parte della loro vitalità. Nel passaggio alla celulloide, Violetta non sa restituirci il fascino con cui seduce il pubblico dell’opera.
Chiudono il numero le consuete rubriche. La bibliografia è particolarmente ricca di titoli, anche per il fiorire delle celebrazioni del centenario della morte di Verdi (2001). Evento non del tutto privo di prezzi da pagare in termini di qualità, come spiega il nostro Caronte informatico, Roberto Campanella, che ci offre un meditato percorso nel Web,
mettendo al primo posto, come l’altra volta, le esigenze culturali degli utenti della Rete.
Michele Girardi
3 JOHN ROSSELLI, Sull’ali dorate. Il mondo musicale italiano dell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1992,
p. 83.
Kát’a Kabanová, una tragedia in riva al Volga
Siamo al terzo appuntamento della stagione 2002-2003 alla Fenice, e per la terza volta, dopo la sacerdotessa di Venere Thaïs, ‘redenta’ e santa, e la demi-mondaine Violetta Valéry, il sipario si spalancherà su un personaggio femminile di straordinario interesse. Molto diversa dalle altre due, Katerina o Káta, non solo perché è situata
geograficamente lontano, ad Est (sul Volga) e parla il cèco, ma anche perché chiude volontariamente la propria esistenza in violenta antitesi col mondo che la circonda. «Intorno, silenzio e pace. Che incanto! E io devo morire?», queste le ultime parole pronunciate, prima di cercare la sua tomba nel grande fiume, utopica pace della natura
contro l’orrore di una vita trascorsa come prigioniera di convenzioni sociali meschine,
bigotte, autoritarie. Quando il suo corpo verrà ripescato dal Volga, la sua implacabile
torturatrice Kabanicha (quasi un mostro ‘espressionista’, come la Kostelnicka del primo successo, Jenufa) rivolge ai presenti, inchinandosi in ogni direzione, la cinica battuta conclusiva: «Grazie, brava gente, vi ringrazio per il vostro aiuto!».
Káta Kabanová è uno dei capolavori di Leos Janácek, tra i sommi drammaturghi
in musica di tutti i tempi, certo uno dei più originali. Prese le mosse dalla realtà sociale
e linguistica morava, in cui era nato e cresciuto, per consegnare gli intrecci più disparati all’opera europea fin-de-siècle, dal genere ‘eroico’ (Sárka) al fantastico (La volpe
astuta, Broucek) fino al suspence modernista intriso di magìa (Il caso Makropoulos).
Ma fu sempre attento a immettere nel proprio teatro, e più generalmente in tutta la
sua musica, quei tratti di aderenza alla realtà che erano stati tra le caratteristiche fondamentali degli scrittori russi ottocenteschi: da Dostoevskij viene l’ultima opera (Da
una casa di morti), e da Ostrovskij, drammaturgo caro anche a Cajkovskij, la nostra
Káta Kabanová. Realtà significava per lui, in primo luogo, la trasfigurazione delle inflessioni del parlato in tessuto melodico, tanto che, per quanto scrupolosa, nessuna
traduzione può rendere il senso di una lingua fondante l’espressione musicale.
In questo volume si possono leggere due brevi scritti del compositore, intento a cogliere e a trasferire su carta i suoni della vita, dal belato alle conversazioni spicciole,
che la coscienza poi elabora. Ottima penna, Janácek aveva esercitato a lungo la critica musicale, e prodotto scritti teorici di rilievo. A Brno si era imbattuto in Cavalleria rusticana, di cui aveva lodato la «modernità armonica»,1 apprezzamento che rivela la sua conoscenza del panorama musicale coevo al di là di ogni barriera e di ogni
pregiudizio. Si veda qui (nell’Inizio di un romanzo) il garbato ammicco a Puccini:
«aspettava in piedi, che lui arrivasse o non arrivasse? Butterfly?», ma si rifletta sul fatto che sia Káta sia Cio-Cio-San sono protagoniste di storie di solitudine. Altère ri1 Cavalleria rusticana (1892), in FRANCO PULCINI, Janácek. Vita, opere, scritti, Firenze, Passigli, 1993,
pp. 287-88: 287, l’unico, ma fondamentale contributo italiano, sul compositore.
10
MICHELE GIRARDI
spetto alla realtà che le circonda e incomprese nel loro stesso milieu – e si legga, a
questo proposito, il bell’articolo che apre la sezione saggistica, firmato da Alessandro
Roccatagliati –, entrambe sono al centro di una sintassi del tragico modernamente rivissuta sino al suicidio conclusivo, vero e proprio sacrificio con cui le eroine rendono al mondo l’equilibrio, sconvolto dal loro agire; e un senso: quello della bellezza
delle loro anime come della musica che le racconta (cui accenna anche Pountney, regista dell’attuale produzione). Si consideri, inoltre, la situazione del finale II di Káta
Kabanová, dove la coppia felice e spensierata, Varvara e Kudrjás, fronteggia in una
sorta di quartetto che è, in realtà, un doppio duetto, quella degli amanti seri e tormentati, Katerina e Boris: come non pensare al finale III di Bohème?
Janácek, del resto, fu detto il Puccini cèco, per l’affascinante lirismo e l’intensa teatralità delle sue melodie, ma l’analogia tra i due è ben più profonda: entrambi miravano al ruolo di operista ‘popolare’, senza rinunciare agli esperimenti musicali, obiettivo che li portò ad attuare soluzioni linguistiche insospettabilmente avanzate. Per
capire sino a che punto si spinga Janácek, pubblichiamo un secondo saggio, dove
Paul Wingfield conduce un’analisi tutta centrata sull’applicazione di un insieme di altezze, quello ottatonico, in quella che è una semplice musica di scena, la canzone ‘dell’attesa’ di Kudrjás in apertura del secondo quadro dell’atto II. Chi avrà la pazienza
di seguire il ragionamento scoprirà di quali ‘arditezze’ segrete sia fatta una drammaturgia viva e comunicativa, e di quali significati, destinati all’inconscio dello spettatore, sia latrice una scelta ‘tecnica’.
Riccardo Pecci, autore della guida musicale all’opera, ha curato contestualmente
l’edizione di un libretto che, come lui stesso spiega (e Roccatagliati ribadisce poco oltre), è nato dalla partitura, poiché Janácek prelevò direttamente dalla traduzione cèca dell’Uragano, di cui si servì, le battute dei personaggi e le didascalìe. Per questa sezione e per l’argomento abbiamo mantenuto la traslitterazione adottata da Sergio
Sablich, brillante traduttore del libretto in occasione delle recite fiorentine della Kabanová (1989), mentre altrove abbiamo scelto la grafia originale dei nomi cèchi. Dato il contenuto semantico dell’ouverture, pubblichiamo come premessa al libretto
un’ampia analisi di questo pezzo, dove si ode in nuce la parabola drammatica della
protagonista, e «il destino della sposa di Tichon, – come osserva Pecci – insomma, è
segnato».
«Fu felice Leos?», si chiede con ironico affetto il nostro Caronte informatico Roberto Campanella: certo ora è finalmente venuto il suo tempo nei teatri di tutto il
mondo, dove i suoi lavori sono acclamati dal pubblico di ogni latitudine.
Michele Girardi
Il bordeaux di un amabile ciarlatano
Dopo tre drammi umani declinati al femminile e in tre lingue diverse (francese, italiano
e cèco), ben venga la prima pausa ‘leggera’ della stagione veneziana, certo L’elisir d’amore non si può ascrivere al buffo tout-court, specie dopo che Rossini, con Il barbiere
di Siviglia, aveva trascinato il genere negli abissi di un comicità delirante, talmente irresistibile da ostacolare sviluppi ulteriori in quella direzione.
Bisognava imboccare altre strade, quindi, e per il capolavoro di Donizetti è più appropriata la definizione di «opera di mezzo-carattere», in armonia con le origini del soggetto – Le philtre di Scribe per Auber, fresco di debutto (1831) e còlto al volo da Felice Romani per Gaetano Donizetti.1 Alessandro Di Profio ci spiega che il compositore
«scelse il libretto francese come passepartout per una carriera internazionale» (p. 77),
per poi illustrare i numerosi argomenti che confermano la sua tesi.
Del resto, che l’elemento sentimental-patetico giochi un ruolo preminente ce lo dicono le orecchie e il cuore, ma solo se canta Nemorino. Quando Adina prende la decisione di anticipare le nozze col tronfio Belcore, la melodia del tenore si fa quasi disperata,
in un gioco di rimandi che va ben oltre la situazione visibile in scena. «Adina, credimi,
te ne scongiuro …» (I, X) è un’invocazione in Fa minore degna di un’opera seria, che nel
passaggio al relativo maggiore, La bemolle («Domani, o cara, ne avresti pena») intensifica la temperatura emotiva. Solitamente la sfera del sentimental-patetico nell’opera italiana dell’Ottocento era appannaggio dei personaggi femminili, mentre qui è incarnata
da un maschio: a che si deve una tale anomalìa? Emanuele Senici si pone il quesito, concentrandosi su «Una furtiva lagrima», che ingemma L’elisir d’amore di un fascino melodico che ha pochi riscontri, e arriva a conclusioni che raggiungono un punto di vista
senz’altro innovativo. Pur lasciando al lettore il piacere di scoprirle, una breve anticipazione non può che dimostrarne l’originalità: «disegnare un personaggio maschile come
incarnazione della vena patetica e sentimentale in un’opera significa quindi per forza di
cose assegnargli delle caratteristiche femminili» (p. 68).2
Il candore quasi virginale di Nemorino risalta nel contrasto con gli altri personaggi, a
cominciare dal rozzo Belcore, rivale macho dileggiato dagli autori sin dalla sua prima uscita, una cavatina i cui richiami intertestuali al brano analogo del cameriere Dandini nella
rossiniana Cenerentola (1817) non dovrebbero proprio sfuggire. Lo rileva Giorgio Pagannone, che cura l’edizione del libretto e redige una guida all’ascolto che ha proporzioni e dignità saggistiche, specie perché si vale dei dati che emergono dall’analisi per trarne conclusioni di autentica drammaturgia musicale. In particolare, il giovane studioso segue con
attenzione il controverso rapporto tra i due protagonisti. La subordinazione di Nemorino,
1 La traduzione italiana di Le philtre è stata già pubblicata nel programma di sala del Teatro La Fenice dedicato a L’elisir d’amore (Venezia, 1983). Ora la si può rileggere, col testo francese a fronte, in L’elisir d’amore, Milano, Teatro alla Scala-RCS Rizzoli, 2000-2001, pp. 107-153 (programma di sala).
2 Si pensi alla Sonnambula di Bellini (1831), altro soggetto di derivazione francese, dove il sentimental-patetico coinvolge sia Amina sia Elvino.
10
MICHELE GIRARDI
ad esempio, emerge sin dal primo duetto, quando «ripete pedissequamente i motivi esposti da Adina»: rivelandosi «troppo arrendevole, mostra la sua incapacità di essere se stesso
di fronte a lei, e quindi rafforza l’immagine di perdente» (p. 20).
Adina, dal canto suo, è una tra le tante donnine frivole, a volte spietate in amore, con
cui Donizetti ha allestito una galleria ben nutrita. Instaura un rapporto biunivoco col
partner, quasi tra ‘carnefice’ e ‘vittima’ (e lo deve pure constatare con un filino d’amarezza quando le sorti si capovolgono all’improvviso: «O amor, ti vendichi di mia freddezza; / chi mi disprezza – mi è forza amar.»; II, VI), che Donizetti spingerà ben oltre le
semplici esigenze delle trame buffe, quando Norina, come ricorderà il pubblico del Malibran che ha assistito al Don Pasquale nella stagione passata, schiaffeggia il povero vecchiotto scimunito in cerca di moglie.
Nella costellazione dei personaggi il dottor Dulcamara rappresenta l’elemento buffo
con l’autorevolezza degna senz’altro dei suoi parenti rossiniani. Squilla la cornetta dal
suo cocchio dorato, e subito i paesani appaiono soggiogati, togliendosi berretti e cappelli, come dovessero entrare in chiesa. Il suo segreto? Quello di tutti i grandi ciarlatani di ogni epoca: spacciare l’illusione, che ha sempre avuto, e sempre avrà, un mercato
vastissimo presso gli ingenui. Si leggano i versi della sua cavatina (I, V, pp. 21-23), esempio straordinario della vis comica di Felice Romani, per constatare che gli assurdi problemi di cui assicura la soluzione sono sempre gli stessi: guarigione da tutti mali («io
spazzo gli spedali»), calo del desiderio virile («un uom, settuagenario / e valetudinario,
/ nonno di dieci bamboli / ancora diventò.»), restauro dell’avvenenza femminile («O voi,
matrone rigide, / ringiovanir bramate?»), «fino il mal di fegato, / che in moda diventò.».
Parole magiche, basta sostituire al ‘mal di fegato’ qualche altra magagna, oggi maggiormente in auge, e il gioco è fatto.
I Nemorini e le Adine ricorrono ciclicamente, e magari la donna capricciosa e volubile («legge, studia, impara», è dunque in carriera), o l’uomo sentimentale e insicuro
(«Io son sempre un idïota / io non so che sospirar»), magari oggi sono di moda, ieri e
domani no, a seconda dei capricciosi ed effimeri cambiamenti del costume. Ma i tipi come l’irresistibile mascalzone Dulcamara, non vanno mai in pensione: si frughi nella cronaca di tutti i giorni, in ogni categoria sociale, e si troveranno esempi a bizzeffe di suoi
intramontabili colleghi. Donizetti e Romani lo sapevano, ed è per questo che, in omaggio al titolo, affidano proprio al dottore la conclusione dell’opera, riprendendo la musica di quella «barcaruola a due voci» intonata nel contesto di un matrimonio di cartapesta che vela la strada della felicità a una donna che ritiene «pazzia l’amor costante»,
ma non sogna altro nella vita:
Rinverdite, rifiorite,
impinguate ed arricchite:
dell’amico Dulcamara
ei vi faccia ricordar.
Ogni imbonitore, prima o poi, presenta il conto: l’importante, per non sentirsi fregati, è
la qualità effettiva di quel che spaccia. Il nostro Caronte informatico, Roberto Campanella, nota come «La boccetta, da cui il povero Nemorino beve con voluttà, […] contiene pur
sempre dell’ottimo Bordeaux che, pur non avendo nulla di magico, sortisce nondimeno il
suo effetto.». Ma Adina lo aveva anticipato: «La ricetta è il mio visino, / in quest’occhi è
l’elisir.». Niente accade, cioè, che non sia già nell’ordine delle cose, ma forse tutti potrebbero aver bisogno di un elisir che corregge ogni difetto per poterlo capire.
Michele Girardi
«Gli uomini! Gesù mio, se volevi davvero che noi si
dovesse resister loro, perché li facesti tanto diversi?»
Già, perché? Buona domanda, quella che si pone l’irresistibile Zerbinetta – e trasmette immediatamente al pubblico: «ad spectatores», recita la didascalia – quando, dopo
le schermaglie amorose di Arlecchino, la giovane viene ‘gratificata’ dall’interesse delle
altre maschere del quartetto (siamo in Ariadne-Oper, e proprio allorché la mescolanza tra il ‘buffo’ e il ‘serio’ entra nel vivo). Del resto poco prima, congedati i compagni,
aveva cercato da donna a donna di consolare Arianna, solitaria nell’isola del suo dolore, davanti alla sua caverna:
Ach, solcher wüsten Inseln sind unzählige
Auch mitten unter Menschen, ich – ich selber,
Ich habe ihrer mehrere bewohnt –
Und habe nicht gelernt, die Männer zu verfluchen!
Ahi… quanti e quanti scogli inabitabili / non v’hanno in mezzo al mondo! Ed io… io stessa / ne ho già abitati molti…, in altri tempi! / Ma non appresi a maledire gli uomini! (Guida all’opera, p. 49)
Non avendo ottenuto effetti apprezzabili con questa perla di saggezza, Zerbinetta si era
poi lanciata nella sua travolgente aria di coloratura. Il brano celeberrimo contiene una
sezione centrale ch’ella dedica a una sorta di elenco cronologico dei suoi amanti pronunciato sul filo della memoria e chiuso senza pruderie con un’adorabile confessione:
Ach, und zuweilen,
Will es mir scheinen,
Waren es zwei!
ahi, e talvolta, / s’io non m’inganno / in sul più bello / erano in due!
Gaiezza in amore, dunque: sarà reale, in tutto quel mare di finzione? E come potrà
suonare agli orecchi d’oggi? Siamo al quinto appuntamento della stagione 2002-2003
alla Fenice, e dopo il bordeaux spacciato come panacea universale dal dottor Dulcamara, i veneziani berranno ai calici del Doktor Strauss, distillatore di un elisir talora
dolciastro, ma certo sempre brillante: Zerbinetta e le maschere sineddoche del ‘buffo’,
Arianna sentinella del ‘serio’, Bacco condiviso tra i due mondi (non scordiamo la prima apparizione come tenore nel Vorspiel, calvo e isterico, dove affibbia un calcio al
Maestro di danza). Su tutti primeggia il Compositore che, sparito dalla scena dopo il
Vorspiel, resta tuttavia presente in quanto creatore dell’Oper a cui assiste il pubblico
in sala; pubblico che recita a sua volta un ruolo, coincidendo di fatto con i convitati
di Monsieur Jourdain, l’anfitrione parvenu nel Bourgeois gentilhomme di Molière, da
cui tutto prende origine.
10
MICHELE GIRARDI
Un congegno metateatrale pregno di raffinati coinvolgimenti emotivi, quello messo
in piedi da Hofmannsthal nell’Ariadne auf Naxos, ma che Strauss modella fortemente
sulla base delle proprie convinzioni, come acutamente rileva Davide Daolmi nel suo
saggio. Il musicista stende un velo di ironia, mantenendo costantemente un magistero
elevatissimo; la sua risposta alle sollecitazioni letterarie, tuttavia, «è solo un’esibizione
di maestria tecnica, non una strada per rinnovare il teatro musicale» (p. 109). Egli gioca con le convenzioni e i linguaggi, mediante rievocazioni talora parodiche talora nostalgiche degli stili, frammiste a citazioni di luoghi celeberrimi della musica, qui discussi
da Virgilio Bernardoni (pp. 81-84) nel primo saggio, in cui sviscera lucidamente le tematiche fondamentali dell’opera.
Abbiamo preferito, per questa edizione del libretto, come per Thaïs, una traduzione
ritmica d’epoca, quella di Ottone Schanzer (1925); scelta che ribadisce come per un italiano, ancora a Novecento inoltrato, il verso e la lingua aulica continuassero a costituire un primato indiscusso. Marco Marica, come Riccardo Pecci per Káta Kabanová,
premette alla guida musicale l’analisi della densissima introduzione orchestrale (pp. 1517), per poi districare meglio i fili di una partitura che è un vero intreccio labirintico.
Ariadne auf Naxos è forse il prodotto più riuscito tra tutta una serie di opere europee fin-de-siècle (anche del tutto diverse, sotto il profilo estetico, come la commedia
dei Pagliacci di Leoncavallo), dove rappresentava il teatro nel teatro. Se ne era ricordato Puccini quando, cercando modelli scenico-registrici per i tre ministri-maschere di
Turandot, scrisse al librettista Adami (8 ottobre 1924) che «nell’Arianna di Strauss a
Vienna s’è fatto colle maschere italiane qualcosa di simile» a quello che aveva in mente lui. Diversissimo, tuttavia, l’atteggiamento dei due compositori: Puccini, che voleva
realizzare «l’inverosimile umanità del fiabesco» e conciliare in un disegno formale superiore la compresenza di generi diversi, nutriva ancora una fiducia nel rinnovamento del genere opera, che Strauss si era già lasciato dietro le spalle.
Come nota il nostro Caronte informatico, Roberto Campanella, «la Weltanschauung
straussiana è strutturalmente costituita da contraddizioni all’apparenza inconciliabili,
ma che, alla fin fine, si integrano mirabilmente» (p. 121): ‘serio’ vs ‘buffo’, Arianna vs
Zerbinetta… Forse, nel ritrarre la capocomica, Strauss si era innamorato al volo, come
il suo Compositore, di una donna talmente schietta da descrivere così l’effetto di un nuovo amante:
120
Zerbinetta
Als ein Gott
kam je
der
Quale un Dio ciascun incedeva
ge gan
gen
und sein Schritt schon
machte mich stumm,
e al suo passo ammutolivo
Michele Girardi
«Allons, enfants de la Patrie!»
Troppe rivoluzioni, di per sé legittimate da situazioni estreme di oppressione, sono degenerate in ‘regime’, e quella francese, madre di tutte le rivoluzioni moderne, non fa eccezione. Ma le funebri carrette, che caricano condannati di ogni ceto per portarli alla ghigliottina, non costituiscono un problema per il poeta Andrea Chénier e l’aristocratica
Maddalena de Coigny, fidanzati con la morte. Al contrario: piombando sul loro collo la
lama li unirà per sempre.
Maddalena non è la prima eroina del melodramma che s’immola volontariamente per dividere la sorte del proprio uomo: l’indimenticabile Aida si era nascosta nella tomba destinata a richiudersi su Radames, condannato a morire per consunzione. «T’aveva il cielo per
l’amor creata / ed io ti uccido per averti amata», canta dolcemente il tenore verdiano, per
poi ribellarsi alla sorte nell’udire il canto dei sacerdoti che segna la fine per entrambi («Né
le mie forti braccia / smuovere ti potranno o fatal pietra»). Mentre gli amanti in basso (la
scena è ripartita su due piani orizzontali) sussurrano il loro addio alla vita, Amneris, l’antagonista, resta sola in alto tra gl’incensi, a invocare una pace utopica.
Anche per Andrea e Maddalena la morte è l’unico modo per realizzare una felicità
amorosa, negata dall’interesse degli uomini di potere; salgono sulla carretta radiosi, cantando «La nostra morte è il trionfo dell’amore». Le regole del tragico si capovolgono e la
morte diventa paradossalmente l’unico lieto fine concesso, mentre noi ci chiediamo dove
siano finite le aspirazioni alla giustizia sociale che il giovane poeta aveva pur sfoggiato nell’Improvviso, franate sotto il peso dell’Amore – «Eterna Canzone!» secondo Gérard. Ci
domandiamo poi perché si passi così repentinamente dal palazzo d’aristocratici dell’inizio, dove i servi vengono duramente oppressi, a una piazza dove si sono trasformati in
carnefici sanguinari (e così rimarranno sino ai fumi del tribunale rivoluzionario e agli
squallori del carcere). Nonostante l’ellissi temporale – cinque anni separano i primi due
quadri (1789 e 1794) – le due situazioni vengono recepite dal pubblico in giustapposizione immediata, tradendo un giudizio negativo sulla Rivoluzione Francese, che si lascia facilmente estendere a ogni momento in cui le classi sottomesse si ribellino a una mole insopportabile di ingiustizie.
Tuttavia la situazione politica dipinta nell’Andrea Chénier finisce per essere, nelle mani di Giordano, solo un pretesto per una storia d’amore a tutto campo, pregna di romanticismo anche nel senso della rinuncia agli aspetti più materiali del sentimento (ancora un
a due significativo dal carcere: «Il nostro è amore d’anime!»). Se il compositore non manifestava posizioni politiche particolari (fu però Accademico d’Italia dal 1929, e certo non
sgradito al regime), così non era per Luigi Illica, la cui produzione letteraria e drammatica era sostenuta da un credo sociale perlomeno ambiguo, di taglio anarchico-populista.
Adorava il grande affresco storico à la Sardou – e si pensi al Cristoforo Colombo per
Franchetti (1892) piuttosto che alla riduzione della Tosca per Puccini –, ma non l’utilizzava per sviluppare grandi temi di libertà e giustizia sociale, quanto come mero sfondo.
Tuttavia i suoi libretti sono la manifestazione di un istinto teatrale innato, che fornisce al
10
MICHELE GIRARDI
compositore soluzioni innovative, mentre le sue didascalie sono talmente erudite e esuberanti da potersi paragonare quasi a una sorta di libro di regìa. Anche per questo abbiamo
scelto di pubblicare la versione originale del libretto, che è molto diversa dal testo cantato. Come spiega Giorgio Pagannone, autore della Guida all’ascolto, «è anche dal confronto, e dal contrasto, tra musica e libretto che si può spiegare la drammaturgia dell’opera.» (p. 13): intento che egli persegue, tra gli altri, cogliendo risultati che aprono nuove
prospettive critiche agli studi sul cosiddetto ‘Verismo’ (si veda, per fare un caso, la scelta
di distinguere le sequenze sceniche come parametro d’appoggio all’analisi). I versi omessi
dal compositore a fini musicali (virgolettati dal curatore, perché si possa ben distinguere
il testo intonato) sono moltissimi, tanto che sovente l’impianto metrico originale risulta
sconvolto – e basti leggere in appendice (pp. 64-68) quel che accade all’Improvviso originale, o alla «Grande scena finale» tra i due amanti. Tra i versi virgolettati si trova pure
l’annuncio dell’arrivo degli ospiti da parte del maestro di casa e del maggiordomo, nel primo quadro (p. 23), uno dei tòpoi vincenti di Illica, sperimentato tre anni prima con la scena dell’appello delle prostitute nella Manon Lescaut: evidentemente Giordano voleva evitare ogni possibile ‘parentela’ con Puccini.
Marco Emanuele, invece, indaga con finezza un aspetto decisamente nuovo: come si
costituiscono i principi del maschile e del femminile nell’opera verista? Il risultato ci consente di lasciare alle spalle i soliti luoghi comuni, primo fra tutti che questo repertorio, per
sete di ‘verità’, esibisca valori ‘atletici’ nel canto ad ogni costo. Il maschio protagonista
contagia con toni da orazione gli altri personaggi a cominciare dalla donna, che assume
gradatamente la sua prospettiva. Emanuele giunge a questa conclusione (p. 102):
La storia di Giordano è la storia dell’impossibilità del canto ‘alto’ nell’opera moderna, in cui i
personaggi non contagiati possono a malapena declamare su un motivo melodico ben squadrato in orchestra, costeggiarlo a tratti, ma sempre in maniera subordinata, e più spesso sono confinati al recitativo, al grido disarticolato (la folla), alla dimensione dimessa di un frammento melodico che muore sul nascere (le mercatine), al canto fasullo di secondo grado (le pastorelle), al
canto popolare rivoluzionario che se è in bocca a Mathieu è proprio in bocca a tutti.
Giovanni Guanti, trattando del personaggio-Chénier tra storia e invenzione, traccia un
quadro efficace dell’espressione del genere ‘dramma storico’, rintracciando lucidamente i
precedenti dello Chénier come pièce à sauvetage, ma a rovescio, e confrontandone in particolare gli esiti con i grandi affreschi verdiani dedicati al potere.
Il nostro Caronte informatico, Roberto Campanella, dal canto suo, punta il dito sui «sostenitori di un ritorno all’ordine», che dipinsero i rivoluzionari «alla stregua di spietati assassini», mentre essi agirono «pur sempre nel nobile tentativo di smantellare un sistema di
potere disumano, che si era retto per secoli sul privilegio di pochi e su indicibili sofferenze
di molti» (p. 129). Concordo con la sua opinione, anche quando sostiene che Giordano vada annoverato tra i «sostenitori dell’ordine»: non mi sembra affatto credibile lo Chénier fustigatore, che soccombendo si erge a giudice di un evento più grande di lui, la Rivoluzione;
né mi convince il suo coinvolgimento nella lotta («Sì, fui soldato»). Quasi per difendere interessi di corporazione, Illica si spinge sino a disturbare quel Platone, che bandiva i poeti dalla sua Repubblica – e si vedano le considerazioni di Guanti in proposito (pp. 111-113). Ma
la didascalia funziona come finale solo per il lettore del libretto, ed è certo meglio così: forse ancora troppi sedicenti poeti si rivelano spesso giullari, pronti a rinunciare a qualsivoglia
impegno sociale pur di cantare il nuovo padrone.
Michele Girardi
«Un bell’affare avete fatto voi
con le vostre fanfaronate!» *
Un’altra novità aspetta il pubblico veneziano, come quello italiano tout court, la prima rappresentazione in lingua originale del capolavoro di Gilbert & Sullivan: The
Mikado. La famosa coppia, che ha rinverdito i fasti della musica teatrale inglese in
epoca vittoriana, è uno dei binomi inscindibili nella mente degli appassionati e, come
Stan Laurel & Oliver Hardy, l’uno senza l’altro è poca cosa. Così coautori da indurci ad affiancare i loro cognomi nella copertina.
Certo, Sir Arthur Sullivan in particolare, come spiega Carlo Majer che introduce
brillantemente il lettore nel laboratorio artistico della ‘premiata ditta G & S’, era un
musicista di talento, e si sente: dietro alla sue spumeggianti intonazioni del testo, e alle sfumature della sua orchestra, c’è una preparazione solidissima, che lo portò sino
a lasciare il genere buffo, come già aveva fatto Offenbach, per tentare la strada dell’opera ‘romantica’. Andò male, tuttavia, anche perché (o soprattutto perché) Sir William S. Gilbert, dopo una lite furibonda con l’impresario, non aveva scritto il libretto di Ivanhoe (1891), che sostanzialmente «sembra una via di mezzo fra Ponchielli e
Goldmark», come scrive Majer (p. 86). Del resto: chi potrebbe anche solo immaginare Laurel senza Hardy?
Ma quali furono i segreti della loro irresistibile comicità? Andrea Chegai ci propone la sua chiave di lettura dell’opera ‘giapponese’, iniziando da un fruttuoso paradosso, cioè dalla logica del nonsense, per poi constatare che vi «prevale lo humour
nero: decapitazioni annunziate, seppellimenti da vivi e supplizi nell’olio bollente. Ma
per ogni nuova malaugurata evenienza c’è sempre una scappatoia» (p. 100).
Su tutto regna un’ironia che nulla risparmia, i nobili stizzosi così come i borghesi,
le signorine della buona società e dalle buone maniere sin troppo ansiose di sciamare per il mondo, le befane dai desideri bollenti, e via dicendo. Compare in scena persino un mito della società giapponese, e cioè l’imperatore eponimo, quel Mikado che,
in climi esotici più familiari per noi italiani, (Madama Butterfly) viene solo evocato
quando tra le mani di Cio-Cio-San brilla la spada con cui il padre si è tolto la vita.
Accanto al libretto inglese abbiamo posto la prima traduzione italiana dei numeri
musicali dell’opera, realizzata da Gustavo Macchi che, come scrive Jesse Rosenberg,
il curatore della guida, «riuscì in modo talora virtuoso a cogliere lo spirito del testo
di Gilbert, non esitando a cambiare spesso, e per necessità, il significato delle parole»
(p. 13), mentre abbiamo deciso di rivedere la traduzione dei dialoghi parlati, dove
pulsa l’azione, per renderla più aderente all’originale. Ci motiva la convinzione che
non sarebbe possibile restituire in modo accettabile un testo che pullula di doppi sensi, sovente assai piccanti.
* Ringrazio per la gentile collaborazione Marcella Musacchia (Palermo).
10
MICHELE GIRARDI
Siamo convinti, tuttavia, che oggi molti possano apprezzare direttamente un prodotto finito che ha del magico, dove «l’intelligenza e l’ironia delle parole di Gilbert si
incrociano con la musica di Sullivan liberandola da quel ‘nonsoché’ di asfittico e impacciato», giungendo a un esito «non di rado irresistibile» (Majer, p. 87). E concordiamo ancora una volta col nostro Caronte informatico, Roberto Campanella, quando scrive:
Comunque sia, la ‘premiata ditta Gilbert & Sullivan’ seppe confezionare una lunga serie di
indovinati prodotti, interpretando le istanze moraleggianti dell’Inghilterra vittoriana e, insieme, il gusto per l’esotico (tipico di ogni grande impero), che corrisponde all’illusione colonialista di ‘addomesticare’, perfino nella finzione teatrale, usi e costumi di paesi lontani
(p. 111).
Mi sembra infine doveroso dedicare almeno un pensiero alla figura di una veneziana
indimenticabile: Maria Teresa Muraro, scomparsa da pochi giorni (il 2 maggio
2003). Ricorderò sempre Deda (così era nota fra amici e conoscenti) fra i nutriti scaffali di San Giorgio, alla Fondazione Cini, dove ha lavorato per tanti anni, insegnando a tanti studiosi, più o meno giovani, l’importanza straordinaria della scenografia,
uno degli aspetti affascinanti della vita, delle cui gioie mai si apprende abbastanza a
far tesoro. Potrei continuare, ma so che lei non avrebbe gradito: preferisco dunque
ringraziarla per quello che ha rappresentato per tutti noi, e che continuerà a rappresentare nei nostri cuori e nel nostro spirito.
Michele Girardi
«È traditor chi è vinto / E tal son io»
In chiusura di stagione La Fenice offre al pubblico un cupo scorcio di storia veneziana: nel 1355 il Doge Marino Faliero, che premeva perché la Repubblica si annettesse l’Impero bizantino, congiura con il popolo per ristabilire il potere personale contro l’oligarchia aristocratica, ma viene scoperto e messo a morte.
In copertina, ritratto in veste nera da Francesco Hayez, Faliero è pronto ad appoggiare il capo sul ceppo posto sulla Scala dei Giganti; il suo atteggiamento è rassegnato, ma fiero al tempo stesso. Il pittore, che gli prestò il suo stesso volto, vibra con
lui, così come Donizetti, che nell’opera, pur rilevandone l’utopia nel finale, gli rese intera la dignità dell’eroe idealista, intento a combattere il sopruso. Francesco Bellotto
offre una lettura originale di questo e di altri due dipinti (uno sempre di Hayez, l’altro di Delacroix), intrecciandoli con la drammaturgia musicale dell’opera:
Il pittore, allo stesso modo di Donizetti, non sceglie come «ultimo momento» il morire del
Doge, ma la sua svestizione, assieme alle storie individuali raccontate dalle espressioni degli ‘attori’: si notino ad esempio i commenti e i diversi atteggiamenti dei tre personaggi che
sorreggono il vestito accuratamente piegato. Insomma, credo non sia un errore collocare il
dipinto nel medesimo ambiente estetico del melodramma (p. 98).
Anch’io credo che l’ipotesi non sia affatto un errore, e neppure il nostro grafico Marco Riccucci che, in copertina, mette a fuoco i protagonisti del dramma individuale: il
Doge, il boia, l’accusatore implacabile (chi potrebbe dubitare che sia Leoni mentre gli
legge la sentenza?), la moglie Elena disperata sulla sommità, che «ha l’atteggiamento
intenso e drammatico tipico di molte Madonne ai piedi della croce» (ibid.).
Chiudiamo la serie 2002-2003 de «La Fenice prima dell’opera» con un volume
dalla struttura simmetrica rispetto al primo (dedicato a Thaïs): tre saggi anziché due
sono giustificati dalla rarità di questi titoli sulle nostre scene. Apre le danze Giorgio
Pagannone, che cura l’edizione del primo libretto, corredandola di un ampio apparato in cui dà conto delle varianti in partitura e delle differenze testuali fra le differenti versioni, ma soprattutto redige una guida all’ascolto che penetra a fondo la
drammaturgia musicale del capolavoro di Donizetti.
Arricchiscono la pubblicazione due bozzetti di Domenico Ferri per la prima rappresentazione del Marino Faliero, reperiti da Maria Ida Biggi, che ringrazio, anche
per il sostegno costante alle nostre ricerche. Le sorprese continuano nella cospicua sezione di documenti inediti, a cominciare dal libretto originale concepito da Bidera,
noto sinora in una riproduzione olografa, ma qui trascritto e pazientemente curato
da Maria Chiara Bertieri. Esso è preceduto dal facsimile del contratto per Marino Faliero tra Donizetti e il Théâtre Italien: se possiamo leggerlo in queste pagine lo dobbiamo alla cortesia della Fondazione Donizetti di Bergamo, che ne è proprietaria. Es-
10
MICHELE GIRARDI
sa garantisce la qualità degli studi sul compositore ed è qui rappresentata, oltre che
da Francesco Bellotto, dal suo direttore scientifico Paolo Fabbri che, nel saggio iniziale, illustra la genesi dell’opera e la sua drammaturgia, ponendone a confronto le
differenti stesure (Napoli, Parigi, Firenze). Guido Paduano, infine, mette a paragone
la fonte principale del lavoro dei librettisti, la pièce di Delavigne, con il dramma di
Byron, antecedente, e l’opera di Donizetti, in un’analisi serrata e ricca di prospettive
critiche nuove.
Nota infine il nostro Caronte informatico, Roberto Campanella, che
Il melodramma romantico del primo Ottocento, dunque, si appropria del mito negativo di
Venezia, come testimonia anche Il Bravo di Mercadante (1839), un altro torbido drammone, fatto di intrighi e colpi di scena, che si svolge sotto il cielo della Serenissima, con la
segreta complicità del famigerato Consiglio dei Dieci. […]
La situazione, nella realtà storica, era alquanto diversa: infatti, al di là delle forzature presenti nel dramma, fu proprio grazie alle istituzioni oligarchiche, se la Serenissima riuscì, nel
bene e nel male, ad impedire per secoli ogni forma di assolutismo (p. 159).
Ma l’arte ha le sue regole, e la scelta drammatica di Donizetti rivela quel pessimismo
di fondo che anticipa, ancora una volta, la visione ‘politica’ di Giuseppe Verdi: nella
dichiarazione di Faliero a Leoni, «È traditor chi è vinto / E tal son io», l’Autore non
condivide certo né la prospettiva tra chi giudica né di chi, giudicato, constata amaramente il proprio fallimento.
Michele Girardi
Un domino per una suora mancata
Riparte la stagione d’opera della Fenice, e riparte anche «La Fenice prima
dell’opera», con l’ultimo titolo della serie 2002-2003: con Nabucodonosor,
in uscita nel gennaio prossimo, daremo alla collana la numerazione dell’anno solare (2004/1). I lettori, inoltre, potranno disporre del libretto dell’opera successiva, A midsummer night dream di Benjamin Britten, sin dalle repliche di quella precedente.
Questo volume è dedicato a Le domino noir di Auber, pressoché sconosciuto oggi, che tuttavia, come Marco Marica spiega nel saggio sulla fortuna
dell’opéra-comique nell’Ottocento,1 godeva di un’enorme popolarità nel XIX
secolo. La ragione principale di tale oblìo sta proprio nella natura formale,
ibrida, del genere opéra-comique, fra teatro di prosa e teatro musicale, una
natura che richiede interpreti che siano attori veri, oltre che cantanti. Il pragmatismo, tuttavia, è d’obbligo nella vita quotidiana dei palcoscenici: meglio
dunque «mediare tra l’esigenza di salvare la commedia a scapito dell’opera e
l’esigenza opposta, di sacrificare l’opera alla commedia», come nota Marica
nella guida all’opera (p. 13). Perciò Marc Minkowski, che dirige questa produzione, ha scelto di sostituire le parti dialogate con i recitativi da lui stesso
realizzati insieme a Jérémie Rohrer secondo l’impianto lasciato da Cajkovskij,
che li concepì tra il 1868 e il 1869, in vista di una ripresa di Le domino noir
a Mosca. Si perderà così la fragranza dell’originale, a tutto vantaggio della
coerenza interpretativa dell’insieme.
I lettori potranno trovare il riassunto della trama di Le domino noir,
provvisto di uno spumeggiante commento, anche nella recensione alla prima
1 Marco Marica ha conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Roma La Sapienza con
una tesi sull’opéra-comique, e attualmente sta per pubblicare gli esiti della sua ricerca in un volume monografico nella collana del dipartimento di scienze musicologiche dell’Università di Pavia (L’«opéra-comique» in Italia, 1770-1830: rappresentazioni, traduzioni, derivazioni, in uscita nel 2004). Collaboratore dell’Istituto nazionale di studi verdiani, ha scritto saggi su Verdi e
altri compositori.
8
MICHELE GIRARDI
assoluta del compositore Hector Berlioz. Un intreccio ricco di colpi di scena,
e di situazioni piccanti, talora di ascendenza mozartiana (sul modello del finale secondo delle Nozze di Figaro): basti pensare che, nel second’atto, l’elegante viveur Horace de Massarena esce da una stanza buia insieme all’attempata governante dell’amico Juliano, Jacinthe – inspiegabilmente lì –;
tornato dentro per cercarvi l’amata misteriosa, ne esce di nuovo, questa volta mano nella mano col cuoco Gil Perez, suscitando la comprensibile ilarità
dei presenti. In realtà la protagonista si è presa una serata di libertà, partecipando al ballo mascherata con un domino nero, che ne protegge la vera
identità. Avrebbe dovuto fuggire a mezzanotte, come Cenerentola, ma invece è costretta a rifugiarsi proprio in casa di Juliano, dove si finge aragonese
e canta per un gruppo di temibili gaudenti, fra cui proprio il suo corteggiatore. Nell’atto conclusivo il mistero si scioglie, come scrive Berlioz:
Eccola salva; corre, arriva, apre, entra, cade mezza svenuta di stanchezza e di emozione… in che luogo, prego?… indovinate un po’… nel parlatorio di un convento delle Annonciades. Sì, in un convento; è una novizia (chi l’avrebbe detto?), prossima a rinunciare al mondo di lì a qualche ora. Angela d’Olivarès, questo il suo nome, deve diventare
presto la badessa del convento, e per meglio prepararsi alla santa e grave cerimonia della sua presa del velo, ha preso la maschera, è corsa al ballo e conversato tutta la notte
con i più eleganti cavalieri di Madrid. Stento a credere alla realtà della sua vocazione per
la vita monastica. In Spagna, forse, non si guarda tanto per il sottile.
Naturalmente la soluzione è positiva: Angèle non prenderà né i voti né la carica e, dispensata dalla regina in persona, potrà finalmente coronare il suo
amore, proponendo a Horace di sposarla davanti alle suorine (ed è un bel
coup de théâtre oltre che un inconsueto segno di emancipazione).
Nel saggio di presentazione dell’opera, Hervé Lacombe scrive: 2
Il pubblico non deve cercare in Auber l’intensità delle passioni, la profondità e interiorità dell’espressione, oppure la proiezione e amplificazione degli affetti che animano il
cuore umano attraverso il medium vocale (come nell’opera italiana), ma abbandonarsi
al piacere dell’intreccio di Scribe, al nascondino dei personaggi, all’emozione deliziosa
delle melodie (p. 162).
È quello che ci auguriamo che accada in questo ciclo di recite di Le domino
noir al teatro Malibran.
Michele Girardi
2 Hervé Lacombe è professore di Musicologia nell’Università di Rennes 2. Specialista della
musica francese del XIX e XX secolo, ha pubblicato presso Fayard (Parigi) Les Voies de l’opéra
français au XIXe siècle (1997), la cui versione inglese riveduta e ampliata è apparsa in inglese
presso la University Press of California nel 2001. Il suo libro più recente è una biografia di Georges Bizet (2000), anch’essa in corso di traduzione. Attualmente lavora sull’opera contemporanea
e sta preparando una monografia su Francis Poulenc.