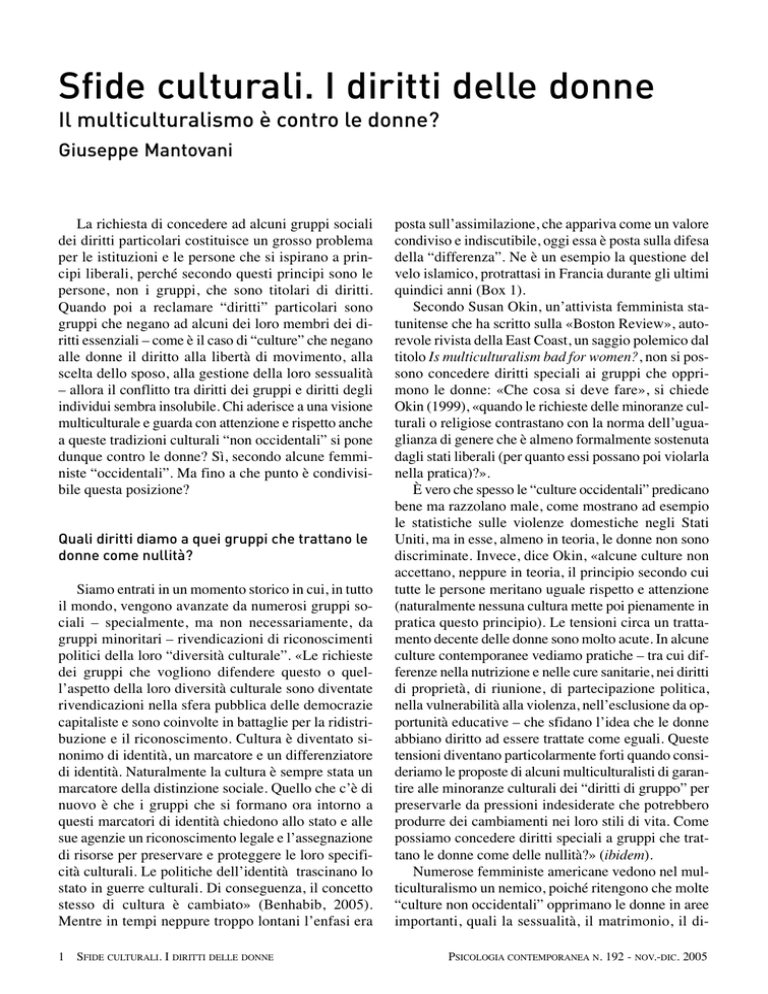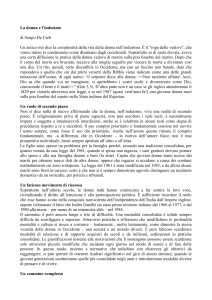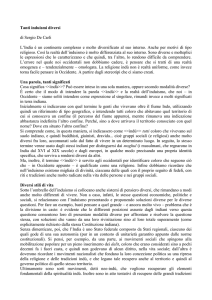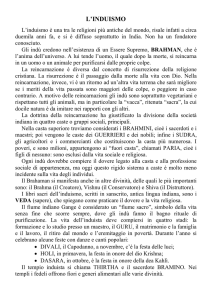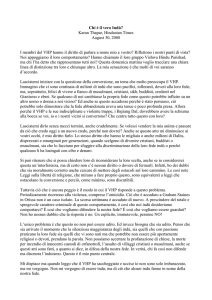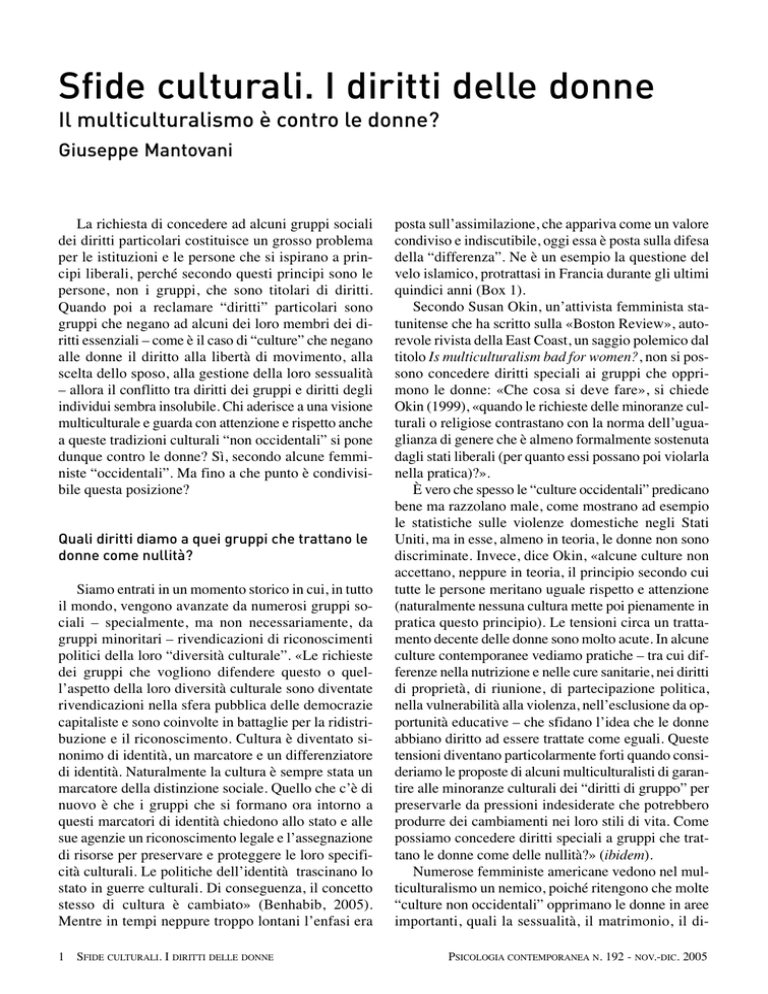
Sfide culturali. I diritti delle donne
Il multiculturalismo è contro le donne?
Giuseppe Mantovani
La richiesta di concedere ad alcuni gruppi sociali
dei diritti particolari costituisce un grosso problema
per le istituzioni e le persone che si ispirano a principi liberali, perché secondo questi principi sono le
persone, non i gruppi, che sono titolari di diritti.
Quando poi a reclamare “diritti” particolari sono
gruppi che negano ad alcuni dei loro membri dei diritti essenziali – come è il caso di “culture” che negano
alle donne il diritto alla libertà di movimento, alla
scelta dello sposo, alla gestione della loro sessualità
– allora il conflitto tra diritti dei gruppi e diritti degli
individui sembra insolubile. Chi aderisce a una visione
multiculturale e guarda con attenzione e rispetto anche
a queste tradizioni culturali “non occidentali” si pone
dunque contro le donne? Sì, secondo alcune femministe “occidentali”. Ma fino a che punto è condivisibile questa posizione?
Quali diritti diamo a quei gruppi che trattano le
donne come nullità?
Siamo entrati in un momento storico in cui, in tutto
il mondo, vengono avanzate da numerosi gruppi sociali – specialmente, ma non necessariamente, da
gruppi minoritari – rivendicazioni di riconoscimenti
politici della loro “diversità culturale”. «Le richieste
dei gruppi che vogliono difendere questo o quell’aspetto della loro diversità culturale sono diventate
rivendicazioni nella sfera pubblica delle democrazie
capitaliste e sono coinvolte in battaglie per la ridistribuzione e il riconoscimento. Cultura è diventato sinonimo di identità, un marcatore e un differenziatore
di identità. Naturalmente la cultura è sempre stata un
marcatore della distinzione sociale. Quello che c’è di
nuovo è che i gruppi che si formano ora intorno a
questi marcatori di identità chiedono allo stato e alle
sue agenzie un riconoscimento legale e l’assegnazione
di risorse per preservare e proteggere le loro specificità culturali. Le politiche dell’identità trascinano lo
stato in guerre culturali. Di conseguenza, il concetto
stesso di cultura è cambiato» (Benhabib, 2005).
Mentre in tempi neppure troppo lontani l’enfasi era
1
SFIDE CULTURALI. I DIRITTI DELLE DONNE
posta sull’assimilazione, che appariva come un valore
condiviso e indiscutibile, oggi essa è posta sulla difesa
della “differenza”. Ne è un esempio la questione del
velo islamico, protrattasi in Francia durante gli ultimi
quindici anni (Box 1).
Secondo Susan Okin, un’attivista femminista statunitense che ha scritto sulla «Boston Review», autorevole rivista della East Coast, un saggio polemico dal
titolo Is multiculturalism bad for women?, non si possono concedere diritti speciali ai gruppi che opprimono le donne: «Che cosa si deve fare», si chiede
Okin (1999), «quando le richieste delle minoranze culturali o religiose contrastano con la norma dell’uguaglianza di genere che è almeno formalmente sostenuta
dagli stati liberali (per quanto essi possano poi violarla
nella pratica)?».
È vero che spesso le “culture occidentali” predicano
bene ma razzolano male, come mostrano ad esempio
le statistiche sulle violenze domestiche negli Stati
Uniti, ma in esse, almeno in teoria, le donne non sono
discriminate. Invece, dice Okin, «alcune culture non
accettano, neppure in teoria, il principio secondo cui
tutte le persone meritano uguale rispetto e attenzione
(naturalmente nessuna cultura mette poi pienamente in
pratica questo principio). Le tensioni circa un trattamento decente delle donne sono molto acute. In alcune
culture contemporanee vediamo pratiche – tra cui differenze nella nutrizione e nelle cure sanitarie, nei diritti
di proprietà, di riunione, di partecipazione politica,
nella vulnerabilità alla violenza, nell’esclusione da opportunità educative – che sfidano l’idea che le donne
abbiano diritto ad essere trattate come eguali. Queste
tensioni diventano particolarmente forti quando consideriamo le proposte di alcuni multiculturalisti di garantire alle minoranze culturali dei “diritti di gruppo” per
preservarle da pressioni indesiderate che potrebbero
produrre dei cambiamenti nei loro stili di vita. Come
possiamo concedere diritti speciali a gruppi che trattano le donne come delle nullità?» (ibidem).
Numerose femministe americane vedono nel multiculturalismo un nemico, poiché ritengono che molte
“culture non occidentali” opprimano le donne in aree
importanti, quali la sessualità, il matrimonio, il diPSICOLOGIA CONTEMPORANEA N. 192 - NOV.-DIC. 2005
vorzio, la riproduzione, la cura dei figli, il lavoro domestico. Okin chiama in causa non solo le “culture”
ma anche le loro religioni, che considera responsabili
dello stato di sottomissione delle donne al potere patriarcale. Secondo Okin non si devono concedere diritti speciali ai gruppi che discriminano le donne, specialmente se in essi le donne non sono rappresentate
in modo adeguato: «Dato che l’attenzione ai diritti
delle minoranze culturali, per essere compatibile con
i fondamenti del liberalismo, deve mirare al benessere
dei membri di questi gruppi, non ci sono giustificazioni per accettare che gli autoproclamati leader di
questi gruppi – che sono invariabilmente maschi anziani – rappresentino gli interessi di tutti i membri dei
gruppi. A meno che le donne – e più specificamente
le donne giovani (perché le donne anziane spesso cooperano al rafforzamento delle diseguaglianze di genere) – siano pienamente rappresentate nelle negoziazioni sui diritti dei gruppi. Gli interessi delle donne
possono essere più danneggiati che favoriti dalla concessione di simili diritti» (Okin, 1999). Che dire di
fronte a prese di posizione così drastiche?
Tensioni fra diritti dei gruppi e diritti
delle persone
La prima reazione, giustificata, è quella di non generalizzare e non ricorrere a stereotipi. Non solo le culture “non-occidentali” sono molto differenti tra di loro,
ma tra esse esistono società che non opprimono le
donne. Anche per quanto riguarda “culture” che sono
spesso messe sotto accusa per le restrizioni che pongono ai diritti delle donne, come è il caso delle società
islamiche, va tenuto presente che si tratta di un mondo
molto diversificato al suo interno. Ciò che accade in
Pakistan può non accadere in Tunisia, ciò che vale per
l’Arabia Saudita può non valere per l’Indonesia. Un
recente studio di Riaz Hassan (2003), un sociologo
formatosi nelle Università del Punjab e dell’Ohio e
oggi docente all’Università di Flinders, in Australia,
condotto in Egitto, Kazakhistan, Indonesia e Pakistan
con 4500 interviste in profondità svolte da squadre di
intervistatori locali, mostra la presenza di una sorprendente gamma di opinioni differenti tra i musulmani intervistati, sia uomini che donne, specie per quanto riguarda i diritti delle donne.
Gli stessi ulema, guide spirituali musulmane, che
vengono di solito considerati legati a concezioni conservatrici dall’opinione pubblica “occidentale”, sono
spesso fortemente impegnati nel rinnovamento della
fede tradizionale (Muhammad Qasim Zaman, 2003).
2
SFIDE CULTURALI. I DIRITTI DELLE DONNE
Clifford Geertz, illustre antropologo culturale, ora professore emerito a Princeton, commenta così queste ricerche: «Ormai, si sarà notato, gli Stati Uniti sono diventati una potenza mediorientale. Quale sarà il loro
contributo in tale veste, specie nell’infuriare delle lotte
tra fazioni sciite a Baghdad, degli attentati dinamitardi
a Riad e Casablanca, di fronte all’inesausta vitalità di
Al-Qaeda e all’intero assortimento di conflitti urbani
in tutta la regione e oltre, resta ancora da vedere. Ma
certo la concezione dell’Islam che professori, politici,
giornalisti, polemisti e altre figure ufficialmente impegnate a orientare l’opinione pubblica si affannano
a costruire davanti ai nostri occhi avrà un’enorme importanza nel determinare la nostra linea di condotta»
(Geertz, 2004). In un mondo globale la responsabilità
di un insegnante, di uno psicologo, di uno studente va
ormai molto al di là del cortile di casa. La nostra idea
di “cultura” influenzerà non solo il modo in cui trattiamo gli “altri” nella vita quotidiana o nell’attività
professionale, ma modificherà anche le politiche pubbliche del nostro paese.
Per questo motivo, pur rendendoci conto del fatto
che si tratta di posizioni in qualche misura contestate,
dobbiamo prestare attenzione alle voci che denunciano
la violazione dei diritti delle donne in alcuni settori
delle società islamiche. Voci che sono spesso perseguitate e che pagano un alto prezzo per esprimersi. Ci
riferiamo, ad esempio, ad Ayaan Hirsi Ali, una giovane
donna di origine somala, figlia di un oppositore del regime di Siad Barre che nel 1976 si rifugiò con la famiglia in Arabia Saudita e poi in Kenya. La storia di
Ayaan è drammatica: promessa sposa – secondo la tradizione, ma contro la sua volontà – ad un cugino, per
evitare le nozze fugge in Germania e poi in Olanda,
dove ottiene asilo politico e trova lavoro come interprete e mediatrice culturale. La sua attività la mette a
contatto con le istituzioni che si occupano delle donne
islamiche maltrattate da mariti, fratelli, padri. Si laurea
in scienze politiche. Viene eletta nel parlamento olandese per il partito socialdemocratico. In seguito passa
al partito liberaldemocratico. Per le sue critiche alla
società islamica riceve numerose minacce di morte ed
è costretta a rifugiarsi all’estero. Scrive la sceneggiatura di un breve filmato dal titolo Sottomissione, che
denuncia la condizione di soggezione ed il regime di
percosse domestiche che affligge le donne musulmane. Il regista olandese Theo van Gogh per aver realizzato il film di Ayaan Hirsi Ali viene ucciso da un
fondamentalista islamico in pieno giorno, davanti a 57
testimoni, in un parco di Amsterdam il 2 novembre
2004. Ayaan vive nascosta e sotto scorta per sfuggire
alla condanna a morte.
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA N. 192 - NOV.-DIC. 2005
Scrive Ayaan Hirsi Ali (2005): «Come membro del
direttivo di Amnesty International, trovo desolante
constatare che la stragrande maggioranza delle donne
musulmane sia tuttora incatenata al dogma della verginità. Questo comporta che le donne arrivino al matrimonio completamente ignare: ogni esperienza nel
campo dell’amore e della sessualità è proibita. Lo
stesso però non vale per gli uomini. Inoltre gli uomini
e le donne all’interno di una determinata cultura musulmana non godono affatto dei medesimi diritti.
Molte donne semplicemente non hanno la possibilità
di organizzarsi la vita in modo libero ed autonomo».
Hirsi riconosce che molti uomini musulmani sono rispettosi delle donne, ma considera inadeguata la relazione tra i sessi che si realizza nelle società musulmane tradizionali: «Naturalmente non tutti gli uomini
musulmani sono violenti o inclini a porre la donna su
un gradino inferiore. Conosco un gran numero di musulmani meravigliosi che trattano con rispetto madri,
sorelle e mogli. Anche gli uomini sono vittime quanto
le donne del culto della verginità, anche se in forma
indiretta […]. Attraverso un’educazione sbilanciata a
proprio favore e la separazione fisica e mentale dei due
sessi, l’uomo non ha quasi nessuna possibilità di sviluppare le doti comunicative necessarie per vivere in
un contesto familiare. Non sorprende allora che molte
musulmane nei Paesi Bassi si lamentino che il marito
quasi non parla con loro» (ibidem).
Di fronte a gruppi che non riconoscono i diritti di
libertà dei loro membri il pensiero politico di ispirazione liberale non ha dubbi: i diritti delle persone
hanno il sopravvento (Benhabib, 2005). L’eventuale
riconoscimento delle “diversità” di gruppi minoritari
è quindi subordinata a tre condizioni. La prima, quella
della “reciprocità egualitaria”, richiede che i membri
di minoranze linguistiche, religiose o “culturali” non
subiscano – in forza della loro appartenenza alla minoranza – delle limitazioni dei loro diritti civili, politici od economici rispetto alla maggioranza. Se una
donna, per il fatto di essere musulmana, non gode
degli stessi diritti della sua vicina di casa non musulmana, allora non c’è “reciprocità egualitaria”. La seconda condizione è quella dell’“adesione volontaria”:
una persona non può essere assegnata ad un gruppo
linguistico, religioso o “culturale” semplicemente in
base al luogo in cui è nata o alla famiglia a cui appartiene. Le persone, in vari momenti delle loro vite, dovrebbero poter scegliere i gruppi a cui aderire e poter
dichiarare liberamente ed apertamente le loro scelte.
In molte società islamiche le famiglie non sono disposte a concedere ai loro membri, in particolare alle
loro figlie, questa libertà. La terza condizione, la “li3
SFIDE CULTURALI. I DIRITTI DELLE DONNE
bertà di uscire” dal gruppo in qualsiasi momento, è un
corollario della precedente. Anche questo principio
non è normalmente accettato nelle società islamiche:
l’apostasia, l’abbandono della religione musulmana, è
punita con la morte.
La cultura è un insieme di narrazioni
conflittuali
Nella posizione delle femministe americane, ma
non solo americane, che vedono in “altre culture” delle
strutture di oppressione della donna, è implicita una
concezione della “cultura” reificata, cioè l’idea che
una “cultura” abbia dei confini precisi e stabili, che
contenga dentro i suoi confini dei gruppi sociali omogenei, che i confini siano impermeabili. Le tre caratteristiche sono chiaramente interconnesse e creano
l’immagine di società separate, isolate, immutabili,
non comunicanti con l’esterno. Nessuna società è così.
Nella realtà i confini tra gruppi sono sempre porosi,
permeabili. I gruppi sociali sono sempre disomogenei
al loro interno; i confini tra gruppi sono di solito imprecisi, dipendono dalle circostanze, cambiano nel
tempo, sono oggetto di continui conflitti e negoziazioni. L’idea reificata di “cultura” non coglie una realtà; è solo uno strumento del “discorso dominante”
che afferma che è bene che “i nigeriani” stiano con i
nigeriani, “i marocchini” con i marocchini, “i sikh”
con i sikh: la creazione di stereotipi consente la creazione di barriere tra gruppi supposti omogenei (Mantovani, 2004a). E questo è il primo passo verso la creazione di ghetti culturali, o di forme di “multiculturalismo a mosaico” in cui ognuno è invitato a stare con
i “suoi”: la soluzione ideale sia per leader “etnici”, interessati a “rappresentare” il “loro gruppo” all’esterno,
che per quelli tra “noi”, gli autoctoni, che non vogliono mescolanze.
La concezione della cultura come narrazione mette
in discussione l’idea reificata di cultura che è sottintesa nelle parole di Okin (si veda il Box 2). Scrive
Bonnie Honig, professore di scienze politiche alla
Northwestern University: «La “cultura” è un modo di
vita, una ricca grammatica dell’attività umana, un insieme di narrazioni diverse e spesso conflittuali in cui
vengono negoziati comuni (fra)intendimenti, ruoli e
responsabilità» (1999). Non possiamo quindi dire che
accettiamo le persone, ma non le loro “culture”; dobbiamo accettare le “culture” differenti come narrazioni
diverse situate nelle persone, persone che agiscono in
un certo modo perché hanno una certa storia. «Come
tale, la “cultura” è un sistema vivente per la distribuPSICOLOGIA CONTEMPORANEA N. 192 - NOV.-DIC. 2005
zione e l’applicazione della agency, del potere e dei
privilegi tra i suoi membri e oltre. Raramente questi
privilegi sono distribuiti lungo un solo asse di differenza così che, per esempio, tutti gli uomini hanno più
potere di tutte le donne. La razza, la classe, la localizzazione, la discendenza accordano privilegi o svantaggi. Anche chi ha meno potere in un certo contesto
ha una certa quota di agency in quel contesto, e questa
agency è legata alla cultura, alle istituzioni e alle pratiche che l’hanno alimentata. Estinguere le culture non
è la risposta giusta. Anni di esperimenti coloniali ed
assimilazionisti dovrebbero aver insegnato che questi
sforzi sono eticamente problematici e politicamente
controproducenti» (ibidem). Introdurre la “agency”,
termine che traduciamo con “agentività”, una parola
assolutamente inelegante, significa dire che non esiste
la “cultura” in astratto, ma esistono le persone, con le
loro responsabilità nell’agire sociale.
Le donne indù: valori e gratificazioni
alternative
Mentre la discussione sulle condizioni delle donne
nelle società islamiche segue percorsi molto frequentati dagli studiosi e dai media, è la riflessione sulle
donne nelle società indù che scende più in profondità
nella disputa tra femministe americane e studiose indiane sostenute da (alcuni) antropologi “occidentali”.
Bhiku Parekh, docente di teorie politiche nell’Università di Hull, chiede polemicamente: «Le culture minoritarie hanno diritto al rispetto solo se diventano liberali? Sarebbe una forma estrema di intolleranza che
mostrerebbe scarso rispetto per la loro identità»
(1999). è vero, ella dice, che nel mondo tradizionale
indù la giovane sposa è spesso vessata dalla madre
dello sposo (non dallo sposo, però), ma è anche vero
che quando la donna diventa a sua volta madre, e poi
suocera, acquisisce un rango molto elevato. A differenza che negli Stati Uniti, in India e in altre società
«le donne sono trattate come inferiori quando sono
giovani e non sposate, mentre sono riverite e considerate superiori agli uomini quando arrivano ad una
certa età, diventano nonne, conducono una vita virtuosa o mostrano qualità straordinarie. Queste società
presentano l’apparente paradosso di essere sessiste eppure capaci di accettare ed anche di apprezzare le
donne come leader in tutti i settori della vita» (ibidem).
Come si può dire che la “cultura” indù in generale opprime le donne? Specie se pensiamo che questa “cultura” accetta senza difficoltà capi di governo donne,
come nel caso di Indira Gandhi, e ospita nel suo pan4
SFIDE CULTURALI. I DIRITTI DELLE DONNE
theon potenti e temute divinità femminili come Kalì.
Il giudizio sulla condizione femminile in India è un
punto di forte frizione fra studiose di origine indiana
e femministe americane. Mentre le femministe americane vogliono liberare le donne indù dal loro asservimento al patriarcato, le studiose indiane pensano che
le donne indù non sono schiave di una “cultura” oppressiva, ma semplicemente hanno una visione del
mondo diversa da quella americana: «Se alcune di loro
non condividono la prospettiva femminista è sbagliato
dire che sono vittime di una falsa coscienza generata
culturalmente e che hanno bisogno di essere liberate
da estranee bene intenzionate. Questo atteggiamento
arrogante ed offensivo negherebbe loro quella condizione di eguaglianza che si pretende di portare»
(ibidem). In effetti le differenze tra il mondo morale
indù e quello statunitense sono notevoli, come mostra
Richard Shweder (2003), docente di antropologia culturale a Chicago, che ha svolto per decenni ricerche
sulla vita domestica delle donne indù di alta casta della
città-tempio di Bhubaneswar, nella regione dell’Orissa. Queste donne vivono in famiglie allargate –
composte dai fratelli adulti, dai loro genitori, dalle loro
mogli, dai figli e dalle sorelle non sposate – in abitazioni in cui possono abitare fino a una ventina di persone. La coabitazione, che incarna il modello ideale di
vita familiare per gli indù che seguono le tradizioni,
cessa con la morte del padre o della madre vedova; allora i fratelli adulti abbandonano la casa comune e
vanno a vivere per proprio conto con la moglie e i figli.
La vita della donna indù è spezzata in due parti differenti: nella prima ella vive nella casa di suo padre,
senza particolari responsabilità; nella seconda entra
nella casa del marito, anzi della madre del marito, in
cui è sottoposta all’autorità della suocera ed ha molti
e gravosi compiti. Deve preparare e servire il cibo ai
membri della famiglia, in pasti separati a seconda dei
ranghi delle persone, pulire la casa e curare i figli, svolgere ogni genere di servizio per tutti i membri della famiglia, in particolare per i suoceri. Deve lavare e frizionare loro i piedi e, come atto di incorporazione nella
nuova famiglia, è apprezzato che beva l’acqua in cui i
piedi dei suoceri sono stati lavati. Inutile dire che il suo
primo e assoluto dovere verso la sua nuova famiglia è
quello di generare figli che continuino la famiglia. Ma
con il tempo le cose cambiano: grazie ai figli e al duro
lavoro sotto la guida della suocera, la nuora viene gradualmente assimilata alla famiglia di cui è entrata a far
parte con il matrimonio. Ella lascia alle nuore più giovani i compiti più faticosi ed inizia a rappresentare la
famiglia nelle relazioni con gli ospiti umani in visita e
con gli ospiti divini che intratterrà in un locale speciale
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA N. 192 - NOV.-DIC. 2005
della casa. Quella della suocera è in India, a differenza
che negli Stati Uniti, una posizione di grande prestigio
e soddisfazione» (Shweder, 2003).
Inevitabile la disputa tra le posizioni femministe,
che vedono nella condizione delle donne indù una
forma di schiavitù imposta dalla religione (Kondos,
1989; Dhruvarajan, 1988), e le studiose come Parekh,
oppure antropologi come Shweder, che accusano le
femministe di nutrire atteggiamenti neocoloniali:
«Nella letteratura dell’antropologia femminista c’è un
evidente tentativo di raccontare una storia di “emancipazione”, di universalizzare l’idea dell’oppressione
delle donne, di abbandonarsi alla creazione di miti a
fini politici. Ignorare i valori morali alternativi che
sono evidenziati nella pratica della vita familiare in
India, pensare che il controllo interiore, il servizio, la
gratificazione differita non siano altro che forme di accettazione dell’oppressione, rappresentare le donne
indù come vittime o sovversive significa non solo denigrare queste donne, ma anche impegnarsi in una
nuova versione fine ventesimo secolo dell’imperialismo cognitivo e morale» (Shweder, 2003). Le donne
indù di alta casta di Bhubaneswar danno alle loro attività quotidiane un senso che procura loro benessere
(“hito”) morale e fisico, afferma Shweder sulla base
delle interviste e autobiografie raccolte nel corso di
lunghi anni, con la collaborazione di colleghi e colleghe locali.
Dietro gli stili di vita differenti, ci sono mondi morali differenti. Mentre il successo di una donna “occidentale” si misura in termini di autonomia personale,
di riuscita nel lavoro fuori casa, di abilità nello stringere (e sciogliere) relazioni intime, di capacità nel cercare nuove esperienze, anche sessuali, e nell’affermarsi in competizione con altri nel lavoro e nella vita
sociale, il successo di una donna indù dell’Orissa si
gioca su altri fattori: «In cima alla lista delle virtù e dei
valori che le donne dell’Orissa sostengono stanno la
castità, la modestia, il senso del dovere, l’autodisciplina, il differimento della gratificazione, il perfezionamento di sé e l’idea del servizio domestico. In fondo
alla lista stanno la libertà personale e l’eguaglianza sociale» (ibidem). Si tratta di valori che sono diversi da
quelli “occidentali” moderni: «In contrasto con i principi del pensiero liberale moderno, la visione del
mondo che le donne e gli uomini dell’Orissa condividono è costruita sulla logica della differenza e della solidarietà invece che su quella dell’eguaglianza e della
competizione.
Né le donne né gli uomini nell’Orissa credono che
donne e uomini siano uguali, anzi la maggior parte di
loro considera incomprensibile, divertente o addirittura
5
SFIDE CULTURALI. I DIRITTI DELLE DONNE
puerile l’idea che non si dovrebbe tenere conto delle
differenze sessuali e che si dovrebbero trattare donne e
uomini allo stesso modo» (ibidem). Per le donne e gli
uomini dell’Orissa, secondo Shweder, le “pari opportunità” non sono un obiettivo desiderabile; la promozione della condizione della donna è vista in una cornice di solidarietà piuttosto che di competizione.
è possibile che l’immagine che Shweder ci fornisce
della “cultura” indù delle famiglie braminiche osservanti della città vecchia sia rigida e reificata (Mantovani, 2004b). è possibile, anzi probabile, che le cose
stiano cambiando anche a Bhubaneswar, in un’India
che si avvia ad essere uno dei poli di attrazione scientifica, economica e culturale del nuovo millennio. è
possibile che già nel momento in cui Shweder conduceva le sue ricerche le cose stessero cambiando, e che
le donne di Bhubaneswar raccontassero un mondo di
virtù e di valori che stava tramontando. Ciò che importa a noi in questa sede non è sostituire ad uno stereotipo (quello della donna indù schiava della tradizione) un altro stereotipo (quello edificante della
donna indù casta, modesta, autodisciplinata) ma provare a mettere tra parentesi il “nostro” mondo di valori – tutto sommato abbastanza vicino a quello delle
femministe americane – quando ci troviamo di fronte
ad “altri” mondi, che non sono totalmente “altri”, ma
neppure completamente riconducibili alle nostre categorie.
Riferimenti bibliografici
Al-Hibri A. (1999), Is Western patriarchal feminism good for third world/minority women?. In S. M.
Okin, Is multiculturalism bad for women?, Princeton,
Princeton University Press.
American Psychological Association (2003), Guidelines on multicultural education, training, research,
practice, and organizational change for psychologists,
«American Psychologist», 58, 377-402.
Benhaib S. (2005), La rivendicazione dell’identità
culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale
(trad. it.), Bologna, Il Mulino.
Dhruvarajan V. (1988), Hindu women and the
power of ideologie, South Adley, Bergin & Garvey.
Geertz C. (2004), Studi sull’Islam, «La Rivista dei
Libri», 10, 26-21.
Hassan R. (2003), Fathlines: Muslim conceptions
of Islam and society, Oxford, Oxford University Press.
Hirsi Ali A. (2005), Non sottomessa. Contro la segregazione nella società islamica (trad. it.), Torino, Einaudi.
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA N. 192 - NOV.-DIC. 2005
Honig B. (1999), My culture made me do it. In S.
M. Okin, Is multiculturalism bad for women?, Princeton, Princeton University Press.
Kondos V. (1989), Subjection and domicile. Some
problematic issues relating to high caste Nepalese
women. In J. N. Gray e D. J. Mearns (Eds.), Society
form the inside out, New Delhi, Sage.
Mantovani G. (2004a), Intercultura. è possibile evitare le guerre culturali?, Bologna, Il Mulino.
Mantovani G. (2004b), Challenging cognitive and
moral imperialism, «Contemporary Psychology», 49
(6), 756-759.
Okin S. M. (1999), Is multiculturalism bad for
women?, Princeton, Princeton University Press.
Shweder R. A. (2003), Why do men barbecue? Recipes for cultural psychology, Cambridge, Harvard
University Press.
6
SFIDE CULTURALI. I DIRITTI DELLE DONNE
Zaman M. Q. (2003), The ulama in contemporary
Islam: Custodians of change, Princeton, Princeton
University Press.
Giuseppe Mantovani è Ordinario di Psicologia
degli atteggiamenti nella Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. Attualmente si occupa di psicologia sociale e culturale e delle conseguenze dell’introduzione delle nuove tecnologie. Recentemente ha
scritto Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali? (Bologna, Il Mulino, 2004). È autore, per
questa rivista, di numerosi articoli di psicologia culturale ed è appena uscita la nuova edizione del suo famoso Elefante invisibile (Firenze, Giunti, 2005). Ha
curato il Manuale di psicologia sociale edito da Giunti
(Firenze, 2003).
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA N. 192 - NOV.-DIC. 2005
BOX 1 - L’affaire du foulard
Se guardiamo ad alcune delle rivendicazioni di "identità" più gridate, ci rendiamo conto del fatto che
la componente di conflittualità politica di queste vicende è spesso preponderante. Consideriamo la vicenda francese del velo islamico.
Mentre in vari paesi "occidentali"
l’adozione da parte di donne musulmane di questo abbigliamento non
ha creato problemi particolari, salvo
quello della riconoscibilità della persona nei documenti di identità e in
certi contesti (banche, tribunali,
ecc.), in Francia l’“affaire du foulard” è stato al centro di uno scontro
molto duro tra i gruppi fondamentalisti musulmani e le autorità scolastiche e statali francesi. Lo scontro
iniziò il 19 ottobre 1989, quando tre
ragazze, Fatima, Leila e Shamira,
furono espulse dal liceo di Creil, nel
dipartimento dell'Oise, perché si
erano presentate a scuola velate, nonostante si fossero impegnate, dopo
una lunga trattativa con le autorità
scolastiche, a non indossare il velo
a scuola. Le ragazze erano state persuase a rompere gli accordi da Daniel Youssuf Leclecq, leader dell’organizzazione islamica “Integrité”.
Le autorità scolastiche ponevano
delle difficoltà all’uso del velo formalmente per ragioni di sicurezza,
specie nelle lezioni di educazione fisica e di chimica, ma in realtà perché
consideravano la presenza del velo
7
SFIDE CULTURALI. I DIRITTI DELLE DONNE
islamico nella scuola pubblica francese una sfida alla sua laicità.
Posta in questi termini, la questione del velo non era un problema
di pudore o di libertà della donna
nella presentazione di sé nella sfera
pubblica. Si noti che nessuno metteva in discussione il diritto di indossare il velo in strada o al supermercato. L'oggetto della contesa era
il diritto di indossare il velo nella
scuola pubblica francese. La posta
in gioco era il carattere a-confessionale della stessa, un contesto che
aveva l’obiettivo di integrarle, in
quanto studentesse della nazione
francese, in un ideale di cittadinanza
egualitaria e secolarista.
Con la loro decisione di portare
il velo a scuola le tre ragazze «introdussero a forza nella sfera pubblica
quello che lo stato francese considerava un simbolo individuale, mettendo in tal modo in discussione le
frontiere tra pubblico e privato […].
Le tre ragazze non hanno più considerato la scuola pubblica come uno
spazio di acculturazione francese,
ma hanno manifestato apertamente
le loro differenze culturali e religiose» (Benhabib, 2005). La lotta per
mantenere (come voleva lo stato) o
modificare (come volevano i fondamentalisti musulmani) il carattere
laico della scuola pubblica francese
era chiaramente una lotta politica.
La rivendicazione del diritto di
portare il velo islamico nella scuola
pubblica francese provocò numerose discussioni nei media, nelle
scuole, nelle sedi politiche, nei movimenti islamici. Nel gennaio 2004,
infine, il parlamento francese votò
a larghissima maggioranza una legge
che vietava nelle scuole elementari,
medie inferiori e superiori «i segni
e gli abiti che manifestano ostentatamente l’appartenenza religiosa
degli alunni». In risposta i movimenti fondamentalisti islamici organizzarono manifestazioni a Parigi
e in tutte le città francesi; ai cortei
però parteciparono pochissime persone, poche migliaia a fronte di circa
quattro milioni di musulmani che vivono in Francia. Opinioni differenti,
per lo più favorevoli alla legge, furono espresse da varie autorità religiose islamiche sul territorio francese. Si registrarono anche interventi
di politici stranieri, come quello di
Rafsanjani, che invocò la «maledizione di milioni di persone» sulla
Francia, qualora la legge non fosse
stata ritirata. Un anno dopo, il bilancio dell'introduzione della legge
appariva decisamente positivo.
Nell'anno scolastico 2003-2004
ci furono 1500 casi, quest' anno ce
ne sono stati 663; grazie al dialogo
con gli allievi e le famiglie, la stragrande maggioranza dei contenziosi
è stata risolta positivamente, cioè
con l'accettazione della legge.
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA N. 192 - NOV.-DIC. 2005
BOX 2 - Libere a modo nostro
Nell’opposizione tra femminismo occidentale e “culture altre”
si può riconoscere anche una buona
dose di etnocentrismo. Varie studiose, specialmente musulmane e
indiane, accusano Okin e le sue colleghe di mettersi nella prospettiva
di un “io” culturale dominante che
vuole dettar legge all’“altro” culturale. Noi lavoriamo alla promozione
della condizione femminile a modo
nostro, dicono queste donne “nonoccidentali”; non è necessario essere allineate con i valori americani
per impegnarsi nella promozione
dei diritti delle donne.
Azizah Al-Hibri, docente di diritto all’Università di Richmond e
fondatrice di “Karamah” (Giuriste
Musulmane per i Diritti Umani)
rimprovera ad Okin di fare confusione tra gli aspetti religiosi e gli
8
SFIDE CULTURALI. I DIRITTI DELLE DONNE
aspetti civili dell’Islam e di non conoscere la posizione islamica sulla
donna: nel Corano la donna non è
la via di ingresso nell’umanità del
peccato originale. Il peccato originale è suggerito dal tentatore sia ad
Eva che ad Adamo; entrambi sono
tentati ed entrambi peccano.
Al-Hibri sostiene che non è necessario abbandonare l’Islam per liberare le donne musulmane: «L’approccio migliore a questi problemi
per le femministe musulmane è
quello di riesaminare criticamente
la giurisprudenza islamica alla luce
dei principi di giurisprudenza e dell’interesse pubblico dei musulmani.
Il risultato è una strategia articolata
in tre punti.
Primo, separare chiaramente le
pratiche tradizionali dalle pratiche
religiose. Questo ridurrebbe consi-
derevolmente la resistenza dei musulmani nei confronti di certi tipi di
cambiamento, cioè dei cambiamenti
puramente culturali.
Secondo, riesaminare in modo
critico la giurisprudenza esistente
per scoprire gli elementi culturali
che sono da eliminare.
Terzo, portare contributi moderni
alla giurisprudenza islamica che tengano conto del tempo, del luogo,
dell’interesse pubblico dei musulmani, di cui la metà sono donne.
Questo processo è complicato e
richiede tempo e non può essere
cancellato a causa dell’impazienza
delle femministe secolari» (1999).
Lasciateci cambiare da sole, dice
sostanzialmente Al-Hibri, non approfittate delle nostre attuali difficoltà per imporci il vostro modo di
essere donne “libere”.
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA N. 192 - NOV.-DIC. 2005