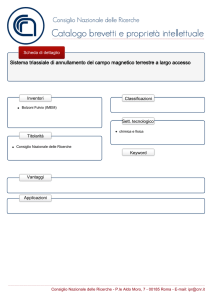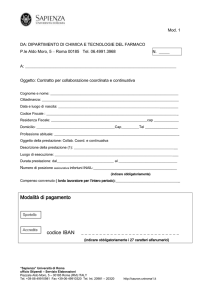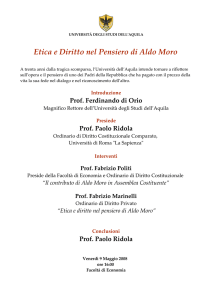Francesco Di Donato
Sul presunto linguaggio criptico
nell’elaborazione politico-istituzionale di Aldo Moro
1. Tra parrhesìa e complessità linguistica del reale
Aldo Moro fu un’intelligenza che per tutta la vita lottò contro la propria identità1.
Vi è nel suo stile, nell’incedere del suo pensiero, nella stessa costruzione del suo
linguaggio una sorta di permanente dialettica interna, che appare oggi
un’evidenza a chi proceda a un’analisi storica il più possibile scevra da
condizionamenti ideologici, culturali e politici. Studiare il linguaggio di Moro è
un’impresa tanto affascinante quanto paradossale.
Gli storici constatano che nelle vicende umane domina spesso l’assurdo. Non è
affatto raro il caso in cui, nel fatto storico, la realtà supera la fantasia. Utilizzando
i termini di un grande giurista francese del XIX secolo, François Gény, si può dire
che il reale non è solo il mero dato, il vissuto, l’accaduto, ma anche, anzi
soprattutto, il costruito, un gioco spesso tacito e muto, avvolto in un velo sottile,
talvolta diafano, di speranze, desideri, progetti, proiezioni utopistiche, fughe
oniriche. Sono le passioni cieche a dominare il proscenio della storia2. I grandi
fenomeni si determinano assai più sulla spinta di potenti energie passionali che
per meditate e ben calcolate scelte razionali.
Compito prioritario del “Politico” è quello di ricondurre i popoli al senso della
realtà e al principio di effettività (la machiavelliana «verità effettuale della
cosa»), senza tuttavia spegnerne l’energia creativa e senza affievolire la
sensazione di poter proseguire un cammino di progresso e d’innovazione.
Nell’azione politica rigore razionale e capacità di alimentare il sogno (I have a
dream) devono coincidere. Precisamente nella realizzazione vivente di
quest’ossimoro, in bilico permanente tra presente e futuro sta la nobile follia del
“Politico”, la sua quasi-impossibilità. L’impresa politica è, per definizione,
impresa paradossale, dal momento che l’energia vitale che attraversa un corpo
sociale (o le minoranze attive presenti in esso), ciò che lo spinge ad agire e che
mette in moto la storia, non è certo l’argomentazione razionale, bensì la
rappresentazione immaginaria e l’abilità di mettere in moto energie passionali
Dedico questo saggio a mio padre, Nicola Di Donato, da sempre interessato all’intelligenza complessa e “fuori le
righe” di Aldo Moro. Anche lui, come il grande statista salentino, è in permanente rivolta contro la cultura dalla
quale trae origine la propria identità.
2 Cfr. S. VEGETTI FINZI, Storia delle passioni, Laterza, Roma-Bari 1995; B. BESNIER, P.-F. MOREAU, L. RENAULT (a
cura di), Les passions antiques et médiévales. Théories et critiques des passions, Puf, Paris 2003; P.-F. MOREAU (a
cura di), Les passions à l’âge classique, Puf, Paris 2006.
1
nel contempo orientandole. Per questo è necessario che il “Politico” sappia
servirsi anche, anzi soprattutto, delle enormi riserve di energia sprigionate dai
sogni, dai desideri e dalle tensioni più o meno chiaramente serpeggianti nei
cunei e negli anfratti dei sentimenti politici collettivi. Vero “Politico” è chi,
riuscendo a intercettare falde nascoste e operanti nel sottosuolo sociale, sa
servirsi dei sogni comuni per concretizzare realtà che sarebbe impossibile far
emergere con l’uso delle sole facoltà del calcolo razionale. Proprio questo, del
resto, è il quid che distingue la politica dall’amministrazione.
L’autentico attore del proscenio politico deve saper costruire linguaggi
complessi che siano in grado di racchiudere e descrivere la multiforme
complessità del reale, tenendo conto della perenne sfasatura tra aspirazioni
soggettive e oggettive possibilità e riuscendo a rendere questa dicotomia
feconda anziché distruttiva. Il discorso politico deve animare un’entità algida e
senza vita (il «lirismo del mostro freddo» di cui parlava Michel Foucault sulla
scorta dello Zarathustra nietzscheano) riuscendo a proiettarla addirittura nel
futuro. Un discorso veramente “politico” deve trasformare l’appiattimento che si
prova quando si è immersi nel grigiore di una realtà deludente nell’industriosa
speranza di contribuire a realizzare un sogno. Il “Politico” vero deve riuscire,
dunque, ad animare l’inanimato, a trarre energia vitale da un corpo che scivola
verso l’inerzia e la morte. Per farlo deve servirsi di arti raffinatissime e spesso
invisibili o criptiche3, perché l’idea che la politica debba coincidere con
l’«autenticità» è stato un mito che ha determinato un enorme progresso nel
campo dell’azione sociale, ma la cui idolatria ha anche generato terribili mostri
dai quali un idealismo subdolo e fallace non ha ci permesso – ancor oggi – di
liberarci del tutto4. Per questo, ci aiuta a comprendere il nucleo profondo della
realtà politica il paradossale aforisma, sempre fulmineo e spiazzante, di E. M.
Cioran, secondo il quale «quando incontriamo un essere vero, la sorpresa è tale
che ci chiediamo se non siamo vittime di un abbaglio»5. L’ingenuità è l’unico
difetto che il “Politico” non può permettersi.
Il “Politico” che costruisca un linguaggio semplice per descrivere una realtà
complessa oltre a essere un baro è anche votato al sicuro fallimento della sua
itrapresa. Egli truffa il pubblico – sapendo di truffarlo – poiché cavalca speranze
che sa impossibili. L’onestà intellettuale e il senso dell’etica impongono, sul
piano epistemologico e metodologico prima che propriamente politico, la
parrhesìa (necessità di dire il vero). Ma la parrhesìa è impossibile se si utilizza
un linguaggio inadeguato alla complessità del reale. Di regola la vita politica è
una selva oscura, piena di trabocchetti e d’insidie. E (almeno) gli storici
Su questo punto, di capitale importanza nella storia politica dell’Occidente, rinvio a M. SENELLART, Le arti di
governare. Dal regimen medievale al moderno concetto di governo, trad. it. (sull’orig. francese, 1995), a cura di
Francesco Di Donato, Esi, Napoli 2013 (e al mio saggio introduttivo Il paradosso di un’arte impossibile. Dal
governo dei labirinti umani all’organizzazione sociale, ivi, pp. VII-XXXVIII).
4 Cfr. A. FERRARA, Modernità e autenticità. Saggio sul pensiero sociale ed etico di J. J. Rousseau, Armando, Roma
1989; IDEM, Autenticità riflessiva. Il progetto della modernità dopo la svolta linguistica, Feltrinelli, Milano 1999.
5 E. M. CIORAN, Confessioni e anatemi, trad. it. a cura di Mario Bortolotto, Adelphi, Milano 2007, p. 123.
3
dovrebbero sempre tener ben chiara la distinzione tra le teorie e le pratiche
effettive di un sistema politico6. Tanto più in un Paese – come l’Italia – nel quale
scarsissimi sono il senso dello Stato e lo spirito delle istituzioni e fortemente
radicati e diffusissimi sono invece l’astuzia truffaldina, il cinismo spietato
rivestito da apparente bonarietà e un radicatissimo particolarismo microfeudale.
2. Dall’olismo idealistico all’interazione empirico-sociale
In un contesto di tal genere la grandezza di Aldo Moro è stato il tentativo
impossibile di condurre gl’italiani verso un’introiettata e profonda riflessione sui
loro atavici mali e di far partire una spinta razionale verso il superamento dello
status quo in vista di un interesse più alto: quello della società e dello spirito
cooperativo che essa porta naturalemente con sé. Per raggiungere questo
risultato, Moro non poteva servirsi ipocritamente di un linguaggio semplice, ma
dové servirsi di un linguaggio articolato, che solo una (prevedibile) reazione di
rigetto poteva definire oscuro e criptico. Basta leggere oggi con attenzione le sue
pagine per rendersi conto che la sua prosa, soprattutto quella della maturità, è di
una chiarezza cristallina, ancorché venata da un costante tormento. Pochi
uomini politici hanno saputo descrivere la situazione italiana con una limpidezza
così attenta tanto alla sostanza dei problemi quanto alle sfumature che li
caratterizzano.
La riflessione morotea parte da lontano e si può dire che essa sia intrinseca alla
stessa formazione scientifico-culturale del giovane studioso e futuro statista.
Appaiono, a questo riguardo molto interessanti i primi corsi che Moro tenne
all’università di Bari nel 1944-19457. È molto significativo che Moro partisse in
quegli scritti dal «problema della vita» per approdare a una visione della società,
del diritto e dello Stato imperniata sul concetto di «esperienza giuridica»8. Certo,
la sua impostazione non è quella di un empirista anglosassone e in molti punti
appare sensibilmente condizionata dall’idealismo crociano con una maggiore
sottolineatura delle tematiche tipiche della visione cristiana9. Moro arriva ad
Da questo punto di vista, sarebbe sempre bene operare, a monte di ogni discorso analitico, la distinzione di
metodo tra spirito e pratica di un sistema, proposta da D. RICHET, Lo spirito delle istituzioni. Esperienze
costituzionali nella Francia moderna, trad. it. (sull’orig. francese, 1973), a cura di Francesco Di Donato, Laterza,
Roma-Bari 1998 (3a ediz. inalterata 2002).
7 A. MORO, Lezioni di Filosofia del diritto tenute presso l’Università di Bari, 2 voll.: I. Il Diritto; II. Lo Stato, Cacucci,
Bari 1978.
8 È appena il caso di ricordare che la concezione del diritto come «esperienza giuridica» era stata da poco al
centro della riflessione di Giuseppe Capograssi, di cui si può ricordare almeno, per la pertinenza diretta
all’oggetto, il vol.: G. CAPOGRASSI, Studi sull'esperienza giuridica, Maglione, Roma 1932.
9 Ad es. nella convinzione dell’esistenza «di una realtà oggettiva» (MORO, Lezioni di Filosofia del diritto, cit. supra
nota 7, I, p. 7), oppure nella definizione della speculazione filosofica come attività tendente a «definire
l’universale giuridico» (ibid.), o nell’idea che il compito della cultura sia un «compito morale», consistente nel
reperire «il senso della vita umana» (ivi, I, p. 8), o ancora nella convinzione che l’intelligenza dell’osservatore
delle vicende storiche sia una «intelligenza operante» che constata la «verità che diventa storia» (ibid.). In alcuni
punti è evidentissima l’influenza dello stile crociano, ma nel complesso appare altrettanto evidente come il
giovanissimo studioso salentino tenda già faticosamente a distaccarsi da quell’impostazione di fondo
6
affermare, un po’ apoditticamente, che la «concezione teologica [è] essenziale
per fondare un’etica»10. La sua preoccupazione principale non è quella di
distinguere fatti e valori, ma piuttosto quella di «riportare l’un termine all’altro,
di realizzare il valore nel fatto, di illuminare il fatto con il valore»11; cosicché, in
definitiva, «la verità più profonda delle cose è nella ideale sintesi di valore e
fatto, per cui la verità vive essenzialmente nella storia»12.
In conseguenza di quest’impostazione, «la sola e vera molla che spinge
all’azione» è per Moro l’«attesa ansiosa della verità» insita in quel problematico
ossimoro che egli vuole «chiamare «fede nella gioia che traspare in ogni dolore
umano»13. L’aspirazione intrinseca di Moro è quella di superare «l’inganno del
tempo che travolge ogni cosa», attraverso l’inserimento di «ogni esperienza
nell’assoluto e nell’eterno»14. Questa esperienza fusionale di assoluto e relativo,
di eterno e contingente, di teologico e storico, è resa possibile da un principio
primo che Moro enuncia in due tempi, un giudizio teoretico-speculativo e uno
assiologico-soggettivo: il primo è formulato nella sentenza in cui egli afferma che
«quello che è stato nella verità, è»15; il secondo nella spiazzante e lapidaria
conclusione: «Per ciò è bello vivere»16, che non ha bisogno di commenti.
Tuttavia, malgrado questo impianto di chiara impronta idealistico-religiosa, in
molti passaggi si comprende chiaramente come la riflessione morotea inizi a
porsi problemi complessi sui quali egli avvertiva l’insufficienza di una visione
troppo sbilanciata sui princìpi ideali e troppo poco attenta all’osservazione
fenomenologica della realtà in divenire. Questa iniziale inquietudine avrà
bisogno di tempo per evolvere in angustiata urgenza di fornire risposte
politicamente adeguate a una società in tumultuosa trasformazione. Osservatore
acuto e sensibilissimo della realtà storica in evoluzione, Moro visse con grande e
attento travaglio la complessa fase di mutamento che l’Italia attraversò dalla
costituente alla straordinaria crescita economica degli anni Sessanta. Il
succedersi degli eventi ebbe sulla sua visione del mondo, il cui impianto egli
teneva a ogni costo a far restare nell’orizzonte di senso di una concezione
cristiana, un’influenza potente che con ogni probabilità sconvolse il quadro
iniziale, innestando numerosi e profondi elementi di ‘disturbo’.
Vanno a questo proposito individuate due fasi cruciali di maturazione critica,
corrispondenti a prima e dopo il “maggio 1968”. Per quanto si sentisse
profondamente e sinceramente radicato in valori nei quali trovava saldo
ancoraggio e conforto spirituale, Moro subì l’impatto delle novità intervenute
abbracciando – sia pure in modo nebuloso e tormentato, una visione molto più tendente all’osservazione
empirica e alla contraddittoria complessità del reale effettivo, cioè di «quel continuo farsi in cui consiste la vita»
(ibid.). Sul punto si tornerà più diffusamente infra, § 6.
10 Ivi, p. 10.
11 Ivi, p. 11.
12 Ivi, p. 12.
13 Ivi, p. 15.
14 Ivi, p. 16.
15 Ibid.
16 Ibid.
nell’intero mondo occidentale nella seconda metà degli anni Sessanta. Lo si nota
chiaramente studiando l’evoluzione dei suoi discorsi politici17. Dopo il 1968 le
aperture alla ‘modernità’ culturale e politica si fanno molto più pronunciate e
decise nell’austera ed elegante oratoria morotea. Moro arriva a parlare di diritti
dell’«individuo», e non più solo di statuto della «persona» e di «personalismo»,
utilizzando un concetto divenuto ordinario nella mentalità sociale odierna, ma
che allora era percepito – specialmente dal punto di vista cattolico – come
pericoloso e blasfemo. La morale cattolica, ufficialmente enunciata dal magistero
papale, ha, infatti, sempre distinto tra «persona» e «individuo», difendendo la
prima e osteggiando il secondo, identificato tout-court con una libertà licenziosa
del singolo slegata da qualsiasi principio etico. È senza dubbio questo coraggioso
linguaggio ad aver messo sull’avviso certi ambienti clericali e conservatori che da
allora iniziarono un’ostilità che non ebbe mai fine nei confronti dell’uomo politico
salentino, considerato astruso, non ortodosso e non allineato alle posizioni ufficiali o
comunque largamente maggioritarie nell’ambito del cattolicesimo italiano. Moro, da
parte sua, non fece mai nulla per ingraziarsi quegli ambienti, per smussare le asperità
e le frizioni e preferì mantenere nel suo linguaggio la linea imperniata su quanto gli
dettava la propria concezione della razionalità politica18.
Per quanto egli restasse sempre coerente nell’abbracciare convintamente
l’ideale di vita cristiano, iniziò allora a essere pienamente consapevole della
solitudine del capitano che deve guidare la nave da solo nell’oceano notturno.
Nasce da qui lo sforzo, mai attenuato in tutto il suo percorso politico, per
superare le secolari incrostazioni che caratterizzavano (come per certi versi
caratterizzano ancora) la secolare mentalità italiana, fondata, com’è stato
recentemente dimostrato, su un’«asociale cordialità» e su un «bigottismo
cinico»19. Il tentativo di conciliare i fondamenti religiosi, da lui fortemente e
Cfr. A. MORO, La democrazia incompiuta, a cura di Andrea Ambrogetti, pubblicazioni del Corriere della Sera,
RcS, Milano 2011.
18 Cfr. infra § 7. A questo proposito è molto significativo, perché dimostra in modo ineccepibile tanto la profonda
laicità di Moro quanto il suo senso razionale dello Stato e delle scelte politiche giudicate necessarie per
l’interesse generale, un episodio inedito che riassumo qui brevemente. Alla vigilia del varo del primo
centrosinistra (1963), fortemente voluto da Moro, il cardinal Siri, arcivescovo di Genova e presidente della Cei
(nonché a lungo uno dei più potenti papabili) inviò a Roma il padre gesuita Angelo Arpa, che insieme a don
Gianni Baget Bozzo era tra i sacerdoti da lui più benvoluti e stimati. Diplomatico accortissimo, Arpa viaggiò di
notte da Genova a Roma e la mattina presto consegnò brevi manu a Moro una lettera personale riservata da parte
del cardinale. La lettera era un imperativo categorico dettato a Moro di desistere dall’idea, giudicata insana, di far
nascere il governo con la partecipazione del PSI. Moro l’aprì, la lesse con attenzione e restò qualche secondo
immobile e impenetrabile. Poi con estrema cortesia, ma senza inflessioni cordiali, disse: «Dica a Sua eminenza
che terrò conto, finché possibile». L’episodio, a mia conoscenza mai rivelato, mi è stato riferito, intorno alla metà
degli anni Novanta, direttamente da padre Angelo Arpa.
19 R. AJELLO, L’asociale cordialità. Contributo alla storia delle mentalità in Italia, in «Frontiera d’Europa», anno
XIII, n. 1, 2007, 5-72. Si vedano anche F. FERRAROTTI, L’Italia in bilico, Laterza, Roma-Bari 1990; R. ROMANO,
Paese Italia. Venti secoli di identità, Donzelli, Roma 1994; E. GALLI DELLA LOGGIA, L’identità italiana, Il Mulino,
Bologna 1998; C. TULLIO-ALTAN, La nostra Italia. Clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità al 2000, con
prefazione di Roberto Cartocci, Università Bocconi Editore, Milano 2000; P. SYLOS LABINI, Un Paese a civiltà
limitata, Laterza, Roma-Bari 2001; S. PATRIARCA, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Laterza,
Roma-Bari 2010 (ma il titolo originale in inglese è assai diverso: Italian Vices); e da ultimi S. CASSESE, L’Italia:
una società senza Stato?, Il Mulino, Bologna 2011; F. FERRAROTTI, Il paradosso italiano. La povertà di un paese
ricco, Solfanelli, Chieti 2012.
17
intimamente sentiti, con i motivi essenziali del pensiero critico moderno si può
osservare su un duplice fronte, uno più scientifico-culturale, l’altro più politico e
istituzionale. Sul primo, come ha osservato Norberto Bobbio, Moro si rivolse a
innovare la vexata quaestio del rapporto tra diritto naturale e diritto positivo, un
«topos classico del giusnaturalismo» che fu da lui «espresso con una singolare
inversione del rapporto tra i due diritti» nel senso che nella prospettiva morotea
il diritto naturale «è diritto positivo esso stesso, ché altrimenti non sarebbe
neppure comparabile al primo e sparirebbe nel nulla»20. Quanto al secondo
versante, soprattutto nella fase della maturità, Moro focalizzò sempre più la sua
attenzione sul problema dell’assetto socio-istituzionale, con particolare
riferimento al sistema politico e alla funzione dei partiti nella società e nelle
istituzioni.
In entrambi i casi – che corrispondono alle due principali fasi della sua vita –
Moro costruì un’originalissima struttura concettuale e linguistica il cui vero fine
era quello di produrre una salutare innovazione della mentalità e della cultura
politica italiana, per emanciparla dalle secche nelle quali si era arenata.
Quest’opera, coraggiosa e difficilissima come possono esserlo solo le azioni
realmente innovative, presupponeva un’accurata presa di coscienza della
complessa realtà peninsulare. Il linguaggio di Moro è perciò sempre fondato (e
Cfr. N. BOBBIO, Il giovane Aldo Moro, in Id., Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le
culture politiche, a cura di Michelangelo Bovero, Baldini & Castoldi, Milano 1997, pp. 283-307: 289-90. La citaz.
del passaggio è in MORO, Lezioni di Filosofia del diritto, cit. supra nota 7, I, p. 52. L’originalità di Moro è però, a
mio parere, anche in un altro punto: nella sua definizione del diritto naturale la metafisica non è affatto
preponderante. Pur essendo il suo impianto di fondo ispirato a un deciso spiritualismo, lo svolgersi del suo
discorso mostra che in realtà egli identificava il “diritto naturale” con l’evoluzione della coscienza storica. In tal
modo, il diritto naturale perdeva l’aggancio con il nucleo dogmatico e immutabile della sua concezione
tradizionale, per diventare evolutivo alla stregua della coscienza etico-sociale. Per Moro, insomma, il diritto
naturale non è tanto un ‘contenuto’ fisso, quanto una modalità dell’essere e del sentire umano che si dispiega in
un’esigenza, in un’aspirazione perenne al perfezionamento della propria condizione. Di conseguenza l’esperienza
del diritto, «per essere vita dello spirito, è libertà, spontaneità, novità» (ivi, p. 90). Lo schema moroteo, quindi, è
agli antipodi di quello vichiano, verticale e discendente, del verum-factum, la Verità che s’invera nel fatto, ma
quello, orizzontale, dal basso (sia pure, per così dire, di un ‘basso’ ispirato dall’‘Alto’) verso il basso stesso. Il
«realizzarsi» della «verità nella storia» per Moro è soggetto a «mille deviazioni e incomprensioni» (ivi, pp. 19 e
135). «Naturale» è quindi quell’innato desiderio dell’animo umano al mutamento del diritto vigente; è, in
sostanza, la spinta verso il miglioramento dell’esistente. Per questo – egli sostiene – il diritto naturale è
perennemente vivo, in quanto energia creativa verso la permanente riforma del diritto positivo, il quale quindi,
coerentemente a quest’impostazione, è in un certo senso un diritto ‘morto’, in quanto suscettibile di essere
rimosso sulla base propulsiva del diritto naturale. In definitiva, pur credendo fermamente nell’esistenza di una
«coscienza etica universale» (ivi, p. 52 ) e di un «valore universale ed indisponibile dell’azione» (ivi, p. 88), e pur
ritenendo che «il mondo morale» si qualifica in un «suo particolare momento che è l’esperienza giuridica»,
cosicché entrambi «sono dominati da una esigenza di universalità che è il dato più squisitamente umano della
nostra natura» (ivi, p. 50), Moro arriva però ad attribuire il primato al divenire storico «mobile ed aperto per la
sua stessa inesauribilità (ivi, p. 52 ). Benché fondato su presupposti metafisico-spiritualistici e malgrado
l’indistinzione tra «etica» e «morale» da lui adoperati come sinonimi senza sfumature (ma va pur precisato che
questa importante distinzione è venuta delineandosi solo molto più tardi: cfr. I. MANCINI, L’ethos dell’Occidente.
Neoclassicismo etico, profezia cristiana, pensiero critico moderno, Marietti, Genova 1990, pp. 27-42; F. CRESPI (a
cura di), Etica e scienze sociali, Rosenberg & Sellier, Torino 1991, pp. 13-31; IDEM, Imparare ad esistere. Nuovi
fondamenti della solidarietà sociale, Donzelli, Roma 1994, pp. 38-44. Sul punto sia consentito anche un rinvio al
mio saggio: F. DI DONATO, Per un cristianesimo debole, in «Prospettive Settanta», nn. 2-3, 1991, pp. 364-405:
364-5), la speculazione morotea può considerarsi ascrivibile a una linea sostanzialmente realistica. Ciò ricollega
il pensiero all’esperienza politica, vissuta da Moro in assoluta coerenza con i suoi princìpi di fondo eppure con
grande e machiavelliana abilità.
20
non si distacca mai da essa) su una obiettiva descrizione della realtà com’egli la
percepiva nella sua intricata evoluzione fenomenologica. Se si considera questo
dato di fondo, questa matrice ‘epistemica’ del metodo e dello stile moroteo, si
può accedere con maggiore comprensione alla struttura essenziale della sua
logica d’interpretazione della realtà. Si può così pervenire a una visione critica
più profonda, che superi il luogo comune che vuole il linguaggio di Moro criptico,
oscuro e involuto, incomprensibile ai più e talvolta persino alle ristrette cerchie
di protagonisti e osservatori politici (è rimasta celebre la battuta, di pessimo
gusto, di un avversario politico che affermò che l’unica cosa chiara che Moro
aveva in testa era la ciocca dei capelli sulla fronte).
Descrivere una realtà complessa con un linguaggio semplicistico è o impossibile
o ingannevole. La superficialità, spesso fedele accompagnatrice della destrezza,
piena di sé e vuota d’idee originali e profonde, ha spesso pagato in un contesto
come quello italiano nel quale il potere decisionale è detestato, temuto e
osteggiato, mentre la difesa perinde ac cadaver dello status quo caratterizzato
dalla polverizzazione microfeudale è la prima regola dell’agire politico. Essere
ammessi al tavolo del gioco politico italiano è impossibile senza una condizione
di piena partecipazione a questo tacito giuramento di fedeltà allo scacchiere
microfeudale. Chiunque voglia proporre e perseguire azioni volte
all’affermazione di una sovranità unitaria è trattato come un corpo estraneo e
immediatamente emarginato ed espulso dal giro corporativo della dirigenza
politica.
La qualificazione identitaria del protagonista politico peninsulare è destinata,
per comune volontà degli (è il caso di dire) attori sulla scena – chiunque essi
siano – del gioco politico, a restare microfeudale: ogni protagonista deve
mostrare in primo luogo e prioritariamente di voler astenersi da azioni volte a
porlo indiscutibilmente al di sopra dell’oligarchia in una posizione sovrana. La
sovranità in Italia è parcellizzata ed è quindi negazione di se stessa.
3. L’imperdonabile ‘colpa’ di Moro: voler superare l’assetto microfeudale italiano
La ‘colpa’ grave di Moro – per la quale egli era guardato con sospetto e con
circospezione nell’ambito del suo stesso partito –, una colpa che oggi appare, a
chi osservi con lo sguardo disincantato dello storico, la sua maggiore e sublime
virtù, fu di voler superare questa forma mentis e di lavorare per affermare un
sistema di regole istituzionali e politiche nelle quali potesse affermarsi
finalmente in Italia una vera sovranità, una sovranità cioè non parcellizzata e
frammentata in un continuo e permanente negoziato tra i micropoteri
centrifughi ciascuno dei quali rivendicante la propria porzione d’influenza. Una
sovranità, in definitiva, collegata alla responsabilità dell’agire politico.
Moro lavorò per tutta la seconda parte della propria vita, coincidente con la
maggiore incisività della sua opera innovatrice, alla realizzazione di un
equilibrio politico e istituzionale in cui si potesse finalmente determinare una
democrazia compiuta con una logica di piena alternanza. Era, in quest’opera
smisurata, nutrito da una convinzione incrollabile, che lo poneva in siderale
distanza dal pensiero ‘debole’, espressione della strategia dei piccoli passi e della
gestione del contingente e della precarietà immediata che invece
caratterizzavano il metodo e la strategia di altri leaders democristiani. Anche se
non lo disse mai esplicitamente, Moro riteneva – lo si evince da tutto il
complesso dei suoi discorsi e scritti – che il potere logora, eccome, chi ce l’ha e
che la realizzazione di uno spirito delle istituzioni che riuscisse ad accomunare
tutto il Paese reale sarebbe risultata impossibile fino a quando una parte
rilevante del Paese medesimo fosse stata aprioristicamente esclusa
dall’alternanza al potere e quindi priva di responsabilità di fronte all’opinione
pubblica.
Effetto dirompente di quest’anomalia era per Moro uno dei vizi capitali della
cultura italiana che inficiava la forma mentis dei cosiddetti intellettuali ‘engagés’
(e ‘enragés’): la critica non costruttiva, ma solo volta a demolire senza proporre
praticabili e realistiche alternative. È un grave difetto che, per quanti passi in
avanti le vicende storiche recenti ci abbiano costretto a fare, non abbiamo
ancora del tutto superato21. Per Moro, invece, la difficoltà di articolare in un
discorso coerente e persuasivo il disegno di una via di uscita dall’incompiuta
transizione italiana al sistema politico-istituzionale democratico andava in
parallelo con un rinnovamento profondo della mentalità e dei presupposti
culturali e ideologici bloccati ai vecchi schemi della dicotomia secca tra bene e
male, tra amico e nemico, tra progresso e conservazione.
Di qui la sua preoccupazione di conciliare l’inconciliabile, di vincere la sfida
impossibile di una causa che appariva persa, nella convinzione che è proprio
nelle grandi sfide, nelle sfide che sembrano irrealizzabili che si tempra il
carattere di un popolo e si forgia la caratura di un’autentica guida politica (oggi
si direbbe leadership, per scimmiottare il contesto inglese dal quale restiamo in
tutto distanti anni luce). Moro era uomo delle sfide impossibili, poiché la sua
stessa condizione identitaria era continuamente sfidata dalla propria
intelligenza sempre in movimento. E il suo linguaggio ne è la diretta
testimonianza. La testimonianza di uno spirito inquieto in perenne ricerca della
saggezza, intesa come punto di equilibrio possibile tra istanze diverse che
dovevano purtuttavia trovare una sintesi politica, ancorché provvisoria e
dinamica, nel superiore interesse di una nazione sempre sul punto di disfarsi per
mancanza di collante socioistituzionale.
Conciliare istanze diverse e persino opposte non significò però mai per Moro
riesumare il metodo della logica medievale fondato sulla coincidentia
È, tra l’altro, proprio questo uno dei principali motivi reconditi per cui non si riesce a introdurre un elementare
correttivo all’assemblearismo parlamentare, che caratterizza il nostro assetto costituzionale, come la “sfiducia
costruttiva”. Sul punto, cfr. però la puntuale disamina comparata di M. FRAU, Le origini weimariane del voto di
sfiducia costruttivo e la prassi applicativa dell’istituto con particolare riferimento all’ordinamento tedesco, in «AIC.
Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti», n. 3/2012, pp. 1-18.
21
oppositorum. Nulla è più lontano dal suo sguardo dell’assemblaggio acritico o,
peggio ancora, interessato, di opposte determinazioni. Conciliare per Moro non
significa annullare le distanze e le differenze, bensì al contrario approfondirle e
sottolinearne la natura alternativa, ma in un quadro comune che è l’interesse più
alto al corretto e ordinato funzionamento del sistema politico e sociale. Tutta
l’azione politica di Moro – e conseguentemente il suo linguaggio caratterizzato
da un’elevato e crescente livello di complessità – fu rivolta a quest’obiettivo:
all’Italia occorreva più che mai superare lo stadio di democrazia imperfetta in
quanto bloccata dal cosiddetto “fattore K” (l’impossibilità, data la collocazione
atlantica del Paese, di vedere ascendere il partito comunista al governo).
La strada, irta ma obbligata, era allora spingere quella cultura politica relegata al
ruolo di perenne opposizione senz’alcuna concreta speranza di diventare
maggioranza di governo, a evolversi verso forme di moderazione e di
occidentalizzazione compatibili con l’assetto democratico e con le scelte di
politica internazionale compiute dall’Italia all’indomani della seconda guerra
mondiale22.
Moro si pone, insomma, di fronte a un compito improbo, un compito che con il
senno di poi appare votato a un più che certo fallimento. Mutare la mentalità di
un vasto contesto partendo dal lavoro ‘alto’ ossia dal funzionamento del sistema
istituzionale e dall’evoluzione delle forze politico-partitiche è – lo si comprende
ictu oculi – un obiettivo pressoché irraggiungibile. Ciononostante, Moro dedicò
tutte le sue energie a questo immane sforzo, che fu prioritariamente uno sforzo
di elaborazione teorica e di conseguenza uno sforzo di articolazione sintattica
assolutamente fuori del linguaggio ordinario, ovviamente inutilizzabile per il
raggiungimento dello scopo che si era prefisso.
Quel linguaggio appariva perciò oscuro per due fondamentali motivi: per un
verso esso era obiettivamente difficile per un contesto che si sentiva attaccato e
minacciato da quello stesso linguaggio e quindi, istintivamente prim’ancora che
razionalmente, lo respingeva e lo combatteva, ridicolizzandolo; per un altro
l’establishment politico, vedendo in esso un potente veicolo di destrutturazione
dei propri equilibri, si adoperò per isolarlo e denigrarlo, sottolineandone, agli
occhi di un’opinione pubblica già di per sé fragilizzata da secoli d’indifferentismo
e d’ipocrisia, le involuzioni e le perifrasi ellittiche, l’uso sapiente e audace della
litote e di una tornitura della frase che per realizzare la descrizione di una
condizione paradossale come quella italiana faceva largo uso di figure stilistiche
e di strutture argomentative non ordinarie e quindi di comprensione non
intuitiva.
In quelle scelte e soprattutto nelle modalità in cui furono pensate e compiute, vi è già in nuce tutto il destino
della nostra repubblica. Molto utile a una comprensione obiettiva degli eventi e della forma mentis che guidò le
risoluzioni decisive, la ricostruzione di A. GIOVAGNOLI, Il partito italiano. La democrazia cristiana dal 1942 al
1994, Laterza, Roma-Bari 1996, spec. pp. 27-32: 30. Sul background culturale di quella mentalità politica, cfr.,
dello stesso A., La cultura democristiana. Tra Chiesa cattolica e identità italiana. 1918-1948, Laterza, Roma-Bari
1991. Si veda pure, al riguardo, la fine sintesi teorica di E. GENTILE, Né Stato né Nazione. Italiani senza meta,
Laterza, Roma-Bari 2010.
22
Il linguaggio di Moro, infatti, nella ricerca di una descrizione puntuale e
ineccepibile della particolare condizione politica italiana, aveva bisogno di
utilizzare costruzioni e immagini che alla media razionalità non potevano che
risultare ostiche, quando non del tutto incomprensibili, secondo una qualità che
trova riscontro solo nel linguaggio dei grandi mistici e dei visionari23.
4. Semplificazione anglo-americana e fumisterie italiane
Su questo facevano del resto leva i suoi nemici (più ancora occulti che palesi).
Per loro Moro era la quintessenza del politico astruso, i cui discorsi mirabolanti
e fumosi nascondevano in realtà una sola idea: «Portare i comunisti al governo».
E così apparve anche alla scarna ed elementare razionalità empirica americana,
per la quale risulta spesso incomprensibile una complessità come quella italiana,
dov’è difficile far emergere le «idee chiare e distinte» e tutto si complica in un
ginepraio d’interessi raramente distinguibili e identificabili, veicolati da discorsi
il cui scopo prioritario è quello di occultare, depistare, deresponsabilizzare.
Se per un verso bisogna riconoscere che spesso questa incomprensibilità d’oltre
oceano, e più in generale dei Paesi del nord occidentale, ha dalla sua più di una
buona ragione, poiché il carattere tipicamente italiano è percepito come il
raggiro e la truffa per eccellenza (tutti ricordano il pungente aforisma di Ennio
Flaiano: «In Italia la linea più breve per collegare due punti è l’arabesco»), per un
altro occorre osservare che mai come nel caso di Aldo Moro quella diffidenza fu
prondamente erronea. E si ha l’impressione che su questo equivoco ha potuto
purtroppo concretizzarsi una delle principali ragioni dell’isolamento culturale
prima che politico di Moro, cosa che fu probabilmente all’origine della sua
tragica fine o che comunque non agevolò la soluzione – per dirla con le celebri
parole di Sciascia – dell’affaire24. La cultura, la mentalità, la logica e la stessa
struttura linguistica angloamericana sono tutte ispirate da un’esigenza primaria
di semplificazione e perciò puntano, più che sulla deduzione da princìpi primi,
sull’osservazione fenomenologica ed empirico-induttiva25. Il perno di questa
struttura è l’Okham’s razor, per cui era estremamente difficile che un americano
potesse persuadersi di fronte a ragionamenti articolati e cesellati come quelli di
Moro. A monte vi è una diversa percezione della realtà, una differente visione del
mondo. L’antiformalismo americano procede per semplificazioni convenzionali
del reale, ossia per compartimenti concettuali direttamente funzionali a
conseguire un determinato obiettivo preposto. Niente di più respingente e
irritante e – oltretutto – incomprensibile per un americano che l’uso di arditi
ossimori, di chiasmi e metonimie, di macchinosi intrecci concettuali tesi a dar
conto di una realtà estremamente paradossale e complessa come quella italiana.
Cfr. M. BALDINI, Il linguaggio dei mistici, Queriniana, Brescia 1986.
L. SCIASCIA, L’affaire Moro, Sellerio, Palermo 1978 (più ediz. successive).
25 Cfr. J. DEWEY, Logica, teoria dell'indagine, trad. it. Einaudi, Torino 1949 (più ediz. successive).
23
24
Il linguaggio di Moro è intessuto di ossimori, di litoti, di epifonemi, di locuzioni
circolari e ardite (mentre decisamente meno frequenti sono metafore e allegorie,
poiché il linguaggio di Moro è alla ricerca di un’asciuttezza che lo ponga a suo
modo in continua presa diretta con l’evoluzione della complessità del reale
sociopolitico italiano). Nulla di più probabile, dunque, che l’incomprensione in
un contesto come quello angloamericano, decisamente incompatibile, nella sua
essenziale ricerca dell’efficacia e dell’utilità immediata, con le ricercate ed
eleganti bulinature del periodare moroteo.
È il caso di soffermarsi a questo riguardo – per il suo forte potere evocativo
dell’intera personalità e azione politica dello statista salentino – sull’immagine
più celebre, considerata nella vulgata ancor oggi diffusa la quintessenza del
linguaggio moroteo, quella delle «convergenze (e/o divergenze) parallele». Di là
da questa paradossale idea è importante cogliere la logica di fondo di
quell’immagine, non tanto perché essa sia del tutto rappresentativa, come si
crede, del complesso pensiero di Moro (è ormai abbastanza noto che la vicenda
filologica di quell’affermazione è piuttosto complessa26), quanto perché essa
esprime bene uno sfondo culturale nel quale si può cogliere sia la tormentata
matrice del pensiero moroteo nel suo farsi, sia la non meno travagliata
evoluzione del rapporto tra elaborazione teorica e sviluppo pratico-politico degli
eventi storici in particolare nel campo sociale e istituzionale. Da questo punto di
vista l’immagine delle “convergenze parallele” esprime perfettamente il lavorìo
di Moro per descrivere una realtà politica assai complessa e intricata che un
linguaggio more geometrico avrebbe finito con il disattendere, falsandola
completamente. Per rendersene conto basterà riascoltare un passaggio del
celebre discorso di Moro intitolato La politica non è solo convenienza, nel quale
egli, con un suo tipico ossimoro concettuale, difende contemporaneamente «la
coerenza e la flessibilità», ossia la fedeltà agl’ideali e la disinvoltura nella
manovra politica27.
Alcuni ne attribuiscono la paternità orale (quindi difficilmente documentabile) a don Luigi Sturzo, altri a
Eugenio Scalfari che la utilizzò in un articolo su «L’Espresso» del 24 luglio 1960 intitolato «Il governo
geometrico»: cfr. l’efficace sintesi della vicenda in M. MEDICI, Aldo Moro. L'intelligenza e gli avvenimenti. Testi,
1959-1978, Fondazione Aldo Moro, a cura di G. Quaranta, Milano, 1979, pp. LXXV-433: 34-5 (devo la segnalazione
di questa citazione all’attenta ricerca di Daniele Mezzana, che ringrazio per avermela premurosamente fornita).
In realtà, l’affermazione testuale di Moro (discorso alla Camera dei Deputati, 13 luglio 1961) parlava di
«convergenze democratiche», riferendosi al governo di centro-sinistra imperniato sull’accordo programmatico
tra DC e PSI. Successivamente Moro saprà però servirsi, accortamente giovandosene, della formula a lui
attribuita e in precedenza da lui stesso disconosciuta come «formula geometrica assurda»; così nel discorso
tenuto a Benevento il 18 novembre 1977 (al quale chi scrive assisté personalmente, giovanissimo,
conservandone tutt’oggi un nitido ricordo), Moro riaffermò la validità di quell’immagine per descrivere il nuovo
scenario che andava delineandosi con il governo della non-sfiducia e l’inizio di una fase di maggiore
coinvolgimento del PCI nella politica di governo: «Se volessi richiamare una frase – che non so nemmeno se l’ho
pronunciata o se mi è stata semplicemente attribuita – potrei dire che si tratta di un tipico caso di ‘convergenze
parallele’».
27 La stessa struttura polidimensionale si nota nel discorso condotto da Moro su un tema di cruciale rilevanza
come la laicità dello Stato. «In occasione dei lavori per la Costituzione», Moro difese gli «elevati valori morali» in
gioco e prese parte per la tesi anti-laicista che a suo dire avrebbe ridotto «lo Stato a mera entità giuridica»
estraniandolo «dal flusso della storia» e rendendolo così «indifferente verso cose che assumono per gli uomini,
nei quali si risolve lo Stato, straordinaria importanza», cosicché «uno Stato che ignori la religione o le religioni,
26
Riascoltando o rileggendo passi come questo vengono in mente altre celebri
parole, quelle di Piero Gobetti, il quale, nel trattare lo spinosissimo problema
(divenuto poi uno dei più efficaci cavalli di battaglia azionisti e bobbiani) del
rapporto tra “politica e cultura”28, scrisse che «i fermenti d’idee liberano il
mondo dell’azione dai pericoli dogmatici e reazionari lasciando libero l’uomo di
Stato ai suoi compromessi e alle sue astuzie»29. La novità, rispetto a questo
schema gobettiano, è che in Moro i due momenti e le due figure – l’intellettuale
che elabora e il politico che agisce – coincidono e coesistono. In Moro si realizza,
al più alto livello della storia politico-istituzionale italiana ed europea,
l’ambizioso tentativo di tenere assieme i due piani senza sfociare in una
stridente e palese, nonché insanabile, contraddizione. È da questo tentativo che
deriva la struttura fondamentale del linguaggio moroteo, irto d’intricate
‘coesistenze’ che sarebbero state in chiunque altro impensabili e impossibili.
5. Le «convergenze parallele»: storia di un ‘vero’ che divenne ‘falso’
L’immagine delle «convergenze parallele», quella che è, a torto o a ragione,
divenuta il simbolo stesso, implicitamente dispregiativo, del linguaggio politico
moroteo e della logica distorta e contraddittoria che vi era sottesa, appare, come
giustamente è stato osservato, meno paradossale di quel che si percepisce di
primo acchito30. L’assurdo si realizza, infatti, solo nel contesto della geometria
euclidea, mentre nella geometria iperbolica (inizialmente detta «immaginaria») e
in quella ellittica le linee geodetiche s’incontrano. Fin dai primi decenni del
secolo XIX «l’idea che il postulato delle parallele non possa essere dimostrato» fu
«comunemente accettata» dai matematici. In molti di loro, tra cui Legendre
(1752-1833), Bolyai (1802-1860) e Gauss (1777-1855), che proseguirono
ricerche già avviate da Saccheri (1667-1733) e Lambert (1728-1777), ma
soprattutto nell’opera di Nicolaj Ivanovic Lobacevskij (1793-1856) cominciò, fin
da allora, «ad affacciarsi l’idea che si possa costruire una geometria
indipendente dal quinto postulato di Euclide»31. Nello spazio curvo, che secondo
Einstein è il contesto oggettivo dell’universo, le rette geodetiche s’incontrano
che si limiti freddamente a garantire ad esse condizioni di libertà è tale che rifiuta un impegno morale che per i
singoli si pone come inderogabile esigenza» e si qualifica quindi come «uno Stato che manca di cose essenziali
all’uomo e che si pone per ciò stesso in qualche modo pericolosamente fuori dell’uomo». Ma, subito dopo, Moro
cambiò improvvisamente registro e affermò che con ciò non s’intendeva «indicare positivamente l’atteggiamento
che ogni Stato deve assumere di fronte al fenomeno religioso (cosa delicatissima e storicamente variabile)», ma
si voleva affermare, solo genericamente, «che lo Stato non può sbarazzarsi della religione, per procedere nella
sua strada, perché con ciò, sia esso pure il più liberale, si è fatto già lontano dall’uomo e non vibra più all’unisono
con lo spirito umano».
28 N. BOBBIO, Politica e cultura, Einaudi, Torino 1955.
29 P. GOBETTI, La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia [1924], ediz. a cura di Ersilia
Alessandrone Perona, Einaudi, Torino 1995, p. 18.
30 Cfr. MEDICI, op. loc. cit. supra nota 26, secondo il quale «la locuzione [solo] erroneamente» può essere
«considerata […] un assurdo logico e linguistico».
31 Cfr. N. DODERO, P. BARONCINI, R. MANFREDI, Nuovi elementi di matematica, Sedes, Milano 1998, p. 363 ss.
per definizione com’è facile dimostrare con il ricorso a semplici immagini
sferiche.
Lo spazio curvo può essere considerato in geometria l’equivalente della
dimensione complessa in (teoria e pratica) politica. Questa complessità, che fu
colta da un altro grande matematico, Bernhard Riemann (1826-1866), si può
focalizzare nel concetto di «varietà n-dimensionale». Il ragionamento di
Riemann dimostra, con una complessa articolazione logico-matematica, che «le
geodetiche sono linee di equazione ax + by + c = 0 che si identificano con le rette
del piano cartesiano»32. Ciò si risolve, in definitiva, a dimostrare che nella
geometria pluridimensionale le linee geodetiche, equivalenti alle rette parallele
nello spazio piano euclideo (unidimensionale), s’incontrano necessariamente.
La conclusione geometrico-matematica è perfettamente sovrapponibile a quella
storico-politica: di fronte a differenti teorie dello spazio e delle forme presenti in
esso la verità non può essere pensata come «una proprietà intrinseca di una
teoria». Ciò significa che per decidere se una geometria (o una teoria politica) è
vera «è inutile indagare sulla sua struttura logica, ma è necessario stabilire se
essa descrive esattamente lo spazio fisico»33, cioè la realtà socio-politicoistituzionale.
32
33
Ivi, p. 365.
Ivi, p. 367.
6. Dalla forbita oscurità giovanile alla cristallina chiarezza di un linguaggio
politico paradossale e complesso
Da questa fondamentale dimostrazione si può inferire, per traslato, che il lessico
di Moro, lungi dall’essere criptico, oscuro e contraddittorio, fu al contrario
l’unico linguaggio capace d’intendere la complessa struttura ‘curva’ della realtà
politica italiana, non solo descrivendola correttamente, ma proponendo anche
soluzioni per favorirne l’evoluzione ragionata verso approdi utili e positivi per
l’interesse generale. Si può dire, quindi, che la complessità del linguaggio
moroteo era finalizzata all’obiettivo di semplificare la vita politico-istituzionale
italiana, depurandola dalle secolari incrostazioni che la caratterizzavano e
proponendo una rivoluzionaria evoluzione verso un sistema politico più
essenziale, accessibile e trasparente.
6.1. La prima fase dell’elaborazione concettuale
Vi è qui da notare un ulteriore paradosso nella falsa valutazione della presunta
natura criptica dell’idioma moroteo: se proprio si volesse andare alla ricerca di
un Moro meno chiaro e a tratti addirittura oscuro e contorto, ci si dovrebbe
allora indirizzare verso l’acerbo e vigoroso pensiero della fase giovanile,
manifestato soprattutto negli scritti universitari di filosofia del diritto. In quei
lavori scientifici, usando un linguaggio forbito ma piuttosto astruso e involuto,
pieno di locuzioni arabescate e di frasi incidentali e parentetiche lunghe,
articolate e decisamente difficili da seguire, egli tentava di risolvere l’irrisolvibile
groviglio insito nella preoccupazione di conciliare la dottrina cattolica con il
pensiero critico della modernità giuspolitica34.
L’intento del giovane Moro era quello di difendere da un lato l’idea che «la legge
morale è necessariamente universale»35, e dall’altro una concezione della società
come coesistenza plurale di opzioni etiche e politiche36. L’intenzione, in sé
ammirevole considerando l’enormità del tema, per di più affrontato da uno
studioso appena trentenne, si scontrava con la dura inconciliabilità di due
universi mentali che veicolavano due visioni del mondo e due molto diverse
sensibilità, teoretiche prima che politiche, nell’approccio al reale, in un momento
storico nel quale quella frattura era molto sentita. Era giocoforza che in questo
tentativo la logica delle idee “chiare e distinte” dovesse subire qualche forzatura
Anche su questo punto, il suo pensiero si pose con largo anticipo problemi che sono in seguito stati oggetto di
riflessioni e sviluppi di grande interesse. Si vedano, sul punto, tra una vasta bibliografia, F. BOLGIANI, V.
FERRONE, F. MARGIOTTA BROGLIO (a cura di), Chiesa cattolica e modernità. Atti del Convegno della Fondazione
Michele Pellegrino, Il Mulino, Bologna 2004; A. PROSPERI, P. SCHIERA, G. ZARRI (a cura di), Chiesa cattolica e
mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi, Il Mulino, Bologna 2007.
35 MORO, Lezioni di filosofia del diritto, cit. supra nota 7, p. 141; «universale» è la parola maggiormente, e
ossessivamente, ricorrente in quegli scritti.
36 Ivi, pp. 17 e 133: «La società si presenta innanzi tutto come molteplicità».
34
di troppo. Osserviamo, ad esempio, quale passaggio rappresentativo del
tortuoso periodare giovanile di Moro, questo brano nel quale egli si sforza di
dare una definizione articolata della compagine sociale, tentando in ogni modo
di riportare a unità – secondo lo schema della logica hegeliana
tesi/antitesi/sintesi – termini fortemente polarizzati:
L’anima della società, quello per cui essa è se stessa, è la relazione, che implica la
molteplicità, ma la supera instaurando l’unità, la quale ultima, a sua volta, non è l’unità
indifferenziata che non rechi traccia del molteplice da cui è scaturita, ma appunto unità
nella distinzione, ideale coesione del molteplice che in ciascun elemento rivive
l’universale esigenza d’unità, e perciò continuo processo in svolgimento, sforzo
nobilissimo per una conquista da compiere in ogni istante della vita. […] La relazione
così intesa, quella che, una volta costituita (ma non è per questo costituita
definitivamente), dà anima unitaria alla società è appunto la relazione che di questa
realizza la profonda verità, e quindi non mero contatto tra soggetto e soggetto, il quale
non si può escludere che esista anche nella forma più risoluta di negazione dell’altrui
esigenza, perché ogni negazione include necessariamente un’affermazione e quindi
ogni disconoscimento dell’altro uomo nella vita sociale è pur sempre un
riconoscimento del rilievo che ha per noi l’altrui vita, ma appunto quella relazione che
instaura un contatto fra i termini particolari, riconducendoli tutti all’universale valore
di cui sono espressioni e quindi compaginandoli nella sola forma di relazione che sia
umana (e da cui scaturiscono tutte quelle particolari) e che è l’amore37.
Peraltro, già in questa fase, s’intravedevano spunti di grande interesse –
soprattutto nel campo politico-istituzionale –, che lasciavano presagire, a una
lettura attenta, gli sviluppi futuri.
6.2. La teoria morotea della statualità
Tra queste linee tracciate dal Moro della prima fase, molto interessante – per la
sua attualità oltre che per la sua originalità – appare la definizione dello Stato
che per lui «è società che si svolge secondo un ideale di giustizia universalmente
valido»38. Ora, quell’ideale di giustizia – che è innanzitutto eguaglianza
sostanziale – non può essere attuato senza il principio di legalità, in quanto nello
Stato democratico è la legge, atto rappresentativo della volontà popolare, il
principale strumento di attuazione della giustizia. Qui Moro non sembra molto
lontano dal giuspositivismo critico – oggi potremmo dire à la Michel Troper,
secondo il quale lo «Stato» non è altro che il potere quando assume la «forma
Ivi, pp. 21-22 e 137.
Ivi, pp. 17, 133 e 150: va notato che nella seconda e nella terza formulazione (quella di pp. 133 e 150)
scompaiono dalla definizione le ultime due parole («universalmente valido»). Il secondo vol. delle Lezioni, quello
appunto dedicato a Lo Stato ripropone tel quel le pagine iniziali dedicate alla «Società».
37
38
giuridica»39, forma che nel contesto democratico non può che essere posta a
tutela del principio egualitario –.
Per Moro, inoltre, «l’esperienza statuale» è imprescindibile dall’identità
nazionale, in quanto «lo Stato, nella sua tipica particolarità, si pone come
Nazione»40. Infatti,
[…] distinguere nazione e Stato è impossibile, perché […] la nazione è la stessa storicità
dello Stato che vibra nella coscienza dei cittadini e che è perciò immanente alla
definizione di Stato come particolare-universale. […] Non è la nazione che crea lo Stato,
perché la nazione è sempre Stato, anche se sembri sfornita di quelle caratteristiche di
sovranità che dello Stato son proprie; […] ché se poi lo Stato non è nazionale, non è
veramente Stato, ma momento negativo e provvisorio dell’esperienza sociale, perché
sfornito di quelle caratteristiche di una unità veramente sentita e storicamente
operante, senza della quale il suo compito proprio non potrebbe venire assolto. […]
D’altra parte neppure esatto è dire […] che lo Stato crea la nazione, perché la nazione
non è come risultato temporalmente distaccato dall’educazione formativa dello Stato,
ma è la sostanza stessa del vivo processo per cui lo Stato è, facendosi come unità viva
nella molteplicità41.
Adottando quindi – com’egli stesso afferma – una definizione non appiattita su
«un formalismo assolutamente inammissibile»42, Moro perviene, a mio avviso
molto correttamente, a una concezione che, sia pure solo nebulosamente
intravista in quel momento (in quanto incapsulata nel vecchio schema dialettico
dell’idealismo ed esposta con uno stile alla cui ridondanza non è estranea una
sensibile influenza crociana), può essere considerata antesignana delle più
aggiornate teorie sullo Stato e sulla statualità43, giungendo in tal modo a chiarire
a se stesso, attraverso un procedimento logico ex contrario, la principale causa
dell’anomalia italiana.
Su questo tema, come non mai, si può osservare perfettamente come
l’intelligenza di Moro sia alacremente all’opera contro se stessa, come cioè essa
si dimeni per fuoriuscire da schemi che pure naturaliter utilizzava, in quanto
elementi che apparivano essenziali e imprescindibili alla formazione culturale
del suo tempo. Malgrado le difficoltà a raggiungere la chiarezza cartesiana, per la
sua spontanea propensione a combinare concetti opposti, che cercava in ogni
Cfr. M. TROPER, Per una teoria giuridica dello Stato, trad. it. a cura di Agostino Carrino et al., Guida,
Napoli 1998, pp. 170-1; IDEM, La théorie du droit, le droit, l’État, PUF, Paris 2001, pp. 267-81: 275.
39
MORO, Lezioni di filosofia del diritto, cit. supra nota 7, pp. 154-5.
Ibid.
42 Ibid.
43 Mi permetto di rinviare, sul punto, al mio recente contributo: F. DI DONATO, Ceto dei giuristi e statualità dei
cittadini. Il diritto tra istituzioni e psicologia delle rappresentazioni sociali, in L. TEDOLDI (a cura di), Alla ricerca
della statualità. Un confronto storico-politico su Stato, federalismo e democrazia in Italia e in Europa, QuiEdit,
Verona 2012, pp. 19-63. Si veda anche il dibattito tenutosi all’Università di Trento e parzialmente pubblicato da
L. BLANCO (a cura di), sotto il titolo Atti del seminario di Trento, 15-16 dic. 2006, in «Storia Amministrazione
Costituzione. Annale dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica», Il Mulino, n. 16/2008. Per ampie
indicazioni bibliografiche rinvio al mio vol.: F. DI DONATO, La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistraturapolitica alla civilizzazione istituzionale europea, Il Mulino, Bologna 2010.
40
41
modo di armonizzare smussandone le angolature più pronunciate, Moro coglie
l’essenziale: per lui la statualità, intesa «come l’esperienza dell’uno che vive
come molteplice»44, non si può ridurre a un mero fattore giuridico-normativo o
teorico-politologico, ma abbraccia l’intera vita culturale e psicologica di una
comunità nazionale, essendo determinata dal carattere e dalla mentalità diffuse
e a sua volta influenzandoli.
6.3. Le «intuizioni di civiltà» e l’ideazione di una sovranità plurisociale
Questa definizione, straordinariamente innovativa nel momento-cerniera tra
l’esperienza dell’autoritarismo fascista e la democrazia repubblicana, porta
Moro a concepire il potere statuale, e il correlato rapporto tra autorità e libertà,
in modo del tutto originale e ancor oggi a mio parere denso di sviluppi fecondi.
Moro sottolinea come lo Stato sia «essenzialmente popolo, perché è […]
essenzialmente società e società vuol dire pluralità di particolari» che recano
però in se stessi una «immancabile vocazione all’unità»45. Di conseguenza egli
intende la sovranità dello Stato non «come una piramide il cui vertice […]
rappresenta veramente l’essenziale», concezione che fa «perdere, quasi
inconsciamente, l’idea più comprensiva e vera dello Stato come totalità
dell’esperienza sociale che si svolge secondo la sua legge», ma come una sintesi
tra istanze differenziate, «rappresentative di tutta la ricca e varia esperienza in
cui il comando vive e per determinare la quale esso è necessariamente posto»46.
Se la sovranità non è perciò riducibile «a puro comando», a sua volta la statualità
non si può identificare – come erroneamente ancor oggi molti studiosi
continuano esplicitamente o implicitamente a credere – con l’apparato
istituzionale e i suoi strumenti decisionali, ma va piuttosto definita «come
totalità dell’esperienza sociale» svolta nel quadro dell’organizzazione dello Stato
e «secondo la sua legge»47. Moro dissipa qui un grande – è lui stesso a definirlo
così – «equivoco» della dottrina classica dello Stato. È fondamentale, per lui,
«rivendicare la complessità» di quest’ultimo, «che non si esaurisce affatto nel
suo momento potestativo»48. Perciò va categoricamente esclusa «l’idea che
sovranità sia espressione di mera potenza»49 e va invece considerata valida
l’idea che lo Stato sia espressione sintetica di «volizioni» multiple50, e che i suoi
«fini», tanto «essenziali» quanto «contingenti», sono tesi a perseguire
MORO, Lezioni di filosofia del diritto, cit. supra nota 7, p. 156.
Ivi, p. 158.
46 Ivi, p. 160.
47 Ibid. Ed è appena il caso di aggiungere che è stato proprio questo errore di fondo, consistente nell’identificare
tout-court la statualità con la sovranità, a determinare l’insistenza sulla cosiddetta “crisi dello Stato”, sulla quale
si è costruita in Italia una tanto vasta quanto ripetitiva letteratura, fin troppo nota per essere qui ricordata.
48 Ibid.
49 Ivi, p. 161.
50 Ivi, pp. 163-75.
44
45
«determinate intuizioni di civiltà»51. Con un’espressione che non avrebbe forse
potuto utilizzare, ma che bene riassume il senso del suo composito pensiero,
Moro sostiene in sostanza che la statualità sia il veicolo fondamentale del
processo di civilizzazione che caratterizza il quid della cultura giuridico-politica
e dell’organizzazione sociale e istituzionale dell’Occidente europeo52. La
statualità morotea s’interseca qui con quello stratificato «spirito delle
istituzioni» che caratterizza la plurisecolare esperienza politico-sociale degli
Stati-nazione più avanzati d’Europa, nei quali è stata proprio quella solidità
socioistituzionale a formare l’ossatura delle future democrazie53.
Con questa concezione che – per quanto ciò possa apparire sorprendente –
apparenta il pensiero di Moro più alla visione ‘liberale’ di uno Spinoza che a
quella politico-morale di uno Hegel o dei pensatori politici cristiani che si
presumerebbero più vicini alla sua sensibilità e alla sua visione del mondo, viene
completamente spiazzata e superata l’idea dello “Stato etico” che si autoinveste
«del compito di promuovere la cultura e di sviluppare l’eticità nel senso più
largo», mentre il fine dello Stato moroteo è la garanzia della libertà dell’uomo «e
non già il totale svolgimento della eticità nella storia»54. In tal senso l’esperienza
statuale si qualifica – e qui Moro coglie con stupefacente acume il punto
nevralgico nel quale si annida la ragione prima del processo di statualizzazione55
– come la sintesi di «ogni concreta attività umana», di ogni «attività sociale, volta
a promuovere con forze associate, e però con efficacia storica di gran lunga
superiore a quella del singolo, tutti gli scopi umani…»56.
Ivi, pp. 176-80: 176. Moro precisa qui, con una frase che è anche un esempio perfetto del suo stile, che
l’esistenza dello Stato si giustifica «in adempimento di una profonda vocazione umana, promuovere la quale in
tutta la ricchezza della sua determinazione, è appunto dello Stato ragion d’essere essenziale».
52 Sia consentito, riguardo questo concetto, un rinvio alle considerazioni svolte nel mio saggio: F. DI DONATO,
Critica della ragione ‘virtuosa’. Roland Mousnier: la civiltà giuridica dello Stato assoluto, in R. MOUSNIER, La
costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento, a cura di
Francesco Di Donato, ESI, Napoli 2002, pp. XV-CXXXVI: LXVIII-LXXVI. Cfr. anche Id., Sulla civilizzazione statuale,
in «Ragion pratica» (in corso di stampa).
53
Cfr. RICHET, Lo spirito delle istituzioni, cit. supra nota 6; Ph. CORRIGAN, D. SAYER, The Great Arch. English
State Formation as Cultural Revolution, Basil Blackwell, Oxford-New York 1985. Per un vasto quadro europeo, cfr.
Ch. TILLY (a cura di), La formazione degli stati nazionali nell’Europa occidentale, trad. it. a cura di Rinaldo Falcioni e
Gaspare Bona, Il Mulino, Bologna 1984; T. ERTMAN, Birth of Leviathan. Building States and Regimes in Medieval
and Early Modern Europe, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1997. Si vedano, infine, l’ampia e originale disamina di
E. ROTELLI, Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799, Il Mulino, Bologna 2005; e l’opera, riassuntiva
di un lungo percorso di ricerca sul tema, di R. AJELLO, Dalla magia al patto sociale. Profilo storico dell’esperienza
istituzionale e giuridica, L’Arte Tipografica, Napoli 2013.
54 MORO, Lezioni di filosofia del diritto, cit. supra nota 7, p. 178. Si veda anche il passo – spinoziano quant’altri mai
– a p. 179: «Scopo immanente dello Stato, sua ragion d’essere, in quanto esperienza sociale particolarmente
caratterizzata, è appunto questa compiuta realizzazione dei fini dell’uomo, per la quale lo Stato è. […] Dire Stato
val quanto dire società, e cioè sviluppo umano nella coesistenza necessaria; ma val quanto dire, che è cosa assai
significativa, sviluppo dell’umanità secondo la sua intrinseca legge e quindi in un ordine». Per questa concezione
della statualità ‘liberale’ in Spinoza, cfr. D. PARIGAUX, Spinoza l’anti-Léviathan, La Libre Pensée, Paris s. d.
55 E ciò in un’epoca, va sottolineato, in cui non esistevano gli studi socioanalitici dei quali disponiamo oggi: cfr.,
per tutti, R. BOUDON (a cura di), Trattato di sociologia, trad. it. a cura di Marco Santoro e Manuela Martini, Il
Mulino, Bologna 1996.
56 MORO, Lezioni di filosofia del diritto, cit. supra nota 7, p. 180 (corsivo mio). In sostanza Moro comprende qui
perfettamente che la nascita dello Stato moderno si fonda sulla necessità di superare l’eterogenesi dei fini e di
mettere in opera di un’azione politica che, grazie a mezzi impersonali di gran lunga più potenti ed efficaci di
quelli di cui sono capaci i singoli individui, riesca a centrare gli obiettivi intenzionali predeterminati dalla
51
Questo sistema organizzativo, finalizzato dunque a potenziare l’efficacia
dell’azione sociale, è il risultato di un lungo processo storico il cui passaggio
cruciale nel corso dell’Età moderna, lo Stato assoluto, non sfugge a Moro, che
anche qui mostra una perspicacia davvero fuori dal comune nell’uscire dal solco
tracciato dai consolidatissimi modelli interpretativi della storiografia politica
egemone nel suo tempo e ispirata a un’idea di fondo che resiste ancor oggi nella
visione di diversi studiosi (soprattutto coloro che sono influenzati dalla
concezione idealistica)57. Con una notevole anticipazione sui tempi
dell’evoluzione storiografica58, Moro comprese «l’assurdo puntuale» insito nella
«formula» della sovranità assolutistica e affermò l’inesistenza storica di quel
modello, formulato solo sul piano della teoria politica, ma mai pienamente
inverato nella realtà istituzionale59.
ragione. Per l’approfondimento di questo tema, rinvio ai miei saggi: DI DONATO, Critica della ragione ‘virtuosa’,
cit. supra nota 52, pp. LIX-LXVIII; IDEM, La rinascita dello Stato, cit. supra nota 43, ad indicem e spec. 449-53.
57 A riprova di questa persistenza dell’interpretazione che vede nello Stato monarchico-assoluto un fenomeno
politico-istituzionale effettivo e non una mera dottrina della sovranità, si vedano, ad es., alcuni dei contributi
inseriti nel vol. curato da L. BARLETTA e G. GALASSO, Lo Stato moderno di ancien régime, «Atti del Convegno di
Studi», San Marino 6-8 dicembre 2004, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Scuola Superiore di
Studi Storici, Aiep Editore, San Marino 2007; su questo vol. cfr. i rilievi critici formulati da E. ROTELLI, L’insulto
del silenzio. Stato moderno come amministrazione, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 25 e 200; dello stesso
A., cfr. anche Lo «Stato moderno» venticinque anni dopo, in IDEM, Amministrazione e costituzione. Storiografie
dello Stato, Clueb, Bologna 2007, pp. 119-30. Si veda, inoltre, il quadro tracciato da G. GALASSO, Stato e
storiografia nella cultura del secolo XX. Appunti su alcuni aspetti del problema storico, in W. BLOCKMANS e J.-Ph.
GENET (a cura di), Visions sur le développement des États européens. Théories et historiographies de l’État
moderne, «Actes du colloque organisé par la Fondation européenne de la science et l’École française de Rome»,
Roma, 18-31 mar. 1990, Éditions de l’École française de Rome, Roma 1993, pp. 95-115.
58 Vale qui, variatis variandis, quanto segnalato supra in nota 55. Gli studi storici più significativi sul tema della
monarchia assoluta (si pensi per tutti a Roland Mousnier e ai suoi lavori usciti tra gli anni Cinquanta e Settanta
del ’900, alcuni dei quali raccolti a mia cura nel volume La costituzione nello Stato assoluto, cit. supra nota 52)
sarebbero usciti solo diversi anni più tardi. È appena il caso di segnalare che il luogo comune secondo il quale la
monarchia assoluta sia realmente esistita e che proprio per abbatterla fosse scoppiata la Rivoluzione, è ancora
totalmente in auge e si rivela un errore tanto diffuso quanto radicatissimo e duro a morire. Cfr. il vol. (peraltro
non eccellente nell’impianto e nella puntualità ricostruttiva, ancorché efficace nell’idea di fondo) di N.
HENSHALL, Il mito dell’assolutismo. Mutamento e continuità nelle monarchie europee in età moderna, trad. it. a
cura di Carlo Gatti Il Melangolo, Genova 2000.
59 Cfr. MORO, Lezioni di filosofia del diritto, cit. supra nota 7, p. 177: «Intesa alla lettera la formula dello Stato
assoluto è l’abdicazione dello Stato ad essere secondo la sua natura; nella sua tipica identificazione dello Stato
con la persona che ne dirige gli svolgimenti, con il conseguente riferimento perciò ad una posizione grettamente
particolare, esso è propriamente la negazione dell’essenza dello Stato. E tuttavia la prassi politica non ci presenta
Stati che siano veramente assoluti [corsivo mio], nei quali cioè lo sviluppo sociale sia condotto del tutto senza
razionalità di mete definite nel senso dell’egoismo e dell’interesse di uno solo. In questo senso la storia svela
l’assurdo puntuale di quella formula [corsivi di Moro], che non potrebbe essere assolutamente applicata in modo
pieno per la reazione immancabile dei valori etici e di libertà, che son troppo veri e troppo forti, per poter perire
del tutto, anche se compressi. [Perciò] non c’è Stato in concreto veramente e completamente assoluto, che poi
vorrebbe dire Stato alienato dalla sua profonda razionalità, perché la società non può essere piegata fino a
perdere, nel suo concreto sviluppo politicamente manovrato, ogni senso di superindividuale, del vero,
dell’umano, fuori dei quali non ci sarebbe Stato». Si tratta, come ognun vede, di un passaggio davvero
straordinario per profondità intuitiva e chiarezza espositiva, che ancor oggi andrebbe letto e meditato da molti
storici modernisti e da tutti gli studiosi di scienze sociali.
6.4. La rivoluzione silente
Coerente con questa concezione dello Stato è la teoria della rivoluzione che
Moro schizza in pochi ed efficacissimi tratti: per lui la rivoluzione non è che
l’«accentuazione particolare di un’unica verità», che consiste nel «perenne
divenire della vita sociale»60. In tal senso la più profonda rivoluzione è, per
Moro, innanzitutto nel «pacifico ricostruirsi in nuova e più adeguata forma
storica della solidarietà sociale normativa ad opera degli stessi organi della
legislazione»61.
Sembra qui già delineata la futura linea politica che avrebbe ispirato lo statista
degli anni Sessanta e Settanta, impegnato a creare le condizioni per una
rivoluzione silente, scavata pazientemente all’interno degli equilibri politici e
istituzionali dell’incompiuta democrazia italiana, priva di alternanza al governo
e sempre più paralizzata dai mille e mille veti incrociati posti dalla miriade di
piccoli e grandi potentati attivi. Per Moro «il Paese» non aveva «trovato,
evolvendo, un suo assetto definito ed accettabile». E non si trattava «di
sovrastrutture, ma di fenomeni di base». E sarebbe perciò stato vano
«approntare piccoli rimedi a fronte di cause importanti»62. La lucidità di
quest’analisi è, vista retrospettivamente, d’impressionante profondità e di
straordinaria chiarezza. Moro indicava uno dei grandi mali italiani nella
«sproporzione», nella «disarmonia» e nell’«incoerenza tra società civile, ricca di
molteplici espressioni ed articolazioni, e società politica»63.
Si tratta, all’evidenza, di un fenomeno che, approfonditosi sempre più negli anni
successivi, è oggi esploso in forme patologiche con ogni probabilità irreversibili
che hanno corroso i tessuti connettivi della nostra già fragile democrazia,
sempre a rischio di essere surclassata dall’anarchia microfeudale e dalle logiche
combinatorie, tipiche di un contesto intessuto di egoismi mai stemperati in una
sana egoità sociale64. Moro vedeva già allora con lungimiranza il proliferarsi di
questa «molteplicità di centri di comando [che] in fatto si sono costituiti con la
conseguenza talvolta di paralizzarsi a vicenda e di non riuscire a contenere e
incanalare l’incandescente materia sociale»65.
Nel «paese dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili»66, Moro, pur in un
sostanziale pessimismo di fondo sulla capacità del sistema italiano di evolversi
verso sperimentate forme di democrazia compiuta, continuò a lavorare per
Ivi, p. 229.
Ivi, p. 230.
62 MORO, Discorso di presentazione alle Camere del governo DC-PRI, 3 dic. 1974, in IDEM, La democrazia
incompiuta, cit. supra nota 17, p. 84.
63 Ibid.
64 Su questo importante argomento, cfr., in una letteratura scientifica tanto abbondante quanto pressoché
totalmente ignorata e inascoltata, R. AJELLO, Egoità sociale. Alle origini del realismo critico e dello Stato moderno
in Europa, «Frontiera d’Europa», n. 2, 1996, pp. 5-150. Si veda anche TULLIO-ALTAN, La nostra Italia, cit. supra
nota 19.
65 MORO, Discorso di presentazione, cit. supra nota 62, p. 85.
66 MORO, Discorso all’assemblea dei gruppi parlamentari democristiani, Roma, 28 febbraio 1978, in IDEM, La
democrazia incompiuta, cit. supra nota 17, p. 121.
60
61
quello che considerò sempre come il traguardo più importante da raggiungere
(l’alternanza al governo in una prospettiva bipolare67), affinando sempre più il
suo linguaggio politico. In questa fase della maturità i suoi discorsi si fanno
sempre più affilati e precisi, sempre più diretti all’obiettivo che egli si era
proposto di realizzare nell’interesse della crescita democratica e della
funzionalità politico-istituzionale68. A rileggerli oggi, molti di quei testi appaiono
di un’ineguagliabile limpidezza cristallina, soprattutto per la loro straordinaria
maestria nel riuscire a descrivere una realtà come quella italiana, caratterizzata
quant’altre mai da un elevatissimo livello di contraddittorietà e d’incoerenza. E
tali dovettero sembrare anche a coloro che, restringendone il senso ultimo
all’ingresso dei comunisti nella compagine governativa, osteggiarono in ogni
modo il disegno moroteo69.
7. Conclusione: un paradossale (e sospetto) rovesciamento di senso
Questa constatazione riporta d’emblée l’osservatore che intenda tenere insieme
storia delle idee e storia dei fenomeni socioculturali a una palmare evidenza, che
si può esprimere con una domanda che sappia implicitamente cogliere l’aspetto
più paradossale di tutta la questione morotea: come mai il Moro più chiaro,
quello della piena maturità, subisce l’amaro (divenuto poi tragico) destino
dell’incomprensione, mentre il Moro giovanile è acriticamente elogiato come un
assoluto esempio di perspicacia concettuale e di limpidità espositiva? Com’è
possibile, in altre parole, che laddove il pensiero moroteo è chiaro esso sia
considerato oscuro e involuto, mentre dov’era effettivamente in fieri, quindi
maggiormente criptico, macchinoso, polisemico e nebuloso, lo si consideri
all’opposto un discorso nitido ed encomiabile? Che senso può avere questo così
palese traviamento della realtà testuale?
Ciascuno può trovare la sua risposta, ma il puzzle dei fatti fa propendere il
giudizio storico-critico verso un’interpretazione tutta politico-ideologica di
questa – solo apparentemente strana – interversione. Con il suo originalissimo
Va notato che questa convinzione è chiaramente delineata in Moro fin dal suo ingresso alla Costituente e resta
poi costante fino ai discorsi degli ultimi anni. Si vedano, come significativi esempi al riguardo: MORO, L’alternarsi
al potere delle maggioranze, in «Osservatorio», n. 2 di «Studium», 1947; IDEM, È tipico delle democrazie
l’alternarsi delle forze politiche al potere, Intervento al Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, Roma, 20
luglio 1975, entrambi in MORO, La democrazia incompiuta, cit. supra nota 17, rispettivam. pp. 94-5 e 102-4.
68 L’esplicita preoccupazione di Moro era quella di «costruire un sistema democratico avanzato […] abbastanza
nuovo nella storia d’Italia»: MORO, Riflessione, in «Il Giorno», 10 dicembre 1976, ora in IDEM, La democrazia
incompiuta, cit. supra nota 17, pp. 110-4: 112 (con il titolo Si parla di una Terza fase della vita politica italiana).
69 Clamoroso fu il diniego da parte del direttore de «Il Giorno», giornale che pure ospitava regolarmente
gl’interventi di Moro, di pubblicare un articolo intitolato A noi tocca decidere in piena autonomia, scritto «nel
gennaio 1978 e non pubblicato per “motivi di opportunità”»: cfr. MORO, La democrazia incompiuta, cit. supra
nota 17, pp. 115-7. Con la stessa determinazione con la quale aveva protetto il governo di centrosinistra dalle
pressioni della Chiesa (cfr. supra nota 18), Moro difendeva in quell’articolo l’autodeterminazione dell’Italia a
decidere sul proprio destino politico a prescindere dalle influenze estere (specialmente, anche se non solo,
americane): «A noi tocca – scrisse – decidere, sulla base della nostra conoscenza, in piena autonomia, ma con
grande equilibrio e senso di responsabilità» (ivi, p. 117). Nessuno poté leggerlo.
67
stile comunicativo, Aldo Moro è riuscito in un’impresa unica: esprimere
nitidamente l’inestricabile groviglio dell’antropologia politica italiana. I suoi
scritti costituiscono un patrimonio d’inestimabile valore per chiunque voglia
studiare e comprendere in profondità il nucleo fondamentale della politica – e
con essa dell’intera società – italiana. Ed è proprio questo ad averlo reso
inaccettabile in un contesto la cui essenza egli aveva portato alla luce del sole
per mostrarne le carenze e le incompiutezze, indicando nel contempo le
soluzioni e le possibili vie d’uscita.
Prende così corpo l’ipotesi che l’indicare nel discorso moroteo la quintessenza
dell’astrusità sia stata un’abile e pilotata operazione – largamente condivisa –
per screditare la sua proposta politica, semplificandola e banalizzandola come
l’azione che «voleva portare i comunisti al potere», sovvertendo così i
fondamenti politici del Paese e la sua collocazione internazionale. Si depotenzia
in tal modo la grandezza del pensiero moroteo e, non potendo del tutto
cancellarla (dato il finto rispetto che in Italia si deve portare ai martiri), si è
spostata sull’innocuo Moro giovanile, tutto dedito a difendere le strutture
portanti della visione del mondo cristiano-cattolica, e tanto zelante e dovizioso
nello stile espositivo quanto del tutto astratto nelle argomentazioni e nei temi
trattati. La subcultura – come la chiamerebbe Franco Ferrarotti – italiana ha così
compiuto la sua ennesima frode, travisando ad arte la profondità di uno
straordinario pensatore e attore politico la cui complessità, capace di cogliere i
punti nevralgici dell’identità italiana, è ancora attualissima ed è perciò ben lungi
dall’essere profondamente studiata e compresa, men che meno attuata. Come
tutti i grandi innovatori, Moro dové lottare contro tutti, a cominciare da se
stesso, da quella parte di sé che era più aderente alla cultura del suo tempo, a
quella cultura cioè che egli si era assunto il compito, dal suo interno, d’innovare.
Mi sembra che possa perciò, in conclusione, perfettamente modellarsi sulla
personalità di Moro e del suo rapporto con la cultura italiana ciò che Ida Magli
ha scritto a proposito del rapporto tra Gesù di Nazareth e l’ebraismo: «[È]
difficile dire se la proposta di Gesù sia inattuabile. Non si può affermare che sia
fallita, in quanto non si è nemmeno tentato di metterla in atto. […Che] cosa ha
fatto Gesù di Nazareth? È uscito da un modello culturale, proponendone un altro,
oppure ha tentato di spostare l’asse della sua cultura, forzandone la direzione?
L’interrogativo rimane senza risposta. L’unica cosa certa è che, contrariamente a
quello che tutti gli uomini hanno fatto, Gesù non ha vissuto in modo
inconsapevole e ovvio i valori su cui si fondava la sua cultura, ma ne ha preso le
radici, profondamente nascoste, e le ha capovolte al sole e all’aria, dichiarando
che esse erano ormai inutili. Tutti sono stati contro di lui»70.
70
I. MAGLI, Gesù di Nazareth. Tabù e trasgressione, Rizzoli, Milano 1982, pp. 173-4.