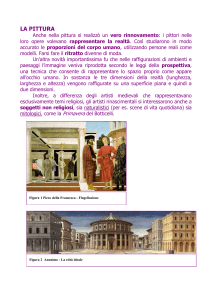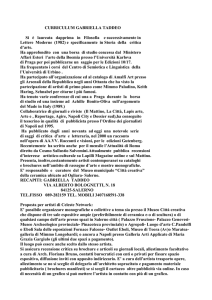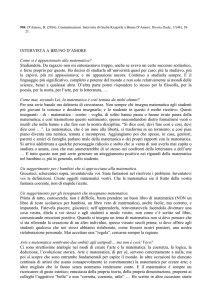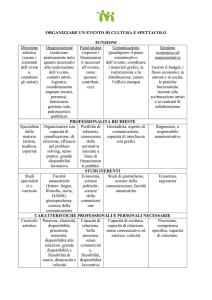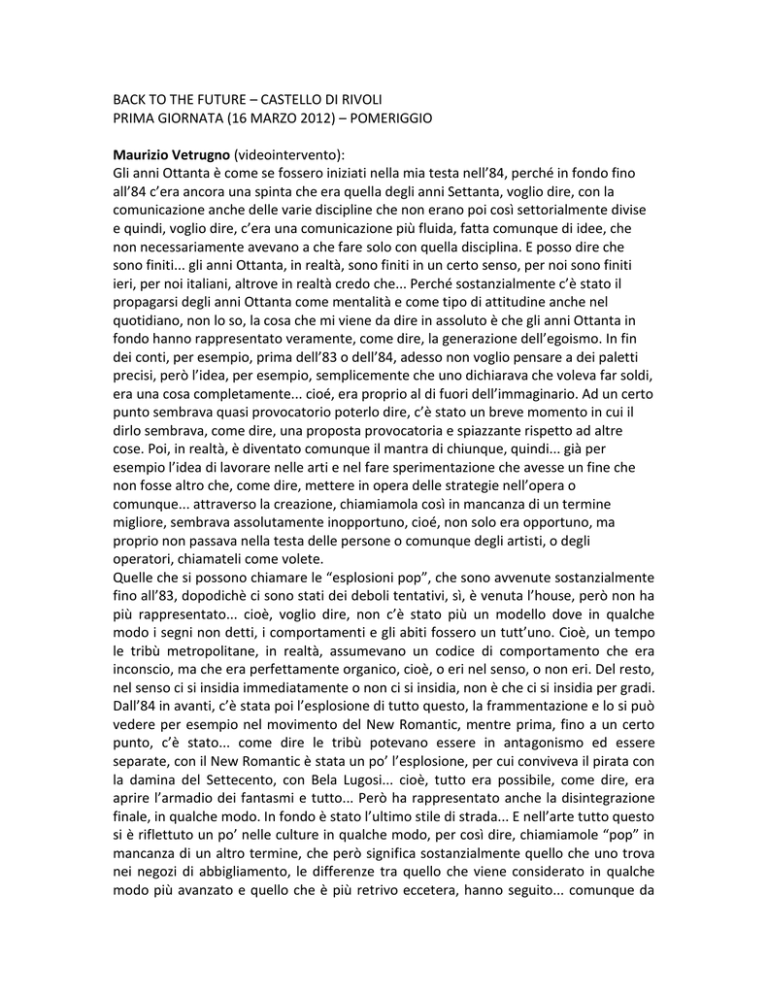
BACK TO THE FUTURE – CASTELLO DI RIVOLI
PRIMA GIORNATA (16 MARZO 2012) – POMERIGGIO
Maurizio Vetrugno (videointervento):
Gli anni Ottanta è come se fossero iniziati nella mia testa nell’84, perché in fondo fino
all’84 c’era ancora una spinta che era quella degli anni Settanta, voglio dire, con la
comunicazione anche delle varie discipline che non erano poi così settorialmente divise
e quindi, voglio dire, c’era una comunicazione più fluida, fatta comunque di idee, che
non necessariamente avevano a che fare solo con quella disciplina. E posso dire che
sono finiti... gli anni Ottanta, in realtà, sono finiti in un certo senso, per noi sono finiti
ieri, per noi italiani, altrove in realtà credo che... Perché sostanzialmente c’è stato il
propagarsi degli anni Ottanta come mentalità e come tipo di attitudine anche nel
quotidiano, non lo so, la cosa che mi viene da dire in assoluto è che gli anni Ottanta in
fondo hanno rappresentato veramente, come dire, la generazione dell’egoismo. In fin
dei conti, per esempio, prima dell’83 o dell’84, adesso non voglio pensare a dei paletti
precisi, però l’idea, per esempio, semplicemente che uno dichiarava che voleva far soldi,
era una cosa completamente... cioé, era proprio al di fuori dell’immaginario. Ad un certo
punto sembrava quasi provocatorio poterlo dire, c’è stato un breve momento in cui il
dirlo sembrava, come dire, una proposta provocatoria e spiazzante rispetto ad altre
cose. Poi, in realtà, è diventato comunque il mantra di chiunque, quindi... già per
esempio l’idea di lavorare nelle arti e nel fare sperimentazione che avesse un fine che
non fosse altro che, come dire, mettere in opera delle strategie nell’opera o
comunque... attraverso la creazione, chiamiamola così in mancanza di un termine
migliore, sembrava assolutamente inopportuno, cioé, non solo era opportuno, ma
proprio non passava nella testa delle persone o comunque degli artisti, o degli
operatori, chiamateli come volete.
Quelle che si possono chiamare le “esplosioni pop”, che sono avvenute sostanzialmente
fino all’83, dopodichè ci sono stati dei deboli tentativi, sì, è venuta l’house, però non ha
più rappresentato... cioè, voglio dire, non c’è stato più un modello dove in qualche
modo i segni non detti, i comportamenti e gli abiti fossero un tutt’uno. Cioè, un tempo
le tribù metropolitane, in realtà, assumevano un codice di comportamento che era
inconscio, ma che era perfettamente organico, cioè, o eri nel senso, o non eri. Del resto,
nel senso ci si insidia immediatamente o non ci si insidia, non è che ci si insidia per gradi.
Dall’84 in avanti, c’è stata poi l’esplosione di tutto questo, la frammentazione e lo si può
vedere per esempio nel movimento del New Romantic, mentre prima, fino a un certo
punto, c’è stato... come dire le tribù potevano essere in antagonismo ed essere
separate, con il New Romantic è stata un po’ l’esplosione, per cui conviveva il pirata con
la damina del Settecento, con Bela Lugosi... cioè, tutto era possibile, come dire, era
aprire l’armadio dei fantasmi e tutto... Però ha rappresentato anche la disintegrazione
finale, in qualche modo. In fondo è stato l’ultimo stile di strada... E nell’arte tutto questo
si è riflettuto un po’ nelle culture in qualche modo, per così dire, chiamiamole “pop” in
mancanza di un altro termine, che però significa sostanzialmente quello che uno trova
nei negozi di abbigliamento, le differenze tra quello che viene considerato in qualche
modo più avanzato e quello che è più retrivo eccetera, hanno seguito... comunque da
quel momento c’è stata davvero l’invasione dell’economia, anche perchè il modello, da
quel momento là, è diventato totalmente da corporation, per cui deciso a monte, con
un tipo di programmazione dove al brano musicale veniva abbinato un video eccetera,
per cui sostanzialmente c’è poi stato un appiattimento fenomenale. Uno in questi giorni
si chiede dove siano finiti i musicisti, perché se tu guardi anche solo una rivista dell’83, ti
rendi conto dell’enorme creatività che non solo circolava negli ambienti, per così dire,
underground, ma anche sostanzialmente poi nel mainstream.
Torino negli anni Ottanta... Be’, insomma, tutti gli anni Settanta a Torino sono stati... Per
quanto poi Torino venga dipinta come una città grigia, in realtà, aveva delle nicchie
assolutamente straordinarie. Sia di cultura, chiamiamola ufficiale, ma era anche un po’
lo stato sostanzialmente italiano. Cioè, se vai a vedere, Ennio Morricone abbiamo
dovuto aspettare 90 anni per poterne fare, come dire, un’icona o comunque
riconoscergli un valore che vada al di là di un onesto artigianato. A Torino negli anni
Settanta passavano sicuramente un sacco di cose anche nel teatro... per così dire, gli
stabili erano pieni comunque di attori che si erano formati sul palcoscenico, uno andava
a vedere uno spettacolo di Goldoni e magari c’erano Lucilla Morlacchi e Lina Volonghi
che tenevano la scena per... correndo da una parte all’altra del palcoscenico per 3 ore
ed era una delizia. Poi passavano anche, non so... Bread and Puppet, che erano...
Voglio dire, era un momento in cui avevi la cultura ufficiale e la cultura contro ed
entrambe erano molto ricche, per cui, insomma, uno si trovava con una tavola
imbandita piuttosto composta.
La scena artistica fatalmente a Torino era molto segnata dall’Arte Povera, credo di non
dire assolutamente nulla di che... E che ha rappresentato nel bene e nel male
un’impronta molto forte e tutto in qualche modo doveva commisurarsi a quello, certo.
Ma già da allora c’erano dei germogli, in fondo la prima mostra di Francesco Clemente
l’ha fatta a Torino da Sperone, Salvo è sempre stato un artista assolutamente originale...
che è stato guardato molto in Germania, perché in qualche modo c’erano una serie di
giovani artisti che si riconoscevano nel lavoro di Salvo. Quindi, insomma, anche come
scena artistica, gli anni Ottanta... non si può dire che fossero ricchi, ma i fermenti
c’erano comunque tutti. Un’altra roba che è successa a Torino negli anni Ottanta e che
in fondo... voglio dire, per esempio, le discoteche hanno rappresentato una specie di
snodo tra le gallerie, che non erano certo delle gallerie... voglio dire, non è che uno
passava dallo Studio 2 alla Stein in un mese e mezzo, cioè, non è mai avvenuto. Però era
anche abbastanza parallelo a quello che succedeva in America, per esempio, dove non
so, il Mud Club o il Club Fifty Seven hanno rappresentato, come dire, il banco di prova di
artisti molto diversi tra di loro, da Glenn Branca a Basquiat, che prima ancora di fare
l’artista visuale era in una noise band, Keith Haring, Kenny Scharf, Robert Longo,
insomma... Tutti loro hanno in qualche modo vivificato la scena, un po’ perché era
divertente farlo e un po’ perché comunque era una scena che, in qualche modo, non
presupponeva il dover pensare a delle strategie, il mercato, i mercanti, vendere...
Insomma, era tutto molto fluido.
E Torino, nel suo piccolo, ha fatto un po’ anche questo, voglio dire... Cioè, in primo luogo
io, che mi viene da pensare che ho fatto delle robe allo Studio 2, ma anche Zanichelli,
Pusole... Anche il Centralino, insomma... In corso Brescia c’era il BIG, anche al BIG
magari suonava Tom Verlaine oppure roba che oggi, in fin dei conti... cioè, come dire,
sono delle chicche che, se tu pensi di avere visto quei concerti là, insomma, hai visto
comunque uno spaccato e nel frattempo c’erano comunque delle cose, Raffaello
Ferrazzi... insomma, facevamo delle cose così perché in fondo era, come dire, lo sbocco
naturale del dover mostrare. Poi dopo, insomma, sono nate anche delle gallerie che
hanno in qualche modo cercato di cogliere quel momento. Le gallerie che in qualche
modo facevano un lavoro, per così dire, più disinibito, sostanzialmente, erano Guido
Carbone, Franz (Paludetto), perché ha sempre avuto comunque uno sguardo abbastanza
dinamico sugli eventi, c’era Edoardo Di Mauro con VSV, che comunque ha mostrato
delle cose per certi anni, insomma, erano anche delle realtà che si sovrapponevano, poi,
insomma, voglio dire, con passaggi di artisti da una parte all’altra... e sostanzialmente
questo era. Con altri eventi come i Murazzi eccetera, ma erano comunque sempre
collegati.
Intorno al ‘92/’93 c’è stata di nuovo una, come dire…, c’è stata di nuovo una specie di
velocizzazione del nastro, per cui certe cose hanno cessato di essere, sono diventate
comunque anche... non so, sono un po’ sfumate, non so dire se sono diventate
inconsistenti o no, si sono affacciati anche degli altri artisti che non avevano vissuto
sostanzialmente il passaggio tra, se vuoi, un’arte che, insomma, aveva tutti i crismi
dell’ufficialità d’avanguardia, voglio dire, era una situazione che veniva fuori dal Gruppo
63, insomma, da tutto quel tipo di apparato che era assolutamente interessante, che
aveva delle analogie con quanto succedeva in Germania, in America eccetera. E in quegli
anni lì, in realtà, si sono affacciati degli artisti che non avevano troppa memoria di tutto
questo ed è stato anche interessante, perché sostanzialmente c’erano, come dire, era
comunque un sistema aperto anche di comunicazione di segni, per cui, insomma,
qualcuno in qualche modo c’è stato dentro e qualcun altro no. Ed effettivamente sì,
insomma, non so... mi viene da pensare che anche Soggetto soggetto come mostra è
stata, come dire, è stata comunque un’occasione rispetto a quello che stava avvenendo
per esempio in Inghilterra, con l’avvento del britpop e quindi di giovani artisti inglesi
che, voglio dire, da un manipolo di artisti interessanti quali erano, non so, tipo Kapoor,
Woodrow... insomma, quelli che venivano considerati la nuova scultura inglese, in realtà
poi c’è stata comunque un’esplosione di linguaggi e di artisti.
Luisa Perlo:
Intervengo in questa sede con una grande responsabilità, avendo il compito, diciamo
così, di “riassumere” gli anni Novanta. Di fronte a una simile responsabilità... ho pensato
che avrei potuto presentare un intervento che definirei “situato”, ossia inteso dal punto
di vista della generazione che entrava sulla scena artistica all’inizio del decennio,
raccontando ciò che queste persone vedevano e con cui si confrontavano in termini
generali.
Dov’ero 20 anni fa? Vent’anni fa ero proprio qui, ero una stagista al Castello di Rivoli. Il
mio primo lavoro fu al Dipartimento Educazione del museo. In quel momento, quando
iniziai la mia collaborazione, il Dipartimento constava – e chi è in sala mi potrà
eventualmente correggere – di sole 3 persone. A questo proposito vi leggo una recente
frase del Sindaco Fassino: “Vent’anni fa”, dice, “Torino contava 61.000 operai e 6.000
addetti alla cultura. Oggi ci sono 18.000 dipendenti FIAT e 35.000 persone nel sistema
culturale”. Questa frase è stata ripresa proprio la scorsa settimana in un articolo su
«l’Espresso» di Alessandra Mammì, che rilancia un’immagine di Torino “capitale della
cultura” che tutti noi in questo momento viviamo come appannata. Ma i dati non sono
percezioni, e i numeri citati dal Sindaco sono fatti.
Gli anni Novanta sono un decennio abbastanza particolare, un decennio di snodo in cui
per gli operatori culturali diventa impossibile prescindere dalla dimensione della
“politica culturale”… è un cambiamento di grande rilievo. La nostra generazione – e
questo vale per coloro che come noi allora venivano definiti “critici”, ma anche per gli
artisti e tutti coloro che operavano in questo settore professionalmente – è l’ultima ad
aver condiviso pratiche, aspirazioni, obiettivi con le generazioni precedenti, in uno
scenario che stava per essere travolto da straordinari cambiamenti (economici,
tecnologici, sociali e creativi). Se ricordate, all’inizio degli anni Novanta i cellulari
sembravano le ricetrasmittenti dell’ispettore Derrick, e non c’era nemmeno Internet (il
primo browser di internet, Netscape Navigator, nasce nel 1994)… stavamo per assistere
a un’autentica mutazione antropologica. Si può dire quindi che si tratti di una
generazione ad alto coefficiente adattogeno.
Ma qual era la situazione che si trovava di fronte chi, nella prima metà degli anni
Novanta, muoveva i primi passi sulla scena artistica, come artista e come operatore? Mi
soccorre a tale proposito quello che ha detto poco fa Edoardo Di Mauro a proposito
dell’interregno politico in cui Torino di trovò fino al 1994, e affido la descrizione di
quello che noi vedevamo alle parole di Francesco Poli scritte nel 1993, in occasione di
una mostra intitolata Torino anni Ottanta, che era insieme un regesto, e un bilancio, del
decennio precedente, allestita nella gloriosa e purtroppo ormai inaccessibile Sala
Casorati dell’Unione Culturale e in parte all’Artifex, ai Docks Dora – una mostra curata
insieme con Beatrice Merz e Carla Barbero dell’Unione Culturale.
Francesco Poli scriveva: “Forse è finita la stagione della grande vitalità culturale di
Torino (spero non degli artisti che ci lavorano), in stretta relazione con la crisi economica
e sociale della città, risucchiata negli ultimi lustri in un preoccupante processo di
implosione. Anche nel campo dell’arte la forza propulsiva delle gallerie si è affievolita
(salvo lodevoli eccezioni) e si è stabilizzata su livelli decorosi ma privi di slancio. Non si
sono create le condizioni per la nascita di gruppi uniti di artisti, come ad esempio è
avvenuto a Roma e a Milano, vale a dire gruppi capaci di imporsi con sufficienza
all’attenzione esterna. Gli artisti più bravi e più abili si sono costruiti faticosamente i loro
percorsi, le loro occasioni espositive in Italia e all’estero, seguendo strategie individuali.
E’ probabile che non ci fosse allora un clima culturale adatto, ma è vero che le cose
bisogna anche inventarle, bisogna rischiare con entusiasmo e intelligenza”.
Sembra un invito a quelli che stavano, per l’appunto, per affrontare quello scenario di
infinita mestizia. Dobbiamo anche tener conto che a quel tempo il mercato dell’arte (e
di conseguenza la scena artistica), aveva appena attraversato una pesante crisi, databile
tra il 1990 e il 1991. C’è più di una analogia tra il clima che stiamo vivendo oggi, fatte le
dovute proporzioni, con quello che si viveva allora. Nel 1987, il 19 ottobre, c’era stato il
famoso Black Monday di Wall Street, il “lunedì nero” delle borse mondiali, all’origine di
una enorme crisi finanziaria globale, la più grave dopo quella del 1929. L’economia si
riprese abbastanza presto, ma ci furono delle conseguenze e la crisi del mercato
dell’arte fu tra queste. Dal punto di vista degli artisti e dei critici esordienti, la strada
quindi era tutta in salita.
Con cosa dovevamo fare i conti? Con, vediamo:
-un sistema fortemente gerarchizzato, costituito da livelli sostanzialmente impermeabili
tra loro;
-un clima corporativo e diffidente;
-la mancanza di risorse economiche e il difficile accesso a quelle che effettivamente
esistevano;
-una percezione di forte isolamento nel panorama italiano (l’Italia allora era ancora un
campo di riferimento);
-un numero esiguo, direi limitatissimo, di opportunità di tipo formativo, sia in ambito
universitario che accademico.
Allora l’Accademia di Belle Arti - lo dico per esperienza perché io non sono una storica
dell’arte e l’ho frequentata - era ancora impostata secondo un modello ottocentesco e a
Torino era assolutamente avulsa dal sistema artistico, con cui era in forte competizione
e sostanzialmente non vi erano (salvo rare eccezioni), figure di riferimento per gli
studenti. In questo senso mi permetto di riprendere quello che ho letto nel recente
rapporto sull’arte contemporanea 2010 promosso da CRT e curato da Torino
Internazionale e Università IULM, nella parte svolta da Pierluigi Sacco e Christian
Caliandro, laddove si dice che gli artisti torinesi non hanno voluto insegnare. A Torino gli
artisti hanno insegnato eccome - abbiamo sentito i nomi di Gilberto Zorio, Mainolfi,
Penone – ma lo hanno fatto al Liceo Artistico, che è stato anche l’incubatore del loro
rapporto con gli artisti più giovani che si sono successivamente formati all’interno dei
loro studi. Ci chiediamo perché non abbiamo invece insegnato all’Accademia di Belle
Arti. La questione è certamente più complessa (e va aggiungersi alla lunga lista delle
occasioni perdute a carico di questa città), e varrebbe la pena di andare a fondo sulle
ragioni di quella mancata volontà.
Con queste premesse, ovviamente, erano possibili soltanto strategie fortemente
reattive, che richiedevano una certa propensione per l’arte di arrangiarsi,
l’autoformazione e l’autoproduzione. La nostra strategia reattiva – e in questo caso
parlo per quanto riguarda il collettivo a.titolo, anche per le mie socie Giorgina Bertolino,
Francesca Comisso, Lisa Parola e Nicoletta Leonardi – fu quella di aprire un tavolo per
studiare una sorta di exit strategy, un tavolo a cui parteciparono molte altre nostre
colleghe, tant’è che il collettivo era composto all’inizio da nove persone, tutte donne.
Ovviamente avevamo interessi comuni, l’interesse nei confronti del dispositivo
dell’archivio, dell’arte nella sfera sociale e urbana, che non trovava un grande riscontro
nella storia recente di Torino, ma era soprattutto nostra intenzione lavorare per
rompere l’isolamento. “La scelta di presentarsi come gruppo” scrivevamo allora,
“risponde a un’analisi del sistema artistico nel quale operiamo e nel superamento della
tradizionale prerogativa individuale della nostra professione”. La scelta del nome,
a.titolo, aveva anche a che fare con la precaria condizione in cui noi, come categoria, ci
trovavamo a operare.
Infatti, la nostra prima iniziativa fu un convegno dal titolo Critica come mestiere?
nell’ambito di una mostra che, intelligentemente, Franz Paludetto, che, come sempre,
aveva l’occhio lungo, decise di fare nel 1997, Critica Donna Torino – in cui erano presenti
anche diverse persone intervenute qui prima di me – che evidenziava la grande
prevalenza, in questa professione, della componente femminile. L’anno precedente, nel
1996, dal nostro osservatorio ipogeo dell’Unione Culturale, io e Giorgina Bertolino, cui
Francesco Poli aveva passato il testimone di responsabile della programmazione
espositiva, avevamo avviato una ricognizione sulla scena artistica torinese, cercando di
disegnare su una grande mappa la città vissuta e percorsa dagli attori che vi si
muovevano, principalmente artisti, e raccogliere un archivio che sondava gusti e
aspirazioni, luoghi, di vita, di lavoro e d’elezione senza distinzione di età o indirizzo di
ricerca. La partecipazione fu notevole, considerato che allora ancora non c’era ancora
una grande dimestichezza con Internet e si procedeva perlopiù per via epistolare e con il
passaparola. Per esempio ci fu una notevole adesione dei galleristi, mentre fummo
completamente snobbati dagli artisti affermati, il che la dice lunga sulle difficoltà che
quotidianamente ci si trovava ad affrontare, e dunque la nostra vocazione enciclopedica
fu un po’ frustrata, ma fu per noi un fondamentale strumento di orientamento e un
ottimo esercizio propedeutico per capire dove ci trovavamo in quel preciso momento.
La nuova scena “locale” con cui ci confrontavamo era principalmente caratterizzata da:
- Artisti che provenivano in buona parte da percorsi formativi non tradizionali (grafica,
scuole tecniche). Ho appena parlato degli artisti formatisi negli studi, ma penso in
particolare ad artisti come Maurizio Vetrugno, o a Nicus Lucà, qui presente, a pittori
come Pierluigi Pusole o altri che hanno esordito più tardi, come Daniele Galliano. Prime
palestre di questa nuova generazione, apparentemente affrancata dal genius loci erano
state tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, gallerie come Guido
Carbone e Franz Paludetto.
- Ricerche emergenti caratterizzate dall’uso della fotografia, e successivamente dal
video, sviluppate soprattutto da una nutrita compagine di artiste - ho visto in sala Giulia
Caira, Elisa Sighicelli, Maura Banfo, penso a Marzia Migliora, tra le altre – che costituirà,
nell’arco di pochi anni, all’incirca per il 50% di una scena che nel decennio precedente si
presentava ancora ad alto tasso di testosterone.
- Nel 1992, mostre come Post Human al Castello di Rivoli, e Viaggio a Los Angeles al
Castello di Rivara, avevano inoltre costituito oggettivi momenti di rottura e discontinuità
con la vulgata estetica torinese, risultando seminali per lo sviluppo delle nuove ricerche
degli anni Novanta. Va ricordato che il Castello di Rivara, in quegli anni, svolge anche un
ruolo molto importante dal punto di vista della socialità, dello scambio e della
trasmissione di informazioni, e quindi dell’innovazione e della scena, in occasione delle
mostre-evento autunnali che radunavano numerosi artisti, tra i quali molti tra i futuri
protagonisti di punta della ricerca italiana: uno per tutti, Maurizio Cattelan.
Se gli anni Novanta, in termini generali, sono stati un periodo di grande cambiamento
antropologico, sociale, tecnologico, sul piano locale costituiscono il momento in cui
inizia un processo inarrestabile di istituzionalizzazione delle iniziative nella prospettiva di
una loro assimilazione nel contesto di una logica di promozione della città, e più
estesamente della regione, in chiave culturale. Il punto di svolta, e
contemporaneamente anche l’uscita dal cono d’ombra della città, si data più o meno
intorno alla metà del decennio, quando si vanno registrando alcuni macrofenomeni:
- un nuovo protagonismo dei collezionisti, in termini di attività pubblica. Nascono per
esempio l’associazione Arte Giovane, nasce la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
ancora non nella forma attuale, ma che prelude alla nascita dei primi spazi non museali
(uso questa terminologia “spazi non museali”, utilizzata da Walter Santagata in un
convegno internazionale su questi temi che non a caso si svolse in questa sede nel
1996). In questo quadro assume notevole rilievo la nascita di Artissima, la cui linea
rappresenta un elemento di innovazione nel panorama delle fiere d’arte in Italia.
- il ridisegno delle politiche pubbliche nei confronti dei giovani artisti, significativo, dal
punto di vista dello sviluppo e della crescita della ricerca a livello locale. Nel 1995
riprende, dopo sette anni, l’attività espositiva in questa direzione della Città di Torino,
con la rassegna Nuovi Arrivi, specificatamente dedicata agli esordienti, e al tempo stesso
viene rilanciata l’omologa rassegna della Regione Piemonte, Proposte, in precedenza
allestita all’IRV di corso Orbassano. In quell’anno entrambe prendono sede entrambe
alla Galleria di San Filippo, il primo luogo veramente deputato in città a questo specifico
tipo di attività.
- lo sviluppo delle cosiddette professioni creative, quale risultato di una notevole vitalità
“di base” e di quella strategia reattiva di cui ho parlato in precedenza, caratterizzata in
vari settori da forme di auto-organizzazione. Penso alla nascita dei primi gruppi di visual
designer, e alle riviste che nascevano in seno alla facoltà di Architettura, ma anche alle
nuove professionalità gravitanti intorno all’arte contemporanea, allo sviluppo di nuovi
progetti nel campo del cinema e della letteratura, per fare solo qualche esempio. Si
tratta di un fenomeno di cui artisti e operatori dell’arte contemporanea sono
pienamente partecipi, nella direzione di una loro progressiva autonomizzazione dal
tradizionale schema del sistema dell’arte teorizzato da Achille Bonito Oliva, basato sul
circuito artista - critico - gallerista - collezionista - museo.
L’investimento sui giovani – vorrei tornare sulle cose che ha detto Luigi Ratclif – è un
grande capitolo della spesa pubblica in cultura alla fine degli anni Novanta, che vede
avvicendarsi nel 1997 la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, e
nel 2000 la prima edizione di una Biennale modellata sulla struttura della precedente, la
BIG. Si è appena parlato di entrambe queste iniziative. Noi siamo fan della BIG da tempi
non sospetti, nonostante il fatto che non abbia goduto di buona stampa, e le oggettive
criticità appena rilevate da Ratclif. A nostro parere c’era una grande vitalità in quella
manifestazione, per noi di grande interesse quando ha sviluppato un carattere di
piattaforma di tipo discorsivo e che ci è interessata assai meno quando è stata, diciamo
così, museificata, e sedata, nella sua versione Triennale. C’è tuttavia un rilievo numerico
che mi interessa fare, a questo proposito, anche rispetto alle cose che ho sentito in
precedenza: nell’edizione del 2000, su 500 partecipanti di 36 nazionalità, 6 soltanto
sono italiani, due dei quali torinesi, sono Botto e Bruno e Paolo Grassino che, se non
ricordo male, erano addirittura nella sezione “Interventi metropolitani”. Mi sembrano
un po’ pochi, in percentuale, soprattutto per una città che ha fatto della promozione dei
giovani artisti un fiore all’occhiello. E non è sufficiente in questi casi attribuire la
responsabilità ai curatori internazionali che non conoscono la scena locale. Infatti, basta
ricavare un dato statistico dalle biennali estere più importanti, per capire quanto la
presenza degli artisti cosiddetti locali giochi un ruolo rilevante anche nel progetto
curatoriale, pensiamo per esempio alla Biennale di Istanbul, e ad altre manifestazioni
che stanno crescendo altrove. In assenza di conoscenza diretta del contesto, per un
osservatore estraneo, la fiducia delle istituzioni negli artisti locali, specie se prestigiose,
è inoltre un indispensabile elemento di valutazione.
Questo esempio macroscopico è solo una spia di quel provincialismo di cui si parlava
prima, che ha caratterizzato a lungo la strategia di internazionalizzazione della città. E’
come se, nel momento della “cosa grossa”, fosse mancato il coraggio di proporsi. E
questo problema è indirettamente, ma forse non così indirettamente, connesso a quel
rilievo intorno alla scarsa penetrazione degli artisti torinesi sulla scena internazionale
presente nel rapporto CRT sull’arte contemporanea a Torino citato poco fa (che peraltro
è un problema degli artisti italiani in generale), all’origine di recenti polemiche. E’ quindi
un problema sistemico, poiché già Poli lo rilevava all’inizio del decennio, facendo proprio
riferimento alla conflittualità e alle difficoltà degli artisti degli anni Ottanta nel
raggiungere la visibilità o comunque l’attenzione che era stata assegnata all’Arte Povera.
Nonostante queste criticità, gli anni Novanta sono anni in cui si cercano o si inventano
soluzioni per rispondere a nuove esigenze creative, a nuove modalità degli artisti, sono
anni in cui emergono nuove istanze relative alla formazione post-accademica, che in
Italia era quasi inesistente, alla mobilità degli artisti, e alla produzione, che troveranno
ascolto soltanto nel decennio successivo. L’appropriazione anche temporanea di spazi
non convenzionali, che riprendono vita attraverso l’arte, è un altro dei tratti distintivi
della metà del decennio, e direi tra i più eccitanti proprio perché finalmente si entrava
(o almeno, noi entravamo) in spazi che non erano mai stati accessibili in precedenza: gli
spazi della Torino industriale che venivano in quel momento dismessi, i Murazzi, la
Cavallerizza Reale, l’ex Arsenale.
La più memorabile che vorrei citare - ce ne sono tantissime, ma il tempo non è
sufficiente - e a mio parere la più significativa sul piano delle sue conseguenze fu
l’esperienza di Abitare le OGR, le Officine Grandi Riparazioni, sconosciute ai più, che fu
offerta dal progetto Città Svelata di Maurizio Cilli, qui in sala, e di Maurizio Zucca, senza
la quale noi oggi non avremmo avuto nessuna Esperienza Italia, ne’ tantomeno il nuovo
polo culturale di cui molto si parla, stante il fatto che fino a quell’iniziativa il nuovo piano
regolatore della città (del 1995) ne sanciva la demolizione.
Quindi, se all’inizio del decennio si poteva intuire, considerato ad esempio
l’investimento sul Castello di Rivoli, che l’arte contemporanea potesse costituire un asse
portante del disegno identitario di Torino in epoca post-fordista, nell’arco di pochi anni
sarebbe stato chiaro a tutti come l’arte contemporanea avesse assunto un ruolo chiave
nel piano strategico della Città, di cui ci ha parlato prima Paolo Verri e di cui Torino si
sarebbe dotata nel 2000 dopo un lungo lavoro di ricerca svolto a partire dal 1998 in una
logica di internazionalizzazione e di marketing urbano. Si tratta della linea strategica n.
5: Promuovere Torino come città di cultura, turismo, commercio e sport. Ed è a questo
punto che le politiche pubbliche, in un processo contrario a quello che aveva
caratterizzato gli anni Novanta, assumono un ruolo determinante nel disegno della città
dell’arte contemporanea, istituendo quindi un rapporto di reciprocità e di
interdipendenza. Un rapporto che oggi costituisce motivo di riflessione, nel momento in
cui la crisi economica mina fortemente le basi di quella politica, e conseguentemente, la
sopravvivenza stessa di molti operatori. Operatori che, e si è molto detto oggi, sono stati
qualche volta fautori, in buona parte partecipi o anche solo fruitori, ma indistintamente
tutti attori di questa politica, ed è questa la principale eredità degli anni Novanta che
ancora oggi viviamo.
All’inizio di questa giornata Maria Teresa Roberto ha fatto riferimento al fatto che gli
anni Novanta non sono ancora finiti. Non so se si riferisse a questo, ma dal mio punto di
vista questa la sua visione è piuttosto efficace. Se negli anni Novanta c’era una certa
consapevolezza da parte degli operatori e degli artisti a proposito della precarietà e del
rischio connesso all’attività in questo settore, e nella cultura in genere, comunque in un
panorama che allora era piuttosto circoscritto e costituito tutto sommato da un numero
limitato di attori, oggi, dopo un quindicennio di politiche nella direzione dello sviluppo di
questo settore, anche sul piano della formazione in una prospettiva professionalizzante
(pensiamo per esempio all’offerta formativa nel settore del management culturale) che
in molti abbiamo atteso e invocato, e talora abbiamo condiviso, nessuno può chiamarsi
fuori o dichiararsi senza responsabilità.
Da qualche anno e con più forza a seguito della crisi globale, si sono sviluppate diverse
teorie, come quelle del sociologo olandese Pascal Gielen, che vedono nell’artista, e nel
creativo in generale, una figura tipo dello sfruttamento nell’era del capitalismo
cognitivo. Qualcuno ha parlato di classe operaia, si potrebbe in effetti parlare di nuovo
proletariato. Quello “creativo” è un tipo di lavoratore che, per farla breve, è disposto a
lavorare gratuitamente per conseguire obiettivi di ricerca, di visibilità o di
posizionamento.
Già nel 1998, nel catalogo stampato a epilogo delle mostre collettive della rassegna
Giovani Artisti a Torino, che concludeva il ciclo delle mostre allestite dall’Assessorato ai
Giovani della Città negli Antichi Chiostri di via Garibaldi, si auspicava “la creazione di uno
spazio nella città dedicato ai giovani artisti inteso non solo come spazio espositivo ma
anche come laboratorio per stages e seminari”. E’ senza dubbio la versione aurorale del
progetto di quella famosa Casa dell’Artista, che in più di vent’anni non è mai arrivata.
Però io mi chiedo: “Ma era il caso che dovesse realizzarla l’ente pubblico?”. Avremmo
voluto che questo posto, e non uno soltanto, sorgesse attraverso pratiche di autoorganizzazione in una delle tante fabbriche dismesse che in questi anni sono sparite o
che si sono trasformate in centri commerciali. L’eredità di questo sogno che abbiamo
condiviso con tante persone che sono qui in questo momento, e che non si è realizzato,
può essere il lascito per un futuro che potrebbe vedere gli enti pubblici assumere un
ruolo di agevolatori di un processo virtuoso, visto che ancora non tutto è perduto.
Qualcuno mi ha fatto notare che, per esempio, ci sono le strutture dei Mercati Generali,
praticamente vuote da circa 6 anni, e non tutte le vestigia della Torino industriale sono
scomparse. E quindi ci sono ancora, e non solo qui, opportunità di dar vita a fabbriche
della cultura potenzialmente low cost.
Oggi, a fronte della crisi, urge una ridefinizione di rapporti e di ruoli tra pubblico e
privato, tra istituzioni e operatori, affinché il milieu - e non parlo delle grandi eccellenze
che si intendono tutelare, ma proprio del sottobosco che fornisce linfa vitale al sistema -
non si estingua facendo seccare la pianta. Cito un ultimo riferimento dal rapporto arte
contemporanea Torino 2010, nella parte sociologica, dove i ricercatori Salvatore Cominu
e Anna Tavella sottolineano come: “Lo sviluppo del terziario creativo e culturale sia
stato letto in ambito pubblico a Torino in chiave compensativa, (quando non
sostitutiva), della contrazione dei settori industriali dell’economia torinese”. E a maggior
ragione proprio perché questa lettura si basa su un falso problema - Torino è stata la
città dell’industria, ma è stata anche città di cultura per tutto il Novecento - finchè
Torino non penserà a se stessa in un modo diverso, ossia riconfermando “una visione
matura e ambiziosa dello sviluppo culturale a base locale”, finirà per ricadere “in quella
logica di uso sociale ed economico della cultura”, ossia una concezione “cosmetica,
autoreferenziale e ricreativa”, “quella cultura dell’effimero che è in conflitto totale con
gli attuali scenari di sviluppo europei e globali”, a grande rischio di implosione di fronte
agli effetti della crisi, compromettendo gravemente il proprio futuro, non solo di
aspirante capitale culturale.
Olga Gambari: Grazie per questo intervento, devo dire, puntuale e preciso di una scena
che riguarda l’arte contemporanea, ma non solo, e che usa l’arte contemporanea come
sguardo per attraversare tutte quelle che sono le politiche legate agli altri ambiti artistici
della citt_ negli anni Novanta, che _ stato veramente un decennio fondamentale da
rileggere come prospettiva di lettura e di presente in corso, soprattutto riguardo a
quelle che sono le politiche pubbliche.
Adesso abbiamo un piccolo contributo di Guido Curto, che _ stato direttore
dell’Accademia Albertina per due mandati e ha finito il suo mandato nel 2011, qualche
mese fa. Gli abbiamo chiesto, visto che, quando ci siamo domandati quali punti toccare
in queste 3 giornate di lavoro, il punto della formazione, dei luoghi di sapere, di
conoscenza, di formazione, _ stato un ambito di grande interrogazione mia e di
Francesco. Ed _ assolutamente latente l’universit_, piuttosto che l’accademia, da un
certo punto di vista... e allora a Guido Curto abbiamo chiesto se l’accademia sia un
meccanismo bloccato. L’Accademia Albertina, ma in generale l’accademia in Italia.
Guido Curto (videointervento):
Olga Gambari mi chiede: “L’accademia è un meccanismo bloccato?”. Credo che
sottintenda l’Accademia Albertina è un meccanismo bloccato, ma poi forse vuole anche
allargare il discorso su tutte le accademie di Italia. Dalla ultima indagine fatta dalla
Fondazione per l’Arte della CRT, in effetti, emerge una forte criticità dell’Accademia
Albertina sullo specifico torinese. Devo dire che quell’indagine mi ha, da un lato, colpito,
ma forse anche un po’ in modo suscettibile fatto adirare, perché io dico: no, ma
dall’Accademia Albertina sono usciti tanti artisti giovani e anche meno giovani, da Botto
e Bruno, per arrivare anche ad altri che oggi non sono così noti, ma che comunque
stanno lavorando molto bene, ad esempio, con il Gruppo Radici di Claudio Pieroni che
sta portando avanti un progetto col Ferrante Aporti. Adesso non mi dilungo a fare una
laudatio dell’Accademia Albertina, ma cerco di rispondere a questa domanda dicendo
“Che cosa succede nelle accademie d’Italia?”. Nel 1999 c’era stata una riforma sulla
quale c’erano tante aspettative: la legge 508 del ’99, in qualche modo, portava le
accademie all’interno del sistema universitario. Da allora, però, quella riforma non è mai
stata conclusa. Quella riforma ha fatto sì che le accademie, da quadriennali,
diventassero dei 3+2, ha fatto sì che gli esami, da una ventina che erano, siano diventati
già nel solo triennio più di 30 e, in generale, che dalle 33 materie che si insegnavano
ancora nel ’99 in accademia, oggi abbiamo 99 e oltre materie. Quindi, una
parcellizzazione forse anche del sapere sui quattro indirizzi: pittura, scultura,
decorazione e scenografia, che erano gli indirizzi tradizionali, ai quali però avevamo già
aggiunto, in via sperimentale, l’indirizzo di grafica, l’indirizzo di restauro e poi,
recentemente, abbiamo aggiunto quattro nuovi indirizzi, sempre previsti da questa
legge 508 del ’99, che sono: didattica per l’arte, promozione e valorizzazione del
patrimonio artistico contemporaneo, nuove tecnologie per l’arte, progettazione artistica
per l’impresa.
Detto questo, sembra tutto bellissimo, stupendo, si è ampliata quindi, come diciamo
noi, l’offerta formativa, ma di fatto qual’è l’impasse? Quali sono le cose che anche oggi
mettono in crisi proprio l’Accademia Albertina di Torino?
C’è un problema, diremmo con un temine alto, di governance: le accademie hanno un
problema di una direzione che, nel mio caso, Cicero pro domo sua, dura da 3 anni e può
essere rinnovata per un solo mandato su 6 anni. In 6 anni si conclude veramente poco, si
è costantemente in campagna elettorale, in molti aspirano alla direzione, e quindi si
crea una difficoltà nel dirigere l’accademia, anche perché poi c’è una parcellizzazione
delle cariche. Senza nulla togliere all’amico e attuale presidente dell’Accademia
Albertina, Marco Albera, le accademie hanno questa duplice struttura: della presidenza
– che è sì presidenza del consiglio di amministrazione, ma il presidente è anche il legale
rappresentante dell’accademia – e del direttore, più un direttore amministrativo, più un
consiglio accademico, più un consiglio d’amministrazione, più il tavolo della RSU. Se poi
applicassimo alla lettera – come in futuro sarà – i nuovi regolamenti che da 11 anni
devono uscire, ma prima o poi forse usciranno, ci saranno i direttori dei dipartimenti, i
direttori delle 10 scuole... vorrà dire che, su 55 docenti di ruolo che ha l’Accademia, noi
avremo... ho fatto un conto, una quarantina di funzioni direttive. Il che, voi capite,
diventa complicato e può anche creare una sorta di cortocircuito, dove le varie
intenzionalità, le migliori intenzionalità, poi vanno a collidere. Quindi abbiamo
accademie come quella di Bologna, dove ci sono in carica, a quanto pare, 3 direttori, un
contro l’altro armati; ci sono accademie dove c’è uno scontro fortissimo tra il presidente
e il direttore in carica; accademie dove c’è una conflittualità altissima – anche qui, spero
di non prendermi delle denunce per diffamazione – come l’accademia di Roma, abbiamo
una conflittualità che in passato era stata altissima. Questo non fa bene all’alta
formazione artistica. Cosa proporrei io? Cosa proporrei al ministro Profumo se fosse qui
questa mattina? Gli proporrei di fare una modifica radicale, di prendere a modello le
accademie francesi o le accademie tedesche, come le Kunsthochschulen tedesche e, in
qualche modo, semplificare al massimo la gestione. Pare che io parli troppo nel mio
interesse, ma io non sono più in questo momento direttore dell’Accademia Albertina...
penso che dovrebbe esserci un direttore unico, in pianta stabile, nominato dal ministro
sulla base di una selezione nazionale, o anche internazionale andrebbe benissimo, dove
questo direttore duri in carica e risponda del suo operato al ministro o alla direzione
generale dell’AFAM – che è il nostro ufficio competente al MIUR, al Ministero Istruzione
Università e Ricerca – ogni 5 anni: se l’accademia sta funzionando, bene, se non sta
funzionando, decade e si sostituisce la direzione. Ci vorrebbe anche più elasticità per
poter assumere i docenti, per potere avere artisti, come abbiamo tanti artisti di chiara
fama quà a Torino, come abbiamo anche ottimi artisti che sono docenti di ruolo
all’interno dell’Accademia, eh, che sia chiaro. Però, per potere avere dei docenti a
contratto che possono essere selezionati con una certa rapidità e velocità. Noi oggi
siamo obbligati a fare dei bandi nazionali dove, accanto ai titoli, che non sono solo i titoli
di studio, ovviamente, ma sono titoli fatti da mostre, per gli artisti, fatte da
pubblicazioni... si aggiungono sempre i titoli di anzianità, cioè, l’avere prestato servizio
di supplenza nella più sperduta accademia, una delle tante accademie, magari anche
private – in Sicilia sembra che ci siano 13 accademie private – fa sì che poi la persona
che ha acquisito questi titoli di servizio, superi anche l’artista di chiara fama. Anche lì,
andrebbe semplificato, dovrebbe esserci la possibilità della chiamata per chiara fama,
per potere avere qua a Torino artisti giovani o meno giovani che insegnano
all’Accademia e che in qualche modo svecchiano il sistema formativo. E invece siamo
molto burocratizzati, si fanno i concorsi, i bandi, arrivano montagne di carta da
dipanare, si fanno le commissioni, si nomina una persona, poi arriva il classico ricorso al
TAR, si interrompe il processo di selezione, per un anno o due anni si va avanti con il
ricorso al TAR, si arriva fino al Consiglio di Stato... Tutto questo – pur nell’ottica di una
trasparenza e di una democrazia – rende le accademie italiane fortemente
burocratizzate.
Il mio modello sarebbero o semplicemente le Ecoles des Beaux-Arts francesi, che
funzionano molto bene, private ma in parte pubbliche, e inglesi, come il Goldsmiths
College, come la Slade School, che hanno prodotto tanti tanti artisti. Perché è vero che
oggi le accademie italiane continuano a produrre artisti, è vero che oggi gli artisti italiani
a volte hanno il difetto di non voler dichiarare, quasi di vergognarsi di essere stati
all’interno di un’accademia, di avere studiato. Poi se si va a scavare, invece, tantissimi
sono usciti, non solo dall’Accademia di Torino, ma dall’Accademia di Brera, la scuola di
Garutti, quanti artisti ha formato, l’Accademia di Bologna ha formato tantissimi artisti.
Però bisognerebbe avere anche l’orgoglio, il vanto di dire ho studiato in un percorso
formativo che, addirittura, può comportare un domani, si spera, un master come c’è
all’estero. Vado a concludere, insomma, questa lunga chiacchierata dicendo che c’è in
atto adesso una legge di riforma che sta per essere votata in Senato, la 4822, il DDL
4822, che dovrebbe dare la piena equiparazione del titolo Diploma di Accademia, con il
titolo di Laurea, ma non credo che adesso sia un problema di equipollenza dei titoli. Qui
è un problema che le accademie devono davvero formare gli artisti, dando meno esami,
meno parcellizzazione, crediti, strutture burocratiche, ma dando momenti ampi, anche
lenti, uno slow art, di formazione accanto a maestri o accanto ad artisti di chiara fama
che abbiamo, con cui si lavora, con cui si progetta, con cui si pensa.
Francesco Bernardelli: Da questa situazione particolarmente emblematica, oltre che
problematica, che evochiamo, perchè chiaramente non entriamo nel dettaglio di quello
che dovrebbe essere la riforma dell’educazione artistica italiana, ma volevano
quantomeno evocarla, entriamo invece in quello che è un ambito significativo di quelli
che hanno rappresentato il nocciolo forte, come dire, in qualche maniera, il nocciolo
duro di quella che è la creatività in questa città ed è appunto la scena musicale. Allora, in
questo senso vogliamo entrare in un ambito professionale, chiaramente, che ha
prodotto tanti interessantissimi e forti nomi e in questo senso abbiamo pensato quindi a
una tavola rotonda. Il punto di vista è quello di partire da un tentativo di descrivere una
situazione, chiaramente anche abbastanza complessa, perchè stiamo parlando di nuovo
di 20 anni, ma addentrandoci in quelli che sono dei parametri. I parametri entro i quali
noi cerchiamo di fare, come dire, una serie di collegamenti, sono chiaramente
l’emergere di tutta una serie di professionalità, nell’ambito prettamente creativo di
musicisti, ma anche di produttori e di tutti quelli che lavorano anche nella promozione e
nell’organizzazione musicale. E’ un terreno particolarmente delicato, stratificato, come
potete immaginare le dinamiche economiche, produttive eccetera, sono
particolarmente forti, veloci e, paragonate all’arte, hanno una tendenza a velocizzarsi
incredibilmente più rapida, quindi le dinamiche sono anche oggettivamente abbastanza
diverse, ma a noi interessano proprio in termini di, appunto, terreno dove, da una realtà
molto locale, si è arrivati a un’eccellenza e a un riconoscimento di livello molto alto.
Allora, in questo senso, siamo molto contenti di potere avere come vero e proprio host
e maitre della discussione, Alberto Campo, che qui a Torino ha rappresentato
effettivamente qualcosa.
Quindi lo salutiamo, prego, Alberto. E poi sarà seguito da Carlo Rossi (segue bio), Silvio
Mossetto (segue bio), Fabrizio Gargarone (segue bio) e, infine, Andrea Costa (segue bio).
Alberto Campo:
Come vi è stato appena detto, il mio compito è quello di creare la cornice entro cui poi
ciascuno degli altri presenti inserirà la propria esperienza individuale. L’origine di questo
racconto direi che si può datare alla fine degli anni Settanta, quando
in città affiora quella che definirei la prima generazione post-industriale, nel senso che,
con le proprie pratiche di vita e con le idee che ha in testa, gli impulsi che spingono a
fare cose, tende a collocarsi al di fuori del tradizionale ciclo produttivo, quello che gli
inglesi chiamano nine to five, cioé l’idea di rimanere fuori dalle
fabbriche e dagli uffici, di fare una vita significativamente differente da quella dei propri
genitori. Energie che quindi tendono a situarsi in modo spontaneo fuori dal circuito
produttivo tradizionale.
Da questo punto di vista, io credo – senza arrogare al fenomeno un ruolo più importante
di quanto gli spetti, è davvero un problema da un lato cronologico e dall’altro di
storicizzazione dell’accaduto – che la musica sia il principale polo attrattivo di queste
nuove energie che si liberano in città. In parte, si tratta di individui delusi dalla politica e
in parte, viceversa, di aspiranti intellettuali che arrivano dopo la rottura generazionale
del 1977. Il centro di gravità intorno a cui ruotano queste forze alla fine degli anni
Settanta è Radio Flash e il ruolo di centro gravitazionale che quella radio esercita fino
alla metà degli anni Ottanta è determinante proprio per dare identità e luogo alle
capacità espressive di quella generazione.
Perché Radio Flash è un luogo di divulgazione culturale, ma è anche amplificatore delle
nuove esperienze che circolano in città, che vanno dal grande business all’autoproduzione musicale. Sul primo fronte, quello dei grandi eventi, chiamiamoli cos_, si
apre la stagione dei concerti che mettono Torino sulla mappa musicale nazionale, con gli
show di Bob Marley e dei Rolling Stones allo Stadio Comunale, mentre
d’altra parte ci sono i locali che ospitano concerti e attivano anche le prime avvisaglie di
quella che si chiamerà poi “movida”, che avrà poi il suo apogeo negli anni Novanta allo
Studio 2: il BIG Club, che è già stato citato, e il Tuxedo, di cui ricordo, proprio per fare
cerniera con l’arte contemporanea, il graffito di Pennarex che
accompagnava la discesa verso il ventre del locale.
Radio Flash è importante perché, oltre a essere punto di contatto tra i consumatori
di musica, chi frequenta i locali e i concerti, e i produttori di musica stessa, è il megafono
che amplifica la voce delle prime band indipendenti cittadine. In ordine di apparizione, e
non vorrei fare torto a nessuno, direi: i Blind Alley del compianto Gigi Restagno, i
Teknospray e gli Eazycon sono i primi ad affiorare e a costituire ciò che prima non c’era
mai stato, una scena musicale in qualche modo coesa, se non dal punto di vista dei
linguaggi, perlomeno dal punto di vista anagrafico. Questi sono i gruppi da cui poi si
dirama la generazione immediatamente successiva, quella dei Deafear, dei Monuments,
dei Carmody, dei Loschi Dezi, che sono i i gruppi da cui
derivano le esperienze con cui abbiamo oggi maggiore familiarità, i Subsonica, gli Africa
Unite e i Mau Mau, ossia coloro che affermano la scena musicale torinese su scala
nazionale negli anni Novanta.
L’unica evidenza immediata di questo processo negli anni Ottanta è l’inopinato successo
dei Righeira, che lavorano con i Monuments, transitano a Radio Flash, arrivano dalla
scena punk, nel caso di Johnson, e portano a Sanremo, in modo improvviso e
spumeggiante, questo fermento che in città cominciava ad agitarsi.
L’altro polo significativo e determinante, su scala metropolitana, per quanto riguarda la
scena musicale, è il Centro di Incontro di Vanchiglia. E’ là che si aggrega la scena
antagonista, da un punto di vista delle presenze musicali, simboleggiate da gruppi come
i Franti e i Negazione (che avranno poi successo su scala planetaria). Viceversa, sul piano
della politica e dell’intervento sul territorio, citerei due
esperienze che vanno in direzioni differenti e però, entrambe, hanno radici là: da un lato
quella delle occupazioni, una stagione aperta da El Paso, e dall’altro quella più
istituzionale dell'Hiroshima Mon Amour, alcuni dei cui fondatori arrivano proprio
dall’avventura del Centro di Incontro di Vanchiglia. Questa semina dà origine, negli anni
Novanta, alla straordinaria fioritura che afferma, come dicevo prima, Torino su scala
nazionale. Fioritura che, volere o volare, è rappresentata dal successo dei Subsonica, che
dal sottobosco dei Murazzi vengono proiettati verso le vette dell’hit parade nazionale e
diventano un simbolo della Torino in trasformazione.
A un certo punto Torino, da questo punto di vista, sembra possa essere addirittura –
quando le scene di Firenze e Bologna cominciano ad appassire – la capitale della nuova
musica in Italia. Questo accade mentre la città, nella sua identità etnica, comincia a
mutare: sono in corso già da anni i primi importanti flussi migratori dal Nord Africa...
Questa città in trasformazione, in qualche modo, è rappresentata sul piano dell’iniziativa
musicale dall’avventura di Musica 90, che inizia proprio agli albori di quel decennio per
volere di Gianpiero Gallina.
Il vento del cambiamento, in senso imprenditoriale in parte, di intervento pubblico
senz’altro e di volontà di cristallizzare questo ruolo nuovo della città, confluisce in
qualche modo in quella avventura, che poi diventa disavventura, chiamata Salone della
Musica, che dura dal 1996 al 1999 e vorrebbe diventare lo snodo del rapporto
fra artisti e produttori, oltre che contenitore di eventi, rappresentando in un certo senso
un’alternativa culturale alle varie manifestazioni televisive e al Festival di Sanremo, ossia
i luoghi tradizionali della musica in Italia. Il Salone della Musica nasce con grandi
ambizioni, ma si accartoccia malauguratamente su se stesso.
Un’esperienza deludente che però, in un qualche modo, è istruttiva, perchè simboleggia
la forza e la debolezza della scena musicale torinese, e io credo non solo musicale, ma in
generale il fatto che la città non abbia piena consapevolezza della trasformazione in
corso e degli interventi che questa trasformazione necessita.
Io identificherei questa debolezza con due fattori, fondamentalmente. Da un lato, la
scarsa capacità imprenditoriale. Torino è una città che è vissuta per tutto il Novecento
all’ombra della “grande madre” FIAT e questo ha in qualche modo, io credo, avvilito
qualsiasi impulso spontaneo all’auto-organizzazione produttiva. In qualche modo la FIAT
esauriva qualsiasi necessità imprenditoriale e produttiva della città.
E’ una specie di blocco psicologico che rende ciascun torinese poco capace a farsi
imprenditore. L’altro elemento di debolezza è il tardivo e mal mirato intervento
pubblico sulle questioni dell’arte, in particolare della musica. Tuttora, benchè in misura
differente rispetto al passato, i flussi di finanziamento pubblico premiano le
grandi istituzioni culturali e penalizzano l’incubazione del nuovo, perchè – io credo –
persiste nella testa di chi è deputato a prendere queste decisioni una differenza non
colmabile fra l’arte istituzionale, la cultura alta, e viceversa l’arte spontanea, in
qualche modo, e quindi la cultura bassa. Quella che, in modo macchinoso, viene
chiamata “musica popolare contemporanea”, diciamo la musica extra colta, è il simbolo
di questa penalizzazione. Questo fa sì che tutto ciò che è accaduto in città da allora
abbia faticato enormemente, un po’ per proprio difetto imprenditoriale, e un po’ per un
contesto di riferimento non amichevole.
Faccio degli esempi specifici: lo studio di registrazione dei Subsonica, che poi diventa
anche etichetta discografica, Casasonica, e che avvizzisce dal punto di vista
dell’esperienza della casa discografica molto rapidamente.
Pensiamo al corto circuito virtuoso che c’era stato fra l’intelligenza tecnologica che fa
capo al Politecnico di Torino, da dove arriva Leonardo Chiariglione, l’ingegnere che ha
formattato l’algoritmo di compressione MP3, di cui ormai il mondo è pieno, e che
derivazione di questo sia stata Vitaminic, impresa che per prima in Italia ha tentato
di dare voce alla musica in rete, prima ancora delle imprese americane di cui oggi
conosciamo il nome a memoria. Vitaminic ha chiuso, dopo aver cambiato proprietà un
paio di volte, un paio di settimane fa, definitivamente. Vitaminic è una storia di fine anni
Novanta, cioè, agli albori di internet, quando internet era ancora 1.0, e il fatto
che noi avessimo in città una ricchezza di questo genere, e che questa ricchezza sia
evaporata, dà il segno del divario clamoroso e per certi aspetti drammatico fra la qualità
e la vivacità della produzione intellettuale, della ricerca e l’incapacità di tenerla poi a
casa e farla fiorire.
Quello che resta, ed è curioso, è che poi i singoli musicisti, per tornare a loro, tendono a
far casa nel proprio studio di registrazione, come se si asserragliassero in una ridotta, in
una trincea in cui difendersi e continuare a sopravvivere col proprio
mestiere. E’ così con i Subsonica e Casasonica, perchè lo studio di registrazione esiste
tuttora, anche se non più nella sede storica di piazza Vittorio, è così coi Mau Mau, che
hanno la Mau House al confine tra Pianezza e Alpignano, ed è così con gli Africa Unite, la
cui forza motrice Madaski ha questo studio che si chiama Dub the Demon a Luserna San
Giovanni. E in tema di studi di registrazione, abbiamo qui Carlo
Rossi, che è una delle “scorie” degli anni Ottanta più luccicanti dal punto di vista della
ricchezza, più ricca di venature auree... Dal Transeuropa, lo studio che nacque
originariamente dal progetto comune di Carlo insieme ai Monuments, sono circolate le
grandi star della musica italiana dei giorni nostri: Jovanotti, i Litfiba, gli 883,
Caparezza... e me ne dimentico di sicuro un mucchio.
Questo quadro, che è il quadro col quale ci confrontiamo grosso modo ai giorni nostri, ci
segnala che abbiamo di fronte una scena che è fatta più di eccezioni che di regole. La
musica a Torino, nonostante questa difficoltà, chiamiamola così, strutturale, organica,
ha continuato ad andare avanti. Dal punto di vista della creazione di luoghi, pensate
all’esperienza dello Spazio 211, che ora vive un
momento di difficoltà, nel quadro di un processo di riorganizzazione urbana in cui non si
è pensato che là c’era un posto dove stavano succedendo cose da anni e che era
diventato un luogo di riferimento per i giovani appassionati di musica.
La musica va avanti con gli esponenti di generazioni successive che si sono affermati su
scala nazionale, come i Linea 77 o i Perturbazione, fino all’ultima ondata della canzone
d’autore che ha messo radici a San Salvario. Ed è così anche per la musica elettronica: il
clan di Xplosiva e la filiazione che ha avuto la capacità di creare in un festival che, ai
giorni nostri, ha un rilievo internazionale come Club to Club. E questo vale anche per il
jazz: l’attività del Centro Jazz – sia dal punto di vista formativo, sia dal punto di vista
della cura di un cartellone come quello di una rassegna come Linguaggi Jazz – segnala
che anche quella musica continua a fertilizzare il territorio. E varrebbe questo anche per
il folk e il Folkclub, non ci fosse accesa su quell’esperienza
l’ipoteca di questa magnifica scatola vuota che è la Maison Musique qui a Rivoli. Sono
tessere queste di un mosaico sparpagliato sul territorio, che nessuno pare abbia voglia
di organizzare e ricomporre in un quadro in qualche modo unitario. E questo,
evidentemente, è un elemento di debolezza che poi rende anche difficile la relazione fra
la scena musicale e le altre forme di espressione, dal cinema all’arte contemporanea.
Nel senso che poi queste esperienze di complicità tendono a essere occasionali: penso al
rapporto fra Club to Club e Artissima o alla vocazione interdisciplicare che cerca di
esprimere Traffic, il festival che dirigo insieme ad altri, tra cui Fabrizio Gargarone e Max
Casacci.
Io credo che manchi uno strumento: da anni giace nei cassetti della Regione Piemonte
un progetto firmato da alcuni operatori del settore per la creazione di una Music
Commission, che sulla falsariga dell’esperienza della Film Commission tendesse a
valorizzare le esperienze del territorio aggregandole fra loro, ma prima ancora di questo
fosse anche solo capace di fare ciò che in tutti questi anni non è stato fatto:
semplicemente, scandagliare e mettere nero su bianco, quali e quante siano le forze in
gioco, quanti individui in città vivano e abbiano a che fare con la produzione musicale.
Sono dati che mancano, non ci sono, e l’assenza di questi dati fa sì che qualsiasi
intervento politico sia, in qualche modo, cieco di fronte alla realtà dei fatti. E’ facile
prendersela ai giorni nostri con la politica, lo fanno tutti... Però io mi domando: "Ma con
chi altro sennò? A chi spetta questo compito?”.
Se guardo fuori dallo scenario cittadino o regionale, e penso ad esempio all’esperimento
di PugliaSounds, credo che questo interrogativo, che necessariamente nasconde una
critica, abbia concretezza, non sia rituale. Non è la solita lamentela degli artisti e degli
addetti ai lavori che denunciano l’assenza della politica e lo scarso finanziamento... E'
semplicemente la constatazione di un problema e il rammarico tra ciò che sarebbe
potuto essere e ciò che non è stato. Credo che in definitiva il vero e
grave problema che ha afflitto in questi 30 anni la scena musicale torinese, nel senso più
lato del termine, sia il fatto che a una produzione musicale di livello nazionale non sia
corrisposta una politica culturale adeguata.
Fabrizio Gargarone:
Volevo ricollegarmi al video che abbiamo visto in apertura del pomeriggio, quando si
dice che nell’anno ‘92/’93 capita qualcosa. In effetti, nel ‘92/’93 capita qualcosa. Capita
l’ultimo movimento, diciamo, di massa giovanile significativo, che è la Pantera, da una
parte, e d’altra parte capita Tangentopoli... Tangentopoli è alle porte. Queste cose qua si
vedono e arrivano nel mondo dell’arte così, in modo fortissimo, non solo nel mondo
dell’arte, di tutto, della televisione, perchè poi arriva anche la Rai dei professori, vi
ricordate il programma con Paolo Rossi Su la testa? Arriva Rai Tre con questi programmi
che lasciano immaginare un Italia migliore, forse, chi lo sa, poi è andata diversamente la
storia, però, per quanto riguarda il mondo musicale accadde qualcosa di particolare.
Cioè, i gruppi che facevano come numero di paganti 200/300 persone, misuravano il
loro pubblico a centinaia, di colpo misurano il loro pubblico a migliaia. Il primo gruppo
italiano che fa questo salto enorme, erano dei torinesi, sono stati gli Africa Unite, che
sono passati da 300 persone a settembre, 2.000 a dicembre, 7.000 all’estate successiva.
Sono stati il primo gruppo che diceva “Si può fare”. Poi questa cosa va avanti ancora per
qualche anno e il primo gruppo indipendente italiano i CSI arriva ad essere primo in
classifica. Mi pare che i CSI siano stati il primo gruppo indie ad andare in classifica di
vendita in Italia di dischi, quindi era chiaro che qualcosa era cambiato. Insomma, è
veramente cambiata questa cosa. L’Hiroshima era là, ma non credo di avere avuto dei
meriti particolari, se non il fatto di conoscere questi artisti e frequentarli. Quest’onda
degli anni Novanta, in realtà, tira la carretta fino ad oggi, anche raggiungendo delle cose
paradossali e incredibili, ovvero che, non più tardi di 2 mesi fa, mi pare che i Subsonica
fossero ospiti di un programma televisivo presentati come “un gruppo di ragazzi che
suona”... Max Casacci è mio fratello, ma ha 50 anni. Quindi, si è creato un blocco strano,
per cui la nuova scena italiana è composta ancora, in qualche modo, da buona parte di
questi gruppi o loro derivati, se pensate ad Africa, Casino, Subsonica stessi... Un blocco
strano, per cui, anagraficamente, c’è qualcosa che non funziona, che non sta
funzionando tanto, per cui il pubblico è tuo figlio, cioè, hai le figlie che vogliono scopare
il padre. Allora, se questa cosa a volte funziona con delle icone, non credo che possa
funzionare in modo così diffuso. Difatti questo gioco si sta incrinando, perché possiamo
dire che negli ultimi 2/3 anni abbiamo visto l’affermazione di una nuova scena italiana,
che al momento è aggregata intorno a un’etichetta di Pordenone, ecco la vecchia
Pordenone che ritorna. Era una delle città caposaldo della prima scena musicale
indipendente anni Ottanta, con Pisa. Forse perché là vicino ci sono delle basi americane,
dei militari americani... Forse questo ha aiutato, ma questa è un’altra storia. Questa
etichetta che si chiama La Tempesta raccoglie quella che oggi è tutta questa nuova
scena capitanata da Vasco Brondi, piuttosto che da Il teatro degli orrori, Capovilla, Tre
allegri ragazzi morti, eccetera. In questa scena però non ci sono molti torinesi, ma
questo magari è un fatto assolutamente casuale... Ma è una cosa che sta in piedi, cioè,
imprenditorialmente, quella cosa là sta in piedi. E qua torniamo a un limite di quello che
accennava prima Alberto, un limite vero: noi siamo tutti dei bravi solisti, secondo me,
Torino ha quest’eccellenza, in realtà ha degli ottimi artisti, dei grandi critici, dei
grandissimi produttori, gente che sa fare il proprio lavoro perché ama intimamente il
proprio lavoro.
Noi, per stare sul mercato da tanti anni, Silvio da 20, adesso l’Hiroshima fa 25 anni, o
Alberto e Carlo... insomma, è qualche annetto che stiamo lavorando... Per starci ed
avere una credibilità abbastanza conclamata, vuol dire che abbiamo fatto una cosa
abbastanza semplice: abbiamo studiato, abbiamo faticato, abbiamo dovuto migliorarci.
Abbiamo migliorato molto noi stessi, le nostre capacità, le nostre persone... e non siamo
gli unici, ovviamente, a Torino. C’è tantissima gente capace a dei livelli fantastici, ma
imprenditorialmente siamo veramente scarsi. Perché, quello che non dice Silvio, nel
racconto bellissimo di quel Pellerossa fantastico, dove c’era la Fura dels Baus in un
tendone che costava 2.000 euro, mi pare. C’era anche Jamiroquai, c’era Bob Dylan...
C’era Jovanotti in concerto e l’apertura alle 19:00 l’hanno fatta i Massive Attack, cioé,
pensate a cosa abbiamo fatto. Si dimentica di dire che noi perdemmo 800 milioni. Cioè,
in quell’anno, io, Silvio e Franco Lucà, che avevamo le firme sul conto alla banca di
Collegno, ci indebitammo per tanti anni a venire, perchè era il 1996, per 800 milioni.
Cioè, come imprenditori, noi facciamo abbastanza schifo.. Io non so perchè sia così, non
ne ho idea, non ho una spiegazione, non so neanche dire come mai la Casasonica
discografica non ha avuto il successo che poteva avere... era anche così ovvio, legata alla
EMI, figurati, quindi anche con la protezione di una multinazionale... non lo so, questo
non sono in grado di dirlo. Io posso pensare però che ognuno di noi non abbia la forza
di...
Fare sistema richiede una forza, che se tu tutta la tua forza la tieni per sopravvivere tu, è
difficile che ne hai ancora per sostenere altri. Il fatto della sopravvivenza, per quanto
riguarda esperienze che hanno rapporti con il pubblico, spesso e volentieri, come può
essere il posto in cui siamo noi o anche i lavori che abbiamo fatto con enti pubblici come
Traffic o Musica 90, o la stessa Hiroshima... la nostra sopravvivenza, in questo momento,
essendo l’anello più debole della catena culturale... non dico che è impossibile, ma più o
meno... Voi immaginerete che ormai Regione e Comune pagano, quando va bene, a 360
giorni/400 giorni, mentre invece gli artisti hanno la brutta abitudine di essere pagati la
sera stessa, non gliene può fregar di meno che la Regione Piemonte abbia un problema
sulla sanità e ti paga un anno dopo. Quindi, nei fatti, le nostre strutture, le nostre
associazioni, ma non solo le nostre, tutto il sistema musicale è indebitato... cioè, muori
di ricchezza. Ovvero, più tu produci, più aumenti l’offerta culturale, più migliori il
prodotto che puoi offrire e quindi più costa questo prodotto, l’ente pubblico non può
darti questi soldi, tu vai in banca, fai un fido, non è vero che le banche danno i fidi e il
denaro costa il 4%, il denaro costa il 10%, cioè, i tassi bancari oggi sono tassi da
cravattari. Questo è un sistema che continua a generare debito e quindi ecco perchè in
questo momento siamo estremamente preoccupati.
Se mi dici “Ritorno al futuro”... futuro, io non lo so. Ho la fortuna singola di avere
un’entrata, avendo un locale, quindi vendi della birra e prendi del cash, che ti permette
di sistemare determinate situazioni, ma – ne parlavo prima con Silvio – un’esperienza
come quella di Silvio... come fai a progettare? Su cosa progetti, se tu aspetti un anno,
anzi, anche due anni... io l’altro giorno ho visto un bellissimo post-datato a un collega di
una grande agenzia, di Live Nation, della Regione Sicilia di 120.000 euro, 2010, cioè, un
assegno inesigibile. Se noi ci becchiamo un assegno inesigibile dalla Regione Sicilia – dico
Sicilia perchè Silvio ogni tanto ci lavora anche – ma dove vuoi andare? Cioè, di cosa
stiamo parlando? Quindi io posso dire che noi oggi, le persone che sono qui presenti del
mercato nazionale, rappresentano veramente delle eccellenze. Per inquadrare bene
cosa siamo riusciti a combinare in questi anni... se nel ’92 a organizzare un concerto ci
mettevi un minuto, perchè c’era fame di arte, di consumo, ovvero, dicevi “Oh, domani
sera alla Lega dei Furiosi ci sono i 99 Posse”, e zac… 5.000 persone, oggi, qualsiasi cosa
tu presenti ha un meccanismo diverso, devi capire il modo di promozione, che cosa
accadrà, è sempre più complicata. Caso Nina Zilli, lo faccio perchè è un’artista con cui
sto lavorando adesso. Due anni fa, Nina Zilli comincia a lavorare con quel signore là, con
Carlo, ci incontriamo una sera e Carlo mi dice: “Ho un’artista veramente forte, questa
diventerà una grandissima”, “Chi è?”, “Nina Zilli”. Chi era Nina Zilli? Nessuno..
Si parte. Il mio compito come organizzatore è seguire quell’artista, seguirne il percorso,
cercare di capire cosa fa. Va a San Remo, va bene, non va bene... non lo so. Dopodichè, il
mio compito è sapere che quell’artista farà un programma con Panariello e devo anche
capire, per il fatto che in Italia muore il fratello di Panariello, quindi io immagino che il
pubblico italiano di conseguenza sia più attento al personaggio. E allora vado là e lo
prendo con gli ascolti, e lei farà la co-conduttrice, e quindi di colpo Nina Zilli è diventata
una star italiana. Oggi chiedono: “Com’è la borsa a New York?” “Chiediamo a Nina Zilli”,
“Eh, così così...”. Sui giornali c’è soltanto Nina Zilli. Quindi vuol dire che queste persone
riescono ad avere queste competenze... Abbiamo sviluppato delle competenze molto
alte, a livello... possiamo parlare dell’Italia, però noi stiamo sul mercato internazionale
con i nostri lavori, ma imprenditorialmente siamo deboli e il sistema, diciamo politico,
perchè anche della politica dobbiamo parlare, non ci considera. La Music Commission, è
da 7 anni che è nel cassetto, viene rispolverata ciclicamente. Non so, arriva l’assessore
nuovo e tira fuori la Music Commission: “Ah no, bisogna sistemare tutto!”. Questa cosa,
Alberto, da una parte un po’ mi preoccupa, perchè quando vedo le super-fondazioni,
quando sento volare ‘ste parole strane, vedo... sto vedendo dei licenziamenti, ad
esempio. Cioè il fatto di una super-fondazione sull’arte... “Ah, risparmieremo”, “Ma
come risparmieremo?”, “Tagliamo metà dei telefoni”. E come mai tagli metà telefoni?
Mi immagino ci sarà la metà della gente che telefona. Cioè, mi preoccupa, non vorrei
andassimo ancora a complicare di più, però... insomma, vedremo.
Carlo U. Rossi: Io ho una visione un po’ diversa dai miei colleghi, perchè io mi occupo di
produrre dischi. Produrre dischi significa produrre delle robe che sono dei dischi e che
qualcuno deve comprare. Quindi io ho una visione molto bassa, molto del mercato, io
faccio dei dischi perchè... l’artista viene da me perchè io lo aiuti ad arrivare al pubblico.
Mi sembra che qua si tenda un po’ a incensare questa presunta scena torinese che, dagli
anni Ottanta, è stata una figata. Io con un solo disco, che _ Buon compleanno, Elvis! di
Ligabue ho venduto più copie di tutta la scena torinese che ha citato lui dall’83 a oggi.
Un milione e 200 mila copie, un solo album. Mettendo insieme Subsonica, Africa Unite,
Mau Mau, Linea 77 – tra parentesi tutti artisti anche miei, con cui ho collaborato a lungo
– non arriviamo a un disco di Ligabue. Quindi, un conto è dire siamo bravi, siamo qui,
siamo là... Lui citava La Tempesta. La Tempesta è una piccola etichetta di nicchia che,
quando vende 5.000 copie di un disco, fa una festa, fa le capriole e tutto quanto... Fabri
Fibra vende 300 mila copie di un disco. A Torino non è nato un Fabri Fibra. Negli anni
Duemila, l’artista torinese che ha venduto più copie è Carla Bruni. Voglio dire, Carla
Bruni ha venduto due milioni di copie... è francese però è anche nata a Torino.
I Subsonica, che sono il gruppo torinese che funziona meglio, che dal vivo spacca
eccetera, non fa tanti numeri. Cioè, alla fine, gli emuli dei Subsonica, che sono i
Negramaro – che sono dei Subsonica andati a male – e i Modà – che sono dei
Negramaro andati a male – vendono molto di più, ma molto molto di più dei Subsonica.
C’è un motivo alla base di tutto questo. Il motivo che, secondo me, a prescindere... Sì,
quello che diceva lui è molto giusto, cioè, la FIAT ha stroncato la capacità
imprenditoriale della città. Però c’è un’altra cosa: che i torinesi sono bravissimi a essere i
più bravi della nicchia. Cioè, lo scopo del torinese non è quello di spaccare il culo ai
passeri, no, è quello di essere il più bravo di quanti qua dentro. Io voglio essere il più
bravo tra di voi, quindi faccio una roba per cui sono sicuro che a voi piace, ma è molto
facile arrivare a 100 persone, 500 persone, è molto più difficile arrivare a...
Adesso vi leggo una frase di un gruppo piemontese che mi fa morire dal ridere. C’è un
gruppo piemontese che ha delle pretese di pop che ha scritto questa bellissima frase in
un suo pezzo: “Endofita errante in buco-società”. Allora... “Endofita errante in bucosocietà”, questo gruppo si chiama Marlene Kuntz, questo era uno dei loro singoli.
“Endofita errante in buco-società” non arriva, non ce la può fare. Cioè, non puoi pensare
di... Chè poi 4 anni dopo questo pezzo, sono andati pure a San Remo con un pezzo
nazional-popolare... Non puoi pensare di continuare a dire “endofita”, perchè “endofita”
non arriva, non vuol dire niente, non me ne frega niente, e non è nemmeno così
trasgressivo. E’ molto più trasgressivo – adesso, è morto Dalla quindi se ne parla sempre
– “Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io”. Cioè “Ti hanno visto bere a una
fontana che non ero io” sta parlando di un pompino ed _ stato un pezzo che ha fatto la
storia della musica italiana. Non “Endofita errante”, quindi se tu dici “Endofita errante”
è perché tu vuoi arrivare a 500 persone. E se tu vuoi arrivare a 500 persone, rimani là,
come sono rimasti là... In realtà, uno dei motivi per cui i Negramaro e i Modà hanno
venduto di più dei Subsonica, non è perché sono più bravi, ma perché dicono delle cose
che arrivano alla gente. Cioè, la gente non è proprio demente, apprezza ciò che le arriva
e ciò che la emoziona.
La musica popolare è fatta di questa cosa, è fatta di cantare una cosa che emoziona. è
chiaro che se io dico “Endofita errante” a qualcuno di voi magari lo emoziona, però
emoziona 20 persone. Lo scopo della musica popolare, però, dovrebbe essere quello di
arrivare a un gran numero di persone, di trasmettere un messaggio a tante persone, a
prescindere dal fatto che uno, se trasmette un messaggio a tante persone, diventa ricco.
Ma è proprio la “pietra emiliana” del fatto di voler fare l’artista di musica popolare, il
fatto di dovere trasmettere il messaggio a tante persone. Quindi, questa cosa della
nicchia funziona poi su tutto il resto, sulla produzione. Per esempio, le etichette torinesi
fanno ridere, sono etichette... Prima lui ha citato Pognant, che _ stato un loro socio, lui
ha fondato 2 etichette che sono importanti perchè si occupano di una musica, tra
virgolette, alta, eccetera, ma lo scopo di queste etichette è di vendere 500 copie di ogni
disco. C’è anche la Toast Record che è stata un’altra etichetta storica, però anche là lo
scopo è di vendere 500 copie di ogni disco. Perchè? Perchè è molto più facile vendere
500 copie di 100 dischi, piuttosto che 50.000 copie di un solo disco. L’investimento che
tu devi fare, e il rischio soprattutto che corri a investire tutto su un solo artista cercando
di fargli vendere 50.000 copie è molto alto. Ma cosa succede? Se tu vendi 500 copie,
l’artista è morto, non farà più un altro disco. E quindi tu non promuovi, non fai crescere
nessuno, non funziona, crei un’illusione, crei il fatto che i ragazzini vanno là, magari
smettono di lavorare perchè pensano “Ah, ce l’ho fatta, ho fatto un disco!” Hai venduto
500 copie, ma stai a casa. Mentre invece l’investimento che spinge un artista nel quale
tu credi a vendere 50.000 copie, quello sa che funziona, perchè così crei una
professionalità, crei un artista che nel tempo potrà vendere 50, 100, 200, poi tornerà
indietro 50... però avrà una sua vita artistica. La Tempesta, con tutto il bene che gli
voglio, sta creando niente. Cioè, sta veicolando delle musiche interessanti, ma non con
lo scopo di far crescere gli artisti, semplicemente con lo scopo di esistere come
etichetta. Però, io dubito che tra 20 anni noi ci ricorderemo di qualcuno di loro, mentre
invece probabilmente ci ricorderemo dei Subsonica, ci ricorderemo di Vasco Rossi, ci
ricorderemo di un sacco di gente.
Però, se voi pensate davvero, a Torino non è uscito nessuno. Cioè, la scena hip hop non
esiste, per esempio. Cioè un movimento così forte come l’hip hop, che muove
veramente una grossa quantità di persone, che coinvolge denaro e investimenti
eccetera, qua a Torino... zero. Cioè, non esiste. Tutti i nomi che mi vengono in mente o
sono milanesi o sono romani o sono pugliesi. A Torino non esiste una scena hip hop che
abbia un senso. Perchè? Non lo so. Questo per quanto riguarda il passato e il presente,
c’è questo problema. Per quanto riguarda il futuro, io per Torino vedrei una soluzione
molto bella. A me piacerebbe che Torino diventasse un centro di formazione. La
formazione, alla fine della fiera, è l’unica cosa che noi italiani – occidentali in realtà
ormai – possiamo esportare nell’era post-industriale. Noi non possiamo competere col
resto del mondo su un sacco di cose, sui costi di lavoro... però possiamo competere sul
fatto che noi abbiamo un know how e il know how dev’essere trasmesso. Quindi, una
delle cose che si potrebbero fare, appunto, è: più che sviluppare, più che investire su i
grandi eventi e queste cose qua, investire sulla formazione, che crea lavoro per chi deve
formare e crea gente che sappia lavorare. Nel nostro campo, ormai, tutti gli artisti si
fanno i dischi in casa, ormai lo studio di registrazione è una roba obsoleta, non serve
assolutamente più a niente. Però non sanno, non sono capaci... C’è molta roba che esce
da questi studi casalinghi che non suona, non funziona. Lo stesso per quanto riguarda i
musicisti, sarebbe bello avere un centro di alta formazione di specializzazione dei
musicisti nei conservatori.
In realtà, sono tutti abbastanza sfigati i conservatori italiani. Io, se devo andare a
registrare un’orchestra, preferisco andare a Sofia o a Londra, perchè qua in Italia... C’è
una cosa che si chiamano “le patate”. Le patate sono, in notazione, gli interi, cioè
quando una misura... quel disegno che c’era una specie di patata in mezzo al rigo... Ecco,
trovare un’orchestra italiana che sappia suonare le patate, che vuol dire una nota fissa
per due misure, intonata, è assolutamente impossibile. Io ho protestato diverse
orchestre italiane, perchè non sapevano fare intonati... dei re. Fatemi tutti un re che
duri due misure e questo re... Lo stesso sul tempo, le orchestre italiane non vanno a
tempo. Sono tutte cose veramente bizzarre. Però tutto questo fa sì che, se io devo fare
un lavoro in fretta, professionalmente di livello, vado a farlo all’estero. E non sono solo
io, cioè, tutti i miei colleghi... se chiedi a un produttore italiano dove va a fare gli archi, o
va in Inghilterra o va a Sofia. Perchè si risparmia tempo, si risparmia denaro... no, magari
denaro no, ma tempo sicuramente – e il tempo _ denaro – e il risultato è assolutamente
superiore. Quindi, anche in questo campo, c’è bisogno di formazione. A Saluzzo c’era,
c’è una scuola di alto perfezionamento musicale che però, nel corso degli anni, si è
sempre più sgretolata e la parte relativa all’alto perfezionamento è semi-svenuta. Nei
conservatori si fa quel che si può, Santa Cecilia è diventata... anche quella non è più la
Santa Cecilia degli anni Ottanta/Novanta... Alla fine della fiera, non ci sono... Ma non
perchè i musicisti non sono bravi, è perchè ai musicisti non viene insegnato a suonare
insieme per dei progetti come i nostri. Noi siamo intonati a 440 invece che 446 Hz, cioè
ci sono un sacco di cose per cui nel pop avremmo bisogno. Ed è un lavoro remunerativo,
perchè fare un’orchestra costa 12/15.000 euro per un disco. Quindi c’è un cash flow che
si muove, non è una cosa così, da mille lire.
Quindi, è per quello che io auspicherei per tutto, non solo nel campo musicale e
culturale, che Torino diventasse un centro di formazione alto. Arrivederci.
Andrea Costa: Allora, io non sapevo bene perché ero qua, adesso finalmente l’ho capito:
sono un esponente dell’“endofitismo” torinese. Uno di quei famosi responsabili di non
aver bucato oltre, in sostanza... Di aver vissuto con il grande sogno che la musica non
fosse fatta dai numeri, cosa che invece tutti quanti voi mi avete amabilmente spadellato
davanti agli occhi.
La cosa che in realtà mi interesserebbe è non parlare proprio per niente di quella che è
stata la mia esperienza, perché a me interessa, ma non mi interessa raccontarvela. Mi
interesserebbe invece un po’ di più approfondire quello che ho sentito da voi. E’
incredibile, ci siamo messi in posizione... forse, non lo so, ma non c’entra nulla, ok, siete
tutti miei santi amici.
Ho sentito nominare prima di tutto la politica. Ecco, secondo me... ho girato intorno a
questo, ho sentito numeri, ho sentito la parola “politica”, la parola “politica cieca” nei
confronti di quello che le capitava sotto gli occhi eccetera. Io penso che, in realtà, il
problema reale sia soprattutto da guardare sul fatto che è stata cieca proprio la nostra
capacità di fare imprenditoria. Quindi, come diceva anche Fabrizio prima. Cioé, non
siamo per niente dei buoni imprenditori ed è quello secondo me il primo passo. La
politica dovrebbe arrivare in causa dopo, come un meccanismo che, successivamente, si
rende conto che qualcosa succede. Cioé, Torino – ma in assoluto l’Italia – un’industria
reale musicale non è stata in grado di costruirla. Sì, a livelli italiani esiste la musica
italiana, esiste quello che in qualche modo... quello che le etichette paludate, grandi...
Però non è esistita una capacità di far nascere dal nulla e di credere in quel nulla, a tal
punto che poi la gente si rendesse conto che quel nulla forse, invece, un valore lo aveva.
E questo, se lo guardiamo proprio nel nostro piccolo orticello, è perché forse tutti quanti
noi – io mi ci metto nel ruolo di musicista, cerco di evitare i ruoli successivi, in questo
caso – non siamo stati così fondamentalmente credibili, penso, per fare in modo tale
che ci fosse qualcuno che credeva in modo tale che si muovesse tutto un meccanismo a
domino, a catena, che portasse in qualche modo a far sì che la situazione si muovesse.
Ma potrei ribaltarlo anche al contrario, lo stesso pubblico non ha avuto fiducia in coloro
i quali aveva intorno. Faccio un esempio stupidissimo: se Kate Bush si fosse chiamata
Caterina Cespuglio e arrivava da Poirino, invece che dall’Inghilterra, non se la sarebbe
filata nessuno, anche se la musica che faceva era la stessa. Perché non crediamo mai
nella possibilità che il nostro vicino possa avere delle idee che possono essere
interessanti, perchè lo vedi al bar a prendersi un caffè, perchè lo vedi intorno a te che fa
le cose quotidiane, questo vale per tutti gli artisti. Allora è più facile, se ti chiami Roger
Tal dei Tali, che il torinese o la torinesità in genere dice “ah sì, certo, lui è interessante”,
poi magari fa delle cose molto meno interessanti del tuo vicino di casa, che molto
probabilmente se le terrà sempre dentro il cassetto della sua scrivania e non usciranno
mai. Quindi questa è un po’ una doppia cecità, una cecità del mondo al quale
apparteniamo tutti quanti noi, da un lato come pubblico e dall’altro lato come
operatori. La cecità di non credere prima di tutto in noi stessi, questo ha fatto in modo
tale che non si sia generata in qualche modo un’industria, che non si sia generata una
realtà che poi si è autoalimentata e che poi, a quel punto là, doveva arrivare
all’attenzione della politica e a quel punto là essere supportata. Io credo molto di più, in
questi settori nei quali operiamo, nell’iniziativa privata che non nel fatto di doversi
rivolgere a un ente, come se fosse una grande mamma che ci aiuta. Mi sembra un po’ un
retaggio anni Settanta... cioè, basta.
Se si vogliono fare le cose, si possono fare, i luoghi si possono anche trovare in 5 minuti,
forse manca questo. Allora, per riallacciarmi a quello che dovrebbe essere un po’ tutto il
meccanismo eccetera, io penso che quando ho cominciato a fare il musicista negli anni
Ottanta, non è che mi chiedevo tanto se era necessario vendere come Ligabue o se era
necessario vendere... niente, come poi normalmente è avvenuto. Mi interessava fare. E
io vorrei che... secondo me, ci si misurasse un po’ più con quello che non con, in qualche
modo, passatemi il termine, piangersi addosso che le cose non funzionano. Stiamo
perdendo un po’ di vista il fatto che c’è “il fare” a monte di tutto questo, che c’è
qualcuno che ha un’urgenza nel cercare di comunicare qualcosa e che queste persone
che dovrebbero raccogliere, alla fine, dall’altra parte quest’urgenza di quel qualcuno,
alla fine preferiscono l’urgenza di qualcun altro perchè sembra più interessante. Allora è
un po’ tutto uno sgretolamento di questo mondo in cui però la cosa meno importante
sono gli artisti, ma questa cosa qui... io direi che sarebbe il caso di rifletterci sopra.
Perchè poi alla fine sennò questo determinato mondo da dove parte, dove arriva? Cioè,
possiamo solo continuare a girarci intorno sulle domande, però vediamo se c’è buona
musica, cattiva musica. Perché è più facile che al mondo vengano vendute un milione e
200 mila copie di Ligabue e che magari ci siano dei gruppi di ragazzini super intelligenti,
che non usciranno mai dalla loro cantina? Perché non ci sono operatori che stanno in
mezzo in questi settori? Un po’ come, non so, immagino... io non è che amo molto il
calcio, però, immagino che un talent scout, per capire se uno gioca bene o male, se lo va
a vedere quando gioca – magari è una visione romantica – nel suo campetto da calcio di
periferia. Ecco, queste figure, questi personaggi che in qualche modo dovrebbero
cercare di capire dove sta il nuovo nelle cose... dove sono? Chi ha questo ruolo? Fare in
modo tale che... Forse è proprio partendo da questo che si potrebbe in qualche modo
ricostruire un attimo la piramide e cercare di fare in modo tale che le cose possano
ripartire, magari non per quello che è già stato, ma per quello che potrebbe essere un
ipotetico futuro. E magari forse, già che la politica adesso non serve più a un cazzo, fare
in modo che non serva veramente proprio a niente e che “il fare” generi “il fare”.
Sarebbe molto più interessante. Vi ributto queste domande.
Alberto Campo: Abbiamo fatto discorsi molto diversi, mi rendo conto che forse il
quadro complessivo che ne viene fuori è disordinato, però è disordinato proprio perché
il mondo da cui ciascuno di noi proviene è disordinato. Diciamo che il cuore di questa
discussione, di questa tre giorni di convegno è, in qualche modo, l’arte contemporanea.
Se noi paragoniamo il mondo della musica al mondo dell’arte contemporanea, ci
rendiamo conto che è assolutamente caotico e non ordinato. Non ci sono percorsi
formativi strutturati; l’iniziativa privata è legata davvero all’estro individuale e alle
fortune individuali, alle occasioni che la vita presenta a ciascun individuo; non ci sono
luoghi strutturati per la musica... non solo le accademie, ma anche...
Gianpiero Gallina ha polemizzato per anni sul fatto che a Torino mancassero strutture
adeguate per la musica dal vivo e tuttora è così. Le discoteche sono costruite per la
musica da ballo e non per i concerti, il Palaolimpico è stato costruito per lo sport e non
per i concerti, allo stesso modo quello che ora si chiama PalaRuffini. Non c’è un
auditorium per la musica che non siano quelli della musica colta, il Conservatorio o
l’Auditorium della RAI in via Rossini. Luoghi progettati per la cosiddetta musica popolare
contemporanea e per l’esecuzione dal vivo della musica popolare contemporanea non
esistono in città. Per cui mi rendo conto che spiegare la realtà della scena musicale in cui
ciascuno di noi, in qualche modo, alligna è complicato. Siamo un mondo così, un po’
abborracciato, disorganizzato. Credo che quell’idea del mosaico buttato là, di cui
nessuno ha voglia di ricomporre i tasselli, renda un po’ l’idea.
Posso dire che alcune cose mi hanno colpito molto dei ragionamenti che sono stati fatti,
mi ha colpito molto la ricostruzione che faceva Fabrizio delle dinamiche che hanno
messo in moto e poi hanno arrestato i processi nel corso degli anni Novanta, mi ha
impressionato, con un po’ di vertigine, il discorso che faceva Carlo a proposito delle
cifre. Mi fa paura sempre quando si parla a proposito della musica solo delle cifre,
perché, se penso che il disco più influente della musica rock – il primo album dei Velvet
Underground – è stato un fiasco commerciale clamoroso, vuol dire che forse non si
spiega solo con le cifre la musica. Si spiega anche con le cifre, ma non solo con le cifre.
Ma questa è una polemica che ci divide da quando eravamo giovani e quindi
continueremo a portarla avanti finchè diventeremo vecchissimi. Le cose che diceva
Andrea a proposito del fatto che il movente originario è il desiderio espressivo del
musicista, che non ha niente a che vedere con la quantità di copie vendute o con
l’ampiezza della platea che ha di fronte, quest’urgenza motivazionale linguistica, di
capacità di esprimersi e di rivolgere il proprio linguaggio ad altri – quanti siano questi
altri - è, in fondo, non rilevantissimo – credo che sia il Sacro Graal che deve ispirare i
nostri ragionamenti. Volevo solo chiarire che ciò che dico io a proposito della politica,
non è la visione anni Settanta dell’assessore con il portafoglio gonfio che sparge denari a
pioggia. Non è questo. Il problema è che noi ci siamo dimenticati cosa dovrebbe essere
la politica. La politica è una cosa che, in qualche modo, raccoglie i nostri quattrini
attraverso le tasse, li raduna e, attraverso questi quattrini, eroga servizi.
Nella fattispecie, per quanto riguarda l’ambito culturale – nello specifico l’ambito
musicale – erogare servizi significa creare un habitat in cui le storie possano crescere. Il
lavoro che si fa adesso in terrazza, se metti le piante... cioè, che metti il terriccio, quello
un po’ arricchito, ci butti dentro i semi e speri che saltino fuori le piante di peperoncino
e di basilico. Questo è il compito della politica, da qualsiasi punto di vista. E non è una
richiesta di elemosina, è la richiesta di “Fate il vostro lavoro”. Gli esempi che faceva
Silvio a proposito della Francia sono assolutamente pertinenti. Faccio un esempio
proprio banalissimo: per la prima tournée transoceanica dei Mano Negra, negli USA e in
America Latina, tutti i voli furono pagati dal governo francese, il Ministero degli Esteri
pagò i voli per fare in modo che i Mano Negra di Manu Chao potessero esportare la
propria musica, la musica di Francia, oltre confine. Questi sono gli interventi della
politica a cui alludo.
Andrea Costa: Io sono d’accordo con te, quando dici queste cose, però il concetto è:
proviamo ad allontanarci un attimo e a guardare... Io guardavo la politica, quando ti
dicevo queste cose, in una maniera diversa. Proviamo a pensare all’inizio degli anni
Ottanta in Inghilterra chi c’era al governo e che cosa stava succedendo al governo e
quanto, in realtà, nello stesso momento esistesse un fermento artistico, e nello stesso
tempo anche industriale, perché tutti ce li andavamo a comprare questi dischi e loro ce
li vendevano. E le due cose non viaggiavano... Non credo che la Thatcher fosse là pronta
ad aiutare i Sex Pistols. C’era un meccanismo di rivolta totale e allora è proprio in
funzione di questo che dico...
Alberto Campo: E’ un esempio difficile, nel senso che il caso inglese è descritto dagli
stessi storiografi inglesi come un caso non ripetibile. Quello che è successo in Gran
Bretagna è che gli inglesi si sono appropriati in modo molto pronto e scaltro del
rock’n’roll che veniva dagli USA, hanno avuto la fortuna di avere gruppi come i Beatles e
i Rolling Stones e intorno a questi esempi hanno costruito un’industria che si perpetua
ancora ai giorni nostri. La Gran Bretagna – lo descrive John Savage in un saggio sul punk
– è un piccolo paese che esercita un potere sullo scacchiere musicale internazionale
assolutamente spropositato rispetto alle sue dimensioni e alla sua popolazione. La Gran
Bretagna è un paese grande come l’Italia e con più o meno la stessa popolazione che,
insieme agli USA, è il principale produttore di prodotti musicali diffusi su larga scala. Non
c’è un altro paese di questo genere, neanche la Germania, la Francia.
Andrea Costa: Però questo vuol dire anche che può esistere un’industria o comunque
una movimentazione di denaro che è scollata da quello che è il meccanismo.. Cioè, la
privatizzazione reale può esistere, scollata dal meccanismo politico o non essere
appoggiata.
Alberto Campo: Relativamente... Il primo governo Blair, in Gran Bretagna, appena
insediato, ha creato una commissione per la popular music affidandone la direzione ad
Alan McGee – che era quello della Creation Records, che aveva scoperto gli Oasis
eccetera – dandogli poteri illimitati, perché in Gran Bretagna ormai è chiaro che la
musica pop è una risorsa nazionale d’esportazione tanto quanto lo è per noi
l’enogastronomia. Cioè, la nostra ricchezza è l’enogastronomia, noi a vendere la musica
pop non siamo capaci. Farinetti con Eataly invece... caspita!
Olga Gambari: Abbiamo questa conversazione con un po’ di ospiti e questa sarà una
versa conversazione, nel senso, un ritornare su temi che sono stati toccati oggi,
affrontarne altri, ci sono figure e persone che adesso presenteremo e che
rappresentano elementi e figure del mondo dell’arte differenti. E’ anche il momento in
cui finalmente vorremmo che, visto che siamo stati un po’ serrati e abbiamo iniziato in
ritardo, accogliere gli interventi di chi ha qualcosa da dire, ha voglia di intervenire, di
ritornare su quanto detto.
Vado a presentare le persone che daranno vita a questa conversazione: Francesco Poli,
Massimo Melotti, Caterina Fossati, Alvise Chevallard, Franco Noero, Alberto Peola e
Nicus Lucà.
(seguono bio)
Anche per collegarci alla scena musicale, ai protagonisti di questo racconto
dell’ambiente musicale che abbiamo appena avuto, una delle persone che avevamo
invitato era Gianluca Gozzi, che è stato diciamo l’ideatore di Spazio 211 – che è stato
uno degli spazi più innovativi proprio a livello di impresa e di programmazione – e che
ha lasciato un anno e mezzo fa questa direzione, è uscito come socio dallo Spazio 211,
adesso ha aperto il Blah Blah – un altro esperimento di luogo assolutamente legato alla
musica, ma non solo. E aveva fatto, come saluto al pubblico, una lettera manifesto
molto personale con alcuni spunti che, in realtà, erano anche graffianti, un’accusa, un
testo anche amaro di saluto al panorama composto dal pubblico, dalle istituzioni, da
tutto un sistema. In realtà, molti punti sono stati già toccati anche da loro...
Francesco Bernardelli: Sostanzialmente possiamo condensare in quella che, come dire, è
la sostanziale delusione dal punto di vista di chi, come dire, è veramente nella funzione
del talent scout, che evocava appunto Andrea Costa, le persone che riescono a
riconoscere qualcosa di molto innovativo quando è ancora difficile da delineare e dargli
la giusta piattaforma e la giusta luce per presentarlo. Appunto, nella sua lettera di
polemica Gozzi segnalava, invece, qualcosa come una sorta di malcostume molto
presente nel nostro paese, soprattutto nelle politiche culturali, dove dice in realtà noi ci
troviamo in qualche maniera soffocati da “direttori artistici, giornalisti tromboni,
faccendieri della cultura” che sono solo capaci di piangere per i tagli dei finanziamenti
pubblici eccetera. Quindi in fondo, come dire, il grande nodo irrisolto in realtà sono
questi due modelli culturali, chiaramente anche come ci si rapporta rispetto al discorso
di sistema che però poi tende a essere riassorbito, congelato, cristallizzato, reso proprio
un po’ sclerotizzato, in qualche maniera, forse da una predominanza istituzionale,
rispetto a chi invece si fa interprete in quel senso di un approccio completamente libero
e imprevedibile, in qualche maniera. Che quindi necessita semplicemente di quel
minimo di spinta, di aiuto, di luce per potere andare avanti.
Noi volevamo partire da questa sorta di provocazione proprio per ragionare in termini di
quanti fenomeni analoghi possiamo riconoscere, anche all’interno della scena delle arti
visive, in una città come Torino dove appunto, citando la famosa mostra e citiamo
questo fatto di essere stati, in qualche maniera, al crocevia di una avventura
internazionale... Ma allora il punto è: quanto di ciò è stato fatto effettivamente e ha
dato dei frutti e quanto è ancora da fare… E’ questo per noi uno dei nodi totalmente
ancora irrisolti. E qui vorremmo magari cominciare a dare la parola per primo a
Francesco Poli, visto che è stato anche citato oggi, è stato evocato su queste che sono
state le conclusioni che venivano date in questa mostra presentata nel ’93 all’Unione
Culturale, dove il catalogo sulla Torino degli anni Ottanta, in qualche maniera, registrava
una situazione di crisi che era, appunto, nata alla fine degli anni Ottanta, ma che
sembrava consegnare all’osservatorio del pubblico una situazione della città in preda a
grosse difficoltà, una sostanziale mancanza forse di grandi prospettive. Allora, a distanza
ormai di 20 anni...
Olga Gambari: E poi, l’altra cosa che volevo mettervi sul piatto, sempre ritornando a
Gozzi, quando noi l’abbiamo invitato, lui assolutamente non ha voluto sentirne parlare
di venire, in maniera, devo dire, anche molto tenera, dicendo “Se io sento ancora la
parola ‘cultura’, mi viene un accidente. Fate quello che volete con la mia lettera,
scusatemi se non vengo, ma non me ne parlate mai più”.
Francesco Poli: Ma non c’è la lettera. Non sappiamo il contenuto...
Olga Gambari: L’abbiamo già accennata prima, non volevamo leggerla tutta. Francesco
aveva citato due o tre di questi passaggi. “La politica arriva troppo tardi a comprendere
quello che succede nel momento in cui sta succedendo, compromessa in un sistema
vizioso dell’apparire anzichè dell’essere, del vincere facile stile Gratta e Vinci” oppure
“In questo nostro Belpaese pieno di artisti di professione, direttori artistici, giornalisti
tromboni, faccendieri della cultura, che piangono per i tagli alle flebo dei finanziamenti
pubblici, ma che ripropongono ogni anno gli stessi cartelloni, farciti di amici e
conoscenti, gli stessi articoli fotocopia, gli stessi rituali che di culturale non hanno più
nulla e assomigliano sempre più alle sagre paesane, all’animazione da villaggio turistico
o agli show televisivi. Io mi sento fieramente un onesto artigiano che ha tentato di fare
miracoli per non perdere il passo e tirare a campare”. E’ molto lunga, però era giusto per
dare...
Francesco Poli: A non voler sentire parlare di cultura credo che sia stato soddisfatto da
tutti gli anni berlusconiani!
Io non parlerò della questione degli anni Ottanta, a me pare di aver citato... chi è che
l’avrà fatto, forse, non so, la Maria Teresa Roberto o altri... Questa mostra che avevamo
curato con Beatrice Merz era una specie di mostra riassunto, a partire da un’esperienza
lunga che forse era stata la prima in quegli anni lì, dell’Unione Culturale, dove erano
passati un po’ tutti gli artisti giovani. Gli spazi espositivi erano l’Unione Culturale e poi
una birreria nei luoghi dei Docks Dora, quindi luoghi abbastanza trovati così, in maniera
indipendente, in maniera un po’ rustica per tanti versi. Ed effettivamente l’aspetto
interessante è stato quello... c’è un momento di crisi... C’è un video, tra l’altro, fatto da
Willy Darko di questo dibattito post-mostra, che era qualche cosa vicino alla
psicodramma di gruppo, perché c’era a un certo punto... a fare così, i commentatori,
c’eravamo io, c’era Mirella Bandini, buonanima poveretta, chi c’era d’altro? Non mi
ricordo più... C’era Melotti… E a un certo punto c’era un discorso generale e, per
avventura, in sala c’era Mario Merz e c’era anche Marisa. E a un certo punto si è
scatenato un discorso, un litigio, di alcuni artisti contro Edoardo Di Mauro, contro altre
cose... Quindi c’era proprio una nevrosi che, al di là dei motivi contingenti, giusti o non
giusti... E poi è cominciato a venire fuori una specie di cosa con Mario Merz, Lucia
Nazzaro... cioè, una scena abbastanza interessante, ma purtroppo significativa della
confusione e della mancanza di prospettive, o della percezione della mancanza di
prospettive di una situazione di artisti torinesi, giovani, in quell’epoca là, rispetto alle
istituzioni che erano la Galleria di Arte Moderna – chiusa – e il museo di Rivoli che
faceva le cose ad alta quota, di altro genere. Quindi si trovavano in una situazione... nel
nulla, nello zero. Salvo qualche galleria che seguiva queste cose e nient’altro. E con la
percezione di essere schiacciati fortemente dalla presenza, dal protagonismo e
dall’epigonismo, se vogliamo dire così, della generazione vincente precedente, che era
poi quella dei poveristi, di altri artisti di questo genere. Devo dire che, dagli anni Ottanta
agli anni Novanta, le cose sono cambiate molto. Io sono sempre stato un osservatore
curioso, fin da allora. Allora ero anche un po’ più attivo, adesso ho i capelli bianchi e
faccio altro, ma seguo però con interesse il tutto. Dagli anni Novanta è cominciato a
cambiare radicalmente anche lo spirito, pian pianino, dal ’95 diciamo... E poi è successo
un fatto statistico straordinario: che, non solo a Torino, ma in tutta Italia – e a livello
internazionale un po’ prima – gli artisti, che erano tutti maschi, rigorosamente maschi
negli anni Ottanta, salvo una o due eccezioni, ma sono pochissime, Lucia Nazzaro e
qualcun’altra qua di Torino, poche... E finalmente si crea una situazione che è
sacrosanta, adesso c’è una presenza, una vitalità, un’energia culturale diversa, che la
generazione di artiste donne che è venuta fuori, che ormai rappresenta il 50%, diciamo
anche di più, se vogliamo, comunque rappresenta quello che dovrebbe, che avrebbe
sempre dovuto rappresentare, ha cambiato anche i criteri, diciamo così, di valutazione
di tutto, i criteri anche della ricerca, degli interessi e di altre cose.
Negli anni Ottanta, un’altra cosa che lamentavano questi artisti, è che non avevano
nessun tipo di collegamento con... neanche con le situazioni italiane o estere. Io mi
ricordo una volta che avevamo fatto una quadriennale... alla biennale qualcuno _
arrivato, per caso, non so, c’erano pochissimi artisti di quegli anni là. C’era Pierluigi
Pusole, ma mica tanti altri... Neanche nella quadriennale di Roma, che era già una
mostra con caratteristiche scadentissime, per molti versi, per clientelismo, eccetera.
Comunque, avevano invitato un certo numero di artisti di Torino, pochi, ma comunque...
La cosa curiosa è che nel catalogo, dove c’erano... Parlo di quella quadriennale perché
era fatta esattamente come un tentativo di ricognizione nazionale... Ah, è già stato
detto?! E mancava assolutamente anche un testo di Torino, da chiederlo a qualcuno.
Anche se sono già stati detti, però sono dati abbastanza significativi di una realtà di un
certo genere. Poi le cose sono cambiate, si è sviluppata molto, devo dire, anche
l’attenzione sull’arte contemporanea.
Il contributo, bisogna dire, del Castello di Rivoli, da un punto di vista generale di
attenzione sull’arte contemporanea, è stato decisivo. Decisivo dal punto di vista della
costruzione della moda per l’arte contemporanea per Torino. Mi ricordo, l’unica mostra
che ho curato qua, insieme a Rudi Fuchs e Johannes Gachnang, si chiamava Standing
Sculpture, e in quell’occasione per la prima volta, era arrivata la signora Marella Agnelli a
segnare l’interesse della FIAT, che difatti poi è entrata anche con Annibaldi e altri... è
entrata dentro la situazione... Questo ha creato anche un’attenzione più allargata per
l’arte contemporanea, è cresciuto di più tutto lo sviluppo... è venuta fuori anche una
vitalità maggiore da parte degli artisti. E devo dire che la realtà al femminile – che non
aveva mai avuto spazio, non solo a Torino, ma in generale – è qualcosa che ha cambiato
decisamente le coordinate. Ma io non vorrei parlare di questo... Poi naturalmente non
sto a ripetere tutto quello che avrete già detto sullo sviluppo, sull’articolazione, sulla
strategia della costruzione del sistema di arte contemporanea a Torino, con tutti gli
elementi che sappiamo...
Quello che volevo invece aggiungere, e poi smetto subito, è che il rapporto tra Torino e
l’arte contemporanea internazionale è un fatto di cultura, prima ancora che di strutture.
Oggi sono andato a visitare – a mezzogiorno, per questo che non ero qua! – una mostra
fatta da persone alla Galleria di Arte Moderna, che è una mostra storica, che si chiama
Strangers, che è una mostra dove sono state esposte tutte le opere di artisti stranieri
della collezione del museo, e sono opere dagli anni Cinquanta, dal dopoguerra insomma,
fino alla pop art, fino agli anni Sessanta. Da fine anni Quaranta, anni Cinquanta, anni
Sessanta. E devo dire che la quantità di opere di grande livello europee, ma anche
americane, è qualche cosa – per un museo italiano, intendiamoci – di considerevole. Ed
è segnale di un gusto e di una cultura, di un contesto e di un ambiente artistico, di
un’attenzione a una scena internazionale che non aveva precedenti in altre città se non
in parte naturalmente a Milano, in parte, in maniera più elitaria, magari per singoli
personaggi a Venezia, o a Roma per altre situazioni sempre particolari.
Da un punto di vista delle collezioni, il fatto che ci siano opere di tedeschi, di francesi, di
americani, di inglesi, è qualche cosa di abbastanza interessante e curioso. Perché?
Perché c’era una conduzione della Galleria d’Arte Moderna all’epoca, era uno dei due
soli musei a livello italiano che si occupassero in maniera attiva, in maniera dinamica,
dell’arte contemporanea. E grazie, bisogna dire, dentro la Galleria di Arte Moderna
c’era, non tanto il direttore ufficiale, Mallé, che era più un funzionario, diciamo così,
quanto piuttosto Aldo Passoni, padre di Riccardo, il quale ha lavorato molto in questa
direzione, ha avuto dei rapporti vitalissimi con, per esempio, Eugenio Battisti e con
Celant giovanissimo che lavorava con Eugenio Battisti... Quindi c’è stato tutto il progetto
dell’elaborazione di questo cosiddetto Museo di Arte Sperimentale, cioé una donazione
massiccia che doveva andare a Genova, e grazie al disinteresse di Genova e all’interesse
di Torino, è arrivata in questa parte. Nel comitato di selezione, di scelta delle opere del
museo, c’erano delle persone, c’era per esempio Corrado Levi, se non sbaglio, c’era
Sperone e Pistoi non erano nel comitato... Sono i punti di riferimento principali
attraverso cui sono state acquistate delle opere di grandissima qualità. Cito due opere
che valgono praticamente tutta la collezione, sono stati comprati da Pistoi : un Twombly
formidabile, che è rimasto là, che adesso varrà sui... Quanto varrà un Twombly così, voi
che siete galleristi?! Varrà 10 - 20 milioni di euro, 20 milioni di dollari, circa. Del ‘62/’63,
straordinario... E un Warhol bellissimo, un Car Crash... Quindi, comprare all’epoca, e
costavano già care delle cose del genere, era un segnale di un gusto, di un interesse, di
un’attenzione per l’arte internazionale, che ha creato le condizioni anche per tutti gli
sviluppi successivi. Un altro aspetto anche mondano, è che la Galleria di Arte Moderna
era all’epoca... C’era l’associazione Amici del Museo, la cui presidentessa era Marella
Agnelli, ma aveva dietro un personaggio come Carluccio, e hanno fatto mostre
internazionali di grande livello. Quindi questo spirito internazionale... Poi c’era Michel
Tapié anche che ha portato un’altra ventata di internazionalità. Questa situazione è
quella che ha creato l’humus, se vogliamo, per Torino di un’identità, per quanto
riguarda il settore dell’arte contemporanea, diversa rispetto al resto dell’Italia, per
un’altra ragione: che Torino è una città marginale, cioé, diciamo una città eccentrica, nel
senso proprio geografico del termine, e quindi l’asse principale dell’attività, degli
interessi galleristici, in Italia era più sull’asse di Milano e Roma. Salvo una serie di
galleristi di importanza centrale, li abbiamo citati, c’era Luciano Pistoi, poi è arrivato
Sperone, c’era anche Il Punto che faceva delle cose interessanti, ma meno, anche la
galleria Martano, la galleria Galatea, importantissima, non tanto per essere una galleria
legata alle ultime tendenze, ma per fare delle mostre di altissimo livello, artisti di
grandissima qualità, tipo Bacon per intenderci, o cose di questo genere. Quindi questo
contesto, che è abbastanza ridotto, abbastanza chiuso, era però del massimo livello
possibile. Poi ci sono stati un gruppo di collezionisti e personaggi che hanno creato
anche le condizioni di attenzione di avanguardia, all’epoca, per esempio il Deposito di
Arte Presente, dove c’era Marcello Levi e mi sembra anche Corrado Levi e altri, e hanno
creato già una specie di modello di Kunsthalle o si spazio espositivo, quasi fosse una
fondazione, cosa che non era...
Francesco Bernardelli: Questo va bene, però questi sono un po’ i “primordi”, noi
vogliamo arrivare a parlare delle trasformazioni tra gli anni Ottanta e Novanta. Quando
oggi, a un certo punto, abbiamo citato in un paio di passaggi due momenti abbastanza
interessanti, in due relazioni diverse, dove vengono evocati modelli di esposizioni, che
peraltro passano proprio in questo palazzo e che sono, da un lato, Soggetto soggetto,
che è una mostra che crea proprio un’attenzione, una riconsiderazione su quello che è il
rapporto fra generi, fra sessi... Qual è lo spirito di questo rinnovamento artistico?
Attraverso quali corpi passa? E sempre su questo tema corporeo, anche le intuizioni
seminali di Jeffrey Deitch con la famosa Post Human, che arriva dalla Svizzera e poi
continua per l’Europa... Quanto meno servono veramente a mettere in atto e in scena
anche dei modelli di arte talmente differenti e talmente di impatto... Questo come si
contestualizza in qualche maniera?
Francesco Poli: Io l’ho tirata per le lunghe semplicemente per dire un concetto di fondo:
se non c’è una stratificazione di... non si costruisce una cultura vera e profonda, con
radici eccetera, di attenzione sull’arte contemporanea e d’allargamento di interesse sia
da parte del collezionista, sia per le condizioni di crescita di gallerie che sono
fondamentali nella costruzione delle nuove proposte e altre cose.
Poi citiamo quelle dopo, c’era sua madre, la Menzio, tanti altri... Non si poteva arrivare,
secondo me, a quella che è stata la scelta strategica, intelligente... devo dare atto a
Giovanni Ferrero, all’epoca, di fare di questo castello un museo di arte contemporanea
di taglio internazionale e chiamando, come ben sappiamo, un direttore che era, al
momento in cui è stato chiamato, giovane ma anche al top tra i curatori internazionali
per avere curato Documenta, eccetera. Questo ha creato anche una programmazione di
mostre, un arrivo di proposte che venivano dalla Germania, ma in particolare dagli USA
che, tra le altre cose, hanno poi creato un’attenzione anche abbastanza forte anche
sulla situazione di oggi.
Francesco Bernardelli: Mi piacerebbe passare la parola, visto che sono stati evocati, su
quello che è il ruolo dei galleristi, visto che abbiamo parlato di libera iniziativa. Visto che
a Torino esiste una solida tradizione...
Alberto Peola: Il problema è che è tutta la mattina che si parla degli anni Ottanta,
adesso tornare agli anni Sessanta... No, ma non ti stanno accusando, era solo per
inquadrare il problema. Adesso bisognerebbe riuscire a parlare di quello che sta
succedendo, cosa che non è tanto semplice, perché non è chiaro cosa sta succedendo.
Però mi ricollegherei un attimo al discorso di Andrea Massaioli di stamattina, perché
non si può non rispondere ad Andrea (Massaioli) e a tutta una serie di artisti torinesi che
in qualche modo... ci penserà poi Nicus che è un esponente di quel gruppo. Comunque,
Andrea ha semplicemente rivendicato una dimenticanza, nel senso che questa galleria,
soprattutto per quanto riguarda la GAM, che è questa galleria d’arte comunale, civica,
non dimentichiamolo, e quindi avrebbe dovuto avere un occhio di riguardo sul
territorio, che invece purtroppo non ha avuto per mille ragioni. Lui ha citato quel ciclo di
mostre che si chiamava Avvistamenti, che è un ciclo di 10 mostre effettuato nei primi
anni di Castagnoli, curato da Alessandra Pace. In queste 10 mostre fatte e nelle due
successive – che non si chiamano più Avvistamenti però hanno lo stesso catalogo –
curate dalla Volpato, là ci sono Bartolini e Marisaldi se non sbaglio, e nei 10 artisti ci
sono 2 italiani e 8 stranieri e i 2 italiani, se non ricordo male, furono Airò e Bonvicini. Che
va benissimo, insomma, non è che dobbiamo fare le mostre degli artisti che se non
parlano in dialetto non vanno bene, però un occhio di attenzione, visto che tutto
sommato è una galleria d’arte comunale, forse avrebbero dovuto averlo. Cosa che è
successa nelle altre città. Ricordo la mostra straordinaria fatta al PAC Due o tre cose che
so di loro, curata da Meneguzzo, ma con interventi di Pietrantonio e di Vettese, su
quella che è stata la situazione milanese. E cioè, in qualche modo, hanno presentato da
Mazzucconi ad Airò, da Caropreso alla Banda Oklahoma, cio_è tutti quegli artisti che
hanno lavorato in quegli anni... Arienti, sono tanti i milanesi... Ha ricordato quello che ha
fatto Castagnoli a Bologna con Officina Bolognese... Cioè qui a Torino stranamente c’è
stata forse una sorta di dimenticanza. L’ultima dimenticanza in ordine di tempo, sono
stati i 150 anni, nel senso che in tutta Italia si è festeggiato, a Torino in particolare, la
meravigliosa mostra alle OGR e la grande mostra a Rivoli sull’Arte Povera e dintorni, e
stranamente ci si è dimenticati di fare una mostra di cosa sta succedendo oggi. Perchè la
storia dell’arte non si è fermata nel 1968, la storia dell’arte e gli artisti hanno continuato
e continuano a lavorare, e quindi forse una presenza o una ricognizione, almeno, di
quello che sono stati gli artisti torinesi, o comunque piemontesi, forse sarebbe stata
necessaria, viste le qualità e visto il valore di molti di questi artisti, non sarebbe stato
male.
Indubbiamente, il ruolo delle gallerie è stato fondamentale, soprattutto nei 12 anni di
chiusura della GAM, perché non dimentichiamoci che negli anni Ottanta, dall’81 o ’82,
per 12 anni la GAM è rimasta chiusa. Rivoli ha aperto, se non sbaglio, nell’84, fine
dell’84, quindi c’è stato in qualche modo un vuoto. Un vuoto che è stato riempito dalle
gallerie. Ovviamente si è parlato molto di Guido Carbone, ma si è dimenticato Remolino
– purtroppo entrambi prematuramente scomparsi. Ed erano forse, con Paludetto, le
uniche gallerie che si occupavano di giovani artisti. Non c’era altro a Torino. Poi negli
anni Novanta sono arrivati gli altri, è arrivato Bertaccini, sono arrivato io, Weber e molti
altri. Oggi, la TAG che è questa associazione che raggruppa le gallerie d’arte torinesi
contemporanee, sono ben 18 le gallerie. Quindi il clima è sicuramente cambiato, il
mercato si è allargato: ci sono gallerie internazionali notissime e ci sono gallerie ottime
che continuano a fare un ottimo lavoro. Però è cambiata davvero tutta quanta la
situazione. Un altra data importante è stata la nascita di Artissima, nel senso che ha
segnato... I primi anni di Artissima sono stati lenti e faticosi, poi il cambio di mercato...
nel senso che il mercato si è leggermente spostato, anzi direi che fondamentalmente si
è tragicamente spostato dalle gallerie alle fiere e alle aste, e quindi il ruolo delle fiere è
salito immensamente, così come è salito il ruolo di Artissima. Artissima è servita a creare
questo... oserei definirlo “mito” di Torino capitale dell’arte contemporanea, e questo ci
ha aiutato, indubbiamente. Capitale dell’arte contemporanea, non dimentichiamolo, in
una situazione italiana. Cioè, in una situazione estremamente difficile e in una
situazione, comunque, non di serie A, insomma, perché l’Italia paga anni di difficoltà,
anni di non cultura... be’, questo lo sappiamo tutti, non è un problema specifico nostro,
è un problema più generale.
Franco Noero: Io arrivo a Torino nell’ottobre del ’98. Logicamente l’ho frequentata
prima, ma non ho il polso che può avere avuto Alberto, eccetera. Quindi sicuramente
posso parlare di quello che è stata la mia esperienza, posso parlare di quello, ma... Ho
visitato Torino, per me l’arte contemporanea era il Castello di Rivoli ed è il Castello di
Rivoli. Scusate, io mi emoziono sempre quando parlo in pubblico e quindi ho sempre un
po’ di problemi di abbrivio. Quindi diciamo che la presenza di questo luogo, per me,
diciamo da quando avevo 14/15 anni, è stata veramente molto importante: è stato
molto importante visitarlo, è stato molto importante vederlo... crescere insieme mostra
dopo mostra, credo di avere comprato negli anni tutti i cataloghi e quindi dovreste
darmi una tessera di fedeltà! Per il resto, ho avuto in Piemonte un’esperienza
precedente a quello che citava anche Francesco, che era... Io sono stato socio di
minoranza e direttore – ma avevo 22 anni, quindi era difficile dirigere qualcosa a
quell’età, senza esperienza – di una piccola galleria in provincia... a Cuneo, però diciamo
che era una situazione completamente distaccata dalla realtà cittadina. Un’altra
presenza che invece frequentavo all’epoca veramente molto assiduamente era la
galleria di Caterina (Fossati), dove nascevano degli esperimenti e delle sperimentazioni,
delle mostre veramente speciali e dove Caterina – prima di molti altri anche, in Italia e
all’estero – sperimentò la formula dell’appartamento.
Questo è per quanto riguarda per me gli anni Novanta e gli anni Ottanta in città. Poi
andai a Roma e venni qui... Scelsi Torino per 4 o 5 motivi, il primo dei quali sicuramente
era la presenza del Castello di Rivoli, e quindi la presenza dell’unico, all’epoca museo di
arte contemporanea di livello internazionale in Italia. Poi, in modo un po’ fanciullesco,
avevo pensato che – con l’idea già del programma che potevo avere nel ‘98/’99, che poi
attuai, speriamo – se una certa parte della borghesia, del collezionismo, si era avvicinata
ad artisti quali l’Arte Povera, l’arte concettuale negli anni passati, magari poteva
interessarsi a qualcuno di quelli che all’epoca sognavo. Questo è sicuramente capitato e
il collezionismo torinese è stato eccezionale anche nel supportare la mia esperienza.
Forse non ho capito bene un passo di quello che ha detto Alberto prima: Alberto diceva
che Torino è stata una capitale, ma sicuramente una capitale marginale... io non credo.
Torino è una piccola capitale, è stata sicuramente una piccola capitale dell’arte
contemporanea, adesso le cose sono un po’ cambiate, perché sicuramente il mercato
sia dell’arte, ma il mercato anche delle mostre e dei musei – e parlo di mercato perché
poi, alla fine, le mostre vengono anche vendute, per cui quello è – si è sicuramente
molto molto allargato. Però Torino è stata un’eccezionale piccola capitale, un posto
catalizzatore di personaggi straordinari, dei più importanti curatori internazionali... ché,
avendo una micro vetrina in città, ho potuto conoscere, quindi per la mia esperienza è
stato fondamentale essere qui, molto meglio di essere... che so, a Foggia, ma anche
magari se uno fosse stato a Milano...
Però Torino ha valicato un po’... Torino era un po’ un riferimento, ma lo è ancora, credo.
Secondo me siamo in tempo a salvare le cose. Sicuramente adesso la situazione non è
semplice, non è facile, ci sono state tante difficoltà, tante campagne, tante qua, tanto là,
da cui mi tengo assolutamente al di fuori, perché non è il mio specifico, però abbiamo
sicuramente la possibilità di beneficiare ancora di quello che è questa città, di quello che
ad esempio... Io non lavoro con artisti torinesi, lavoro con una sola artista che vive a
Torino, ma non è torinese, e questo è capitato, non è una scelta, sono delle cose che...
L’arte la si incontra e non la si sceglie per espressioni geografiche, almeno per quello che
sono io. Ma quello che è straordinario per una galleria, per un gallerista, è vedere la
passione che hanno gli artisti, giovani e non, quando vengono in questa città, quando
cominciano a lavorare e quando approcciano una mostra, quando approcciano anche la
produzione di un lavoro. E anche quello che – ne abbiamo discusso molte volte con
Alvise (Chevallard) – questa città ha la possibilità di offrire, dall’artigianato alla grande
industria, al fatto che siamo riusciti a produrre opere che non si riusciva a produrre in
Belgio, l’artista non è riuscito a farle a Londra e neanche in America, e qui per la tenacia,
l’ostinazione magari tante volte di qualche piccolo industriale di None o di Carmagnola o
Carignano... Io sono riuscito a far fare un triangolo del cestino della carta che finiva a
zero non tagliato al laser, che sembra una stupidaggine, però poi dopo era
fondamentale per la creazione di un certo qual lavoro. Senza dimenticare il fatto di cui
dicevo prima, del collezionismo. Che è un collezionismo che, appunto, ha beneficiato
della presenza di grandi gallerie, di grandi musei, della possibilità di interfacciarsi con
uno spirito del tutto internazionale, comunque, pur essendo in provincia, marginali
d’Italia, epicentrici e tutto quel che vogliamo, ai confini di qualunque cosa... Credo
comunque che questo sia un posto dove vi sono delle persone, vi sono delle collezioni –
anche magari molto nascoste – ma che lasciano veramente a bocca aperta quando le si
conosce. E poi c’è una cosa, ho sempre detto a tutti i miei colleghi, anche quelli giovani
che volavano aprire, magari uno a Milano sembra subito di essere più al centro... Ed è
forse vero, noi qua abbiamo un aeroporto incredibile, abbiamo delle cose che... E’
difficile veramente lavorare in un certo qual modo, soprattutto con la velocità che ci è
richiesta...
Francesco Poli: Però, tu vedi il caso (di Galleria continua) a San Gimignano...
Franco Noero: Però è diverso...
Caterina Fossati: San Gimignano ha delle particolarità diverse.
Francesco Poli: Ormai il lavoro dei galleristi, e anche quello degli artisti, è quello di avere
un reseau internazionale...
Franco Noero: Io sono andato ieri a Istanbul. Per andare a Istanbul, se fossi stato
milanese, ci mettevo 3 ore e 40, invece ce ne ho messe 7. Ed è diverso. Sembra una
stupidaggine, ma non è solo Istanbul. Vai a New York ci metti 14 ore al posto di 6.
Comunque, a parte l’aeroporto che tanto non credo che possiamo risolverlo in questa
sede... A proposito dell’aeroporto, c’è una cosa che dovremmo forse abbracciare tutti,
che Hans Ulrich Obrist usa sempre questa cosa. Lui vorrebbe assolutamente che la
comunità artistica torinese si facesse portavoce per intitolare l’aeroporto di Torino a
Boetti.
Caterina Fossati: Non sarebbe stato per niente contento.
Franco Noero: No?!
Massimo Melotti: Io invece devo riavvolgere il nastro, perché sennò saltiamo un pezzo
centrale, che parte proprio dalla nascita del Castello di Rivoli. E’ poi lì che nasce il
sistema dell’arte contemporanea, almeno, quel piccolo nucleo del sistema dell’arte
contemporanea in Italia. Perché? Perché la Regione Piemonte – e qui dobbiamo anche
spezzare una lancia in favore delle istituzioni e della politica – a seguito anche di una
serie di discussioni di piano strategico che si erano fatte in quegli anni, grazie a
personaggi come Ferrero e grazie a una giunta, diciamo, illuminata, proprio nel
momento in cui inizia una programmazione politica a pieno regime... perché dobbiamo
ricordare che è il periodo in cui nascono e incominciano a lavorare a tempo pieno, per
così dire, le Regioni, nel senso che l’istituto regionale è un istituto che assume sempre di
più delle capacità autonome rispetto al potere centrale. In questa logica, entra il bene
culturale che, per la prima volta, viene gestito a livello locale. E questo è il fatto
rivoluzionario, allora, che spiega anche molte cose rispetto al sistema dell’arte torinese.
Nasce il Castello con delle singolarità. Anzitutto, è un museo dedicato al
contemporaneo, non vi sono in Italia fino a quel momento, musei dedicati al
contemporaneo. E poi, altre anomalie, tra virgolette: il Castello di Rivoli è il primo
esempio di pubblico/privato, e questo vuol dire sottrarre potere amministrativo al
settore pubblico, per permettere una gestione autonoma, quanto più possibile, perché
ai tempi si diceva: “Cerchiamo di imitare il modello dell’impresa, in quanto consente di
diminuire i costi e di essere più efficaci”.
Il modello era l’impresa, quindi uscire dal contesto statale.
Massimo Melotti: Quindi, questa anomalia e singolarità del Castello di Rivoli, che ha
delle conseguenze non di poco conto. Un’ultima postilla: Rivoli è l’unico esempio a
livello internazionale, perché, se ci guardiamo intorno in quegli anni, a parte la Biennale
di Venezia, non c’è altra un’istituzione che abbia una vocazione internazionale già dalla
nascita. Queste sono le caratteristiche di fondo. Abbiamo avuto la grande fortuna e
veramente il merito di avere trovato un direttore come Rudi Fuchs, che ha giocato una
carta vincente, che era quella di rifiutare la mostra per la collezione permanente. Non
era scritto da nessuna parte che ci sarebbe stato un Castello di Rivoli – Museo per l’arte
contemporanea, poi con i politici che spingevano o da una parte o dall’altra... Pochi anni
prima, si stava discutendo se abbattere la Manica Lunga per fare un eliporto e non
venne abbattuta perché ch’erano i profughi del Polesine che ancora stavano là...
Quindi... Qui si parlava del museo dell’antiquariato, il museo delle bandiere... ogni tanto
saltava fuori un museo. Comunque nasce il Castello di Rivoli, dedicato all’arte
contemporanea. Io non sono torinese, venivo da un’esperienza a Milano come critico
d’arte, già allora mi occupavo dei processi culturali in università, quindi ero interessato
anche a questi fenomeni. Un giorno mi è stato chiesto da una casa editrice di scrivere un
testo che avesse come oggetto gli artisti di Torino e io ho pensato all’Arte Povera, no?
Invece, no. Allora ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto: “Sì, è vero. E’ così, ma ci
interessa quest’altro perché siamo sicuri che le copie vendute saranno molte di più”.
Questo è un primo dato di vissuto, che vorrei portare alla vostra attenzione. E cioè, in
quegli anni lì, la realtà del sistema... non lo chiamo neanche “sistema”, diciamo dell’arte
contemporanea a Torino, era una realtà fortemente aristocratica. Incentrata su due
elementi fondamentali, su due soggetti del sistema dell’arte, questo sì, fondamentali: i
galleristi e i collezionisti. A Torino particolarmente forti i collezionisti, i galleristi un po’
meno, rispetto alla massa di Milano, ma sicuramente più legati al collezionismo. Non a
caso qui a Torino nasce una gallerista che è anche collezionista: Stein. Quindi c’è questo
momento forte. Ma la percezione e l’influenza che ha l’esperienza “arte
contemporanea” negli anni Ottanta è già meno forte di quello sperimentale che vede la
nascita dell’Arte Povera e sicuramente non è forte rispetto all’opinione pubblica
generale. Se si andava a parlare, come facevo io per motivi di ufficio, del Castello di
Rivoli in un’assemblea o in un convegno dedicato alla cultura, si toccava un tasto
estremamente delicato. Io ricordo che a un convegno un relatore accennò a cambiare la
destinazione del Castello di Rivoli, ci fu un boato, un’acclamazione perché
evidentemente il Castello e quella arte contemporanea erano percepiti come un
elemento estremamente negativo. Il mio primo incontro con l’allora direttore
dell’Accademia Albertina, quando andai a proporre un’attività in comune con il Castello
di Rivoli, la sua reazione fu: “Ma lei non sa dov’è, perché qui insegniamo ai nostri allievi
che al Castello di Rivoli... c’è il demonio! E’ una cosa da non fare, da non frequentare,
perchè quella non è l’arte”. Cosa voglio dire? L’opinione pubblica generale della città,
nella sua stragrande maggioranza, non capiva e non era favorevole a un’operazione di
questo tipo. Quest’operazione è riuscita grazie a quei due elementi che dicevo prima,
all’intuizione regionale, quindi della politica, diamone atto, a un gruppo di artisti che si
sono impegnati in prima persona per appoggiare questa iniziativa, e al primo direttore
che l’ha sostenuta.
Questo apre tutto un nuovo scenario. Quello che ho detto prima, è anche
estremamente collegato con la Galleria Civica d’Arte Moderna. In quegli anni là è chiusa,
però c’è una rivalità nascosta, che poi viene fraintesa dai politici, tant’è che poi diventa
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, e si entra in un meccanismo politico dove
c’è il Comune, c’è la Regione e diventano i due momenti di una storia che, insomma...
Ma comunque sia, da lì nasce – a questo punto sì – il sistema dell’arte contemporanea
torinese, che è composto – faccio dei salti temporali notevoli – dal Castello di Rivoli, poi
c’è la Galleria d’Arte Moderna, ci sono le fondazioni private, eccetera. Questo sistema va
avanti – è quello che noi abbiamo vissuto per moltissimi anni – su un canone: quello del
pubblico/privato. Cioè, si dice: “Il modello pubblico/privato funzione e quindi bisogna
applicarlo a tutti”, tant’è che non solo a Torino, ma in tutta Italia c’è questo modello,
ancora oggi è il modello che viene attuato. Ma è un modello che è un modello
all’italiana, purtroppo. Perché il privato chi è? Il privato ben presto si rende conto che
non ha alcun interesse di partecipare all’attività culturale dell’ente. Perchè? Ma perché
non ha nessun riscontro economico. Non ha la defiscalizzazione, non scala, il ritorno di
immagine è limitato, e comunque non può intervenire neanche nelle scelte culturali,
quindi non funziona. E poi il mercato interviene. Il Castello di Rivoli è emblematico. Nella
storia del Castello di Rivoli c’è il fallimento, il crack del GFT, c’è la crisi della FIAT, tutte
cose che hanno fatto sì che il Castello rischiasse di chiudere. E se non era per la Regione
Piemonte, il museo avrebbe chiuso. Questa è la faccenda. Succede che quel famoso
modello pubblico/privato, che è ottimo a mio avviso, scopre che il privato non esiste.
Chi è che lo sostituisce? All’italiana, lo sostituisce la fondazione bancaria. E quindi, con
un escamotage, siamo usciti dalla sfera pubblica, ma siamo entrati in una dimensione di
amministrazione e di controllo a livello locale. Adesso, per abbreviare, la festa è finita.
Questa è la situazione. Allora cos’è successo? Però io vorrei aprire una parentesi, ma lo
dico senza malizia e con un po’ di rammarico. Tutti coloro che hanno operato,
soprattutto chi aveva delle responsabilità in tutto questo arco di anni alla testa delle
istituzioni culturali, soprattutto delle arti visive, hanno accettato, perché era gioco
accettarlo, il teorema secondo il quale il pareggio di bilancio andava bene perché tanto
poi c’era l’ente di riferimento che riappianava. Nessuno ha mai pensato di fare una
programmazione a 3 anni, come si usa nei musei internazionali, nessuno ha mai pensato
di attuare delle politiche e delle strategie di marketing a lungo periodo. Questo non era
un problema, veniva e non veniva affrontato. Se allora avessero affrontato questi
problemi, o se qualcuno avesse detto loro “Guarda che devi affrontare questi problemi”,
probabilmente non saremmo in questa situazione. Kotler, che scrisse Il marketing dei
beni culturali 20 anni prima, aveva già previsto le due grandi situazioni, le due grandi
sfide risorse/pubblico. Delle risorse c’era chi ci pensava e il pubblico... facciamo finta di
niente, perché non era una cosa poi così importante, visto che per molti, o per alcuni,
l’arte contemporanea doveva limitarsi a un ristretto giro di persone, ma questo a livello
di grandi numeri, ovviamente.
Quindi che cosa succede? La situazione attuale è quella che bisognerebbe riuscire a
utilizzare delle nuove strategie. Mi ha fatto molto piacere, ad esempio, che il mondo
della musica si sta interrogando su queste strategie. E cioè, coloro che operano nel
settore delle arti visive, devono avere anche una guida di imprenditorialità. Non è più
pensabile di mettere su un’impresa se quanto meno non si ha la capacità o la forza,
anche economica, di poterla iniziare perché poi, sì, certo, sia sostenuta dall’ente
pubblico, ma perché sennò non si riesce. E, vorrei dire, questo discorso non vale
soltanto per le istituzioni. Quando sento il discorso degli artisti che dicono: “Non ci sono
situazioni promozionali della mia attività”, è vero e non è vero, perché se noi andiamo a
vedere quegli anni lì, io e lui abbiamo curato non so quante mostre che proponevano
giovani artisti, sia in gallerie private, tipo Franz Paludetto quando abbiamo fatto
Centomila Anni, Proposte, che nasce in quegli anni lì. Quindi, insomma...
Bisogna trovare una logica mentale, una disposizione mentale per la quale, se si inizia
una impresa di tipo culturale si deve accettare la logica dell’impresa.
Alvise Chevallard: Io mi riallaccio un attimo solo... Forse hai dimenticato di citare tra i
grandi protagonisti per privato del Castello di Rivoli Marco Rivetti, perché insieme a
Giovanni Ferrero, Marco Rivetti è stato il protagonista del Castello di Rivoli.
A me dispiace che per un disguido non siano arrivate le copie del libro di Guido Carbone,
saranno qui domattina, verranno distribuite gratuitamente una cinquantina di copie che
Edibas ci ha messo gentilmente a disposizione. Perché, a parte i contributi di Guido
Costa, di Maurizio Vetrugno, di Massimo Sterpi, cari amici di Guido, c’è anche un
interessante saggio di Luca Beatrice, che ricollega il discorso di Francesco, di quanto
Guido, prima di tutto sia stato, con Anselmino, il ponte tra gli anni Sessanta/Settanta e
l’introduzione agli anni Ottanta. Quindi, la galleria di Guido nasce da un rapporto con
Anselmino e i suoi collaboratori, per poi andare sui giovani artisti. Quindi domani avrete
modo, chi non ha avuto modo di trovarlo... ci saranno qua le copie in distribuzione.
Credo che il ruolo di Guido, come quello di Paludetto, cui poi si sono susseguiti quello di
Bertaccini e di Peola, siano assolutamente straordinari, almeno in una prima fase.
Anch’io questa mattina ero a Milano e quindi non so se avete accennato un po’ alla
genesi di queste giornate, questo per rispondere un po’ ad Alberto Peola. Nel senso che
Artegiovane, con Franz e Olga, aveva proposto alla vecchia giunta, all’assessore Oliva,
con Paolo Verri, per Torino 150 anni, una grande mostra da tenere alla Promotrice. Il
Comune aveva già messo a disposizione la Promotrice (delle Belle Arti), avevamo già
trovato il 30% di fondi privati, sia in contanti che in supporto tecnico – cosa che ci era
stata richiesta dalla Regione per organizzare la mostra in occasione di Torino 150 anni.
La mostra avrebbe dovuto tenersi alla Promotrice e il titolo era Il crogiolo. Torino
80/2010 e voleva essere una panoramica che poi portasse agli anni dopo il 2010, una
panoramica degli anni torinesi Novanta/Duemila con gli agganci alla cultura degli anni
Ottanta. Alla Promotrice, con la presenza di musica, teatro, moda, design, quindi un
ricco catalogo, per cui... ci abbiamo lavorato oltre 6 mesi a questa mostra, eccetera. E
doveva essere la mostra conclusiva per i 150 anni. Poi con il cambio di giunta, in un
primo tempo avevano confermato la disponibilità e l’interesse, poi è saltato fuori Luca
Beatrice con la sua grandiosa mostra al Museo di Scienza Naturali ed evidentemente il
progetto è stato affossato. Sì, hanno silurato anche Paolo Verri... ma non per questo.
Quindi diciamo che il Castello di Rivoli ha recepito la proposta di Franz e di Olga e,
quindi, ecco un po’ il retroscena del perché ci troviamo qui e quello che lamentava
Alberto, che non c’è stato nei festeggiamenti dei 150 anni alcuna attenzione al problema
di Torino capitale dell’arte contemporanea... Ah, dimenticavo di dire che all’interno del
progetto, c’era anche una proposta di Ugo Nespolo di realizzare un video sui 10/15
artisti di quel periodo con una maggiore presenza internazionale, che voleva riprendere
un po’ i film che aveva fatto negli anni Sessanta/Settanta sull’Arte Povera. Quindi era
una progetto ben congegnato e complessivo e internazionale da presentare in città.
Questo come inciso e doverosa annotazione.
L’ultima osservazione, invece, sul periodo centrale. Io voglio dire che Torino... è vero che
la politica, il Comune, la Regione, hanno dato un grande contributo, ma un grande
contributo non in termini economici o di proposta, un grande contributo di laisser faire.
Perché in realtà, la Fondazione Sandretto, Artegiovane, tutti i vari movimenti in Barriera
di Milano, piuttosto che le realizzazioni di a.titolo, sono nate spontaneamente, sono
germinate autonomamente, non grazie alla politica, ma la politica le ha lasciate fare e
non le ha contrastate. Questo va rilevato. Nel senso che ha lasciato fare, ma non le ha
neanche aiutate più di tanto, voglio dire. A parte alcuni ben identificati di questi
protagonisti.
L’altra conclusione è che non è vero che Torino è rinata dopo le Olimpiadi. Il lavoro è
stato tutto prima, le Olimpiadi è stata l’occasione, ma non il fattore scatenante
dell’interesse di Torino artistica e turistica. Tutta la base è nata prima. La creatività e la
creazione, le strutture, i movimenti, gli artisti eccetera sono nati ben prima di Torino
2006. Torino 2006 ha saputo utilizzare e sfruttare in termini turistico-sportivi tutto
quello che già c’era, ma non ha creato assolutamente niente di nuovo e non ha portato
niente di nuovo sotto il profilo appunto artistico e culturale.
Adesso, boh... A me sembra una grande assenza, come diceva Alberto quando c’è stata
alla Fondazione Merz il convegno di «Arte Sera», ci sembra che l’attenzione all’arte da
parte di questa amministrazione, almeno per il momento, sia abbastanza latente, quindi
con ancora maggiori incertezze per il futuro.
Caterina Fossati: Io ho ascoltato abbastanza il convegno, che partiva dalla lettera di
Massaioli che, invece, sono contenta che qui abbiamo un po’ ribaltato, perché secondo
me Torino è una città che ha offerto molte occasioni agli artisti. Più che Foggia, di sicuro.
Nel senso che, se un artista nasce a Foggia, secondo me, ha avuto più difficoltà...
Partendo da quello che diceva Peola, che siamo in Italia, che... Mi ha colpito quello che
diceva Campo, che ci sono state delle promesse disattese negli ultimi 30 anni, ma non
solo nella cultura. Questo paese ne ha disattese parecchie di promesse, e la cultura di
conseguenza. Quindi, partendo dal fatto che siamo italiani, Torino in realtà ha dato
tantissime occasioni. Poi magari alcuni artisti non sono stati invitati, ma hanno avuto la
possibilità di vedere delle opere, di dialogare con dei personaggi che sono passati di qui.
Cosa che non è stata data all’artista foggiano.
E poi mi ha molto colpito, invece, l’intervento della musica, perché secondo me,
appunto, se si vuole fare un ragionamento, oltre a buttare le responsabilità sugli altri,
bisogna prendersi le proprie responsabilità. Allora era carino che ognuno ha detto: “Io
non so fare l’imprenditore”, cioè, che ognuno si interroghi sul perché... Ed è stato anche
molto curioso, non so come si chiama il signore che era seduto al posto di Melotti, che
ha fatto questo discorso sulla patata. Io ho lavorato con artisti italiani, anzi, la mia prima
galleria lavorava solo con artisti italiani, dopo invece ho lavorato con gli artisti stranieri,
e tu quando ti mandano un’opera, riconosci se è uno straniero o un italiano. Solo dal
pacchetto! Ed è un po’ il discorso della patata quindi bisogna anche domandarsi come
mai poi uno rimane più al palo di un altro artista, perché non sono solo responsabilità di
altri, ma ci sono le proprie. Come appunto, anche come galleristi. Adesso io non sono
più una gallerista, ma mi metto in quella categoria. Ci sono sicuramente... Quando si era
pensato alla TAG, avevamo capito che da soli c’erano delle cose che non potevamo
ottenere, che l’unico modo era di fare un sistema, ma di non aspettare il pubblico, di
fare un sistema fra di noi. Tra l’altro, la TAG nasce dopo la Biennale del Mediterraneo,
dove noi galleristi – allora eravamo 14 gallerie di arte contemporanea – non avevamo
avuto comunicazione di nulla, non ci avevano ne’ interpellato, ma neanche dato i
volantini da distribuire al nostro pubblico…
Alberto Peola: Non è cambiato nulla, oggi.
Caterina Fossati: Sì, non è cambiato nulla. Ma forse, prima di dire: “Tu devi cambiare”
bisogna anche pensare...
Alberto Peola: Volevo fare un’annotazione. L’assessore nuovo, Braccialarghe, ha
replicato a un articolo di Rocco Moliterni in cui Rocco diceva: “Come mai, per la nomina
di questo nuovo direttore di Artissima, non viene mai sentito un gallerista?”. La replica
di Braccialarghe è stata: “Perché c’è un conflitto di interessi”.
Caterina Fossati: Esatto, c’é l’idea che se tu guadagni, è ambigua la tua figura.
Francesco Poli: Ma questo è un retaggio... Io, che sono un vecchio comunista, ho
superato questo spettro del mercato.
Caterina Fossati: Tu sì, ma Braccialarghe no!
Francesco Poli: Il mercato non è più il demonio.
Caterina Fossati: No, infatti. Ma poi, tra l’altro, è quello che... Ma questo fa parte del
sistema, come diceva lui, che non si può scaricare una donazione. Fa parte tutto di un
sistema che malfunziona in Italia. Ma non è che malfunziona solo a Torino, anzi, Torino
cerca di supplire a molto del sistema sbagliato italiano. Non abbiamo una sala di
Fontana in tutta Italia, adesso ha aperto a Milano, ma... Voglio dire, noi siamo famosi
per le nostre avanguardie storiche e in Italia non le possiamo vedere. Dobbiamo andare
nel paesino ultimo tedesco, che le ha. Quindi, questo è il problema italiano. Però se si
parla di Torino negli anni Ottanta, secondo me, sono stati anni super fertili, come diceva
giustamente lui, nascevano su un tessuto precisissimo. Però hanno continuato una
tradizione molto fertile. Infatti mi ha fatto piacere che ci sia lui, che invece ne ha una
visione assolutamente positiva. Questa è una riflessione da fare sulla lettera di
Massaioli, perché secondo me si parte da un presupposto... appunto, interroghiamoci su
cosa ognuno di noi non ha fatto, o cosa può fare per il futuro. Anche come gallerie,
perché, appunto, ci sono dei sistemi che, è vero che poi non ti chiamano, ma che sono
proprio ormai finiti o sbagliati di per sé, secondo me. Al di là, se poi ci chiamano o ci
interpellano – o vi interpellano – per la biennale, piuttosto che Artissima o piuttosto
che... Queste sono le mie prime riflessioni, poi se me ne vengono altre ve le racconto.
Nicus Lucà: Ad esempio, io noto che, rispetto a un bel po’ di anni fa, ci sia poca
frequentazione da parte di chi cura le mostre, dei critici, non dico tutti, degli studi degli
artisti. Vedo che sono, appunto, invitati gli artisti... dei nomi di cui spesso non si
conoscono nemmeno le opere. Pertanto, questo crea il problema della sostituibilità. Se
per qualsiasi motivo un artista non va bene o ha qualche discussione, eccetera, viene
subito risolto con il metterne un altro. Prendo come esempio gli inviti alla Biennale di
Venezia di quest’anno, abbastanza vergognosi: a me è arrivato un invito della serie “Se
entro 3 giorni non arriva la fotografia, vuol dire che non ci sei”.
[commenti in sala]
Nicus Lucà: Però è una realtà... è una realtà che mostra il rispetto... cioè, come sono
cambiate un po’ le priorità nella scala dell’importanza delle cose, nella quale il primo
posto, alla fine, dovrebbe spettare all’artista. Perché, se non c’è l’artista.. non ci sono
neanche tutti gli altri addetti ai lavori. Mentre invece, appunto, diventa tutto
sostituibile, no? E’ aumentato esponenzialmente il numero degli artisti, dei galleristi, di
tutto... ma anche in altri mestieri. Pertanto diventa un’enorme accozzaglia nella quale è
difficile distinguere, separare e dare spazio a tutti, specialmente. Per quanto mi
riguarda, io ho scelto di fare un percorso abbastanza, diciamo, autonomo, con tutti i
problemi che questo crea. Però diventa... cioè, ci vuole tempo, bisogna investire molto
tempo per promuoversi. E dico promuoversi, prima ancora di promuovere il proprio
lavoro. Della serie che se non ti fai vedere, non ci sei, piano piano non cerchi di creare
un attimo di confidenza con chi di dovere, nessuno viene da te perché è curioso, perché
ha visto qualcosa del tuo lavoro, pertanto vuole magari approfondire. O almeno, sono
rare le persone che... Non dico che non lo faccia nessuno, con Olga sono in rapporti, ci
vediamo, eccetera. Però, in generale, è difficile lavorare... perché la prima cosa che mi
coinvolge veramente è la mia vita, cioè il quotidiano, tutte quelle cose che non
c’entrano niente e non interessano agli altri, se non al momento che io le faccio passare
attraverso un’opera. Io noto che si parla poco delle opere, si parla sempre di tante altre
cose, che sono per lo più importanti, non dico di no... però ci si lamenta. Io so che se
volessi fare qualcosa per andare avanti nella mia carriera, diciamo, troverei anche
qualcosa da fare, saprei più o meno come muovermi. Cioé, sono io che non faccio niente
perché non ho tempo, perché non ho voglia, perché mi annoia questa cosa qua. E faccio
le mie opere. E’ vero che a volte ci si trova in difficoltà per realizzare le opere, proprio a
livello economico, non è che ci si può sempre inventare così, con un pezzo di carta e una
matita... a seconda delle esigenze, a volte c’è bisogno di un diverso supporto. E infatti
spesso bisogna un po’ limitare la possibilità di azione a seconda di quello che si ha in
tasca. Una volta va bene, l’altra magari rinunci a fare un’opera che sarebbe eccezionale,
ma nel frattempo quell’opera con quei soldi la sta facendo qualcun altro. Insomma, c’è
sempre questo bivio: o il tuo lavoro diventa sbatterti per far sapere che esisti, però nel
frattempo magari non hai avuto il tempo di lavorare, di perderti nel tuo mondo, nella
tua giornata. Cioè, un artista adesso dev’essere anche uno che è capace di relazionarsi,
non può più essere uno che è mezzo matto o che... Non è che dev’essere per forza
matto un artista, però quello che era diventato un mondo un po’ a volte anche idilliaco,
che però apparteneva a un artista che si esprimeva con delle opere, era un po’
secondario – anzi, poteva diventare anche pittoresco, al limite – il suo comportamento
nella vita, oggi diventa un po’ primario, perché sennò non sanno neanche cosa fai.
Paradossalmente proprio in un’epoca dove c’è la rete e dove ognuno si può
pubblicizzare da solo. Infatti si va a click, ormai, no? “Quanti click hai?”. E spesso diventa
più una questione di quantità, dove è difficile – non dico che non ci sia – trovare la
qualità. Pertanto, io parlo appunto come artista e non tanto di quello che ci sta intorno,
però io mi scontro con la mia quotidianità, la mia vita, con tutti gli squilibri e gli equilibri
del caso. E credo che anche altri artisti alla fine vivano primariamente questo tipo di
esperienza, non è facile riuscire a capire come funzionano le cose, anche perché tutto
dura poco, tutto si brucia, si parla spesso di cose che tra 2 mesi sono già cambiate:
l’assessore di turno, piuttosto che il concorso lì, la cosa là... Cioè, tutto si brucia, si
mangia da solo e noi, ogni volta, puntualmente, spendiamo delle energie per trovarci,
per incontrarci... Io di questo, diciamo che mi sono un po’ stufato, cioè mi annoia
parlarne... Non dico che non ci siano cose interessanti da dire eccetera, però alla fine
bisogna fare anche una scelta, le energie sono limitate. Io ho scelto di fare le mie opere,
una alla volta, e al momento buono le tiro fuori e le faccio vedere. Non me la sento più
di parlare, di chiedere, di aspettare, di dire, perché mi porta in un’altra tangente
proprio. E allora, o coincide con la mia vita tutto questo, perché le cose si incrociano in
modo puntuale, oppure ci rinuncio. Perché diventa veramente... ti porta da un’altra
parte e questo è quanto. Non sto a parlare dagli anni Ottanta a oggi, a questo punto.
Olga Gambari: Prima di rispondere o di fare un giro, finalmente volevamo chiedere al
pubblico se c’erano degli interventi, delle... qualcosa che volevate...
Pubblico: Perché non c’é Franz Paludetto?
Olga Gambari: Purtroppo non è stato possibile invitare “tutti”... Ci sono tantissime
figure che mancano, l’abbiamo premesso all’inizio della mattinata. Non è un tavolo
esaustivo, molti presenti sono una parte per il tutto... Comunque, visto che è una
mancanza, per fortuna Franz è stato comunque citato spesso e ne siamo contenti.
Pubblico: ...cioé, lui (Carbone) e Paludetto sono stati veramente le chiavi di lettura,
secondo me, degli anni Ottanta e del perché questa città, da “poverista” e ingessata in
un certo modo, ha poi avuto un certo tipo di storia dopo. Per cui, già Carbone ci manca
molto... ma Paludetto…
Olga Gambari: Sicuramente Franz è un grande assente, è uscito spesso il suo ruolo,
anche la sua preveggenza e il suo istinto... molto animale, anche proprio come talento
nell’essere un talent scout e nell’avere uno sguardo anche internazionale di
aggregazione e di lettura di movimenti europei e non solo, e legati al territorio... capace
di individuarli e di portarli qui, di avere uno scambio tra territorio e scena
internazionale... Come lui mancano però anche altre figure importantissime di
galleristi…
Nicus Lucà: La mia storia, diciamo, come artista, non sarebbe esistita se non fosse
esistito Franz. Perché io non ho frequentato scuole, volevo fare la musica, mi sono
trovato nell’85 a lavorare in via Susa – c’era via Susa, piazza Solferino – mi sono trovato
da Franz a dipingere i pannelli di Torino Fotografia, perché avevo bisogno di soldi, e
sono rimasto là. In quei giorni si prendeva il Castello di Rivara, pertanto ho lavorato degli
anni con lui e ho avuto modo, l’opportunità di lavorare praticamente con tutti gli artisti
che sono passati da lì. Non diciamo poi Aldo Mondino, con cui sono stato a Milano, per
del tempo... Però da ogni artista ho avuto modo di acchiapparci qualcosa, dandogli il
mio aiuto e chiedendogli spudoratamente anche spiegazioni a livello teorico. Per me è
stata una formazione unica.
Al Castello, un pezzo alla volta, con molto sforzo, piano piano è stato restaurato un
pezzettino, un altro pezzettino. Poi, nel bene e nel male, gioie e dolori, Franz è una
persona a tutto tondo... però praticamente sono passati un po’ tutti da lì dentro,
situazioni e specialmente ho vissuto in prima persona come nascevano le idee. E
certamente non nascevano da strategie di... Era un po’ come Oltre il giardino con Peter
Sellers, no?
Un luogo di incroci, penso al progetto Equinozio d’autunno, nell’88, che raccoglieva
praticamente artisti, galleristi, curatori, non solo dall’Italia... Rudi Fuchs veniva tutte le
domeniche su a Rivara. Cioè, per me, dico nella mia esperienza d’artista, sono qua,
faccio quello, ho avuto modo di conoscere anche le persone in una maniera diciamo
conviviale, no? Mentre si mangiava, si portava a fare il giro della mostra, magari di sera
con l’accendino, perché si era rotto l’impianto della luce, c’era sempre qualcosa che non
andava. Però intanto le cose si facevano e sottolineo anch’io che è una presenza molto
importante.
Olga Gambari: C’erano delle domande o degli interventi?
Giulia Caira: Io volevo approfittare, collegandomi con quanto detto oggi a pranzo con
Caterina, dove si parlava di autocritica e ha ragione da questo punto di vista. Uno dei
punti degli artisti torinesi – che, tra l’altro, purtroppo sono veramente pochi, quindi il
mio intervento sarà... va be’, lo faccio per noi – è il fatto che comunque non si
riconoscono mai una possibilità, come dire, di posizione politica, posizione anche
imprenditoriale. Perché purtroppo è così, il mondo è cambiato in questa direzione, ci
richiede una partecipazione al nostro lavoro, che non è solo ed esclusivamente
operativa, ma anche di contenuti e quindi di possibilità di relazionare in pubblico,
relazionare per difendere il proprio lavoro, eccetera. Questo, quindi, include anche il
fatto che, rispetto per esempio a quanto si è citato questa mattina, quando si dice che a
Torino non ci sono artisti... include anche il fatto che gli artisti debbano reagire e,
comunque, non dico difendersi, ma quantomeno fare sentire una presenza anche solo...
Non parlo solo di giovani artisti, perchè ricordiamoci che noi non siamo “giovani artisti”.
Cioè, noi abbiamo tutti... forse qui sono io la più giovane e ho quasi 42 anni. Quindi,
insomma, siamo già a una media carriera, diciamo. Che è sicuramente uno dei punti
dolenti, non di questa città, ma di questo paese, nel quale hai questa proposizione
costante di giovani artisti – ed è giusta, perché comunque è un modo di raccogliere le
idee, di dare la possibilità di fare le cose – ma poi ci sono anche altre questioni, che si
devono necessariamente misurare non con le relazioni nel nostro paese, ma con le
relazioni con le istituzioni, i mercati e le gallerie, insomma, il sistema internazionale. E
quindi è su quello che poi bisogna lavorare, cercando quando serve anche copiare come
fanno altri, insomma, cercare di capire quali possono essere i nostri punti forti e tenerli
in giusta rilevanza e copiare esattamente altrove dove, evidentemente, su certe
questioni operano in un senso che, sul piano della comunicazione internazionale,
funziona meglio. Primo. Quindi, gli artisti italiani, quelli che conosco, alcuni sono amici,
spesso fanno fatica a, come dire, esprimersi. Perché non si riconoscono un ruolo che
invece mi pare che all’estero... Be’, per esempio a Berlino c’è questa galleria che si
chiama 91mq, dove ci sono anche artisti italiani, e sono operativi, cioé lavorano creando
un network, cercando di lavorare anche su uno scambio internazionale per dialogare
con altre posizioni, questa è una cosa. Un’altra questione è la questione dove, sempre
Caterina, diceva: “è meglio essere a Torino, piuttosto che a Foggia”. E’ vero, Caterina,
ma è anche vero che è meglio nascere in una famiglia di estrazione alto-borghese,
piuttosto che alle Vallette. E questo è un altro punto, che non può essere trascurato,
perché allora se si parla di questioni legate all’uso pubblico del prodotto culturale, allora
bisogna ragionare su cosa significa questa cosa sul piano pubblico. Sul piano pubblico
bisogna tenere conto, primo: dei nuovi assetti della città, che devono per forza – questo
anche nella musica, che non ho seguito interamente – far convergere le nuove famiglie,
non solo per vendere loro nuovi appartamenti, ma magari immaginare dei modi con i
quali creare degli scambi. Questo non può non richiedere dei punti che convogliano,
anche solo dei semplici punti di ascolto, dove gli artisti di tutte le nazionalità che abitano
a Torino possano avere la possibilità di presentare progetti, i quali possono essere,
attraverso l’ente pubblico, aiutati ad arrivare a delle fonti private, per esempio. Questa
è un’altra cosa, bisogna rendersi conto che effettivamente il pubblico è quello che è,
non possiamo più contare su quello, bisogna usare delle nuove strategie. Quindi, per
concludere, volevo riconnettermi alla bellissima frase di Corrado Levi questa mattina,
che dice: “Lavorare, fare le cose... La struttura, se non ti uccide, ti alimenta”. Bellissima,
devo dire. Io, francamente, penso che per lavorare magari vorrei un livello di vita in più,
per fare questo lavoro e magari non farmi uccidere solo perché faccio l’artista in una
situazione come questa. Grazie.
Massimo Melotti: Io vorrei fare una riflessione su questo intervento, che è molto
importante, perché se c’è una parte debole nel sistema di Torino – e mi riallaccio al
discorso che avevo fatto prima – che è fortemente espositivo, è quella della produzione,
cioé la produzione della città è debole non perché non vi siano gli artisti, ma perché non
esistono, non dico le strutture, chiamiamoli “incentivi” tali che permettano a questi
artisti di esprimersi compiutamente. Il discorso però è molto difficile, perché si toccano
molte sensibilità. Fino a che punto può intervenire un ente pubblico senza tarpare la
creatività dell’artista? Voglio finire, poi ti lascio controbattere. Diciamo che questa è
effettivamente la debolezza di Torino. Se può essere di qualche conforto, si sa. ..cioè, ci
si sta lavorando. Nel senso che ci sono già dei progetti in atto, per supportare in qualche
modo questa esigenza. Farebbe ben sperare, nel senso che praticamente si uscirebbe
dal concetto della dimensione di Torino = fabbrica, dove viene fatto un prodotto
sbattuto fuori e poi chi si è visto si è visto, ma invece Torino-città laboratorio, dove si
devono aiutare coloro che fanno... non arte, ricerca, e quindi bisogna supportarli. E qui
ci colleghiamo un’altra volta con gli amici della musica, perché arte contemporanea vuol
dire ricerca, noi dobbiamo farci entrare nella testa che, se dobbiamo essere competitivi
a livello internazionale, dobbiamo battere sulla ricerca. Perché non potremo mai
sconfiggere i cinesi o gli indiani in altri settori. La nostra forza sono i brevetti, le idee e i
ricercatori. Questo è, perché quello che fa lei, ha una ricaduta che noi non possiamo
quantificare, ma ce l’ha sicuramente su una serie di altre attività produttive. Questa è la
realtà e dobbiamo prenderne coscienza. So che è difficile farla capire ‘sta cosa, perché
non è immediata. Un altro punto e poi chiudo. Questa strada è confortante, perché si
cominciano a vedere anche a Torino degli esempi di produzione culturale, che non sono
più quelli tradizionali individuali, ma sono quelli collettivi, collettivi in rete, realizzazioni
in rete, con delle ricadute sul territorio, con gruppi di persone, di individui che
abbandonano il ruolo autoriale, ma acquistano un ruolo di compartecipazione in una
sorta di cooperativa di gestione di creazione, instaurando, tra l’altro, delle economie che
non sono economie nostre, ma sono economie di scambio. Io faccio il grafico, tu fai
l’artista: io ti faccio il depliant, tu vendi la tua opera, poi mi dai una parte del ricavato.
C’è il curatore che interviene, l’altro fa l’allestitore, insomma, si crea un’economia
minima, ma si crea quest’economia. Il problema sarà poi vedere come da una fase
progettuale su rete, si ritorni a una fase di concretezza. Però, io penso che questo,
quello che dici tu, unito all’opportunità che danno le nuove tecnologie... quella può
essere la strada per fare un passo oltre la crisi.
Franco Noero: Non è molto paragonabile Berlino con Torino. Berlino è una città che ha
avuto anche grandissime difficoltà negli ultimi 15 anni, proprio per questo sviluppo che
le è stato imposto nello spostare nuovamente la capitale da Bonn, che era sicuramente
un’altro tipo di città, a quella che era stata la capitale della grande Germania
precedente. Quindi non credo che si possa paragonare. Ma invece quello che potrebbe
avere Torino, che potrebbe essere paragonata alla città di Berlino è a partire dal costo
basso della vita e degli affitti che, devo dire, è stata una delle cose fondamentali che mi
ha portato a lavorare e ad aprire in questa città. Io vivevo a Roma, stavo benissimo,
sono venuto qua a Torino perché a Torino potevo aprire la galleria con 150 mila lire al
mese, sennò non era possibile. Queste possibilità, secondo me, questa città le dà
ancora. Magari non bisogna pensare di aprire la galleria in super centro... Magari una
volta dalle parti di via Della Rocca si riuscivano ancora a trovare delle possibilità, adesso
sicuramente il mercato si è alzato. Però, sia per le gallerie, che per i giovani artisti,
sarebbe straordinario incentivare in qualche modo il loro arrivo in città. Io sarei, credo
che Alberto sarebbe assolutamente d’accordo, spero, con quello che vado a dire: io
sarei la persona più felice del mondo ad avere altre gallerie che lavorano sul territorio,
nuove gallerie giovani che nascono, che aprono, che cercano di portare avanti il
discorso, perché a un certo punto quello che faccio io verrà obiettivamente esaurito,
perché non avrò più la visione e la visione l’avrà qualcun altro. Quindi,
fondamentalmente, è una cosa secondo me questa di Torino che dovrebbe essere
sfruttata, non ho idea di come, forse il Comune... Mah, io dialogo malissimo con gli enti,
non so mai... non saprei da che parte iniziare, però sarebbe una cosa veramente
fondamentale. Così come l’opportunità – quello che ho detto prima, molto brevemente,
nel mio intervento – della produzione, degli artigiani, dell’industria che esiste in questa
città e nei dintorni, che possono essere un aiuto eccezionale per un artista, per la
produzione delle proprie opere. E anche il fatto che, se io... Ad esempio, io adesso
produrrò a Torino un lavoro di cui abbiamo fatto fare i preventivi per l’artista, che
voleva farlo a Londra, perché è di Londra, eccetera. Poi devo esporlo a Basilea, quindi
abbiamo detto con l’altra galleria americana, facciamolo a Basilea, così non c’è il
trasporto. Adesso ha tre preventivi di tre professionisti. Sicuramente io ho un uso
quotidiano con il mio professionista con cui lavorerò, però quello che io vado a pagare
per la produzione di quell’opera a Torino è esattamente un terzo di quello che si poteva
pagare a Londra e la metà di quello che avremmo pagato a Zurigo. Questa cosa qua dà
molte opportunità. Berlino è un posto freddo, un posto terrificante in un certo qual
senso, ci sono 3 mesi l’anno in cui è difficile vivere, mi diceva un mio amico gallerista,
con cui ero ieri, che l’anno scorso ci sono stati 47 giorni dove non hanno mai visto il sole.
Noi quà ci lamentiamo della città ombrosa, eccetera, però è sicuramente molto... Fa un
freddo cane eccetera. Però gli affitti costano poco e quindi sono arrivati moltissimi
artisti. Questa cosa qua non è capitata in città da noi.
Francesco Poli: Volevo solo chiudere anch’io. Come anche questo convegno, che devo
dire è straordinario, si deve ricreare un tessuto culturale di dibattito... Parlare di ‘sta
roba, non c’era più un luogo, un contesto... Questi nascono spontaneamente, nascono
per incontri, nascono per sollecitazione. L’aspetto culturale... Per quello che ho tirato
fuori un po’ Adamo ed Eva, prima. Questo _ uno. Secondo: questa riorganizzazione
intorno al fare, al produrre, che giustamente lui ha accennato e che ci sono anche dei
progetti, mi auguro che vengano anche realizzati, ecco.
⨪
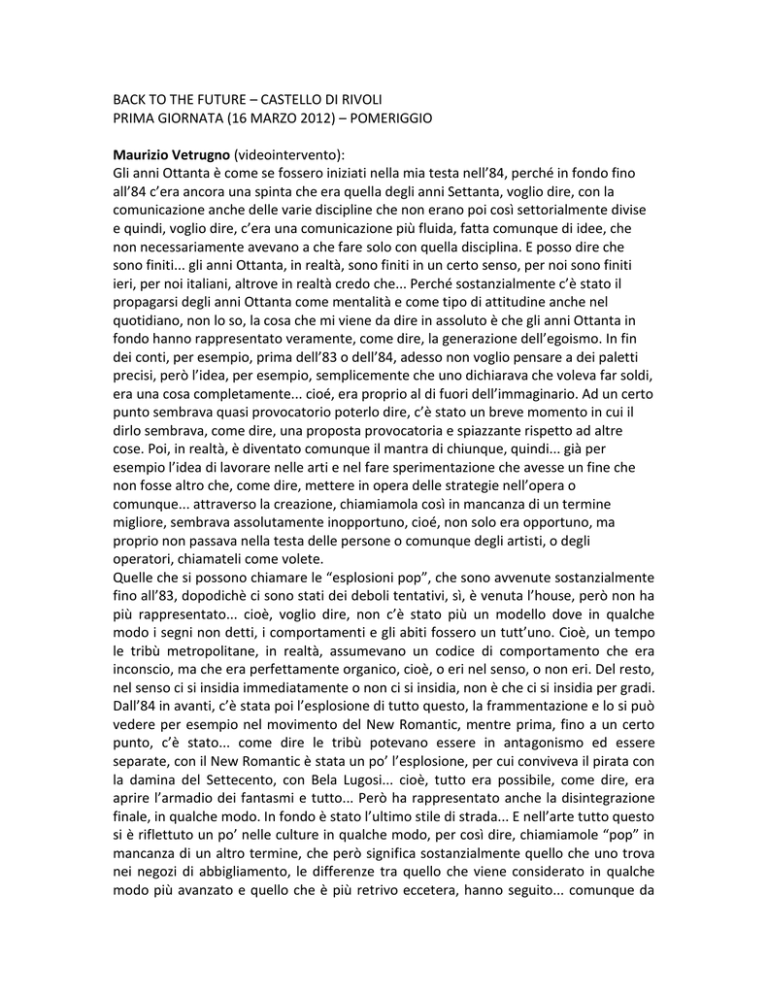



![È AR[t]CEVIA per l`ottavo anno. Inaugura sabato 1^ Agosto la più](http://s1.studylibit.com/store/data/002079329_1-f1f55cb8322a7e6ef250ace4952af4c5-300x300.png)