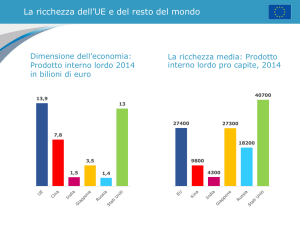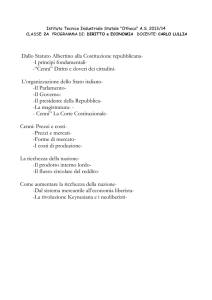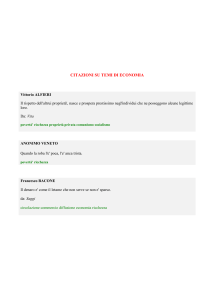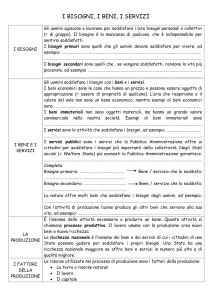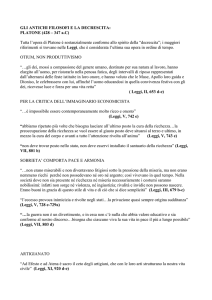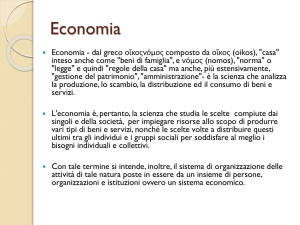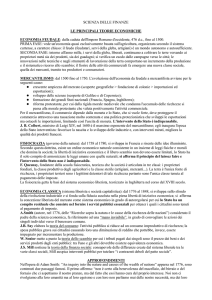Terzo settore e politiche attive del lavoro un esperienza italiana per il rilancio
dell’inclusione sociale in tempi di crisi - Lectio di Romano Benini
Si fa presto a dire lavoro. Lavoro: una parola usata ovunque e spesso comunque. Con
molti significati. Si dice lavoro e spesso poi si parla d’altro. Il termine in sé è piuttosto vago.
Persino sul reale significato del primo articolo della Costituzione, che descrive la nostra
come una Repubblica “ fondata sul lavoro”, si potrebbe discutere. La crisi del primo
decennio del nuovo secolo coincide con una crisi che è innanzitutto una crisi del lavoro,
soprattutto in Italia e negli altri paesi dell’Europa mediterranea. Per questo è utile chiarire
cosa diciamo davvero quando parliamo di lavoro. Per evitare o quantomeno provare a
limitare un dibattito sul lavoro che spesso è strumentale, il più delle volte sterile: in cui si
parla di lavoro, ma si intende in realtà parlare d’altro. Descrivere quello che in questi anni
è accaduto all’Italia ed in altre aree dell’Europa significa anche raccontare come non si sia
compiuto il passaggio di una fase in cui un tipo di lavoro tramontava e necessariamente
doveva sorgere una modalità di lavoro in buona parte nuova.
Un passaggio di fase, maturato nel tempo, che partiva dal lavoro e dalla sua
organizzazione, per diventare poi un cambiamento nell’economia, nella società e nella
cultura. La crisi finanziaria della dell’ormai lontano 2008 ha rappresentato per questo uno
spartiacque: ne sono usciti e ne stanno uscendo in Occidente quelle Nazioni che avevano
avviato e guidato questo passaggio di fase e che soprattutto avevano saputo già alla fine
del secolo scorso collegare le scelte della politica e dell’economia ad una diversa idea del
lavoro dell’uomo. Proprio per guidare e gestire il passaggio di fase limitando i danni ed
aumentando le opportunità.
Crisi è un termine che deriva dal greco e che significa proprio scelta, decisione. Si intende
quindi per momento di crisi quello della decisione che va presa per affrontare la necessità
del cambiamento. La crisi implica quindi una azione: se non scegli, sarai scelto, se non
agisci, subisci.
Chi non è uscito dalla crisi del 2008 o ne sta uscendo con le ossa rotta sono soprattutto
quelle Nazioni che non hanno compiuto il passaggio di fase che dalla modernità, per dirla
con i sociologi, ci ha portato alla postmodernità; che dal fordismo, per dirla con gli
economisti, ci ha portato al postfordismo.
Dopo la crisi qualcuno sta iniziando a disegnare i contorni di questo “essere post” in modo
chiaro, svelando come il futuro spesso ci riproponga in modo nuovo e diverso soluzioni,
punti di vista, modi di essere e di fare, che ci vengono dal passato. Poi ci sono quelle
Nazioni che non hanno fatto le scelte quando queste dovevano essere fatte e che oggi si
trovano nel limbo: nel mezzo indistinto tra un sistema che non c’è più ed uno che deve
ancora essere. Color che son sospesi. Tra baratro e futuro.
Tra queste nazioni l’Italia è forse la nazione occidentale più importante ed al tempo stesso
in difficoltà. Un Paese con le ali legate. Ali un tempo possenti, che hanno portato questo
paese nella sua storia davvero lontano, ma oggi quasi atrofizzate da pratiche sbagliate e
da pessime abitudini, che lo hanno reso, nel corpo e nella mente, quasi inadatto al volo.
Quasi che quelle ali appartengano a qualcun altro e siano lì per caso.
Il lavoro, nei termini che chiariamo ed analizziamo, è il paradigma, la chiave. Nei diversi
significati: opera, azione, risultato, posto, produttività, saper fare. Non c’è niente di meglio
del lavoro per interpretare e capire cosa funziona e cosa non funziona. In una economia,
nella società, quindi anche in noi. Per vedere dove stanno andando le Nazioni che stanno
riprendendo a volare sul mondo contemporaneo e postmoderno e per capire chi è stato a
legare le ali all’Italia, una Nazione che ha un grande passato, ma stenta a cogliere la
dimensione del futuro che l’aspetta. E resta per questo come un uccello in bilico tra il volo
e la gabbia, con poca fiducia sulla forza di ali, che in questi anni ha usato davvero poco
per potersi fidare fino in fondo.
Si fa presto a parlare di crescita. Da tempo siamo stati ammoniti a considerare il prodotto
interno lordo come una misurazione di aspetti che non spiegano le ragioni per cui vale la
pena vivere. In questi anni di passaggio, non a caso, alla misurazione forse un po’ sterile
della ricchezza economica si sono collegati nuovi criteri, tra i quali il BES, l’indice del
benessere equo e sostenibile, che tendono a misurare il “ benessere” . Lo sviluppo è
quella crescita che genera benessere.
La principale lettura della crisi italiana riguarda la
misurazione della ricchezza economica e considera in primo luogo l’andamento del
prodotto interno lordo, il PIL. E’ giusto partire da questo dato, ma sarà importante capire
come la ricchezza economica, quella misurata dal PIL, sia solo la conseguenza, l’effetto di
un sistema basato sul ruolo delle capacità e delle competenze che in Italia ha smesso di
funzionare molti anni fa e che ha generato conseguenze sulla creazione di ricchezza
economica che la crisi del 2009 ha fatto esplodere. Consideriamo allora il PIL pro capite,
che è costituito dal valore di tutti i prodotti e servizi finiti in un certo paese in un dato anno,
diviso per la popolazione media di questo paese nello stesso periodo.
Il confronto sul PIL pro capite, che misura la ricchezza individuale, tra l’Italia e gli altri
paesi del mondo è davvero impressionante: tra il 1999, anno chiave dell’introduzione
dell’Euro al 2014, l’Italia è l’unico tra i paesi dell’Euro, ad avere avuto una diminuzione
della ricchezza delle persone, che è calata del tre per cento. Nello stesso periodo la
media europea ha visto invece, nonostante la crisi, un aumento medio della ricchezza
individuale di circa il dieci per cento. La Germania dopo l’unificazione e dopo l’introduzione
dell’euro è il paese europeo in cui il PIL procapite è aumentato di più: rispetto al 1999 i
tedeschi sono più ricchi del venti per cento. Non possiamo che riflettere che forse, se ci
confrontiamo con l’Europa, il problema non stia tanto nella crisi, ma proprio nell’Italia. Il PIL
pro capite misura la ricchezza economica, non comprende però tutto quanto determina il
benessere e la qualità della vita. Misurare la crescita come benessere: ecco un altro dei
paradigmi utili per interpretare, conoscere cosa di buono ci può arrivare da questa “
postmodernità”. Il benessere considera non solo la ricchezza materiale, ma anche quella
ricchezza che deriva dalla speranza di vita, dalla condizione di salute, dalla relazioni, dalla
legalità, dall’inclusione e mobilità sociale. Il benessere di una società in cui una persona
sta bene se in quel tempo ed in quel luogo anche gli altri possono stare bene come lui. Si
tratta di quella ricchezza che deriva dalla conoscenza e dalla solidarietà. Il capitale
economico (guadagno) che è prodotto dal capitale culturale (competenza) e sociale
(relazioni). Alla base di questo benessere troviamo proprio il lavoro, nell’idea e nelle forme
che andiamo a conoscere e ad indagare.
Scopriremo che questa idea di benessere e questa idea di lavoro è stata portata in
Occidente nella modernità proprio dall’Italia, dal Rinascimento. Il rapporto tra saper fare,
giusto guadagno e cura per la propria comunità è una conquista dell’ umanesimo italiano.
L’Italia potrà uscire dalla post modernità di questi anni bui se riuscirà a recuperare molti di
quei valori che ai tempi del Rinascimento ha insegnato al resto del mondo e dell’Europa e
che oggi, in forme e con strumenti nuovi, permettono alle altre Nazioni di camminare oltre
la modernità con maggiore sicurezza e rispetto. Per questo nel nostro viaggio nella selva
oscura di questa ultima modernità, la selva del declino e della disoccupazione, avremo
spesso occasione di farci accompagnare proprio da Dante, esattamente come lui si fece
accompagnare da Virgilio nel suo viaggio dentro quella selva oscura della nostra esistenza
descritto nella Divina Commedia.
Siamo in altro modo anche noi nel bel mezzo del
cammino in una analoga selva oscura, che la diritta via ha smarrito da tempo. Da almeno
dieci anni, secondo gli esperti.
Per l’Italia questo decennio è stato il decennio perduto. Il tempo che si è perso ha coinciso
con l’assenza di sforzi per cogliere le gravi contraddizioni di questo momento di passaggio
e per definire le riforme e gli interventi in grado di permetterci di uscire da questo guado
che dobbiamo ancora attraversare. Il decennio perduto è stato ed è ancora per l’Italia un
periodo di pigrizia ed immobilità. Perso nell’illusione di poter rincorrere la produzione di
ricchezza attraverso altra ricchezza e di poter fare a meno di creare benessere attraverso
il lavoro. Per capire meglio di cosa si tratta dobbiamo provare ad individuare gli snodi che
richiedono scelte e decisioni che non sono state ancora fatte, per capire i motivi ed i poteri
che, in modo piuttosto evidente e purtroppo efficace, impediscono questi cambiamenti e
queste decisioni. Gli avversari del cambiamento sono spesso subdoli ed i peggiori non
sono nemmeno quelli dichiarati. La logica gattopardesca del momento che l’Italia sta
vivendo e di questa sua prolungata decadenza è proprio quella che prevale anche oggi ed
è la logica che emerge in tutte le decadenze: una classe dirigente, politica ed economica,
che dichiara e proclama il cambiamento, ma non lo mette in pratica; che non fa, perché
preferisce far credere. Una classe dirigente che ancora oggi, mentre proclama di essere
immune dalla malattia che dichiara di voler curare, vista più da vicino rispetto a quanto si
può vedere dalla distanza di un comizio od un talk show, appare invece del tutto
compromessa con le logiche che si dichiara di ostacolare, portatrice insana della stessa
malattia. Valutare come e perché l’Italia in questo decennio sia stata resa incapace nel
creare lavoro, nel produrre benessere, nel generare sviluppo, è il modo più efficace per
togliere la maschera ai responsabili. Gli effetti delle scelte sbagliate di questi anni sono
chiari e sono altrettanto evidenti anche i responsabili.
Si tratta di una responsabilità diffusa, più difficile da riconoscere e quindi da estirpare,
perché riguarda non tanto nomi e cognomi, ma pratiche ed abitudini, scelte e mancate
scelte, che sono molto più vicine a noi e diffuse di quanto si possa credere.
Il risultato di questa situazione è oggi una situazione che non si può affrontare usando il
solito metodo della composizione degli interessi rappresentati: anche perché gli interessi
veri, quelli che per esempio muovono il mercato del lavoro e creano opportunità, sono in
Italia sempre meno rappresentati o rappresentabili da una classe dirigente selezionata con
criteri ben diversi da quelli delle competenze e del merito.
Quando, dopo anni di colpevole inerzia, il Governo italiano, ha provato ad attivare una
misura europea straordinaria per il sostegno all’occupazione giovanile ed ha messo di
fronte allo stesso tavolo tutti i soggetti che rappresentano le istituzioni che operano sul
mercato del lavoro, il quadro che si è reso evidente era del tutto caotico e scoraggiante.
A quel tavolo, chiamato “ struttura di missione”, si è resa evidente la necessità di mettere
mano, di dover iniziare appunto una vera e propria missione. Una missione diventata
quasi impossibile per la quasi totale incapacità ed abitudine delle istituzioni, proprio quelle
intorno a quel tavolo, di lavorare insieme, di progettare, di comunicare. La missione era
l’obiettivo, ma non c’era nessuna struttura, se per struttura si intende la presenza di un
sistema. L’Italia della crisi non ha e non fa “sistema”.
Se non c’è sistema, non c’è
nemmeno l’organismo che viene generato e che a sua volta genera. Niente “ sistema del
lavoro”, ma solo pezzi sparsi, nei mille rivoli di una Italia del lavoro sempre più disunita
negli anni del decennio perduto. Con governo, regioni, province, sindacati, organizzazioni
di impresa, enti di formazione, Università, in ordine sparso e spesso confuso. Una
incapacità di collaborare e di progettare che è figlia di ceti autoreferenziali, tesi solo a
perpetuare la loro rendita di posizione. E’ un male diffuso, il male oscuro del decennio
perduto che proviamo a conoscere da vicino, per le conseguenze che determina sul lavoro
e sul nostro futuro.
I risultati di questo modo di fare sono evidenti, nella situazione del nostro paese, e
vengono anche misurati, dai rapporti dei centri di ricerca europei e mondiali, che vedono
l’Italia tra i paesi meno competitivi dell’Occidente, anche per via di un mercato del lavoro
che non funziona e di una capacità di governo sul territorio del tutto inadeguata.
Le scelte sul lavoro di questi anni sono state non a caso deboli, poco convinte, con scarsi
investimenti e per alcuni aspetti importanti, come i servizi da dare ai disoccupati,
addirittura in controtendenza rispetto a quanto fatto in Europa. Ci siamo persino permessi
il lusso di smettere di investire proprio dove l’Europa aumentava gli investimenti e ci
chiedeva di fare altrettanto.
Era quindi chiaro a questa “ struttura di missione” del governo italiano: il problema è quello
di rimettere insieme i pezzi per far funzionare il mercato del lavoro e per poter sostenere la
creazione di lavoro in un Paese che sembra aver perso la ricetta. Rimettere insieme i
pezzi è davvero il primo obiettivo, ma per farlo servono due condizioni : sapere bene qual
è il disegno, il progetto che dovrebbe rimettere in ordine ed insieme i pezzi e capire che
questo disegno deve essere oggi molto diverso rispetto a quel disegno di insieme che per
decenni ha saputo collegare interessi e ceti diversi, in quel patto tra i produttori che ha
tenuto e fatto crescere l’Italia industriale del boom economico, cementata dal sistema
fordista e dai contratti nazionali di lavoro benedetti dagli accordi tra Confindustria e
Sindacati. Sono stati, quelli del modello industriale, gli anni della crescita economica, ma
anche quelli della crescita del debito pubblico e del mancato sviluppo. Gli anni in cui era
possibile che le aziende assumessero in cambio di incentivi e sgravi fiscali, più che per un
reale bisogno di competenze ed in cui, terminati gli incentivi, le aziende potevano mandare
in cassa integrazione a vita od in pensionamento anticipato i lavoratori in più, magari
cinquantenni, che in molti casi avrebbero poi continuato a lavorare in nero. Gli anni della
crescita del nostro sistema industriale non hanno spesso seguito la strada della qualità ed
hanno permesso l’adozione di comportamenti e di relazioni che hanno contribuito a
dissanguare i conti pubblici. In ogni caso quelle pratiche oggi sarebbero del tutto inutili ed
insostenibili.
La riflessione in questi anni non può essere su come rimettere insieme oggi il sistema che
ha governato e promosso il lavoro nell’Italia del modello industriale: perché questo sistema
in realtà non c’è più da tempo ed è giusto che non ci sia. Sopravvivono resti di pratiche del
secolo scorso, che affiorano come rovine di antiche vestigia in mezzo al deserto di
relazioni industriali, contratti, servizi e strumenti di welfare per il lavoro, reperti storici del
tutto inadatti ad una società chiamata a sfidare il nuovo millennio.
Questi sono i fenomeni ed i dati degli anni che viviamo, chiari ed evidenti: un tasso di
occupazione ai minimi, in un paese che da sempre ha meno occupati rispetto alla media
europea; una sostanziale inefficacia del mercato del lavoro, nella convinzione che ancora
oggi valga la regola del vecchio modello industriale per cui l’economia ed il lavoro si
autoregolano, si definiscono e si generano reciprocamente. La regola bizzarra che
funzionava quando bastava dare soldi e sgravi alle imprese perché assumessero e che ha
portato tante imprese italiane fuori mercato o a trasferirsi all’estero, dove continuano ad
avere soldi e sgravi in cambio di lavoro. Un principio che considera il lavoro solo come un
problema di diritti sul posto, da lasciare al sindacato ed agli avvocati, e prevede che il
lavoro non abbia a che vedere con il mercato, le competenze, la capacità, la presenza di
un ambiente adatto ad agire, ma sia legato solo ai benefici che si concedono all’impresa
attraverso l’uso del denaro pubblico e l’accesso agli appalti.
Un’idea di lavoro che ci ricorda il medioevo e l” animal laborans” di Aristotele, ma i cui
retaggi sono duri a morire, come le sicurezze fallaci che porta con sé. Siamo forse l’ultimo
paese al mondo in cui qualcuno sembra avere nostalgia della catena di montaggio. Non
perché la catena ( di montaggio o di altro tipo) sia una cosa buona, ma per il disagio e la
paura che assale l’italiano di fronte alla estrema e fragile precarietà di quel terziario senza
qualità che è la cifra dell’occupazione che si viene creando in questi anni di difficoltà e di
declino.
Ed è proprio questo il paradigma di fondo, lo snodo che andiamo ad affrontare: lavoro e
benessere sono i due aspetti che misurano le conseguenze, come strumento e come fine,
come metodo e come risultato, della nostra capacità. Il declino dell’Italia del decennio
perduto è soprattutto un declino della nostra capacità. Essere capaci significa avere gli
strumenti per pensare, progettare e determinare il proprio futuro. Non si nasce capaci,
capaci si diventa. In un sistema ingiusto ed immobile la capacità certo dipende anche dalla
famiglia di provenienza. Se nasci con i genitori benestanti è più difficile essere sprovvisti di
opportunità. Il rapporto tra capacità e mobilità sociale è oggi il metro con cui valutare il
livello di giustizia e misurare la qualità della democrazia presente in un Paese. Un criterio
in grado di collegare lavoro, benessere, giustizia e democrazia, di grande significato:
proviamo quindi a misurare l’Italia ed i suoi territori su questa combinazione di valori, per
vedere come la crisi del lavoro sia anche figlia della crisi della democrazia reale e per
capire che ricomporre il rapporto tra lavoro e benessere significa ricreare le condizioni
oggettive per una democrazia migliore. Si diventa capaci perché esiste, si alimenta e si fa
funzionare sul territorio dove vivi e lavori un sistema costruito per creare capacità. Questo
sistema è per gli individui simile a quello che per i territori misura la competitività: parliamo
di capacità individuale, come capacità d’agire, e capacità dei territori, come capacità
competitiva. Si tratta di avere stabilità economica, infrastrutture, potenzialità di mercato, un
fisco giusto. Si tratta, nell’economia del nuovo millennio, di avere una sanità che funziona,
una scuola ed un sistema di alta formazione adeguati, servizi per il lavoro efficaci, una
capacità di innovare e di utilizzare le tecnologie per vivere e lavorare meglio. Si tratta
sempre e comunque di avere governanti all’altezza nel prendere le decisioni giuste nel
tempo giusto. Questi sono i parametri, del tutto oggettivi, che andiamo a valutare e
sviscerare per cogliere le ragioni profonde del malessere italiano e del declino del popolo
che ha portato la modernità in Europa.
La capacità di una persona e di un territorio hanno a che vedere con l’ identità individuale
e collettiva. Perdere l’identità ci porta alla depressione, che non a caso è la malattia del
nostro decennio perduto; dalla crisi individuale si passa presto a quella collettiva, che
genera quel senso di sfiducia che è il principale detonatore delle crisi dei consumi e della
produzione. Il lavoro è l’aspetto fondamentale, lo strumento necessario per promuovere
benessere e mettere in equilibrio la società ed i suoi costi. Se i giovani non lavorano chi
paga le pensioni degli anziani ? Se la disoccupazione è alta, chi paga i servizi pubblici ?
Se la ricchezza non proviene dal merito e dalla capacità, ma dalle rendite, quale società
creiamo e quali valori promuoviamo ? Gli effetti di un basso livello di occupazione incidono
gravemente sull’equilibrio dell’organismo sociale.
La diffusione del lavoro è necessaria per il funzionamento dell’economia, perché collega la
ricchezza alla capacità, e per il funzionamento della società, perché collega la ricchezza
alla legalità. Soprattutto il lavoro è necessario per il buon funzionamento dell’individuo, che
promuove attraverso il lavoro la sua scelta di vita. Il lavoro, in questa fase storica di
transizione, in cui il disagio è diffuso, torna anche ad essere una sorta di terapia, di cura
per il senso dell’ esistenza.
La chiamiamo terapia dell’azione. Il lavoro che si cerca di ricreare nel nuovo secolo torna
ad avere il significato profondo ed originale di fattore di identità e di senso, non soltanto
come fattore di sicurezza economica o di “posto da occupare”. Il lavoro che da un senso
all’esistenza non è ogni tipo di lavoro e soprattutto è molto lontano sia dal lavoro
gerarchico e per mansioni del passato industriale e manifatturiero che dal lavoro precario
e ripetitivo del presente del terziario senza qualità e consumistico. Quale sia e come stia
crescendo il lavoro del terzo millennio lo possiamo vedere e capire soprattutto in altri paesi
occidentali, ma anche in alcuni dei nostri distretti di impresa del Made in Italy che innova
ed esporta. In ogni caso, la grave situazione della competitività italiana è strettamente
collegata al problema della capacità degli italiani. E’ il lavoro, inteso come capacità ed
autonomia, l’anello debole della capacità competitiva dei nostri territori. Non parliamo
quindi di crisi finanziaria e di spread, non sono i mercati e le borse: queste sono misure,
dati e luoghi che funzionano solo come misuratori parziali dello stato di salute reale. Non
sempre quello finanziario è un misuratore preciso, perché valuta la ricchezza economica e
non la più interessante ed ampia capacità di produrre benessere. Anche gli indicatori
finanziari sono aspetti che ci possono fare capire il nostro stato di salute, ma l’errore che in
questi anni si è compiuto è stato quello di valutare questi fattori di analisi finanziaria come
se fossero il metro con cui valutare lo stato di salute dell’intero sistema. Non è così, non
poteva essere così in un paese come l’Italia, in cui la crisi finanziaria ha solamente
accentuato una crisi più profonda, rendendo evidente un processo di decadenza che
riguarda l’economia, la società ed anche la cultura diffusa. Non è un caso che il momento
di maggior calo dello spread finanziario di questi ultimi anni sia coinciso con il periodo con
il maggior numero di disoccupati. Non è la salute finanziaria che crea lavoro. L’enfasi del
dato finanziario in un paese come l’Italia in cui la ricchezza privata è notevolmente
superiore a quella pubblica ha messo in disparte una riflessione , certo più significativa e
doverosa, su come si presenti la ricchezza italiana in questi anni di crisi profonda.
E’ possibile continuare ad avere una alta ricchezza privata con una forte diseguaglianza
sociale? Come è possibile continuare a generare ricchezza privata senza produrre lavoro?
In che modo si condizionano e si tengono insieme una alta ricchezza privata ed un forte
debito pubblico ? Come si è formata, alimentata e distribuita la ricchezza privata italiana
in questi anni ? Sono queste domande semplici, a cui si è prestata poca attenzione, ma a
cui dobbiamo cercare di dare una risposta per cogliere alcune delle ragioni di fondo di
questa crisi, della incapacità degli italiani e della difficoltà nel creare opportunità. Il fatto,
per esempio, che più della metà dei miliardari italiani vivano in una città, Roma, che ha il
record di disoccupazione tra le capitali europee e che importa per un valore pari al doppio
di quanto esporta, ci permette di capire molto di quelle logiche che in Italia hanno in questi
anni separato la ricchezza dal lavoro, il denaro dalla produttività, alimentando rendite ed
ostacolando il valore aggiunto. Non sono logiche perverse, ma molto chiare, mentre forse
è perverso il Paese che fa finta di nulla e non le contrasta.
Percorrere questa strada ci permette di capire cosa ci impedisce di “ fare sistema”, e quali
siano i motivi che hanno indebolito in Italia gli anticorpi che contrastano le crisi:
la
capacità, il territorio ed il lavoro. Siamo l’ultimo paese europeo con un ambiente adatto a
fare impresa, il diciottesimo per competitività, il penultimo per il funzionamento del mercato
del lavoro. Tutto si spiega e come tale va spiegato: è proprio un organismo che non
funziona ed è utile vedere come dalle “ analisi del sangue “ della nostra capacità escano
insieme dei valori sani insieme a valori del tutto fuori posto e fuori controllo. La
disomogeneità italiana è duplice ed estrema : nei territori e negli indicatori, manteniamo
luoghi ed aspetti che funzionano, ma sono circondati da tumori che incalzano. Un
potenziale davvero esplosivo, una bomba ad orologeria che va disinnescata.
E’ chiaro che questo non è più solo un tema economico: la capacità e la creazione di
opportunità fanno parte dell’identità che definisce un popolo ed il funzionamento di una
società. Serve una analisi coraggiosa, che offra insieme a valutazioni spietate ed
imparziali anche una visione chiara su come uscire dal baratro. Non sembra comunque il
caso in questo di continuare a dare credito e fiducia al parere di quei politici, spesso con
cattedra universitaria, che sono stati tra i maggiori responsabili delle scelte che ci hanno
portato così vicino al baratro. Sono state scelte di fondo, che riguardano gli elementi del
funzionamento della società e dell’economia, e non mere teorie fiscali od ideologie
giuridiche di diritto del lavoro. Serve una operazione verità sul perché siamo diventati
incapaci di creare lavoro e di costruire futuro.
Dobbiamo per questo togliere gli alibi sul perché l’Italia non potrebbe crescere, come se si
stesse riproponendo quel complotto internazionale delle plutocrazie giudaico massoniche
di cui Mussolini parlava per provare a nascondere agli italiani la sua disastrosa incapacità
di governo. E’ una storia già vista. Se c’è un complotto è quello di una parte degli italiani
contro la maggioranza di chi lavora. Per crescere e creare benessere diventa invece
necessario il cambio di paradigma, assumere un atteggiamento culturale che sembra oggi
ancora lontano e difficile da promuovere. Perché ci siano politiche e riforme che funzionino
serve un diverso punto di vista e magari dare spazio al punto di vista di chi le politiche e le
riforme rischia solo di subirle, proprio perché in questi anni è stato tenuto lontano dai
luoghi del potere e delle decisioni.
dell’occupazione,
della
produttività
e
La diminuzione della ricchezza, il calo
della
crescita
italiana
di
questo
periodo
corrispondono ad una fase in cui tutti i decisori e tutte le decisioni sembrano aver operato,
con metodo quasi scientifico e con risultati conseguenti, per rendere gli italiani sempre
meno capaci, autonomi e liberi. Se confrontiamo i dati ed i risultati e ci mettiamo al
confronto con buona parte delle democrazie più avanzate, si può dire che quello italiano è
un popolo che è stato “ disattivato”.
Quando i paesi europei decisero, proprio all’inizio del nuovo secolo, nell’ormai lontano
1999, di definire una strategia comune per la promozione delle capacità, la “ strategia di
Lisbona”, che prende il nome dal vertice europeo che ne diede il via, l’Italia era un paese
ancora in buona salute ed in grado, quantomeno sulla carta e leggendo i numeri, di
incamminarsi su questo percorso . Con questa strategia l’Unione Europea decise di
promuovere i quattro pilastri della capacità attraverso una cospicua dotazione di risorse:
l’occupabilità, per rendere le persone in grado di lavorare, l’imprenditorialità, per rendere le
persone in grado di mettersi in proprio, l’adattabilità, per rendere le persone in grado di
affrontare i cambiamenti e le pari opportunità, per rimuovere ogni discriminazione nelle
condizioni di partenza ed ostacolo alla vita attiva delle persone. L’Italia degli anni
successivi all’inizio del nuovo secolo ha invece mancato completamente questa
prospettiva; si è trattato di una discriminante perché quando nel 2008 i sette anni di
strategia europea e di risorse destinate alla capacità ed alla autonomia attraverso il lavoro
sono terminati ed è iniziata una grave crisi, sono usciti più forti i paesi , come la Germania
e l’Olanda, che hanno saputo far tesoro della strategia di Lisbona, in molti casi cambiando
le proprie politiche. I paesi come l’Italia che non hanno saputo coordinare le proprie
strategia e prospettive con il metodo della promozione sociale delle capacità e della
persona, sostenuto con gli accordi di Lisbona, si sono trovati in grave difficoltà, privi degli
anticorpi per affrontare la crisi e promuovere il cambiamento. Sono i paesi che, ignorando
il significato letterale del termine crisi, che significa scelta, hanno deciso di non decidere.
E’ il caso in questa fase di provare a vedere e poi a capire come e perché l’Italia negli anni
ormai passati non sia riuscita ad allinearsi con indicazioni e principi che chiedevano
semplicemente di creare opportunità dando valore alle competenze, alla capacità ed al
mercato come strumento di promozione della società e di regolazione dell’economia. Per
questo diventa oggi centrale tornare ad essere e diventare “capaci”, ritrovare quel nostro
saper fare in una idea di lavoro molto diversa da quella attuale e per molti versi molto
antica e molto italiana. Dicono che noi italiani siamo seduti sulle spalle dei giganti e che
per questo possiamo vedere più lontano. I giganti su cui siamo seduti ci permettono forse
di vedere lontano, ma non ci regalano la vista che dobbiamo avere e saper usare. Per
capire come tornare ad essere capaci è necessario capire perché non lo siamo più: per
quali motivi l’Italia ha fatto e continua a fare spesso cose diverse da ciò che dovrebbe fare;
quali sono gli interessi, le logiche, i poteri che determinano le mancate scelte o le scelte
sbagliate. Non c’è anche qui nessun complotto internazionale : il colpevole lo conosciamo
bene, vive tra noi.
Si tratta in fondo di tornare a guardare la mappa e di riprendere il cammino. Dal nostro
passato, dalla storia, dalle esperienze, anche recenti, ci arrivano indicazioni preziose: su
quale sia e come si è espressa e si può tornare ad esprimere l’identità italiana attraverso il
lavoro.
Dall’Europa, da ciò che funziona e che ha in questi anni saputo contrastare la crisi,
soprattutto quella del lavoro, ci arrivano indicazioni precise e priorità di intervento. Da noi e
dalla nostra voglia di essere artigiani del nostro futuro e non cortigiani disponibili a
qualsiasi compromesso, ci dovrà arrivare la voglia e la forza per riprendere questo
cammino ed arrivare dove altri Paesi sono arrivati e forse ci stanno aspettando. Perplessi
su come proprio noi, il Paese che ha portato la modernità in Europa, il Paese della
bellezza e del Made in Italy, sia oggi diventato incapace di agire e di reagire. Per questi
motivi, con questo libro, proviamo ad affrontare il lavoro, nei suoi diversi significati e nelle
sue dimensioni, come chiave di interpretazione di questa difficile fase di passaggio. Le
dimensioni del lavoro sono diverse: riguardano la nostra identità, la società, l’economia,
ma al tempo stesso si tratta solo di diversi punti di osservazione con cui guardiamo in
realtà noi stessi attraverso ciò che facciamo e come lo facciamo.
Ritegno che questo sia il modo migliore, il più efficace per interpretare e capire cosa sta
succedendo e ci è successo in questi anni di declino: per parlare di noi, del nostro posto,
di quale società vogliamo, di che futuro vorremmo e di quale stiamo davvero costruendo.
Per capire meglio la differenza tra il fare ed il far credere. E per valutare bene le
conseguenze prodotte da questa pericolosa differenza, che ci tiene sull’orlo del baratro. Si
tratta di riattivare un popolo immobile e disattivato, impaurito e sfiduciato: bisogna per
questo capire bene cosa è successo per tornare a star bene con il nostro lavoro, per poter
stare meglio con noi stessi.