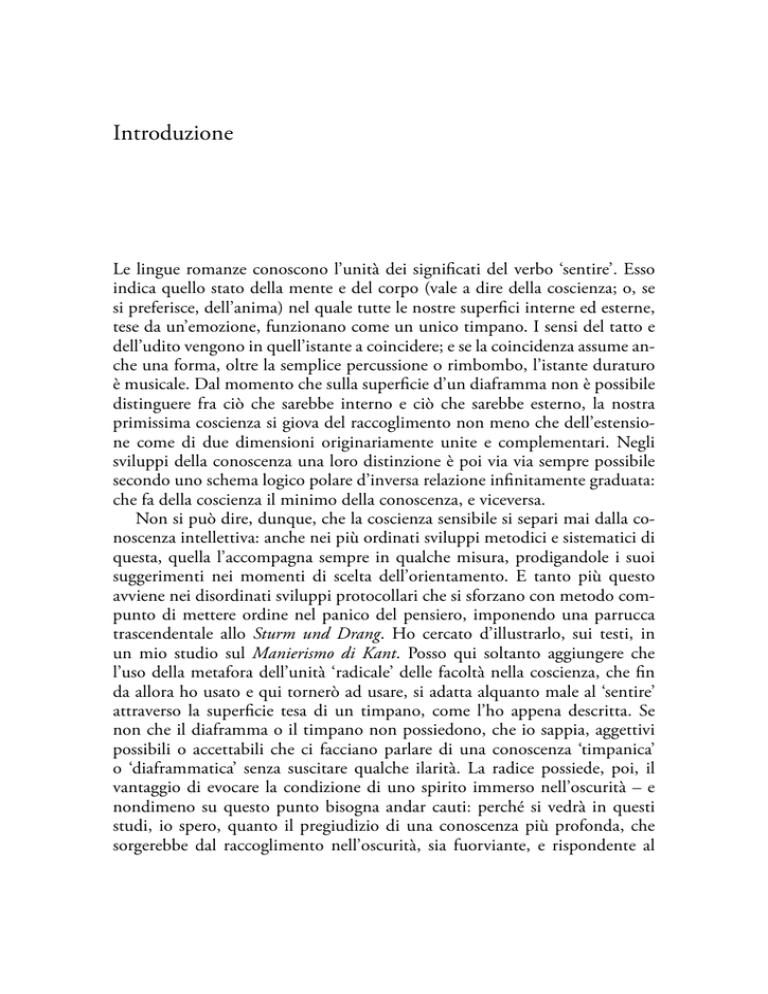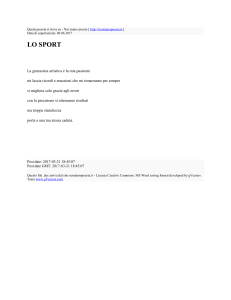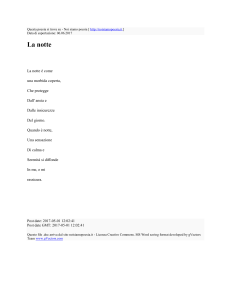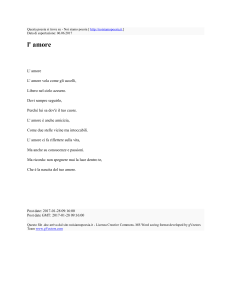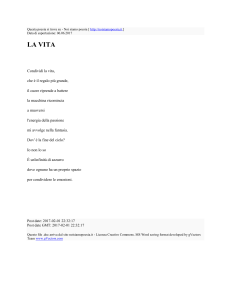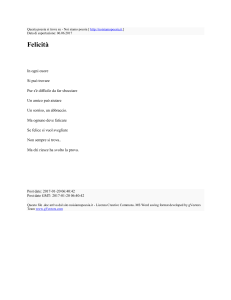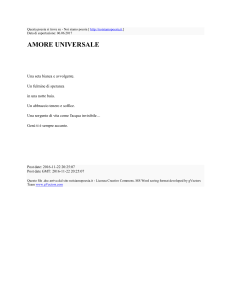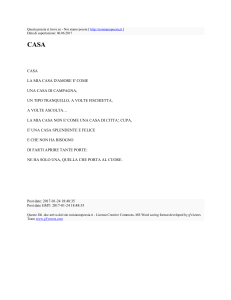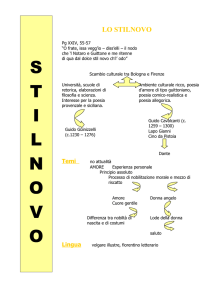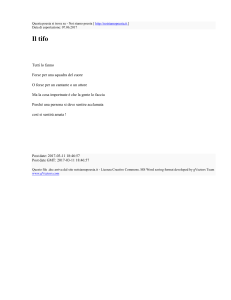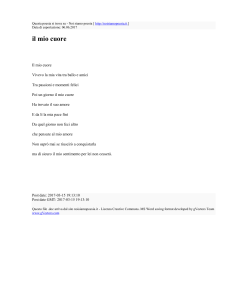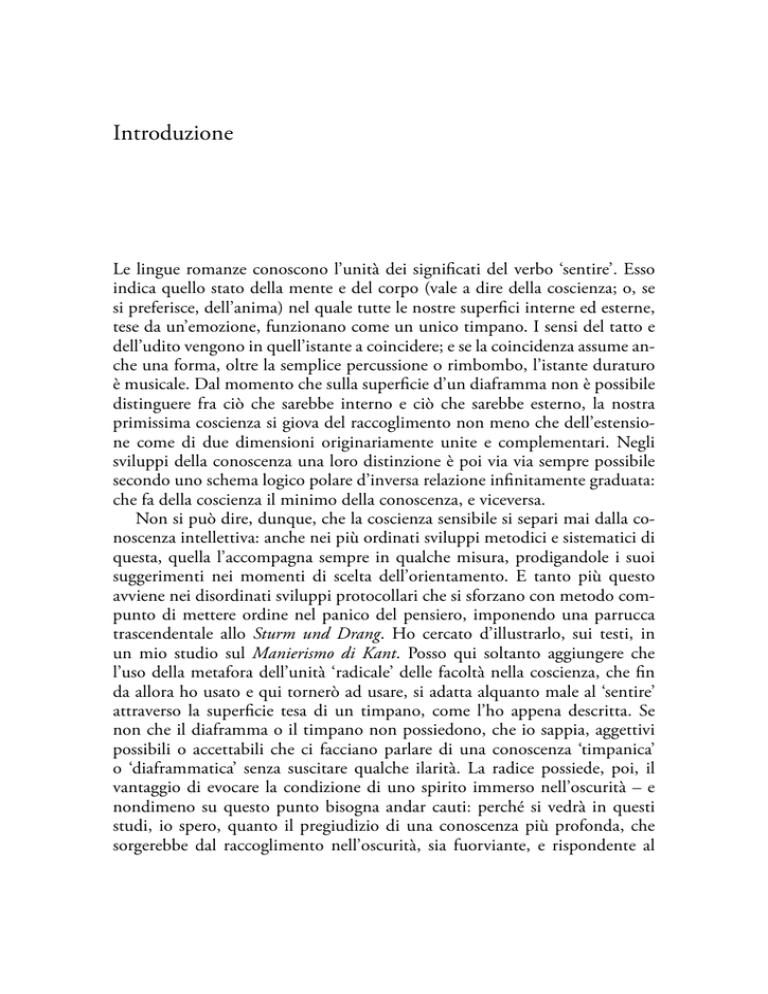
Introduzione
Le lingue romanze conoscono l’unità dei significati del verbo ‘sentire’. Esso
indica quello stato della mente e del corpo (vale a dire della coscienza; o, se
si preferisce, dell’anima) nel quale tutte le nostre superfici interne ed esterne,
tese da un’emozione, funzionano come un unico timpano. I sensi del tatto e
dell’udito vengono in quell’istante a coincidere; e se la coincidenza assume anche una forma, oltre la semplice percussione o rimbombo, l’istante duraturo
è musicale. Dal momento che sulla superficie d’un diaframma non è possibile
distinguere fra ciò che sarebbe interno e ciò che sarebbe esterno, la nostra
primissima coscienza si giova del raccoglimento non meno che dell’estensione come di due dimensioni originariamente unite e complementari. Negli
sviluppi della conoscenza una loro distinzione è poi via via sempre possibile
secondo uno schema logico polare d’inversa relazione infinitamente graduata:
che fa della coscienza il minimo della conoscenza, e viceversa.
Non si può dire, dunque, che la coscienza sensibile si separi mai dalla conoscenza intellettiva: anche nei più ordinati sviluppi metodici e sistematici di
questa, quella l’accompagna sempre in qualche misura, prodigandole i suoi
suggerimenti nei momenti di scelta dell’orientamento. E tanto più questo
avviene nei disordinati sviluppi protocollari che si sforzano con metodo compunto di mettere ordine nel panico del pensiero, imponendo una parrucca
trascendentale allo Sturm und Drang. Ho cercato d’illustrarlo, sui testi, in
un mio studio sul Manierismo di Kant. Posso qui soltanto aggiungere che
l’uso della metafora dell’unità ‘radicale’ delle facoltà nella coscienza, che fin
da allora ho usato e qui tornerò ad usare, si adatta alquanto male al ‘sentire’
attraverso la superficie tesa di un timpano, come l’ho appena descritta. Se
non che il diaframma o il timpano non possiedono, che io sappia, aggettivi
possibili o accettabili che ci facciano parlare di una conoscenza ‘timpanica’
o ‘diaframmatica’ senza suscitare qualche ilarità. La radice possiede, poi, il
vantaggio di evocare la condizione di uno spirito immerso nell’oscurità – e
nondimeno su questo punto bisogna andar cauti: perché si vedrà in questi
studi, io spero, quanto il pregiudizio di una conoscenza più profonda, che
sorgerebbe dal raccoglimento nell’oscurità, sia fuorviante, e rispondente al
12 introduzione
manierismo di una mentalità ‘riformata’. Si vedrà, spero, come le nostre più
certe conoscenze siano rese possibili, in definitiva, dai lampi di ben chiare e
ben superficiali estensioni.
Sebbene in questo libro si parli con insistenza della necessità del raccoglimento quale accumulo di potenza creativa per la poiesia, o poesia genericamente intesa, non di meno si parla dunque di estensione: allo scopo di significare un’attività che non si ritragga nel chiuso dell’infanzia sicura del pensiero,
bensì verso la soglia della sua adolescenza girovaga e pratica: allorché (come si
vede in un quadro di Manet, più noto che eloquente, come illustrerò) tutte le
strade si aprono, e tutto diventa possibile non meno che incerto – non senza
residui di pentimento. Sotto questo riguardo si può senz’altro dire, dunque,
che la prima estensione non rappresenta affatto l’inizio del decadimento della
potenza nell’atto, bensì precisamente il suo culmine ermetico.
Il rapporto fra due sostanze è un’essenza, che le costituisce nell’unità di un
essere complesso. Chiusa com’è nella pura necessità del pensiero, simile costituzione non può veramente meritare il nome di forma (π, numero trascendente, è un’essenza, ma non è una forma) se non allorché l’essenza conosce una
sua primissima estensione materiale in un inizio poetico del tutto generico
– vale a dire: poietico. Si può dunque affermare che il vero senso della pratica
stia tutto racchiuso in quest’inizio; e ogni cosiddetta applicazione (come abitualmente si usa descrivere la pratica) non è, in ogni singolo istante, che un
riferimento materiale alla memoria del significato del rapporto nella forma
della sua primissima estensione. In quell’istante, come un vettore tangente
in derivata sulla curva, la prima legge della dinamica riprende il sopravvento
sulla seconda, e la logica riprende il dominio sulla storia.
Spero che tutto ciò serva a sancire quanto verrò saltuariamente ripetendo,
allo scopo di vincolare un discorso politecnico, e tematicamente alquanto perimetrale, ad alcuni punti d’ancoraggio ben chiari: essere inammissibile per la
poiesia qualunque distinzione tra facoltà sensibili e intellettive; essere il riconoscimento del dualismo delle facoltà un indispensabile momento di sviluppo
successivo, adatto all’esercizio costruttivo delle discipline, ovvero all’esercizio
autocritico del giudizio nel soggetto; essere la ricerca dell’unità in direzione
anabatica, anziché catabatica, inizio di sviluppi superfetativi senza vero progresso.
Sondiamo ora per ordine, da diversi lati, il segreto dell’origine come primo
sentire.
introduzione 13
dal lato della poesia
La poesia consiste in un sorprendente bisogno musicale di conoscenza. È uno
stato d’indigenza saziato da un animale sentore di verità che può sorprendere
chiunque possieda un’intelligenza ellittica e una sensibilità ritmica. Non è,
dapprima, spiraglio di malchiuse porte: chi sa intravvedere così nitidamente è già poeta, e lo sa. È invece dell’inizio, che parlo, e della sua sorpresa.
Dal primo barlume di verità invariabile che emana dalle cose comuni che
ci circondano la nostra vista immobile, intenta a percepire, non viene meno
sopraffatta che dall’abbaglio. Si capisce che l’inizio poetico consiste in uno
stato assai particolare d’equilibrio dei sensi, che si realizza parzialmente nostro
malgrado. Coltivarlo con metodo, in seguito, può essere utile per mantenere
la continuità: chi lo fa, insomma, vuol essere poeta.
Descrivere un simile stato d’equilibrio, com’è pure facile capire, non è cosa
semplice. Dante, come spiegherò nella mia interpretazione dei versi 127-132
dell’ultimo canto della Commedia, ci offre la sua descrizione della conclusione
del cammino di perfezionamento, che ridiscuterò nel contenuto e nella forma
estremamente succinta:
Quella circulazion che sì concetta
pareva in te come lume riflesso,
dagli occhi miei alquanto circunspetta,
dentro di sé, del suo colore stesso,
parvemi pinta della nostra effige:
perché ’l mio viso in lei tutto era messo.
Ma egli non dà (che io sappia, almeno) alcuna indicazione antropologica
sull’inizio poetico – se non con la preziosa ammissione che esso fu per lui
oscuro. Quella di Dante, come ancora dirò meglio, è una precisa scelta di reticenza. È altrove che dobbiamo rivolgerci, dunque; e nessuno mi sembra averlo
fatto meglio di quel Dante nostro contemporaneo che è Baudelaire, con la
poetica sancita in Bénédiction secondo la versione di Antonio Prete:
Ma i gioielli perduti di Palmira gloriosa,
le pietre ancora ignote e le perle del mare,
anche se le incastona la tua [mio Dio] mano operosa,
al fulgido diadema [della poesia] non possono bastare;
poiché sarà composto di vivido fulgore,
attinto al primo raggio di quell’incendio santo,
di cui gli occhi mortali, pur nel loro splendore,
sono solo un riflesso, un opaco rimpianto!
14 introduzione
Baudelaire ha scoperto a suo modo il segreto della Commedia: essere Poesia la divinità nella quale infine specchiarsi – se non che il rapporto di contemplazione risulta essere qui invertito, e inaccessibile al senso della vista. La
creazione ineguagliabile della poesia attinge la sua luce abbagliante da una
alquanto misteriosa sorgente primigenia, alla quale gli occhi non possono fare
che da dolenti specchi opachi. Di che mai può trattarsi, se non di tutto ciò
che il poeta ha già patito, fin dai primi passi, nello spirito e nella carne? Tutti i
torti, gli affronti e le ingiurie da Dante commessi e confessi (ma non elencati
che per altrui) il poeta di Baudelaire li ha invece patiti: la maledizione della
madre e l’ostilità dei vicini, il pane impastato di cenere e di sputi, gli affronti
d’una moglie che, sazia, ancora gli strappa il cuore. Il buio di questa sua selva
è dunque verità travolgente d’abbaglio di tutti quanti i sensi – e fra essi la vista
è di certo il più misero. Ecco dunque l’inizio, pressoché cieco, da un sommovimento ben chiaro, sebbene indistinto, delle unite radici dell’essere. Ad una
simile sensibilità da scorticato accenna Shakespeare nel Racconto d’inverno,
quando ad un Leonte accecato dalla gelosia fa dire di sentire la verità con tutti
i suoi sensi, a cominciare dal tatto e dall’olfatto.
Una volta scritta e stampata, poi, la poesia appaga il desiderio di rendere
memorabile tanto il bisogno che la sazietà della conoscenza da poco acquisita.
La creatività poetica sta già tutta raccolta nel sorprendente bisogno musicale
di conoscenza che ci scuote; e tuttavia, senza il proposito di renderli memorabili in una creazione, bisogno e sazietà si dissolverebbero. Non potremmo
dunque dire che la poesia stia tutta raccolta nella potenza, senza l’atto – anche
se possiamo dire (e abitualmente si dice) che un uomo ‘è un poeta’ per la sua
sensibilità e per come vive, sebbene non scriva poesie. Una volta destatosi,
il raccoglimento nella potenza della memoria, dove sensibilità e intelletto si
confondono, chiede nuova memoria – e la poesia diventa allora del tutto necessaria mediante la primissima estensione d’una comunicazione.
La poesia è bisogno di conoscenza perché chi scrive ha a malapena conosciuto, e più vuole conoscere; oppure ha conosciuto, e vuol dare a conoscere.
È musicale sul nascere, nel senso della simpatia consonante fra corde vibranti contigue; ed è musicale nell’attuarsi, perché una chiarezza indistinta nella
mente assume sulla carta una scandita forma sillabica (ritmica) e un’agognante pretesa semantica (ellittica). È sorprendente, perché nessun vero poeta ‘si
accinge’ a fare della poesia: essa gli sortisce dalle mani in questa forma suo
malgrado, allorché egli crede di ‘accingersi’ ad esprimersi in forme che gli
sembrano del tutto accessibili. Con la scoperta di non essere capiti, la poesia
riserva allora una seconda sorpresa – e qui, di solito, si deve decidere se fare
mestiere della seconda sorpresa, oppure virtù della prima.
introduzione 15
La conoscenza poetica implica dunque, nell’insieme, il fatto di essere involontariamente posseduti da un’idea, o nozione, per poi possederla mediante
l’uso della memoria volontaria e dell’immaginazione. In questo senso, essenziale, la poesia nasce da un sorprendente risveglio musicale della memoria
privata, che diventa un bisogno di conservarsi in memorabili nozioni comuni
esercitandosi mediante l’immaginazione concreta. Sulla comunanza delle nozioni e la concretezza dell’immaginazione si misura la differenza fra la buona
e la mediocre poesia. L’esercizio dell’immaginazione è necessario, è implicito
nel significato di nozione chiara e indistinta: dalla tensione che si crea fra la
chiarezza e l’indistinzione (sia del barlume, che dell’abbaglio) scaturisce il primo atto d’una serie di suddivisioni e di moltiplicazioni, le quali si protraggono
secondo le caratteristiche logiche del genere e del discorso.
La sorpresa della memoria privata vuol diventare memorabile conservandosi con la lettura nella sorpresa dell’ascolto – cosicché la poesia risulta, in
definitiva, da un bisogno di conservazione in forma tipicamente estesa, diversificata, comunicabile e persino discutibile, di un inatteso accumulo istantaneo d’energia.
dal lato della scienza
Filosofia e filologia dovrebbero avere il compito di rendere accessibile e discutibile ciò che per sua natura non lo è, né lo richiede: la poesia. Una pietra un
coniglio un malfattore un potere, in quanto esistono in una forma e bastano
sempre a se stessi, sono poiesia. Qualcuno per suo diletto, per frustrazione o
più spesso per inquietudine, s’interroga circa la possibilità della loro discutibile giustificazione. In che modo? Riducendo le idee a concetti.
Un’idea è una vasta galassia di sostanze e di riferimenti, i più diversi e persino reciprocamente inammissibili, che trova un punto di gravitazione attorno
ad un centro nebuloso, il quale si rende a malapena comunicabile mediante
l’uso d’una parola – una sola, di solito: tutti i sostantivi terminanti in -ismo,
per esempio, oppure tutti gli aggettivi sostantivati che, come altrettanti pregiudizi, formano il corredo delle nostre più importanti sintesi a priori; e ciò
che avanza oltre questa parola rimane ermeticamente chiuso nella testa di chi
la dice e di chi l’ascolta, finché una narrazione non viene pazientemente a
sdipanare l’interminabile filamento dei casi empirici in cui essa si trova avviluppata.
Portare esempi non dovrebbe essere necessario; ma per la sua attualità ed
evidenza mi basterà menzionare la più cospicua fra le nozioni d’una persona-
16 introduzione
lità immaginaria assai complessa, qual è una nazione. Allo scopo di celebrare
i centocinquant’anni dell’unità d’Italia, fra la miriade di manifestazioni s’è distinta, per intelligenza, una rassegna radiofonica di Radiotre intitolata Tre colori: la quale ha sdipanato la nozione attraverso centocinquanta conversazioni
su altrettanti temi. Ciascuno di essi rappresenta spesso a sua volta una nozione
(per esempio: la Costituzione, le Città nuove, la Mafia, l’Emigrazione, e simili); ma queste nozioni sono già meno complesse, si avvicinano alle sostanze
semplici in virtù d’onomastico (Gozzano, Mina, Sordi, Verdi, Don Camillo
e Peppone, e simili), oppure in virtù dell’oggetto (il riso, la pasta, la Lettera
22, la radio, e simili), o ancora in virtù dell’occasione (come le Olimpiadi, il
Plebiscito, e simili). Ora, riducendosi una grande sintesi a priori pressoché
inestesa ed indicibile ad una miriade di sintesi a priori alquanto più esigue ed
accessibili, comunicabili e discutibili, a loro volta riducibili, anche l’allegoria
si smembra in metafore sineddochi metonimie ipotiposi e quant’altro; e ciò
significa che il cammino logico riduttivo della nozione verso il concetto è mediato dalla retorica e dalla sensibilità, dalla memoria per lo più involontaria, e
infine anche dalle convenzioni.
Sotto quest’ultimo profilo occorre pur dire che la riduzione dei nostri apriori conoscitivi alle sole convenzioni terminologiche e linguistiche predispone
all’empirismo di Locke la non poco sorprendente base intellettualistica d’un
dogmatismo pattuito, tacitamente ammesso o spontaneamente consentito. Si
tratta, dopotutto, della versione logica della dottrina giurispolitica hobbesiana: questa ignora senza ambagi la lotta nella fase di dualismo dei poteri, e
quest’altra senza ambagi l’ammette come una lucida contrattazione – in una
simmetria complementare che alla lontana (per necessità logica, non storica)
s’è riprodotta tale e quale nelle dottrine di Carl Schmitt sulla sovranità decisionista degli stati d’eccezione e l’ordinarietà del rapporto amico-nemico. Chi
è il sovrano? È la nozione della ‘sovranità’ che s’impone ipso facto nella continua riaffermazione di un comune bisogno di sicurezza e di certezza. Il potere
e la logica coincidono nella spontanea sottomissione a dei simulacri personali
o lessicali, che trasformano lo stato d’eccezione in accezione.
Deve uscire rafforzato dal pericolante (nonché sempre pericoloso, a mio
giudizio) morfema di questo dogmatismo empirico, per opposta conseguenza, il riconoscimento dell’effetto che una miriade di vincoli sensibili esercita
sulla nostra conoscenza, avvolgendola come una seconda epidermide – cosicché parlare di scetticismo per questo stoico vento di ragioni seminali che
impollina il nostro periéchon è puro e semplice difetto di cultura. Storia o
non storia, il lettore intelligente avrà già capito che per tali e per altre simili
ragioni io non so che farmi degli schemi di Kant, o delle sue sintesi a priori; e
introduzione 17
tantomeno so che farmi d’una sua estetica che prepara la via al trascendentale
intellettualismo del fondamento, nonché alla pretesa di certezza dell’induzione. Quando si tratta di ricominciare, lo schietto dualismo cartesiano resta
sempre migliore di ogni sua rigovernatura; ed esso ha non conosciuto superamenti in superfetazioni speculative di valore che non sia meramente storico,
bensì estensioni inversamente graduate, o raccoglimenti verso unità radicali.
Estensioni e raccoglimenti costituiscono, per l’appunto, l’oggetto dei saggi e
studi che seguiranno.
***
Il concetto è invece qualcosa di logicamente assai più esiguo dell’idea, e si
esprime in una semplice proposizione la quale non ammette contraddizione.
In ciò consiste tutta la sua narrazione della cosa – la più breve possibile: nella
quale e dalla quale nulla è possibile aggiungere o togliere. Fra gli opposti estremi logici della nozione e del concetto si stabilisce così un’insensibile continuità infinitesima di gradi sensibili.
Ora, sebbene esigua, le pretese della logica concettuale sono davvero notevoli: perché anziché sdipanarla in una narrazione essa si propone nientemeno
che di smembrare la galassia dell’idea, allo scopo di ridurla ad una serie di
proposizioni non contraddittorie fra loro, cucite insieme in qualche modo in
un discorso che non di rado assume la forma del trattato. Questo discorso è
tutto ciò che resterebbe, per noi, di quell’idea, se la sensazione insopprimibile
dell’inesauribilità della poiesia non facesse risorgere la sensazione dell’unità
della cosa nella poesia, con nuove parole a malapena accennate.
Chi, a questo punto, non desidera che il ciclo ricominci da capo lo spezza,
affermando la sufficienza della trattazione per la cosa, e la superiorità dell’atto
sulla potenza, distinguendo magari il valore logicamente tecnico dell’idea da
quello empirico della vaga nozione; oppure afferma, viceversa, la priorità della
cosa rispetto al discorso, e la superiorità della potenza sull’atto. E così filosofia
e poesia si separano.
Chi invece è disposto a ripristinare il ciclo, in modo da conservare l’unità
della conoscenza per lo meno in quanto essa è un bisogno, considera la filosofia stessa come un discorso di poesia vincolato sempre, in un modo qualsiasi,
all’oggetto tramite un sentimento – confessato in poesia, inconfessato in filosofia. Conosce, e talvolta persino studia, gli espedienti di cucitura delle proposizioni, mediante i quali la logica del concetto cerca di avvolgere l’oggetto, e il
sentimento dell’oggetto, in un involucro cartografico d’innumerevoli superfici
piane tangenti che lo manifesterebbe a puntino e lo renderebbe discutibile. La
18 introduzione
filologia entra perciò qui a far da tramite fra poesia e filosofia mediante l’uso
dei suoi espedienti tecnici – ché altro mai non sono.
Ora, se levando di mezzo gli accademici pregiudizi disciplinari non è difficilissimo ammettere che la filosofia sia essa stessa poesia, è invece alquanto più
difficile ammettere che lo sia anche la filologia. E c’è una buona ragione per
non capirlo – una ragione che dura finché la poesia, come di norma accade,
non viene praticata nella composizione o nella recitazione. Allorché però questo accade, ci si accorge ben presto che le tre cose stanno unite insieme.
Nessuno ha assegnato a filosofi e filologi un simile compito d’esperienza
e d’esercizio: la poesia potrebbe bastare a se stessa, non meno della poiesia;
filosofi e filologi dovrebbero perciò dare a se stessi le giustificazioni che meglio
gradiscono per il compito poetico che si sono assunti – malauguratamente,
non di rado. Per il dispensabile tedio che infliggono a chi li legge essi hanno
una sola giustificazione, io credo: la confessione di non essersi potuti astenere;
di non aver potuto fare altrimenti.
dal lato della pratica
Desidero infine chiarire che cosa intendo annunciando nel titolo la necessità
d’una riforma ‘pratica’ della poesia. È pratico tutto ciò che nasce facendo da
sé – e ciò non esclude affatto il concepire col pensiero. È pratico l’andare a
tentoni in silenzio, o ancora mal parlando a se stessi; è pratico l’immaginare
con precisione; è pratica la volontà di aggirarsi con la memoria sul barlume
involontario d’un ricordo; è pratico il dedurre a fatica, senza aiuti, provando e
riprovando, ed è pratica la cauta sorveglianza delle induzioni; è pure pratica la
noncurante giustificazione d’una qualche analogia, persino gratuita, in attesa
che risultati d’un qualche valore, ancora ben di là da venire, la vengano a legittimare. È pratico mettere al mondo una qualsiasi cosa e proteggerla a lungo,
indisturbata, in attesa che cresca – è pratico, insomma, non domandare mai:
‘A che serve un bambino?’. È pratico astenersi, attendere, tacere, assentarsi,
vegliare, almanaccare, distrarsi, pentirsi, credere, subire, concedere, viaggiare,
ripensarci, dubitare, ignorare, adirarsi o umiliarsi senza sapersi spiegare, dire
‘basta per sempre!’ e ritrovarsi da capo. È pratico il giudicarsi. Il rancore è più
pratico dell’odio, il desiderio dell’amore: generano migliore poesia. Non è
pratico il fare, bensì disporsi con tutto l’essere al fatto preciso e al fare ben determinato. Sono pratici Montaigne, Lessing, Alfieri. È pratico Proust quando
definisce gl’italiani un popolo inestetico: incapaci di soffermarsi ad osservare
e ad ascoltare – innanzitutto se stessi.
introduzione 19
Che cosa, allora, non è pratico? La Ragion Pratica, innanzitutto; il ‘devi,
dunque puoi’ e consimili sciocchezze. Non sono pratiche la petulanza e la dissipazione, così come ogni forma d’attivismo parenetico che esaurisce le nostre
potenze con le altrui. Il dovere d’omissione, in quanto è un ossequioso dovere
di trapasso amministrativo. La critica pedagogica della ragion pura. La Critica
del giudizio che arriva per ultima, anziché esser la prima. Le sintesi a priori
e la deduzione trascendentale – vale a dire: la tavola delle categorie senza la
tavola dei giudizi. Non sono pratici gli schemi come quei misteriosi qualcosa
che nella nostra testa starebbero (come del resto non sarebbe stato difficile
prevedere) a metà strada fra le categorie e le rappresentazioni. Non è pratico
tutto ciò che dalla testa di un professorino prussiano di filosofia è uscito ed è
riuscito, per un insieme di circostanze storiche, a viziare la filosofia creando
un mestiere per i filosofi tenuti a ruolo con denaro pubblico, e bisognosi di
giustificarsi nei confronti del contribuente. Il criticismo, dopo l’aristotelismo,
ha ucciso la poesia ch’è sempre stata animatrice della filosofia come qualcosa
di pratico? In poche parole, sì – è proprio ciò che penso.
Chi cerca una strada non può pensare d’insegnarla ad alcuno, e una simile
pretesa accampata da una qualsiasi ragione rappresenta dunque, per l’appunto, la negazione della pratica – vale a dire della poiesia. Per conseguenza, la
cura d’una qualsiasi finalità concernente la prossima comunicazione o persino
la discutibilità d’una pratica rappresenta l’opposta affermazione della teoresi
critica. Comunicabilità e discutibilità d’una cosa non sarebbero un arduo problema, che mette in moto tutte le tecniche delle arti, se fossero possibilità già
accessibili o insite fin dalla concezione. Perciò non lo devono essere – né del
resto lo potrebbero, se la pratica è vera poiesia. È dunque la pratica teorica che
deve aprirsi la strada verso la teoresi, anziché essere questa a decadere in quella,
come abitualmente si pensa.
L’equivoco è assai ben mascherato sotto i monumentali costrutti dogmatici
e antidogmatici che da due secoli abbondanti costituiscono ormai il patrimonio senza dubbio più cospicuo della filosofia contemporanea. L’origine sta nel
criticismo di Kant: grazie al quale dogmatismo e antidogmatismo si saldano nel circolo ‘trascendentale’ della ‘fondazione’. Allorché i filosofi smettono
d’essere uomini d’ogni mestiere, e la filosofia diventa l’unico mestiere possibile per professori di filosofia, accade che essa non solo leghi strettamente le sue
concezioni poietiche alla possibilità prossima della comunicazione discutibile
e dell’insegnamento, ma anzi addirittura accade che nasca dal seno stesso della
didattica accademica – o, come si suol dire, dalla ‘pratica’. E al criticismo si
sono poi affiancati gli storicismi impersonali, che hanno operato sulla poiesia
riduzioni complementari o simmetriche: per cui una cosa si riduce dapprima
20 introduzione
alla storia di quella cosa; la storia della cosa che non voglia morire d’erudizione deve poi acquistare senso in un Giudizio riflettente sulla Storia stessa; e il
Giudizio diventa infine nient’altro che la storia letteraria del farsi del Giudizio
medesimo.
Così, nel breve giro di pochi rapidi passaggi che vedono realizzarsi la coincidenza della logica con la sociologia degl’intellettuali come una coincidenza
del pensiero con l’essere, la filosofia si riduce allo studio delle opere dei filosofi come suo divenire progressivo, ovvero attuarsi esaustivo. Essa coincide
con esse – salvo sempre negare risolutamente, o fingere d’ignorare, che questa
storia non è, per l’appunto, nient’altro che un nuovo genere letterario della
nostra éra: la quale, insieme col grande romanzo scritto da chi sapeva vedere,
non poteva non veder nascere i romanzi della ragion ragionante di chi vedere
non sapeva, né preferiva, o affettava disdegnare. La pretesa di riscoprire il
valore dell’Essere al di là della sua letteratura, e magari persino d’una Poesia
ch’è in definitiva ontologia, non è che l’ultima trovata di una simile sdegnosa
affettazione antiletteraria dei filosofi di professione – i quali si guardano bene
dal tuffarsi in questa loro Poesia con le attrezzature della filologia.
dal lato della volontà
Eppure – ecco: io credo che proprio nell’iniziatore Kant di questa lunga éra
di decadenza si possa ancora trovare, volendo, della poesia oltre al pessimo
romanzo; e credo che la sua opera possa essere interpretata, volendo, come
un’istintiva rielaborazione autistica, come una tattile e per così dire fetale reinterpretazione del ricchissimo lascito teorico e culturale europeo depositato,
pressappoco, lungo quella dozzina di generazioni che collegano Valla a Leibniz attraverso Cartesio e Galilei. In una nazione ritardataria come la Germania, che con Goethe si preparava ad assumere una precisa identità letteraria,
e in uno Stato desideroso di tutto apprendere per tutto osare, come la Prussia
federiciana, un uomo senza talento che non fosse perseveranza nella mediocrità del mestiere didattico cava fuori in pochi mesi, dai brogliacci di dieci
anni di lezioni, quel che gli sembra di dovere ritenere per certo, e che ancora
dovrebbe rimanere fermo nel gassoso universo mondo spalancato, da scarse
letture, davanti alla coscienza allarmata della sua agorafobia ultraprovinciale.
Rannicchiato in una camera oscura, inverte le parti, e facendo come Tolomeo
proclama la necessità di fare come Copernico. Senza molti sforzi ha già fatto
l’attore di paese, dandosi un’identità con la macchietta della puntualità; ottenuta la docenza, si cimenta con la drammaturgia logica allestendo nella prima
introduzione 21
Critica, con una mezza dozzina di personaggi (Sensibilità, Intelletto, Ragione, Ragionpura, Opinione, Giudizio, oltre al Popolo seminascosto e ad un
Principe ben nascosto), una sceneggiatura cartesiana con boschereccio finale
pascaliano a sorpresa – al quale già mirava fin dall’inizio. Fidando nella fortuna che protegge gli audaci, gli danno la forza di destreggiarsi ad oltranza nel
rabbercio della scrittura l’esempio della guerra dei Sette Anni e il re di Prussia. Finché dura, l’avventura europea cominciata con loro è per l’appunto, di
fatto, anche la sua fortuna: che culmina e comincia a tramontare insieme con
l’unico Reich che abbia contato e conti ancora per noi davvero: il secondo.
Ora, se nel criticismo e nel suo indefesso praticantato teorico tutto fosse falso, esso non sarebbe neppure una vera tedescheria: perché piramidi rovesciate come quella della giustificazione per mezzo della sola fede, o della
produzione per l’uso che precederebbe la raccolta e lo scambio, e della storia
come lotta di classi, e dello spirito protestante del capitalismo, e di tanti altri simili rigorosi affastellamenti generati da lampi d’intuizione affondano, è
vero, nella sabbia la loro cuspide – ma per noi non è la precarietà dell’equilibrio ideologico che conta, ormai. Così come tutta questa filosofia non va
giudicata, nella sua estensione, che come un illeggibile romanzo della ragione,
così, all’opposto, quei primi moti tellurici scaldati e sepolti nel nulla d’un
proprio bisogno di credere in se stessi altro non erano, in definitiva, che poesia. Essa in realtà non chiedeva che d’essere trattata per ciò che voleva essere
praticamente – come un’arte della vita gioiosa, della città solidale e dell’igiene
del lavoro che il socialismo cosiddetto utopistico anglo-francese ha tramandato alle mani di architetti e urbanisti, ottenendo nel Novecento i suoi migliori
risultati. La pretesa scientifica (vale a dire antiutopistica: a dispetto di Leibniz
le due cose sembrarono ovviamente coincidere) del biblismo, del criticismo
e del socialismo fu tramandata altrove: in altre mani, ben diverse e lontane
la sete di salvezza di verità e di giustizia di Marx Lutero Kant diventarono
quell’efficiente solidarietà politecnica d’un nazionalismo che come ‘pratica’
era stato in sul nascere soltanto un ossessivo bisogno di sicurezza per il corpo e
di certezza per la mente. Tutto finì per saldarsi nel Secondo Reich bismarckiano e guglielmino, col quale la Germania si sentì pronta a candidarsi col pugno
all’egemonia del nuovo secolo. Non fu il retroterra romantico, bensì storicista
e criticista, che soppiantò per simmetria il retroterra illuministico dell’impresa
napoleonica, in un’impresa che nulla ebbe d’irrazionale – con buona pace di
chi vorrebbe addossare con notissime tesi tutte le colpe delle catastrofi tedesche a mode nicciane che, indipendentemente da ogni giudizio sul vero valore
intrinseco dell’opera di Nietzsche, non contarono, e non potevano contare,
assolutamente nulla.
22 introduzione
E dunque, ripensando all’Ottocento ma soprattutto all’esecutore testamentario delle sue ideologie, al Novecento che s’è appena da un decennio concluso
– che fare ormai delle tedescherie, che non hanno mai considerato il bisogno
di giustizia come una delle forze motrici del progresso umano? Che fare della
bisecolare avventura prussiano-kantiana per la conquista di un secolo della
Germania? Ho appena dato qui sopra la mia risposta: può essere utile farne
l’esempio clamoroso di unità radicale, indistinta, delle facoltà, per trarre una
lezione di volontà pratica di quella poesia che è sempre insita nell’inizio anche
delle dottrine più ingombranti e pretenziose. Col suo antico vizio di fare il
cortegiano, l’intellettuale italiano non può passare dalla sudditanza speculativa alla sprezzatura letteraria, perdendo l’occasione di giovarsi di simili esempi
di volontà e di energia che gli vengono dalla barbarie filosofica. Il segreto della
forza che essa possiede sta nella cecità esplosiva, ottenuta col massimo raccoglimento dell’inizio; e se ciò che viene dopo è, di solito, cattiva letteratura
teorica e catastrofica applicazione politica, può tuttavia anche diventare, io
credo, buona e pratica poesia civile – purché conservi la consapevolezza della
sua vera natura.
Non è necessariamente vero, perciò, che uomini passati attraverso la filosofia professionale debbano per forza essere negati alla poesia – così come
del resto non è vero ciò che la lettura dei poeti contemporanei ampiamente
mostra: essere i meno filosofi migliori poeti. Ciò dev’essere tanto più vero in
un paese come l’Italia, la cui grande poesia non ha mai conosciuto divorzio
dalla filosofia, e dove il professionismo filosofico didattico e storicista, vivente
d’importazioni divulgazioni e commenti, non è che un’attività compradora. E
la nostra ultima (improbabile) disgrazia sarebbe proprio questa: che simili filosofi si mettessero a fare poesia. Non è per conseguenza del tutto impossibile
illudersi che una riforma della poesia possa anche trasformarsi in una rinascita
della filosofia.
Mia moglie Paola Luciani ha letto questi studi con attenzione
rendendoli in diversi punti alquanto più accessibili.
Il suo sano giudizio mi ha aiutato a correggere
una certa mancanza di carità per il lettore
della mia prosa scientifica
legenda ad oltranza.
Le sono grato.